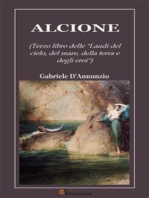Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Dubliners Riassunto
Dubliners Riassunto
Caricato da
Sabrina GrilloCopyright:
Formati disponibili
Potrebbero piacerti anche
- Virginia Woolf Appunti PDFDocumento10 pagineVirginia Woolf Appunti PDFValeria CutoloNessuna valutazione finora
- Riassunto Da Ovidio A TacitoDocumento3 pagineRiassunto Da Ovidio A TacitoGiuseppe TerzoNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento15 pagineLeopardiVito Di VirgilioNessuna valutazione finora
- Manzoni, Le TragedieDocumento2 pagineManzoni, Le Tragedielu2deNessuna valutazione finora
- Gabriele D'AnnunzioDocumento3 pagineGabriele D'AnnunzioSimona MagrìNessuna valutazione finora
- Italo SvevoDocumento7 pagineItalo SvevoOftalmo StataleNessuna valutazione finora
- TesinaDocumento31 pagineTesinaGiacomo IavaroneNessuna valutazione finora
- Ermetismo, Ungaretti e MontaleDocumento12 pagineErmetismo, Ungaretti e Montalejoaoguilhermepaiva100% (1)
- VergaDocumento10 pagineVergaRebecca CaggiariNessuna valutazione finora
- Tesina Su Italo SvevoDocumento5 pagineTesina Su Italo SvevoFrancescoNessuna valutazione finora
- Enzo Noè Girardi - La Struttura Dualistica Dei Promessi Sposi PDFDocumento3 pagineEnzo Noè Girardi - La Struttura Dualistica Dei Promessi Sposi PDFPietro_V100% (1)
- Età Dei FlaviDocumento22 pagineEtà Dei FlaviMattia SantilliNessuna valutazione finora
- Giovanni PascoliDocumento2 pagineGiovanni PascoliConCy MaCcNessuna valutazione finora
- Verga e LeopardiDocumento4 pagineVerga e LeopardioolongNessuna valutazione finora
- Romanzo Storico e Promessi SposiDocumento30 pagineRomanzo Storico e Promessi SposiMerloNessuna valutazione finora
- Saba, Ungaretti, Montale, Gadda, Calvino RiassuntoDocumento7 pagineSaba, Ungaretti, Montale, Gadda, Calvino RiassuntoAlessandro FalcettaNessuna valutazione finora
- VERGADocumento6 pagineVERGABenedetta PiliaNessuna valutazione finora
- Schema DellinfernoDocumento2 pagineSchema Dellinfernolucrezia iacobazziNessuna valutazione finora
- Montale Riassunto Letteratura Italiana ContemporaneaDocumento5 pagineMontale Riassunto Letteratura Italiana ContemporaneaGiacomo Milone100% (1)
- Dannunzio SintesiDocumento5 pagineDannunzio SintesixarenwoNessuna valutazione finora
- Poetica PirandelloDocumento18 paginePoetica PirandelloDavide ColottiNessuna valutazione finora
- Antonio Gramsci (Mustè)Documento10 pagineAntonio Gramsci (Mustè)Lorenzo CognettiNessuna valutazione finora
- Leop SintesiDocumento4 pagineLeop SintesixarenwoNessuna valutazione finora
- VergaDocumento8 pagineVergailary__94_57523284Nessuna valutazione finora
- PinocchioDocumento9 paginePinocchioMaddalena TintiNessuna valutazione finora
- La ScapigliaturaDocumento2 pagineLa Scapigliaturariccardo0% (1)
- Stile Seneca TaciToDocumento4 pagineStile Seneca TaciToAEHNessuna valutazione finora
- PascoliDocumento5 paginePascoliflory73Nessuna valutazione finora
- Domande Su SenecaDocumento4 pagineDomande Su Senecamarco2300100% (1)
- Dannunzio Sint PDFDocumento5 pagineDannunzio Sint PDFHibinoNessuna valutazione finora
- Svevo SchemiDocumento9 pagineSvevo SchemiFrancesca MelisNessuna valutazione finora
- Verga 'ClassicoDocumento6 pagineVerga 'ClassicoArianna CalabrettaNessuna valutazione finora
- Il Romanzo Storico in Lingua ItalianaDocumento5 pagineIl Romanzo Storico in Lingua ItalianaMichele MazzieriNessuna valutazione finora
- Poetica MontaleDocumento3 paginePoetica MontaleSilvia GreenNessuna valutazione finora
- Interrogazione Di Italiano L. OPEREDocumento14 pagineInterrogazione Di Italiano L. OPEREMcd ColombiaNessuna valutazione finora
- Italo Svevo Riassunto AutoreDocumento4 pagineItalo Svevo Riassunto AutoreStefanoMologni100% (1)
- 13 DecadentismoDocumento11 pagine13 DecadentismojacoptNessuna valutazione finora
- TACITODocumento4 pagineTACITOCarolina CorteseNessuna valutazione finora
- SenecaDocumento5 pagineSenecaFederico ToffoliNessuna valutazione finora
- Persio e GiovenaleDocumento5 paginePersio e GiovenaleMarco S BoffoliNessuna valutazione finora
- Giovenale, Marziale, Plinio Il Vecchio, Quintiliano, Plinio Il Giovane, SvetonioDocumento13 pagineGiovenale, Marziale, Plinio Il Vecchio, Quintiliano, Plinio Il Giovane, SvetonioTomasoNessuna valutazione finora
- Leopardi SSLAZIO8Documento9 pagineLeopardi SSLAZIO8Valentino MasiNessuna valutazione finora
- Lirici GreciDocumento5 pagineLirici GreciGiorgio OttolinaNessuna valutazione finora
- Il - Verismo Di Verga Con Rispetto Alla Questione Del MeridioneDocumento20 pagineIl - Verismo Di Verga Con Rispetto Alla Questione Del MeridioneTrillina Gira MondoNessuna valutazione finora
- La Germania Di TacitoDocumento1 paginaLa Germania Di TacitoMorgause2011Nessuna valutazione finora
- SenecaDocumento5 pagineSenecaAdriano DionisiNessuna valutazione finora
- Mastro Don Gesualdo AnalisiDocumento4 pagineMastro Don Gesualdo AnalisiLucyNessuna valutazione finora
- La ScapigliaturaDocumento4 pagineLa ScapigliaturaAnonymous kieQreiPZNessuna valutazione finora
- Montale (Sintesi)Documento4 pagineMontale (Sintesi)nicolasgueraNessuna valutazione finora
- 0 - Svevo - Inetto, Senilità e Una VitaDocumento3 pagine0 - Svevo - Inetto, Senilità e Una VitaNicolaNipolinoNessuna valutazione finora
- Manz Sintesi PDFDocumento6 pagineManz Sintesi PDFHibinoNessuna valutazione finora
- La ScapigliaturaDocumento3 pagineLa ScapigliaturaLeonardo MeggiolaroNessuna valutazione finora
- PirandelloDocumento15 paginePirandelloLucas FaillaNessuna valutazione finora
- TacitoDocumento9 pagineTacitoHibinoNessuna valutazione finora
- Opere Di VergaDocumento10 pagineOpere Di VergaAndreaNessuna valutazione finora
- Decadentismo, D'annunzio e PascoliDocumento7 pagineDecadentismo, D'annunzio e PascoliLO FARO GIUSEPPENessuna valutazione finora
- Alcione (Terzo libro delle "Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi")Da EverandAlcione (Terzo libro delle "Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi")Nessuna valutazione finora
- La Profezia Di Ratzinger Sul Futuro Della Chiesa - Dicembre 1969Documento2 pagineLa Profezia Di Ratzinger Sul Futuro Della Chiesa - Dicembre 1969fesousacostaNessuna valutazione finora
- 08 IndiosDocumento4 pagine08 IndiosAnna CastoldiNessuna valutazione finora
- Una Fuga in Egitto Di Ambrogio Figino inDocumento21 pagineUna Fuga in Egitto Di Ambrogio Figino inMauro PavesiNessuna valutazione finora
- Atto Preventivo e Atto Attuale. I Giri Dell - AnimaDocumento6 pagineAtto Preventivo e Atto Attuale. I Giri Dell - AnimavaleNessuna valutazione finora
- Opere Rudolf Otto Lxxvii (2009)Documento436 pagineOpere Rudolf Otto Lxxvii (2009)rodericuignatiusNessuna valutazione finora
- Le Campane Di Uggiate e Ronago - Bollettino ParrocchialeDocumento32 pagineLe Campane Di Uggiate e Ronago - Bollettino ParrocchialeLeCampaneNessuna valutazione finora
- Arte BizantinaDocumento4 pagineArte BizantinaAlessandro BiasilloNessuna valutazione finora
- Saluto Del Vecchio Priore, e Del NuovoDocumento2 pagineSaluto Del Vecchio Priore, e Del NuovoVito CassoneNessuna valutazione finora
- Mese Di Maggio Di Don G.TomaselliDocumento62 pagineMese Di Maggio Di Don G.TomaselliAGR LUCIANO CIROLLANessuna valutazione finora
Dubliners Riassunto
Dubliners Riassunto
Caricato da
Sabrina GrilloTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Dubliners Riassunto
Dubliners Riassunto
Caricato da
Sabrina GrilloCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|7922014
Dubliners
Letteratura inglese 1(sd 12 cfu) (Università degli Studi di Firenze)
StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
DUBLINERS
Dubliners è la prima raccolta di James Joyce, che contiene 15 racconti, pubblicata originariamente da Grant Richards nel 1914,
dopo essere stata svariate volte rifiutata da altre case editrici.
I protagonisti del libro sono gli abitanti di Dublino, presentata con la sua corruzione, di cui vengono narrate le storie di vita
quotidiana.
Il libro vuole focalizzare l’attenzione principalmente su due aspetti:
la paralisi: una paralisi morale, intellettuale e spirituale, causata dalla politica e dalla
religione dell’epoca
la fuga: la conseguenza della paralisi, nel momento in cui i protagonisti comprendono
la propria condizione; la fuga, però, è destinata a fallire sempre.
17 mesi dopo la pubblicazione del libro, Joyce scrive a Richards, affermando che il suo libro era stato “an utter flop”, un fiasco
solenne.
La censura voleva bloccare il libro, perché alcuni testi erano ritenuti troppo audaci, si parlava di sesso e vi erano nomi di
persona all’epoca ancora in vita e nomi di luoghi reali; perciò le autorità religiose e i nazionalisti, ritratti in modo poco
piacevole nel libro, si opponevano. Grant Richards, invece, lo aveva giudicato pubblicabile perché lo stile era diretto e sincero
ed il testo ritraeva in maniera naturale Dublino.
Nonostante questo, Joyce aveva dovuto combattere per 10 anni contro gli editori, che volevano modificare il libro,
riformulando frasi o addirittura cambiando i veri nomi di posti con nomi di finzioni, o eliminare due delle quindici storie
presenti.
Joyce, però, voleva mantenere il suo scopo, ovvero quello di civilizzare gli Irlandesi mostrandogli come erano
realmente attraverso il suo “nicely polished looking-glass”.
Secondo Joyce lo scopo di un artista non era quello di mostrare la bellezza in sé, ma la verità e l’arte era vera solo se
aveva a che fare con la verità.
Per questo motivo voleva mantenere il libro così come lo aveva scritto, con quell’onestà non censurata e quel realismo non
contaminato dal romanticismo; secondo lui il suo libro così com’era, era il primo passo verso la liberazione spirituale
dell’Irlanda (a contrario degli altri scrittori che non parlavano altro che di amore puro).
Il punto di svolta di ogni storia è proprio quello di conoscere se stessi, ma Joyce non si presenta mai come un educatore ed
infatti il tema principale della raccolta è proprio l’impossibilità di uscire da questa condizione di paralisi (la fuga fallisce
sempre).
Joyce pubblicò la prima storia nel 1904, finendo la quindicesima “The Dead” nel 1907 anche se il libro fu pubblicato solo nel
1914. Egli stesso definiva il volume con termini quali “truthy”, “exactness”, “polished looking-glass”, “liberation”,
“civilisation”;
la creazione di un lavoro in cui si rifletteva esattamente la vita in Irlanda non era solo un documento di un momento storico
del paese, ma era un mezzo per civilizzare i cittadini.
Joyce scrive le storie con uno stile di cattiveria scrupolosa (crudo) e afferma che non poteva fare a meno di offendere le
persone; questo, però, non era il suo obiettivo, bensì era solo una conseguenza di un programma estetico. Poco dopo
ammette di essere stato troppo cattivo e di non aver inserito nel racconto gli aspetti positivi di Dublino, infatti, non si è mai
sentito a suo agio come a Dublino e l’ospitalità di questa città è una caratteristica unica.
Alla fine mitiga la sua critica e riconosce al suo paese la dote dell’ospitalità, ma il tono complessivo rimane “harsh”, perchè
rispecchia un uomo che si è sentito tradito dalla sua città. (Dietro al suo contratto con l’editore irlandese, Joyce scrive un
poema satirico “Gas from a burner”).
Secondo Joyce, vedendo se stessi rappresentati così com’erano realmente e tutti i loro difetti, gli irlandesi sarebbero
arrivati a un momento di auto-riconoscimento, che sarebbe stato il primo passo per uscire dallo stato di paralisi in
cui si trovavano.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
I lettori, però, hanno trovato le storie di Dubliners fredde, insensibili, distaccate, derisorie e le hanno descritte come
‘naturalistiche’ (ovvero realistico). Queste storie, infatti, rappresentano momenti della vita quotidiana dei cittadini di Dublino,
delle tranches de vie, slices of life, e siccome secondo Joyce la vita era violenta e dolorosa, non poteva coprire nulla ma
descrivere tutto con realismo (e non con romanticismo).
Quando Joyce parla di “spiritual liberation” non intende la trascendenza spirituale del mondo o del corpo, bensì l’esistenza
che non comprende esclusivamente proprio queste cose; egli credeva che una tale esistenza fosse impossibile in Irlanda a
quel tempo ed era la verità che voleva raccontare.
Il progetto artistico di Joyce era quello di dover essere sempre veritiero, ma anche linguistico; i suoi scritti erano manufatti
linguistici e vi era sempre una difficile relazione tra la rappresentazione del materiale reale & sfruttare la fecondità potenziale
del significato caratteristico dell’arte tra letterale e retorico, tra vita e letteratura. Si tratta in questo caso di storie di una
ricchezza retorica e narrativa enorme.
‘four of its aspects’
La struttura non è pensata secondo una divisione immaginaria, ovvero il libro non è diviso in 4 sezioni, bensì Joyce vuole
presentare Dublino sotto quattro aspetti: infanzia, adolescenza, maturità e vita pubblica. All’inizio le storie non erano
composte in questo ordine, Joyce ha cambiato all’ultimo anche dopo aver aggiunto storie alla collezione fino a raggiungere la
suddivisione attuale:
1) Infanzia: “The Sisters”, “An Encounter”, “Araby” (3)
Questi racconti sono in 1° persona e sono accumunati dal tentativo d’evasione
2) Adolescenza: “Eveline”, “After the Race”, “Two Gallants”, “The Boarding House” (4)
Qui 2 racconti parlano di tradimenti meschini, mentre gli altri 2 del tentativo di evasione dalla paralisi dublinese che viene
ostacolato. La città = prigione, la famiglia = carcere, gli ambienti sono opprimenti e squallidi e si rifanno sul protagonista che
ha avuto il coraggio di scappare.
2) Maturità: “A Little Cloud”, “Counterparts”, “Clay”, “A Painful Case” (4)
4) Vita pubblica: “Ivy Dai in the Committee Room”, “A Mother”, “Grace” (3)
Joyce vuole riprendere la politica irlandese e fa riferimento ai momenti di gloria dell’Irlanda e all’eroe politico del tempo; in
questa parte, vi è un valore metaforico alla paralisi dell’Irlanda intera, ovvero si passa dal microcosmo di Dublino al
macrocosmo dell’Irlanda nel suo insieme.
L’ultima storia “The Dead” è una novella e non una short story; composta più di un anno dopo la rottura della relazione con il
suo amico editore Richards,nel 1907, non fa parte di questo schema, ma è la summa delle istanze critiche presenti nei
quattro precedenti aspetti/fasi.
Nel libro si distingue non solo personaggi singoli/individuali, ma un singolo soggetto visto attraverso il tempo, prima
nell’infanzia fino alla maturità, quindi un singolo soggetto che muta; in questo senso Dubliners è molto simile all’altro lavoro
di Joyce “A portrait of the Artist as a Young Man” e al suo ultimo lavoro “Finnegans Wake”.
Secondo Joyce, Ulisse è l’unico personaggio completo nella storia della letteratura e nel suo lavoro, cerca di presentare non
solo un personaggio completo, ma anche un individuo rappresentativo, ovvero a “kind of everyman”.
In Dubliners Joyce presenta una moltitudine di individui distintivi, che insieme sono rappresentativi: la loro peculiarità
smentisce ogni allegorica cecità, mentre la loro composita collettività li rende metaforici.
Dubliners rende una Dublino personificata, anche se i dettagli hanno anche un significato simbolico.
Joyce afferma che ha scelto proprio Dublino perché gli sembrava il centro della paralisi e che lo ha scritto con uno stile di
scrupolosa meschinità.
Inoltre, riprende la differenza di Aristotele tra poeta e storico:
storico: descrive le cose come sono e si occupa di attualità
poeta: descrive un tipo di cosa come dovrebbe essere e ha a che fare con la
potenzialità.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
“alter [not] in the presentment”
Tra gli scrittori moderni Joyce ha una peculiarità, ovvero il particolarmente insistente atteggiamento nei confronti dei fatti,
nel descrivere Dublino, la sua cultura e la sua storia, minuziosamente e accuratamente. Inoltre Joyce non fa mai affidamento
sul narratore per rivelare cose che stanno dietro ai fatti.
La minuziosità di descrizione di Joyce, però, non sta solo nel descrivere i facts e unfacts, ma anche nel rendere l’idioma della
parlata a Dublino.
“chapter in the ... history”
In Dubliners, comunque, i fatti hanno dietro anche dei veri significati. Joyce usa il trascorso storico della città per espandere il
significato delle storie dietro la piccola circoscrizione delle vite dei personaggi; in realtà, egli inspessisce il commento storico
inframmentando la storia con precise referenze alle strade ed edifici della città che portano il nome di coloro che, non solo
hanno oppresso la città nel passato, ma che sono stati ricompensati per questo.
In tutto il libro, Joyce si aspetta che i suoi lettori conoscano già alcuni fatti storici del loro paese, l’Irlanda, come per esempio
in “After the Race” si aspetta che conoscano la ‘Naas Road’, il posto in cui si combattè nel 1798 la ‘Rebellion of the Irish’
contro l’Inghilterra.
La straordinaria abilità di Joyce risiede, non solo nel raccogliere i “facts”, ma anche gli “unfacts”, per utilizzare ellissi
(omissione di parole) e disegnare con destrezza e umorismo i personaggi umani che sbagliano.
“a style of scrupulous meanness”
Joyce, appunto, durante tutto il libro, dipende direttamente dalla conoscenza del lettore per quelle cose che la narrativa
stessa non esplicita. Egli afferma che la storia non rivela niente in nessun modo letterale o volgare, perchè durante la sua
realizzazione, Joyce esercita uno stile di “scrupulous meanness”, dove ‘scrupulous’ sta per attento ad ogni minimo dettaglio e
‘meanness’ denota la frugalità. La frugalità di Joyce si allea con il suo rifiuto di raccontare quando invece può mostrare; il
mostrare si allinea con la consapevolezza e il linguaggio della storia.
“what he called ‘epiphanies’ ”
La fine delle storie arriva sempre inaspettatamente, lasciando il lettore con quel sentimento, come se lo scrittore avesse
lasciato in sospeso qualcosa e non avesse l’intenzione di spiegare.
Questo tipo di fine sovverte l’aspettativa creata dal genere stesso e questo assomiglia a ciò che Joyce chiamò “epifania”. Il
termine è stato preso in prestito per la prima volta proprio da Joyce dal linguaggio sacrale della Chiesa cattolica e rigirato per
servire l’arte. “Epifania” applicata alla letteratura viene a precisare un momento di improvvisa rivelazione, o per il
personaggio o per il lettore; questa definizione assomiglia a quella di Stephen Daedalus, anche se quella di Joyce differenzia
un po’ in un modo tipico joyciano. Stanislau descrive l’epifania di Joyce come una manifestazione o una rivelazione che arriva
per errore, dalle quali le persone ingannano le cose reali che volevano invece nascondere (?).
LE STORIE
In una lettera al fratello, Joyce ammette il dato autobiografico presente nella storia (“Questa è la mia infanzia”) -
autobiografismo estetico.
Ogni racconto è incentrato su un momento epifanico: un momento in cui un evento risveglia nel soggetto un’emozione o
un’esperienza che era stata rimossa, ma che è comunque rimasta sepolto dentro (la riporta alla luce) e che perturba e
inquieta il soggetto; si scopre così una nuova consapevolezza della realtà. Al livello narratologico, questo si riproduce
attraverso lo stream of consciousness.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
CHILDHOOD
THE SISTERS
Joyce pubblicò “The Sisters” nel 1904, ma dopo che finì tutto il lavoro, a parte l’ultima storia “The Dead”, riscrisse questa
prima storia. I critici ritengono che sia non solo perchè non era soddisfatto della disinvoltura della prima versione, ma anche
perchè era la prima storia del libro, un libro che aveva solo vagamente immaginato all’inizio quando pubblicò la storia.
Entrambe le versioni hanno la stessa trama di base.
Il racconto inizia con i ricordi del narratore, ovvero del protagonista, (scritto in 1° persona) che delinea la dimensione
psicologica, temporale e simbolica dell’intera vicenda, che può essere assunta anche come un esame di coscienza del
protagonista, del prete o del lettore. Sono presenti, infatti, continui flashbacks e ricordi che descrivono Padre Flynn come un
prete intellettuale con una forte vocazione religiosa, ma che non è in grado di sopportare la routine dell’essere prete, fino al
suo collasso. Il ragazzo lo ammira, ma padre Flynn viene considerato come un fallimento e come un cattivo esempio per i
ragazzi e la sua morte è sentita come un sollievo. (old Cotter durante una cena lo dice esplicitamente).
TRAMA:
Un giovane ragazzo cerca di capire se Father Flynn è morto (guardando attraverso la finestra del prete e cercando di cogliere
la simbologia delle luci), ma la notizia della sua morte giunge la sera durante la cena dal vecchio Cotter, che insinua che c’era
qualche cosa che non andava nel prete da qualche tempo. Leggendo l’annuncio della morte del prete, al ragazzo vengono in
mente le sue frequenti visite dell’ultimo periodo e la varietà di cose che padre Flynn gli aveva insegnato. Insieme alla zia,
vanno a trovare le due sorelle di Flynn sopravvissute, Nannie e Eliza, vedono la salma e restano nel salotto ad ascoltare i
racconti delle sorelle. Elisa, una delle due sorelle, racconta che una volta Flynn aveva rotto un calice e anche se si riteneva
fosse vuoto, da allora non fu più lo stesso, una notte lo ritrovarono addirittura tutto solo nel confessionale a ridere da solo.
CRITICA RELIGIONE:
“The Sisters” è un’analisi dell’educazione cattolica borghese e della mancanza di un senso in questa educazione. La morte del
prete assume il valore simbolico di:
- la morte di una trasmissione della cultura
- la mancanza o il guastarsi di un maestro
- la mancanza della spiritualità
- la mancanza di un’autorità
L’inizio del racconto è definito dall’assenza di speranza, che si ritrova specularmente nel racconto “Grace”, l’ultimo della
“Public Life”; speranza e grazia sono i due poli cristiani e perciò, l’assenza di speranza costituisce una critica alla religione
cattolica, considerata il pilastro della società irlandese. Tutto il racconto si può interpretare come l’allegoria della carità
cristiana che, però, è perversa; Dublino non riesce ad essere caritatevole (si rompe il bicchiere del vino nell’omelia).
In entrambe le versioni, la zia evita sempre di parlare direttamente del motivo della morte del prete (es. “Did he...
Peacefully?”).
Nella prima versione, sembrava solo perché diminuisse la voce o era vista come una pausa per riflettere, ma nella seconda
versione, le omissioni nei discorsi degli adulti sembrano essere state fatte per evitare di parlare apertamente davanti al
ragazzo.
Questa figura retorica è chiamata aposiopesi, ovvero la figura retorica dell’incompletezza, delle frasi non finite:
Gli adulti non dicono, ma fanno sottintendere che c’è qualcosa di importante dietro al loro non-dire, che di quello di cui non
parlano non è adatto a dei bambini, perchè trattasi di qualcosa di spiacevole e sporco.
Nella versione finale, infatti, il ragazzo capisce che nella società in cui vive ci sono cose di cui non è possibile parlare.
Riscrivendo la storia, Joyce ha trasformato un racconto di una relazione tra un ragazzo e un prete in una descrizione di usanze
di una cultura di soffocamento e di un’aura di insinuazione e inquietudine.
[In questa seconda versione, il lettore si trova ad identificarsi per la prima volta con la posizione del ragazzo e presume che
quel bizzarro non-parlare deve riferirsi a qualcosa di sessuale. La situazione imbarazzante del ragazzo riflette perfettamente
quella del lettore]
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
A differenza della prima versione, l’inizio della seconda versione comprende tre parole in corsivo che si ripetono in tutta la
storia: ‘paralysis’, ‘simony’, ‘gnomon’.
Il racconto può essere visto come un’allegoria, dove la carità cristiana è povera: i cittadini non sono caritatevoli, ma falsi e
questo si verifica con la scomparsa del maestro; si ha quindi l’interruzione della tradizione cattolico-borghese.
PARALYSIS: immobilità, incapacità di scappare o di muoversi dalla routine del pensiero o delle azioni in cui le persone hanno
rinchiuso se stesse. Si tratta di una paralisi letterale e non figurativa, ovvero di una sofferenza effettiva del prete.
C’è un’analisi del senso dell’educazione cattolica borghese; il prete è malato, una malattia fisica, letta anche come morale per
la rottura del calice, fino alla morte. La morte ha il valore simbolico della morte di trasmissione di insegnamento. Mancanza di
un’autorità per tutta la famiglia.
Tema: alienazione di fronte a se stesso. (testo anticattolico). la paralisi è data tecnicamente anche dai puntini di sospensione,
dalle parentesi, ovvero dalle esitazioni nei dialoghi che costituiscono il primo tentativo di silenzio.
SIMONY: scambio delle cose spirituale per cose temporali; si tratta di un atto peccaminoso secondo cui tutto diventa
commerciale/economico. Proprio la mancanza di una guida favorirebbe la simonia. Anche lo stesso ragazzo è colpito da
questo atto.
GNOMON: è la parte della meridiana che segnala l’ora, quella figura geografica che è costituita da ciò che rimane nel
quadrato grande; nel quadrato grande manca quella parte che indica la direzione. Infatti, lo gnomon è vista come la figura di
incompletezza, che corrisponde alle ellissi della storia, a quei gaps nei pensieri dei personaggi (mancano le istituzioni al
ragazzo per progredire).
Inoltre, come figura di parallelismo, corrisponde alla straordinaria abilità di Joyce di far scontrare e dare importanza a due tipi
di significato simultanei ma apparentemente peculiari: il letterale e il simbolico, l’attualità dello storico e la potenzialità del
lettore, il regno della storia e quello del lettore.
Questo racconta ci presenta il tema della corruzione e della tradizione culturale guasta e del tradimento; nell’animo dei
giovani viene lasciato un vuoto, sono invitati alla violenza o alla disperazione. La classe egemone criticata è la classe
borghese-cattolica e il tradimento è quello dei sacerdoti, con il quale viene meno anche il messaggio cristiano.
Con questo racconto inizia la riflessione fra allievo-maestro, madre-figlio, padre spirituale-figlio spirituale, un conflitto ovvero
fra adulto-ragazzo. Si tratta di un Bildungsroman ridotto all’essenziale ed è anche una confessione mancata (il prete non
riesce a confessarsi, perchè impazzito, e ad assolversi e quindi la possibilità di purgarsi è negata. È forse il racconto in cui
l’esperienza di vita di Joyce è “quasi presente”.
AN ENCOUNTER
È un racconto in cui si parla della creazione del carattere di un giovane ed è importante il ruolo della finzione drammatica,
della finzione della letteratura, vista come un gioco, e della trasgressione, tutti visti come strumenti educativi. Il racconto
verte sul problema dell’istruzione dei giovani dublinesi, ma non nel ruolo e della disfunzione della Chiesa (come nel primo
racconto), bensì nel ruolo che la fiction, ovvero la letteratura, ha sulla crescita. La finzione contribuisce alla formazione del
carattere del giovane.
Scritto in prima persona e il narratore è il protagonista, un ragazzino di buona famiglia annoiato dalla routine quotidiana,
dalla scuola e dalle finte battaglie che fa con i suoi amici; lui vuole delle vere avventure e per questo un giorno decide di
marinare la scuola con altri due ragazzi, per andare a fare un giro per Dublino. Anche se uno dei ragazzi non si presenta, il
protagonista insieme a Mahony partono, prendono il traghetto e ad un certo punto incontrano un vecchio (assomiglia ad
Ulisse, con il bastone e gli occhi verdi).
Il signore all’inizio parla molto, fa domande, parla di letteratura erotica, diventa perverso; poi si allontana per masturbarsi
(anche se nel testo non è esplicito). I due ragazzi avevano dato dei nomi falsi (Finzione di ruolo: si tratta di cambiare la
propria identità strumentalmente in base ad una situazione pericolosa).
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
Quando il vecchio ritorna, Mahony, con la scusa che per loro era l’ora di andare, fugge impaurito. Il protagonista, invece, si
impone di affrontarlo e questo confronto con l’alterità serve al protagonista per maturare. Ora i toni del vecchio sono
cambiati e comincia un sermone sul castigo (i giovani devono essere frustati). Il ragazzo ha paura, ma non vuole darlo a
vedere e anche questo rappresenta la maturazione del protagonista.
Alla fine vi è un passaggio di ruolo: il narratore diventa il ragazzo e l’ascoltatore il vecchio; il tono del vecchio si indebolisce,
mentre quello del ragazzo si rafforza.
Il filo conduttore è la trasmissione dei vizi e delle virtù da una generazione all’altra; secondo Joyce, il giovane sognatore di
oggi diventerà il vecchio avventuriero. Si tratta, perciò, del rapporto tra le varie generazioni e della trasmissione culturale,
vista nella prospettiva della fiction, e formazione dei giovani, che non è un percorso facile.
C’è un legame tra il primo e il secondo racconto, la coesione narrativa è perfetta. L’educazione religiosa del primo racconto si
sostituisce con l’educazione letteraria e mentre nel primo la trasmissione della cultura religiosa si interrompe con la morte
del prete, qui si interrompe la scuola per intraprendere un viaggio che termina con la crescita e la maturazione della
coscienza. Questa crescita, però, coincide con un tono di voce del protagonista sicuro ma anche vacillante e questo
sottolinea la sua insicurezza, ovvero la maturazione non è definitiva (è cresciuto ma non in maniera definitiva).
Un altro tema è il rapporto tra peccato e conoscenza, come in tutta la raccolta: l’incontro-scontro con l’alterità produce una
consapevolezza dei propri limiti.
Il fiume è visto come passaggio, il vecchio con il bastone è visto come un messia.
ARABY
Scritto in prima persona, ricorda l’Arabia, ambientazione esotica, ma il titolo inganna perché il testo parla del primo
innamoramento. È un testo molto breve, ma delicato, quasi ‘arabesco’, una tipologia poco leggibile, ricca di dettagli minuziosi
ma realistici ed è quasi una topografia dell’illusione fanciullesca del protagonista.
Il protagonista è segretamente innamorato della sorella del suo migliore amico e vicino di casa, ma non ha il coraggio di
parlare; la pensa, la segue e la spia dalla finestra, quasi in maniera ossessiva. Una sera ha il coraggio di parlare di una fiera
“Araby”, ma lei non può andarci a causa di un ritiro spirituale (la religione = ostacolo); in un atto di spavalderia, che si
connette al secondo racconto, lui promette di andarci e di comprarle un regalo, ma arriva tardi, perché lo zio se ne era
dimenticato e torna a casa tardi, e perciò trova quasi tutti i banchi chiusi. Torna a casa sconsolato senza comprare niente.
Il racconto presenta un movimento duplice di memoria e immaginazione verso la fanciullezza del passato e verso
l’adolescenza/la maturità.
Il ragazzo è proiettato verso il futuro dall’innamoramento, in quanto il primo amore è visto come tramonto della fanciullezza;
attraverso la memoria cerca di trattenere la fanciullezza che però sprofonda nell’infatuazione e perciò si ha il passaggio dalla
fanciullezza all’adolescenza e il simbolo è la finestra semiaperta/che si apre. Alla fine, però, non riesce a compiere l’atto
d’amore che vuole e l’Arabia diventa un bazar chiuso.
Il racconto si apre con un dettaglio realistico, ovvero la mappa di Dublino con vere coordinate geografiche; questo incipit è in
contrapposizione con il titolo, perché “Araby” è sonoro, mentre l’inizio è piatto, in quanto parla della realtà squallida nella
zona nord di Dublino.
Joyce descrive la North Richmond Street, una strada chiusa che ha una casa allontanata dalle altre, ma tutte hanno la
caratteristica della facciata scura.
Si crea, così, un gioco tra:
cecità - visione
luce - ombra
illusione - delusione (il vero soggetto del racconto)
La conclusione rappresenta l’epifania: il vicolo cieco e la casa isolata diventano il paesaggio interiore del protagonista.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
Altri temi importanti sono:
- l’occhio magnetico: lo sguardo penetrante del protagonista attraverso la fessura della
finestra, legato all’illusione-delusione e quindi all’epifania.
- la visione dello sguardo: lo sguardo è fondamentale (a differenza di “An Encounter”,
dove importante era la voce, il dialogo, l’ascolto e lo sguardo
serviva solo per attirare l’attenzione)
Si riprende il tema religioso che sta cadendo; uno dei termini con cui il testo termine è “vanità”, intesa in maniera biblica, che
in ebraico si dice “Hebée”, ‘nebbia’, ‘futilità’, ‘illusione’. Ciò si riferisce alla vanità dell’amore ed infatti alla fine del racconto lo
sguardo del protagonista è rivolto verso se stesso e scopre la sua inutilità ed introietta questa siluette nebbiosa della fanciulla,
diventando la dimostrazione di vanità (aver amato inutilmente).
Questo 3° racconto è la sintesi degli altri due:
Tema del viaggio
1. il ragazzo sogna di andare in Persia, verso l’esotico
2. i ragazzi sognano l’America, un luogo lontano
3. la fuga diventa tema fondamentale perchè già presente nel titolo
(≠ altri temi di sottofondo) - qui è legato al sogno,
all’inammoramento, all’illusione-delusione
Tema dell’immaginazione
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
ADOLESCENCE
EVELINE
Scritto in terza persona. È la scelta mancata della protagonista che è il centro propulsore da cui partono a raggiera i ricordi, le
esperienze, le emozioni. Sono presenti molti flashbacks ed infatti ricorda il passato, immagina il futuro, ma resta bloccata nel
presente (esperienza di tempo chiuso).
Eveline, 19 anni, è seduta alla finestra e progetta la sua fuga dall’Irlanda verso Buenos Aires con il marinaio Frank, il suo
innamorato. Ricorda la sua famiglia e il suo passato di tristezza e violenza: la madre è morta, il padre era violento con i suoi
fratelli, Ernesto, che muore, e Henry, e finisce per minacciare anche lei; inoltre è frustrata dal suo umile lavoro di commessa.
A questi ricordi, però, affianca anche le gioie familiari, ovvero l’amore per la madre; Eveline le aveva promesso in punto di
morte di prendersi cura della famiglia ed è questo che la inchioda davanti alla finestra (è per questo che non partirà, ma
rimarrà seduta inerte e inespressiva).
Prima di partire, tiene in mano due lettere, scritte una al fratello Henry e una al padre, e si lascia cogliere dai dubbi, in
conflitto tra il nido familiare e l’esperienza dell’ignoto. Il ricordo della vita monotona che aveva fatto la madre, però, la porta
a partire, ma quando è insieme a Frank al porto, ripensa alla promessa fatta alla madre e non segue il fidanzato sulla nave;
rimane immobile con una maschera d’indifferenza, mentre Frank è costretto a partire (perchè già sulla nave).
La fine drammatizza la rinuncia della scelta dell’inizio; viene rappresentata la difficoltà di superare il confine tra
interno-esterno, psiche-mondo e la vita di Eveline è inerme, è incatenata tra il dentro-fuori e immaginazione-percezione.
Il vetro della finestra è il correlativo oggettivo del confine tra mondo interiore e gli oggetti del mondo esteriore, è l’ostacolo
tra il mondo della psiche e il mondo esterno. Inoltre, la finestra è il luogo di transito tra chiuso-aperto e metaforicamente tra
passato-futuro.
La funzione della finestra, però, è diversa da:
- la finestra in “The Sisters”: qui è una cornice che dall’esterno si guarda per capire che
succede all’interno
- la finestra in “Araby”: qui è solo uno spiraglio
- la finestra in “The Dead”
→ La finestra di “Eveline” è instransitiva e simboleggia la morte in vita (simbolo psiche)
Eveline è la vittima sacrificata per i valori della famiglia, ma è un sacrificio sterile, ovvero non vero, non desiderato, non
consapevole, perché è stata obbligata alla sua scelta dalla promessa fatta alla madre. Di conseguenza, il sacrificio è
considerato peccato per la vita che si nega.
Mentre in “Araby” lo sguardo è fermo su qualcosa di reale, qui è disperso e distratto, senza un obiettivo, e si perde con gli
altri sensi (es. L’odore della stoffa) ed è epifanico, perchè ricorda qualcosa di diverso ed il presente è diverso dal passato (il
padre non era così cattivo quando la madre era ancora viva).
I primi 3 racconti erano in prima persona, perchè visti dall’interno, in quanto il punto di vista dell’autore non era molto
distante da quello del personaggio. Ora la narrazione è in terza persona, perchè l’ottica è esterna ai fatti e ai personaggi, è
più oggettiva.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
AFTER THE RACE
Se “Eveline” era il racconto dell’immobilità, questo è il racconto dell’azione frenetica.
Scritto in 3 persona, ha uno scenario inedito: una corsa automobilistica a Dublino. Le macchine sfrecciano davanti agli occhi
degli spettatori tutti agghindati: quindi c’è movimento e non paralisi. Il tema, perciò, è la velocità, sia quella reale delle auto,
che quella simbolica, ovvero la giovinezza frenetica, quella che rappresenta il desiderio di velocizzare la vita. La velocità è
un’essenza primaria del romanzo modernista del primo ‘900, dove vi è una costante velocizzazione verso la fine (scrittura tra
le righe).
A differenza di “Eveline” che era un racconto individuale, questo è un racconto corale con molteplici punti di vista.
Si racconta di una serata passata tra un gruppo di amici di nazionalità diverse (francesi, ungheresi, inglesi, americani) che
dopo la corsa vano a mangiare a casa di Jimmy, un pilota. Dopo si recono sullo Jacht dell’americano, dove si ubriacano e
giocano a poker; durante la partita, Jimmy Doyle, irlandese figlio di un macellaio arricchitosi tardivamente, perde tutto il
patrimonio al gioco d’azzardo. (Quando incontra un francese che gli propone di fare affari con lui, il padre è contento ed
organizza una cena irlandese.) All’alba, l’ungherese sveglia tutti dalla sbornia.
Joyce con questo racconto evidenzia l’inferiorità degli irlandesi, quando i vincitori della gara sono tuti stranieri e quando il
gruppo di ragazzi si approfitta dell’irlandese per spillargli tutti i soldi a poker.
Tutto è raccontato in modo ironico e la descrizione:
- ha una visione dall’alto che dal generale arriva al particolare
- vede tutti automobilisti di nazionalità diversa
- i personaggi sono tutti giovani di buone speranze
TWO GALLANTS
Scritto in terza persona con due protagonisti principali: i galanti Corley e Lenehan; la trama, come anche in altri racconti, è
assolutamente inesistente.
I due amici passeggiano per la città, si scambiano opinioni sulla conquista delle donne e parlano di un appuntamento che
Corley sta per avere, la sua ultima conquista, che vuole sposare per poter vivere alle sue spalle. Quando incontra la donna, i
due si danno appuntamento due ore dopo e Lenehan comincia a girare per le strade della città, riflettendo sulla sua
miserevole vita, senza regole e senza un amore, annegata nell’alcool. Quando si rincontrano, Corley mostra all’amico una
moneta d’oro, il pegno d’amore lasciatogli dalla ragazza: la ragazza pur di aiutare Conroy, che è poverissimo, si prostituisce.
Il tema del racconto è il rapporto tra la parola e l’ascolto, è una riflessione sull’atto del raccontare e dell’ascoltare (è Conroy
che parla); i due protagonisti sono figure reciproche, sottolineando la complementarità di parola ed ascolto. Conroy è
narcisista e prepotente, mentre Lenehan è duro d’orecchi.
La situazione finale rappresenta la strumentalizzazione del gesto simbolico della svendita della parola d’amore; la parola è
simoniaca e il testo si incentra sul suo senso di valore.
L’arpa è al centro del racconto = emblema dell’Irlanda feminized (=femminilizzata) e della donna tradita (altro tema, infatti, è
il tradimento).
Il testo presenta un gioco retorico di alternanza fra grande-piccolo, iperbole-litote; è ritenuto, inoltre, anche un racconto
semi-poliziesco, un’inchiesta.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
THE BOARDING HOUSE
Scritto in terza persona, presenta eventi quotidiani che si intrecciano con drammi universali.
La signora Mooney è una donna dal carattere forte, reduce da un matrimonio sfortunato. Gestisce una pensione, frequentata
da una clientela maschile quasi esclusivamente composta da artisti, con la figlia Polly, 19 anni, la quale si innamora di un
cliente, Bob Doran, 35 anni, e che rimane incinta di lui all’insaputa di tutti. All’inizio della tresca la madre fa finta di nulla, ma
alla fine interviene e per salvare la reputazione della figlia, vuole farli sposare; il signor Doran, però, è contrario anche se sa
che non sposandola perderebbe il lavoro e dovrebbe andarsene da Dublino. Il racconto termina con Polly che aspetta la
chiamata della madre, per comunicarle come si sarebbe risolta la situazione.
Il titolo è significativo: “to board” = fare delle avnces sessuali ed infatti la figura della signora Mooney era presente anche in
“Ulisse” dove aveva un bordello.
I temi principali sono: lo sfruttamento, lo spillare denaro e la simonia, presenti anche nel racconto precedente, dove si
trattava di un complotto di due uomini per comprare una ragazza, qui si tratta di due donne che cercano di incastrare un
uomo
La conquista del giovane ha un valore di compensazione per il brutto destino della madre nel matrimonio, che viene
appunto compensato nell’aggiustare la figlia. La proposta fatta al giovane rappresenta la parola d’amore estorta,
mentre nel racconto precedente la parola d’amore era svenduta.
Conseguentemente, altri temi principali sono:
l’accalappiamento della preda attraverso la seduzione femminile
il peccato e la sua riparazione (Doran deve ripagare il suo peccato)
Il nome “Polly” è un nome greco ‘poly’ che significa ‘molto’: molto aperta, molto bella; serve quindi per designare una
ragazza facile.
Il nome “Doran” è un nome gaelico e significa ‘straniero’.
Il racconto è lo studio della vita domestica dublinese e cerca di trovare rimedio all’essere scapoli andando a cercare la
domesticità delle case dublinesi; l’Irlanda, perciò, è vista come una grande maitresse, incarnata qui dalla Madame, la signora
Mooney.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
MATURITY
A LITTLE CLOUD
Scritto in terza persona, è il primo racconto della maturità.
Il protagonista è Little Chandler, un uomo estremamente timido e dall’aspetto fragile; è infelicemente sposato e scontento
della sua vita quotidiana. Lavora come scribacchino in un ufficio legale, un lavoro di routine e non creativo, e mentre è nel
suo ufficio, attende con ansia l’incontro con il suo amico Gallaher, il quale ha fatto carriera come giornalista a Londra. Si reca
all’appuntamento fantasticando su quello che può succedere, ma è abbattuto ed infastidito per la miseria che vede nelle
strade della città. Una volta all’appuntamento, in un ristorante di classe di nome “Corless”, ritrova la felicità; Gallaher gli
racconta tutte le sue avventure e Chandler è un po’ invidioso, perché sarebbe capace di fare meglio, ma la sua timidezza
glielo impedisce (la timidezza provoca in lui frustrazione). Chandler lo invita a cena, ma Gallaher rifiuta perché ha già una
partita a carte con Ignatis; Chandler, rimastoci male, lo esorta a mettere la testa apposto, ma Gallaher vuole prima divertirsi
ancora un po’ e si sarebbe sposato poi solo con una donna ricca. L’ometto ritorna a casa amareggiato e se la prende con il
figlio che comincia a piangere a dirotto; la moglie, dopo aver rimproverato il marito, riesce a calmare il figlio. Il racconto si
conclude con il pianto di rimorso di Chandler.
Si tratta di una piccola tragedia domestica, come una piccola nuvola; i rimandi presenti sono biblici nel personaggio di
Gallaher, che richiama il profeta Elia, nato alla città di Gaalad e anche se la vita dei due è diversa, Gallaher è il prescelto dal
signore.
I temi centrali sono il rapporto tra la scrittura e la vita, ma soprattutto le opposizioni presenti in tutto il racconto (es.
grandezza dell’uomo e il suo opposto).
Il nome del ristorante “Corless” è significativo: è un incontro ‘senza cuore’, in cui Gallaher vince e umilia l’amico.
COUNTERPARTS
Scritto in terza persona. Il protagonista è Farrington, un impiegato addetto alla trascrizione a mano di documenti, dal
carattere iracondo; odio la routine giornaliera (proprio come Chandler).
Mentre è al lavoro, viene rimproverato dal titolare, Alleyne, per non aver finito in tempo un lavoro e gli ordina di consegnarlo
entro la sera stessa; pur preoccupato, esce di soppiatto e va a bere in un pub con degli amici, ma quando torna in ufficio, il
capo si accorge del lavoro incompleto e si infuria. Senza soldi già a metà mese, impegna il suo orologio e con i soldi ricavati va
nei locali, offrendo da bere a tutti; si mostra incline alle avances quando una donna grassoccia in vestito giallo e col un grande
cappello gli sfiora il braccio per sbaglio, ma lei subito chiede scusa e lui si mostra irritato, inoltre, perde due volte la sfida a
braccio di ferro, irritandosi per la sua reputazione di uomo forte ora minata. Torna a casa infuriato e frustrato dalla giornata e
trova il fuoco spento; tutti i figli sono a letto, tranne Tom che gli dice che la madre è in chiesa. Preso da una rabbia cieca,
picchia Tom con un bastone perché aveva permesso che il fuoco si spengesse; il bambino in preda al terrore, lo prega di
smettere in cambio di un Ave Maria per lui.
Questo personaggio è molto diverso da quello di Chandler: Chandler è timido, mentre Farrington è senza autocontrollo.
Rottura del patto: con il contratto di lavoro, la routine si interrompe.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
CLAY
Scritto in terza persona. La protagonista è una piccola donna di una certa età e dai lineamenti marcati (naso e mento lunghi),
Mariah che svolge la professione di lavandaia.
È una donna umile e mite, capace di mettere sempre pace tra le persone, ma allo stesso tempo carente di carattere, per
questo può rappresentare una caricatura della Vergine Maria.
Una sera, dopo aver lasciato il lavoro, si mette in viaggio per andare a trovare Joe, a cui ha fatto da bambinaia da piccolo e a
cui è ancora molto legata. Lungo il tragitto si ferma in una pasticceria per comprare dei dolci per la festa di Halloween. La
ragazza che la serve, indisposta dall'incertezza di Maria su cosa comprare, le chiede se stia per caso scegliendo una torta
nuziale, ironizzando sulla condizione di nubile della donna.
Sul tram Maria viene avvicinata da un gentiluomo ubriaco che le cede il posto e le rivolge qualche parola. Arrivata da Joe,
Maria è calorosamente accolta dalla sua famiglia, ma il suo entusiasmo svanisce quando si rende conto di aver dimenticato
sul tram il plum cake appena comprato, confusa dall'incontro con l'uomo sul tram.
Maria partecipa con un certo imbarazzo a un gioco divinatorio tradizionale della vigilia di Ognissanti: una persona bendata è
chiamata a scegliere tra alcuni piattini contenenti oggetti simbolici. Tra gli oggetti del gioco c'è un anello, che indica un
matrimonio in vista.
La scelta di Maria cade invece su un pezzo di argilla (da cui il titolo originale del racconto, Clay), e tutti nella stanza
ammutoliscono. La moglie di Joe rimprovera una ragazza presente, che ha preparato il gioco. L'argilla infatti indicava morte e
pertanto in epoca vittoriana essa era omessa dal gioco per delicatezza nei confronti dei partecipanti. Tuttavia Maria sembra
non essersi accorta di nulla e procede a una seconda scelta, questa volta un libro di preghiere, che simboleggia l'entrata in
convento. I festeggiamenti proseguono e Maria viene invitata a cantare un'aria operistica. Nel cantare, Maria commette
quello che il testo definisce 'un errore', ma nessuno la corregge: omette infatti un verso che fa riferimento a corteggiatori che
Maria mai ha avuto nella sua vita.
Il racconto si conclude con la descrizione della profonda commozione che Joe attribuisce all'esibizione di Maria, ma che più
probabilmente è dovuta al ricordo dei vecchi tempi, questa dissonanza nella reazione di Joe è palesata dal fatto che stia
cercando il cavatappi, serve a “ridicolizzare” abbassare o ironizzare il motivo della reazione.
A PAINFUL CASE
Scritto in terza persona, il protagonista è un funzionario di banca, James Duffy.
È un tipo strano, paranoico, parla di se stesso in 3 persona; la sua vita è caratterizzata da una routine meticolosa e da pochi
contatti sociali. È appassionato di musica classica e ad un concerto conosce Emily Sinico, una donna sposata e con una figlia. I
due cominciano a frequentarsi e sembra nascere una storia d’amore, ma quando lei si dichiara lui la rifiuta, perché crede che
qualsiasi legame affettivo provochi dolore.
Quattro anni dopo, Duffy legge sul giornale della morte della signora, morta sotto un treno, forse suicida; infatti, dopo la
rottura fra i due lei diventa alcolizzata. Duffy inizialmente è disgustato, perché si rende conto che si era aperto ad una donna
bassa moralmente, ma poi si sente responsabile della tragica fine della sua vita.
Inizia, così, a comprendere la rigidità della sua vita che lo ha condannato ad una paralisi esistenziale; infatti, Duffy sprofonda
nella sua solitudine, rimarrà sempre ai margini della vita, respingerà sempre l’amore.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
PUBLIC LIFE
La vita politica irlandese è centrale in questa sezione insieme alla figura del grande statista Charles Parnéll, un uomo politico
molto attivo che mirava ad ottenere l’autonomia dell’Irlanda e morì per gli ideali di libertà in cui credeva; si fa simbolo, perciò,
dell’Irlanda tradita e traditrice.
IVY DAY IN A COMMITTEE ROOM
Scritto in terza persona, è il primo racconto dell’ultima sezione e per la prima volta si ha un bersaglio nuovo, ovvero il target è
la politica.
È un episodio accaduto realmente e raccontato dal fratello di Joyce, i cui racconti non sono solo fiction, ma anche esperienze
vere; vi è quindi la rielaborazione di esperienze dirette.
L’ambientazione è una stanza ma illuminata sopra ad un bar e riscaldata solo da un fuoco di un camino; la scena accade il 6
ottobre, una giornata fredda e piovosa.
C’è una maggiore coralità: una serie di personaggi che vanno e vengono durante una campagna elettorale, dove si parla di
politica e pettegolezzi
I personaggi sono 6:
Jack: vecchio custode del quartier generale del candidato nazionalista Tirney come sindaco comunale
il signor O’Connor (giovane butterato)
il signor Henchy
il signor Crofton
il signor Lyons
il signor Hynes: rimasto fedele a Parnéll.
La giornata è l’anniversario della morte di Parnéll: egli si allontanò dalla politica e venne accusato di delitti politici; fu
scagionato, ma riaccusato di adulterio con una donna sposata e allontanato definitivamente.
C’è il tema del tradimento (lui tradito dalla sua stessa patria), attraverso simboli cristiani; la figura di Parnéll ricompare anche
in Ulisse, dove Joyce lo definisce “il Messia non incoronato d’Irlanda”.
La conversazione tra Old jack e O’Connor, vista in maniera naturalista, delinea lo scenario simboli; il vecchio parla della
difficoltà del rapporto con il figlio e quindi viene riproposto il rapporto vecchia-nuova generazione. Il giovane si fa una
sigaretta arrotolando il volantino elettorale, e questo simboleggia che si fa cenere della politica.
Nella stanza arriva un giornalista, che denuncia l’opportunismo politico dei personaggi eletti, e successivamente entra un
prete, ma esce subito.
Tutti sono d’accordo su una cosa: bisogna bere ed infatti si aspetta da bere e notizie dal candidato; il pettegolezzo annulla
l’azione politica.
Alla fine arriva il barista, ma inizia un’odissea per trovare il cavatappi (situazione ironica) e si finisce per aprire le bottiglie di
birra scaldandole al fuoco del camino, con il suono “pock” che risuona nell’aria.
Presto arriverà in visita il re inglese Edoardo VII, considerato vivace con le relazioni con le donne; il padre, il principe Filippo,
era morto di crepacuore, mentre la madre lo ripudia.
Alcuni sono convinti che il suo arrivo in città potrebbe causare alcuni problemi a causa delle manifestazioni nazionalistiche,
ma Henchy difende il re per motivi economici.
È presente qui una distorsione: a Parnéll non è stato perdonato nessun errore, mentre viene difeso il re.
Il racconto si conclude con il signor Hynes che entra e legge una poesia in onore di Parnéll, applaudito da tutti.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
Il titolo è un contrasto simbolico:
edera: è sempre verde ed è un simbolo di forza e rinascita; questo vuol dire che con Parnéll l’Irlanda potrebbe
rinascere
stanza del comitato: fumosa e fredda e rappresenta il luogo del tradimento.
C’è un’opposizione fra scrittura, ripetitiva e morta, e parola, viva e appassionata (come la recitazione della poesia per Parnéll)
La descrizione della parete: rimanda al mito della caverna di Platone, dove gli uomini sono prigionieri nella caverna e
preferiscono la finzione alla teoria.
Il tema più importante è l’inutilità del sacrificio di Parnéll e anche della sua memoria, perchè la celebrazione viene riassorbita
in questo squallido luogo. Parnell è presente come idolo e come fantasma e le storie che lo riguardano sono i temi di fondo,
insieme alla svalutazione della politica e all’era della pubblicità.
A MOTHER
Scritto in terza persona ed inizia con un nome, Hoppy Holohan, che caratterizza il personaggio, impresario di un’associazione
nazionalista: il cognome deriva dal gaelico ‘Huallach’ e significa “proud”, ‘orgoglioso’, mentre uil soprannome definisce un
difetto fisico (si tratta di un vecchio zoppo e orgoglioso). I protagonisti sono la signora Kearney e la figlia Kathleen, il cui nome
ricorda quello dell’eroina irlandese, Kathleen Honliham, simbolo del nazionalismo iralndese; è, perciò, la personificazione
dell’Irlanda sotto la forma di una pura e anziana donna, rappresentata con l’arpa.
Il contesto sociale è la borghesia nazionalista cattolica e i temi principali sono:
- l’amore per la musica ed il canto
- il nazionalismo
- l’impegno per conservare la lingua e la cultura irlandese
Mrs Kearney ha maniere altezzose e vuole che le figlie abbiano la sua stessa educazione. Quando Katheleen inizia a lavorare
nell’ambiente musicale, lei le fa da manager; durante, però, una festa di celebrazione degli ideali nazionalistici in cui la figlia
deve cantare, la madre ritarda l’entrata in scena perché Katheleen non è ancora stata pagata. Mrs Kearney comincia a
minacciare gli organizzatori e finisce per tornare a casa con la figlia, pregiudicandole, così, una promettente carriere di
cantante e trascinandola in una fine tragica.
I nomi in Joyce sono molto significativi: il cognome della madre era O’Catharnagh = ‘vittorioso’ (strano per definire la madre);
in ogni caso, i nomi significanti simboleggiano:
- la capacità imperfetta (zoppicante)
- il sacrificio della figlia
- il carattere guerriero della madre
Il dialogo è il tipo di narrazione che prevale; le varie voci compongono una polifonia, ma poi si sovrappongono e perdono
armonia ed efficacia. La parola di ciascuno è metaforicamente attraversata dalle intenzioni altrui - sillogismo- e quindi
intenzioni e voci entrano in conflitto (le voci sono annullate dalle intenzioni altrui). Il dialogo si carica di tensioni e alla fine
sfocia in un litigio tra Mrs kearney e Hoppy Holoham.
Il dialogo è anche tra i vari generi letterari e generi di discorso, oltre all’azione comunicativa effettiva tra i personaggi; c’è un
dialogo anche tra le voci narranti: al narratore esterno, extradiegetico in 3 persona si sovrappone spesso la voce di Mrs
Kearney, un narratore invece interno.
A livello retorico domina l’ossimoro, che caratterizza soprattutto Mrs Kearney: ad es. ad un certo punto appare come una
figura in movimento ma pietrificata e dalla rabbia che la pervade viene definita come un’immensità di pietra arrabbiata
(ossimoro). L’ossimoro portante, però, è la passione sterile della figlia, che alla fine non porta a nulla.
Inoltre, è presente un’esclation emotiva che dona suspance all’intero racconto.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
GRACE
Scritto in terza persona, ha una continuità con il racconto precedente e funge da racconto di chiusura, da cornice dell’intera
raccolta insieme a “The Sisters”.
Paradossalmente al titolo, il racconto inizia con una disgrazia, ovvero con una caduta, sia fisica che morale: un uomo, dopo
aver bevuto molto, cade giù dalle scale di un pub e si taglia la lingua perdendo i sensi.
Un suo amico, il signor Power, lo trova lì, gli rivela di chiamarsi Tom Kernan e lo riporta a casa da sua moglie. Kernan è un
venditore che un tempo possedeva un fascino e bei modi, poi è caduto nell'alcolismo.
Una ferita alla lingua causata dalla caduta costringe Kernan a letto.
Due giorni dopo, viene visitato dai suoi amici Power, M'Coy e Cunningham; gli amici hanno architettato un piano per far
assistere Kernan ad un ritiro spirituale con loro; i quattro discutono per un po' di alcune questioni e poi parlano di religione.
Gli amici parlano di un ritiro confessionale in una chiesa di gesuiti, poi invitano anche Kernan, al quale l'idea non va subito a
genio.
La conversazione dimostra una conoscenza superficiale della fede, e gli amici fanno molti errori comici sulla storia della
Chiesa. La scena si sposta alla Chiesa dei gesuiti in Gardiner Street, dove tutti stanno ascoltando il sermone di un prete.
Oltreché superficialità, il prete rivela nel suo discorso il lassismo morale tipico d'ogni gesuita: nella sua predicazione dal
pulpito egli ribadisce, infatti, la possibilità di salvazione anche per i peccatori.
La fede subisce quindi una svalutazione totale nel discorso del gesuita, ridotta a merce "popolare", accessibile a tutti.
Come la salvazione, così pure la Grazia viene degradata, dimodoché anche l'alcolizzato più accanito può dire di credere.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
lOMoARcPSD|7922014
THE DEAD
Parte altamente autobiografica e la presenza di Joyce è palpabile nel protagonista. GABRIEL CONROY è una proiezione
dell’autore e rappresenta la tipologia d’uomo che Joyce sarebbe diventato se fosse rimasto in Irlanda → Il testo, perciò,
inaugura il metodo modernista dell’autobiografismo estetico, che sublima il dato autobiografico ed estranea
l’autorappresentazione, ma lo proietta in una dimensione artistica attraverso le maschere (in questo caso di Gabriel).
Il racconto può essere suddiviso in 5 sezioni:
1. arrivo di Gabriel a casa delle zie e il party
2. cena con tutti i personaggi
3. partenza degli ospiti
4. il viaggio: il tragitto in carrozza da casa delle zie all’Hotel di Gabriel e Gretta
5. scena finale in camera da letto con Getta e Gabriel
La vicenda si svolge nel periodo natalizio, a casa delle signorine Workau che vivono con la nipote Mary Jane. I protagonisti
sembrano dei morti viventi, in quanto parlano sempre del passato, dei ricordi, contribuendo a creare quella solita atmosfera
di paralisi.
Solo il personaggio di Miss Ivors agisce, andandosene dopo una discussione con Gabriel; anche Gabriel vorrebbe andarsene
da quella casa, ma purtroppo è legato alla tradizione e perciò quello che prova dopo la festa è “I’m sick of this country”.
Gabriel ha una preparazione culturale superiore a tutti gli altri e per questo si sente superiore; il discorso che fa durante la
cena, infatti, è adatto al pubblico ma non è quello che sente lui, tanto che infatti aveva deciso di cambiare una citazione
perché credeva che l’ignoranza degli ospiti non l’avrebbe capita.
Ad un certo punto, Gabriel rimane solo con la moglie, ascoltando una canzone celtica e durante il tragitto di ritorno lui è in
preda al desiderio erotico, ma Gretta è distante.
Nella parte conclusiva, Gretta ricorda un giovane, Michael Fury, che morì per lei e quindi Gabriel, in preda alla gelosia, capisce
che lei non l’ha mai amato (climax). Gabriel guarda fuori dalla finestra mentre nevica (evasione) e tutte le cose intorno a lui
sembrano morte → rappresentano la paralisi dublinese.
La neve è il simbolo del rapporto con il mondo: tutto bianco, annulla l’identità. Il tema è sì la paralisi, ma anche la rinascita,
perchè la neve sciogliendosi diventa acqua, simbolo di vita.
Micheale e Gabriel sono due nomi con riferimenti cristiani di due arcangeli:
Michael: giudizio universale (acqua - passato)
Gabriel: annunziazione (fuoco - presente)
La riconciliazione è il fuoco che scioglie la neve (Joyce amava il paradosso).
Dubliners iniziava con un bambino che guardava da fuori la finestra e finisce con un adulto che fa il contrario, ovvero
guarda da dentro la finestra.
Downloaded by Vittoria Grillo (vittoria.grillo@liceomontaleroma.it)
Potrebbero piacerti anche
- Virginia Woolf Appunti PDFDocumento10 pagineVirginia Woolf Appunti PDFValeria CutoloNessuna valutazione finora
- Riassunto Da Ovidio A TacitoDocumento3 pagineRiassunto Da Ovidio A TacitoGiuseppe TerzoNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento15 pagineLeopardiVito Di VirgilioNessuna valutazione finora
- Manzoni, Le TragedieDocumento2 pagineManzoni, Le Tragedielu2deNessuna valutazione finora
- Gabriele D'AnnunzioDocumento3 pagineGabriele D'AnnunzioSimona MagrìNessuna valutazione finora
- Italo SvevoDocumento7 pagineItalo SvevoOftalmo StataleNessuna valutazione finora
- TesinaDocumento31 pagineTesinaGiacomo IavaroneNessuna valutazione finora
- Ermetismo, Ungaretti e MontaleDocumento12 pagineErmetismo, Ungaretti e Montalejoaoguilhermepaiva100% (1)
- VergaDocumento10 pagineVergaRebecca CaggiariNessuna valutazione finora
- Tesina Su Italo SvevoDocumento5 pagineTesina Su Italo SvevoFrancescoNessuna valutazione finora
- Enzo Noè Girardi - La Struttura Dualistica Dei Promessi Sposi PDFDocumento3 pagineEnzo Noè Girardi - La Struttura Dualistica Dei Promessi Sposi PDFPietro_V100% (1)
- Età Dei FlaviDocumento22 pagineEtà Dei FlaviMattia SantilliNessuna valutazione finora
- Giovanni PascoliDocumento2 pagineGiovanni PascoliConCy MaCcNessuna valutazione finora
- Verga e LeopardiDocumento4 pagineVerga e LeopardioolongNessuna valutazione finora
- Romanzo Storico e Promessi SposiDocumento30 pagineRomanzo Storico e Promessi SposiMerloNessuna valutazione finora
- Saba, Ungaretti, Montale, Gadda, Calvino RiassuntoDocumento7 pagineSaba, Ungaretti, Montale, Gadda, Calvino RiassuntoAlessandro FalcettaNessuna valutazione finora
- VERGADocumento6 pagineVERGABenedetta PiliaNessuna valutazione finora
- Schema DellinfernoDocumento2 pagineSchema Dellinfernolucrezia iacobazziNessuna valutazione finora
- Montale Riassunto Letteratura Italiana ContemporaneaDocumento5 pagineMontale Riassunto Letteratura Italiana ContemporaneaGiacomo Milone100% (1)
- Dannunzio SintesiDocumento5 pagineDannunzio SintesixarenwoNessuna valutazione finora
- Poetica PirandelloDocumento18 paginePoetica PirandelloDavide ColottiNessuna valutazione finora
- Antonio Gramsci (Mustè)Documento10 pagineAntonio Gramsci (Mustè)Lorenzo CognettiNessuna valutazione finora
- Leop SintesiDocumento4 pagineLeop SintesixarenwoNessuna valutazione finora
- VergaDocumento8 pagineVergailary__94_57523284Nessuna valutazione finora
- PinocchioDocumento9 paginePinocchioMaddalena TintiNessuna valutazione finora
- La ScapigliaturaDocumento2 pagineLa Scapigliaturariccardo0% (1)
- Stile Seneca TaciToDocumento4 pagineStile Seneca TaciToAEHNessuna valutazione finora
- PascoliDocumento5 paginePascoliflory73Nessuna valutazione finora
- Domande Su SenecaDocumento4 pagineDomande Su Senecamarco2300100% (1)
- Dannunzio Sint PDFDocumento5 pagineDannunzio Sint PDFHibinoNessuna valutazione finora
- Svevo SchemiDocumento9 pagineSvevo SchemiFrancesca MelisNessuna valutazione finora
- Verga 'ClassicoDocumento6 pagineVerga 'ClassicoArianna CalabrettaNessuna valutazione finora
- Il Romanzo Storico in Lingua ItalianaDocumento5 pagineIl Romanzo Storico in Lingua ItalianaMichele MazzieriNessuna valutazione finora
- Poetica MontaleDocumento3 paginePoetica MontaleSilvia GreenNessuna valutazione finora
- Interrogazione Di Italiano L. OPEREDocumento14 pagineInterrogazione Di Italiano L. OPEREMcd ColombiaNessuna valutazione finora
- Italo Svevo Riassunto AutoreDocumento4 pagineItalo Svevo Riassunto AutoreStefanoMologni100% (1)
- 13 DecadentismoDocumento11 pagine13 DecadentismojacoptNessuna valutazione finora
- TACITODocumento4 pagineTACITOCarolina CorteseNessuna valutazione finora
- SenecaDocumento5 pagineSenecaFederico ToffoliNessuna valutazione finora
- Persio e GiovenaleDocumento5 paginePersio e GiovenaleMarco S BoffoliNessuna valutazione finora
- Giovenale, Marziale, Plinio Il Vecchio, Quintiliano, Plinio Il Giovane, SvetonioDocumento13 pagineGiovenale, Marziale, Plinio Il Vecchio, Quintiliano, Plinio Il Giovane, SvetonioTomasoNessuna valutazione finora
- Leopardi SSLAZIO8Documento9 pagineLeopardi SSLAZIO8Valentino MasiNessuna valutazione finora
- Lirici GreciDocumento5 pagineLirici GreciGiorgio OttolinaNessuna valutazione finora
- Il - Verismo Di Verga Con Rispetto Alla Questione Del MeridioneDocumento20 pagineIl - Verismo Di Verga Con Rispetto Alla Questione Del MeridioneTrillina Gira MondoNessuna valutazione finora
- La Germania Di TacitoDocumento1 paginaLa Germania Di TacitoMorgause2011Nessuna valutazione finora
- SenecaDocumento5 pagineSenecaAdriano DionisiNessuna valutazione finora
- Mastro Don Gesualdo AnalisiDocumento4 pagineMastro Don Gesualdo AnalisiLucyNessuna valutazione finora
- La ScapigliaturaDocumento4 pagineLa ScapigliaturaAnonymous kieQreiPZNessuna valutazione finora
- Montale (Sintesi)Documento4 pagineMontale (Sintesi)nicolasgueraNessuna valutazione finora
- 0 - Svevo - Inetto, Senilità e Una VitaDocumento3 pagine0 - Svevo - Inetto, Senilità e Una VitaNicolaNipolinoNessuna valutazione finora
- Manz Sintesi PDFDocumento6 pagineManz Sintesi PDFHibinoNessuna valutazione finora
- La ScapigliaturaDocumento3 pagineLa ScapigliaturaLeonardo MeggiolaroNessuna valutazione finora
- PirandelloDocumento15 paginePirandelloLucas FaillaNessuna valutazione finora
- TacitoDocumento9 pagineTacitoHibinoNessuna valutazione finora
- Opere Di VergaDocumento10 pagineOpere Di VergaAndreaNessuna valutazione finora
- Decadentismo, D'annunzio e PascoliDocumento7 pagineDecadentismo, D'annunzio e PascoliLO FARO GIUSEPPENessuna valutazione finora
- Alcione (Terzo libro delle "Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi")Da EverandAlcione (Terzo libro delle "Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi")Nessuna valutazione finora
- La Profezia Di Ratzinger Sul Futuro Della Chiesa - Dicembre 1969Documento2 pagineLa Profezia Di Ratzinger Sul Futuro Della Chiesa - Dicembre 1969fesousacostaNessuna valutazione finora
- 08 IndiosDocumento4 pagine08 IndiosAnna CastoldiNessuna valutazione finora
- Una Fuga in Egitto Di Ambrogio Figino inDocumento21 pagineUna Fuga in Egitto Di Ambrogio Figino inMauro PavesiNessuna valutazione finora
- Atto Preventivo e Atto Attuale. I Giri Dell - AnimaDocumento6 pagineAtto Preventivo e Atto Attuale. I Giri Dell - AnimavaleNessuna valutazione finora
- Opere Rudolf Otto Lxxvii (2009)Documento436 pagineOpere Rudolf Otto Lxxvii (2009)rodericuignatiusNessuna valutazione finora
- Le Campane Di Uggiate e Ronago - Bollettino ParrocchialeDocumento32 pagineLe Campane Di Uggiate e Ronago - Bollettino ParrocchialeLeCampaneNessuna valutazione finora
- Arte BizantinaDocumento4 pagineArte BizantinaAlessandro BiasilloNessuna valutazione finora
- Saluto Del Vecchio Priore, e Del NuovoDocumento2 pagineSaluto Del Vecchio Priore, e Del NuovoVito CassoneNessuna valutazione finora
- Mese Di Maggio Di Don G.TomaselliDocumento62 pagineMese Di Maggio Di Don G.TomaselliAGR LUCIANO CIROLLANessuna valutazione finora