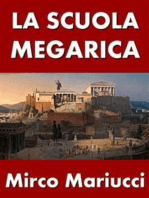Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
L'apparire Delle Cose-Giuseppe Potenza
Caricato da
Massimo ZambelliCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
L'apparire Delle Cose-Giuseppe Potenza
Caricato da
Massimo ZambelliCopyright:
Formati disponibili
L’APPARIRE DELLE COSE
INTRODUZIONE
L’apparire delle cose corrisponde all’espressione di un’ambivalenza
insuperabile, destinata a ripresentarsi con continuità nell’itinerario non
lineare che porta dall’antichità greca fino al pensiero moderno e
contemporaneo. Questo non per fingere che siano molte le cose che
mancano allo studio della questione. Però, forse oggi più che mai, ci si
deve interrogare su quel fenomeno complesso che è l’apparire delle cose.
Non interessa qui ricercare le forze o le qualità che stanno oltre l’apparire
delle cose. Non si vuole cioè individuare un ordine, una forma in ciò che
appare, in ciò che è oggetto della percezione sensibile. Per dirla con Kant,
la differenza tra intellectus archetypus e intellectus ectypus non definisce
l’opposizione tra cose reali, ma solo il raggio e il valore degli specifici
strumenti conoscitivi umani. Ciò che la metafisica tradizionale attribuiva
alle cose in quanto tali si dimostra essere un elemento necessario nel
processo di oggettivazione. Non ci si rivolge qui alla pura fatticità delle
cose, ma al mondo di simboli che caratterizza l’attività dell’uomo, dove
nasce non tanto il problema dell’oggettività dell’esistente, quanto piuttosto
dell’oggettività del significato. Ogni cosa rinvia ad un’interiorità, la
necessità delle leggi alla libertà di una forza originariamente creativa, ogni
cosa appare piuttosto determinata dall’interiorità e quindi come elemento
di un ordine quasi teleologico. Non c’è, nella coscienza, uno strato iletico
anteriore al significato, perché ogni fenomeno appare secondo una
determinata modalità di visione delle cose, secondo un determinato ordine
simbolico che gli conferisce senso.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 1 di 87
IL BELLO
Omero e Tucidide
In un quaderno scritto nel 1942, poco prima di morire, Simone Weil
sosteneva che tutte le volte che si riflette sul bello , si finisce contro un
muro. Tutto ciò che è stato scritto sull’argomento è insufficiente. Anche
oltre l’affermazione della Weil, si può sostenere che il giudizio sul bello
portato avanti dalla filosofia a partire da una riflessione che voglia far
emergere i problemi fondamentali legati al tentativo di definizione del
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 2 di 87
bello sia solo l’inizio della questione. Evidentemente, il rimando al muro
sottintende il fatto che, durante tale itinerario, la via sia bloccata, il pòros
si esprime come a-porìa. Un primo passo, ancora insufficiente per
superare il blocco, ma allo stesso tempo necessario per cominciare, è
individuato dalla stessa Weil, quando evidenzia che non si può concepire il
bene senza passare per il bello. Secondo la Weil c’è una suggestione di
ricerca, più che un canone metodologico, di cui si tasterà la correttezza:
indagare sui nessi che legano la nozione di bellezza ad una moltitudine di
lemmi che non necessariamente vi corrispondono, e a volte ne divergono
radicalmente. Per ricostruire anche solo in modo sommario la genealogia
storico-concettuale della nozione di bellezza, è necessario risalire ad alcuni
documenti letterari antichi, nei quali appare per la prima volta il termine
kalòs. Già in Saffo si trova l’espressione kàlan selànnan, in un frammento
molto intenso: le stelle intorno alla luna bella che nuovamente celano il
bell’aspetto ogni volta che, piena, risplende sulla terra intera. Il contesto
esprime l’equivalenza tra i due aggettivi lunari, e quindi il fatto che essa
possa dirsi bella non esteticamente, ma piuttosto perché pléthoisa, cioè
piena. Ciò vuol dire che quella luna può dirsi bella, perché è piena, perché
è compiuta. Un contesto analogo si trova, sia pur indirettamente, anche in
altri due frammenti saffici, dove la bellezza è in rapporto all’eros, ossia
quando il venir meno della bellezza, dovuto alla vecchiaia, è rappresentato
come un processo di perdita graduale della pienezza giovanile:
l’ineluttabilità dell’incanutirsi dei capelli. Insieme a tale aspetto della
bellezza nel mondo antico, già in Omero inizia a definirsi un tema che
verrà svolto in pieno in Erodoto e Senofonte, cioè la relazione tra il bello e
il buono. Si osservi, tuttavia, che, in particolare nell’Iliade, si trova
l’unione casuale, se non la contrapposizione, tra bello e buono. Ancora più
netta è l’opposizione tra bello e buono in Paride: sebbene sia éidos àriste,
nobile d’aspetto, egli è anche dispari, un disgraziato: sarebbe stato meglio
per lui non essere nato, o perlomeno non essersi mai sposato.
L’opposizione tra la bellezza e il coraggio si ritrova anche nelle parole di
Glauco ad Ettore, quando lo definisce di nobile aspetto ma vile. Nei poemi
omerici, non compare quindi ancora netto il nesso tra la bellezza e la
bontà, anche se è indubbio che, quando si parla di Achille, ciò che è
valorizzato è la sua andréia, la sua mascolinità, più che altre qualità
morali. Il grado ultimo della bontà è l’àristos, ma non quella dell’animo,
ma quella del corpo: la forza, la potenza, il coraggio, la nobiltà fanno
anche la bellezza. Parlando ancora di Omero, si ritrova il termine kalòs
utilizzato anche in altre due accezioni, in ogni caso non riconducibili
all’estetica. Bella è, infatti, anche un’impresa che genera qualcosa di utile,
e bello è anche ciò che è conveniente, come ascoltare chi parla senza
interromperlo, cioè anche chiedere qualcosa all’ospite, solo dopo che a lui
si è permesso di ristorarsi con il cibo che gli è stato offerto. Il termine
kalòs riappare in un’accezione simile a quella saffica anche in un contesto
lontano nel tempo dalla poetessa di Lesbo, cioè nell’epitàphios lògos,
pronunciato da Pericle nella Storia del Peloponneso di Tucidide. Da una
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 3 di 87
parte, infatti gli ateniesi amano ciò che è bello nella sua pienezza, mentre
dall’altra amano la conoscenza senza debolezza. Come si sa bene, nella
formulazione di Tucidide si riassumono gli ideali fondamentali della
cultura ateniese, fondata su due forme, collegate tra loro, di philìa: l’amore
per il bello e l’amore per la conoscenza. Per ciò che concerne questo
secondo aspetto, si osservi, sia pure di sfuggita, che l’uso del verbo
philosophéin, nel contesto di un discorso per i caduti in guerra, conferma
ciò che dovrebbe essere noto, e che invece a volte è omesso dagli studiosi.
E cioè che, fino a tutto il V secolo, non si trova mai un’accezione tecnica
di philosophia, che si ritrova invece nei Dialoghi platonici. Ma più
interessante, perlomeno per la questione qui dibattuta, è concentrarsi su
quella parte del discorso, nella quale si menziona la philokalìa ateniese,
ossia l’amore per il bello. L’amore per il bello è inscindibile dall’euteléia,
da una qualità che è spesso tradotta con senso della misura. In realtà,
teléios significa compimento, cosicché euteléia vuol dire buon
compimento, e quindi pienezza. Si può quindi sostenere che, così come
l’amore per la cultura è legato all’assenza di debolezza, allo stesso modo si
può parlare di amore per il bello, solo se ciò è legato a quel buon
compimento, di cui parla l’euteléia. Insomma, anche in questo contesto la
bellezza definisce lo stato di pienezza, così come la luna saffica è bella
perché è piena. Ma il lògos epitàphios di Tucidide permette di sviluppare
anche un’altra argomentazione, legata alla questione qui dibattuta.
L’orgoglio ateniese di sentirsi superiori agli altri greci, è fondato
soprattutto sul possesso di talune qualità, che hanno il loro acme
nell’areté, cioè nel valore e nella gloria ottenuti con la morte in battaglia.
Ciò vuol dire che le due forme di amore, esaltate come segni di
riconoscimento della grandezza ateniese, rimandano a un orizzonte etico,
più che a definizioni estetiche. Ne segue che, pur definendosi in forme
diverse, l’amore per il bello, e l’amore per la conoscenza, appartengono a
quella stessa tipologia di valori, a cui appartiene to andréion. L’amore per
il bello degli ateniesi non concerne un atteggiamento estetizzante, che non
si confaceva a coloro che aspiravano fondamentalmente al kléos, la gloria,
ottenuta con la morte in battaglia. I due amori ateniesi esprimono lo stesso
atteggiamento, teso alla tutela della pienezza. Si può meglio comprendere,
sotto tale riguardo, ciò che potrebbe altrimenti sembrare stupefacente,
ossia perché nell’epitaffio di Pericle l’indicazione delle due forme di
amore sia accompagnata da talune precisazioni che ne definiscono il
significato, circoscrivendolo con cura. Mentre, infatti, l’amore per la
conoscenza si manifesta àneu malachìas, e quindi senza debolezza, poiché
non sarebbe confacente a chi affronta con coraggio la difesa della patria,
anche l’amore per il bello si rifà allo stesso modello, è coerente con tale
ideale. Non corrisponde, quindi, con una concessione alla degustazione di
forme privilegiate, ma è piuttosto un amore finalizzato, che interiorizza un
fine specifico, non in contraddizione, ma piuttosto in coerenza con gli
austeri valori di chi aspiri alla gloria della morte in battaglia. Di qui
l’ineluttabilità delle precisazioni di Tucidide: teso a garantirsi la gloria, la
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 4 di 87
luce promessa a coloro che siano pronti a sacrificarsi per la patria, il
cittadino ateniese è anche mosso da talune forme d’amore che non sono
divagazioni, rispetto a tale fine, ma sono piuttosto manifestazione della
stessa virtù. Del resto, le precisazioni di Tucidide, per definire quale sia la
natura degli amori ateniesi, si addicono anche ad un altro, e forse più
interessante, tipo di considerazioni. Seguendo letteralmente l’epitaffio,
infatti, si può affermare che ciò che è tipico degli ateniesi è che essi non
amano il bello in sé, ma solo se è accompagnato da un buon fine. Dove
l’accento è posto sul buon compimento, più che sull’amore per il bello.
Ciò che infatti distingue gli ateniesi dagli altri greci, e che ne consacra la
superiorità, è il modo specifico con cui si manifesta tale amore. Un modo
che, evidentemente, esclude che il bello sia qualcosa che possa essere
amato in sé, perché, al contrario, esso comporta una forma d’amore che
rechi in sé la necessità di un fine, senza il quale l’amore per il bello non
potrebbe essere inserito nei valori tipici che distinguono gli ateniesi dagli
altri greci. Come già in Saffo, anche secondo Tucidide bello è qualcosa a
cui non manca niente, così da racchiudere anche un fine, verso cui è
diretto. Le due forme d’amore citate da Pericle articolano, definendolo, un
atteggiamento più generale, che ha il suo centro nell’esaltazione della virtù
guerriera. A sua volta tale virtù non può essere accomunata a un abito, o in
ogni caso ad una qualità fissa. Kalé, intensivamente bella, è la morte in
battaglia, è morire difendendo la patria. Ci si ritrova, a tal riguardo, in una
delle concezioni al tempo stesso più tipiche, e per molti aspetti
stupefacenti, della cultura greca, secondo la quale tra le tante cose alle
quali si possa riservare il termine bello un posto notevole va conferito alla
morte. Una prima testimonianza di tale concezione è presente in Omero, in
un passaggio interessante, oltre che eloquente, dell’Iliade dove afferma
che quando muore un giovane in battaglia gli si addice tutto ed è bello in
tutto ciò che si vede in lui. Ma un documento notevole, anche se in
apparenza indiretto, si trova anche in un passaggio delle Storie di Erodoto.
Avendo lasciato il suo paese, Solone va in Egitto presso Amasi e poi
anche a Sardi da Creso. Tutto era splendido e fastoso. Dopo che Solone
vide e osservò le ricchezze di Creso, quest’ultimo gli chiede se ha
conosciuto l’uomo più felice del mondo. Solone, non scadendo nella
cortigianeria, e restando aderente alla verità, rispose che lo aveva
conosciuto, e che si chiamava Tello ed era ateniese. Tello aveva avuto figli
belli e buoni e vide rimanere in vita i suoi nipoti. A Tello, quindi, sarebbe
stata risparmiata la dolorosa esperienza di sopravvivere alla morte di un
figlio. Non come successe a Pericle. Oppure ad Anassagora. Ritornando a
Tello, il primato che gli attribuisce Solone si spiegherebbe col fatto che
essendo gli ateniesi in battaglia a Eleusi contro i loro vicini, egli, avendo
costretto i nemici alla fuga, morì nel modo più bello. Come evidenzia
Jean-Pierre Vernant, rifiutando la lunga vita, e al tempo stesso dandosi alla
guerra, alla morte eroica, l’eroe tenta di garantirsi lo statuto di morto
glorioso perché non c’è altro modo, per un mortale, di inscrivere il proprio
nome nell’eternità, le proprie imprese, la propria vita nella memoria
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 5 di 87
futura. La felicità consta di due aspetti in apparenza umili, come il morire
prima della propria discendenza, e l’ottenimento della bella morte, quella
che si può avere per sé morendo in difesa della patria. Ancor prima che si
definisca la tradizione dei lògoi epitàphoi, come quello di Pericle
tramandato da Tucidide, sono i poeti a cantare la bellezza della morte,
quando essa venga in battaglia: è onorevole combattere i nemici, difendere
la terra, la famiglia. La morte verrà quando le Moire la fileranno. La morte
è bella quando il coraggioso muore per la patria. Come recita un’antica
gnòme, e poi una tradizione che su di essa si incentra, meglio per l’uomo
sarebbe non essere mai nato, la morte può essere desiderata, e in ogni caso
si può aspirare a che essa sia bella, evitando ciò che della morte è
peggiore. Come sarà confermato da Platone e da Aristotele, bella sarà la
morte ottenuta con gloria in battaglia. Seppur deluso dalla risposta di
Solone, persuaso di poter aspirare al secondo posto, Creso insiste nel voler
sapere chi altri, oltre Tello, debba essere considerato il più felice sulla
terra. Solone risponde Cleobi e Bitone. Essi trasportarono la madre in
processione al giogo al posto dei buoi. La madre pregò che gli si
concedesse la cosa migliore che si possa desiderare. Essi quindi morirono
non risvegliandosi più. Per la divinità è meglio che l’uomo muoia piuttosto
che godersi la vita. Pànta gar kairò kalà. Nella sua icasticità, tale
affermazione definisce un rapporto tra i due termini kalòs e kairòs. Tutto
ciò che è bello accade nel momento opportuno. Un’accezione diversa si
può cogliere in un’altra traduzione, ogni cosa a suo tempo, nella quale
tuttavia manca quel kalà che sta al centro della questione. La gnòme
definisce un nesso, tale per cui l’essere bello non è una qualità assoluta,
ma è piuttosto il corollario di un rapporto con ciò che è opportuno. Per
parlare di bello, esso deve intervenire al momento opportuno. Oltre al
tempo come chrònos, come misura del divenire, come successione lineare,
si parlava anche del tempo come aiòn, cioè come durata, usato per definire
l’eternità divina, il tempo come eniautòs o grande anno, cioè un periodo di
lunghezza variabile, al termine del quale il corso degli eventi ricominciava
daccapo, e infine il tempo come kairòs, termine intraducibile, poiché con
esso ci si riferiva al momento buono, a ciò che si può far corrispondere
con l’attimo immenso, del quale parlerà Nietzsche. Diversamente dalle
altre determinazioni temporali, che rimandano a un’accezione quantitativa
del tempo, il kairòs si rifà a una sfera qualitativa. Il kairòs appare come un
giovane bello, alato, seminudo o giù di lì, con un aspetto che lo rende
inconfondibile, rispetto ad altre possibili rappresentazioni simili. Il kairòs
è l’attimo fuggente che subito scompare. In tale prospettiva, si può
comprendere quali siano le implicazioni del nesso tra bello e momento
propizio. La bellezza è legata a quella specie di momento magico
incarnato nel kairòs. Leggendo al contrario la frase di Sofocle, si potrebbe
sostenere che non ci sia bellezza al di fuori di quella sfera temporale
qualitativa definita col termine kairòs. Racconta Pausania, che all’ingresso
dello stadio di Olimpia c’erano due altari, Hermes e Kairos. Come
evidenziava Callistrato, la bellezza della statua di Kairos la definiva come
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 6 di 87
origine di tutto ciò che è bello, non invecchiando mai. Il contesto
applicativo del kairòs nella Grecia classica racchiude ambiti diversi, dalla
medicina alla politica, dalla strategia alla retorica. Secondo i sofisti, per
esempio, il kairòs stava nella capacità di un oratore di cogliere le
sfumature di un contesto retorico, avvantaggiandosene. Così, per esempio,
il sottotitolo del trattato di Gorgia sulla retorica è Sul kairòs, perché il
sofista pensa che la parola possa liberare una potenza sorprendente, se
adoperata in maniere e contesti opportuni: la parola è una signora potente
che, pur essendo minuta, compie le opere più divine. Così come Ulisse è
polytropos, e cioè capace di usare diversi modi di espressione sulla stessa
cosa, adattandosi ai contesti, allo stesso modo polytropos dovrà essere
anche il medico che sappia cogliere il momento e la forma più opportuni
per la propria terapia. Il kairòs assume così la forma di una conoscenza
che si adatta ai contesti, e assume di conseguenza forme diverse,
rinunciando alla rigidità apodittica dell’epistéme. Che la medicina sia il
contesto applicativo più adatto per il kairòs è confermato anche da
Aristotele, sulla base del riconoscimento della particolarità e della
diversità tra le persone e quindi tra i casi, ognuno dei quali merita una
terapia particolare: ciò che concerne le azioni e ciò che è utile nella vita
non ha nulla di fisso, così come per la salute. Ed essendo di tal fatta la
questione, ancor minore precisione possono avere le questioni particolari;
esse infatti non concernono alcuna conoscenza tecnica e nessuna regola
stabile, ma è necessario che chi agisce esamini l’opportunità dei vari
contesti applicativi, come succede anche nella medicina e nella tecnica di
navigazione. Quale che sia il contesto nel quale si possa definire in modo
adeguato il concetto di kairòs, un punto resta fermo. Ciò che i greci
chiamavano kalòs, e quindi non solo il bello in senso estetico, ma una
nozione complessa, nella quale convergono accezioni e significati diversi,
era concepito in maniera indissolubile dal kairòs. Da una parte, per poter
dire di trovarsi in presenza del bello è necessario che esso accada non in
un momento qualsiasi, definito in modo quantitativo, ma piuttosto in
connessione con quella accezione qualitativa di tempo definita dal kairòs.
Dall’altra, dispiegando le implicazioni della gnòme come appare
nell’Edipo re e in altri contesti, si può sostenere che tutto ciò che
appartiene alla sfera kairologica sia di per sé bello. Tutto questo serve a
ribadire quello che si è detto in precedenza, cioè che nella cultura greca
antica, ma anche in quella classica, la bellezza non è un valore assoluto,
tale da poter essere apprezzato indipendentemente da ogni altro rapporto,
poiché invece essa rimanda ad una particolare sfera temporale, e in
particolare a quel momento opportuno, che sarebbe poi il kairòs. Tutto
questo comporta che, in un certo senso, la bellezza non possa essere
concepita come un dato stabile, inerente a un oggetto, a un volto o a
qualsiasi contenuto visivo, perché essa è al contrario dipendente dal fatto
che tale contenuto si dia alla visione a tempo debito. Quello stesso corpo,
trafitto dalle armi, sfuggirà alla decomposizione, e anzi apparirà bello, se
la sua espressione si darà in quella sfera kairologica che è data dalla lotta
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 7 di 87
per la difesa della patria. Per il greco, più che una qualità estetica, e quindi
inerente al contesto sensibile, la bellezza si manifesta nel suo rimando ad
altro: alla pienezza formale, alle facoltà morali dell’andréia, ossia alle
opportunità di una versione qualitativa del tempo. Eraclito parla della
bellezza che si manifesta con l’apertura di una lotta non componibile.
Potrà succedere che gli uomini non comprendano pienamente in che modo
discordando da se stessi con se stessi concordino, e con questo non siano
capaci di cogliere quell’armonia che da un estremo ritorna all’altro
estremo. Ma il divario tra l’opinione mortale e la conoscenza divina si
esprime anche nel fatto che mentre per la divinità tutte le cose sono belle,
buone e giuste, per gli uomini alcune di esse sono giuste, altre ingiuste.
Come sostiene Eraclito, è migliore l’armonia invisibile, rispetto a quella
visibile. A rivelarsi bello, nei frammenti di Eraclito, non è ciò che è
sensibile, in particolare il visibile, ed è quindi manifesto. Come la natura
ama celarsi, allo stesso modo la bella armonia che segue dallo scontro tra
gli opposti è qualcosa di aphanés, celato alla vista. Si potrebbe sostenere
che la bellezza si possa definire per differenza, rispetto alla sensibilità. Tra
l’VIII e il V secolo alla sua prima apparizione nella tradizione culturale
occidentale, il concetto di bellezza, e più in particolare il termine col quale
essa è indicata in origine, non corrisponde a qualità riconducibili al
contesto della sensibilità, non definisce una facoltà distinguibile, rispetto a
connotati inerenti alla sfera etica. La gamma applicativa del termine bello
è al tempo stesso ampia e differenziata. Bello può essere ciò che è pieno,
ciò che è compiuto, ciò che ha in sé il suo fine. Ma bello è anche il
coraggio, l’atteggiamento virile del guerriero. Tra tutte, l’accezione forse
più precisa della nozione antica di bellezza è quella che ne riconosce
l’appartenenza a quella sfera qualitativa del tempo che si manifesta nel
momento buono del kairòs. Se è bello solo ciò che accade nel kairòs, se la
bellezza è ciò che balena nell’attimo fuggente, allora essa non potrà che
apparire come un evento, più che come un connotato immanente alle cose
che si definiscono belle. Nel mondo greco antico permane a lungo, almeno
fino al IV secolo, la distinzione tra la dimensione del bello e quella
dell’arte, nel senso che il bello preserva un fondamento ontologico, di per
sé non necessariamente implicato nell’ambito dell’arte. In particolare,
rimane preponderante il nesso tra bello e buono, che unisce l’estetica
all’etica. Dal latino tellus, da cui deriva l’italiano bello, si può risalire ad
un diminutivo di bonus. Il fatto che bello non stia per sé, ma piuttosto è ciò
che rimanda ad altro comporta che la bellezza stessa non sia univoca, ma
al contrario si esprima nella sua duplicità.
Amore e bellezza
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 8 di 87
Questo è difficile da capire. Così afferma Platone riferendosi al termine
kalòn, subito dopo aver definito il brutto come ciò che ferma il divenire. Si
osservi che, a conferma del nesso non casuale né irrilevante che, nella
cultura greca antica, lega la dimensione della bellezza a quella della bontà,
il ragionamento platonico sul nesso bello/brutto consegue alla trattazione
della relazione tra vizio e virtù. Nel dialogo in questione, la prima risposta
data alla domanda su cosa sia il bello è che esso sia un soprannome del
pensiero. Questo perché ciò che ha dato nome alle cose e ciò che dà loro il
nome è il pensiero, sia divino, sia umano o entrambi. E come accade per
ciò che è adatto a costruire e a ciò che si presta a curare, dai quali si ha una
costruzione e una cura, allo stesso modo si può sostenere che to kaloùn,
cioè ciò che dà il nome, compie kalà, e cioè cose belle. Ne deriva che il
bello sia una specie di soprannome del pensiero che compie cose di questo
tipo che sono care all’uomo quando dice che sono belle. Le etimologie del
Cratilo non servono a fini filologici, e non presuppongono quindi di
ricostruire l’étymon autentico, essendo teoretico l’interesse che fonda la
ricognizione platonica. Del resto, sicuramente nel caso del termine bello,
ma anche in altri casi, anche se sparuti, la genealogia platonica sembra
meno fantasiosa di quello che si potrebbe pensare. Rileva, infatti, da una
parte il nesso tra il bello e la virtù, e dall’altra lo spunto con il quale il
bello è ricondotto al pensiero, del quale è indicato come eponimo. Kalà
sarebbero quindi le cose in quanto prodotti del pensiero. Ma c’è un
secondo, e non meno interessante, tipo di considerazioni, suggerite dal
passo del Cratilo in questione. La derivazione del bello dal kaléin, e quindi
dal chiamare, si riferisce a un’accezione del concetto di bellezza nuova, e
destinata a trovare sviluppo in altri testi platonici. Essa si identificherebbe,
infatti, con qualcosa che chiama, nel senso che in-voca a sé, attrae oltre i
limiti di una sfera da superare. In tale prospettiva, anche se appena
accennata nel Cratilo, bello è ciò che chiama a superare un limite,
permanendo nel quale l’esistenza resata priva di qualcosa d’essenziale,
non piena. Si è chiamati dal bello, da esso si è con-vocati, e quindi indotti
a procedere oltre i limiti della condizione umana manchevole. La bellezza
può agire come phàrmakon capace di curare ciò che addolora l’esistenza
umana. Del resto, il nesso del Cratilo tra bellezza e pensiero conferma, sia
pure in modo indiretto, ciò che si era accennato prima, e cioè che la
nozione originaria di bello non è riconducibile a un aspetto estetico,
limitato quindi all’àisthesis, alla sensazione, ma si riferisca a un piano più
alto di relazione col reale, poiché coincide, come altro nome, con la
diànoia, e quindi col ragionamento, o meglio col pensiero discorsivo. Si
comprende allora, secondo tale punto di vista, perché Platone si spieghi, e
si esprima in forma più piena, quanto già era balenato nel rimando ai testi
della cultura antica, nei quali la bellezza non è avulsa da un più ampio
contesto etico e ontologico. C’è, infine, un altro aspetto, concernente il
significato originario di bello, sul quale si è concentrata la Arendt. Nel
mondo greco antico, la bellezza presuppone una sfera che va oltre i limiti
dell’òikos, che è quindi altra rispetto a quelle mura domestiche, nelle quali
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 9 di 87
si pensa solo al necessario, rappresentato dalle condizioni materiali di vita.
Per definizione, il bello presuppone la libertà concepita come liberazione
dai bisogni basilari, come possibilità di attingere il centro della polis,
quello spazio politico, rappresentato dall’agorà, nel quale le virtualità
umane possono trovare la loro piena realizzazione. In tal senso, la bellezza
si fonde con un’accezione della libertà che racchiude, come sua
condizione interna, il necessario, ma al tempo stesso lo supera, così come
la vita biologica è presupposto necessario, ma non sufficiente, dell’ideale
greco dell’éu zén, del vivere bene. C’è quindi, inerente alla nozione stessa
di bello, qualcosa che chiama. In presenza del bello, insomma, si è
chiamati a non contentarsi del sensibile, ma si è invece mossi a superare, a
ricercare ciò di cui ciò che si manifesta è solo un sintomo. Kalòn kaléin, il
bello chiama a non arrestarsi al livello sensibile, andando oltre le
apparenze. Quella bellezza che, in età moderna, sarà indicata come
l’oggetto dell’estetica, e cioè di ciò che concerne l’àisthesis, e quindi la
sensazione, originariamente agisce come voce che chiama
all’oltrepassamento del piano sensibile, alla ricerca di un altro, e più
adatto, livello di realtà. Platone indica le tappe di tale itinerario. Chi vuole
arrivare a tale limite deve iniziare fin da giovane ad andare verso i corpi
belli; e, in un primo momento, se chi lo guida, lo guida bene, amare un
corpo solo e in quello creare bei discorsi; poi, arrivare a comprendere che
la bellezza che è in qualsiasi corpo è sorella di quella che è in un altro e
che, se si deve seguire il bello che è nelle forme visibili, sarebbe come non
capire nulla non ritenere una e una sola la bellezza che è in tutti i corpi. Si
arriva alla visione di quello che si può chiamare to poly pélagos tou kaloù,
il gran mare del bello. Ciò che è definito è quindi un percorso, un
oltrepassamento di gradi e forme diverse di bellezza, che muove da
quell’espressione che se ne coglie nei bei corpi, per salire fino a una vera e
propria scienza di una bellezza superiore a tutte quelle accessibili con i
sensi. L’approdo, che tuttavia non conclude il dinamismo né lo ferma, ma
segna la meta mai acquisita dalla ricerca, un fine capace di orientarla, pur
senza arrestarne la spinta, sarà una bellezza meravigliosa: bellezza eterna,
che non nasce e non muore né cresce né scema, che non in parte è bella e
in parte è brutta, né ora sì, ora no; né bella sotto certe relazioni e brutta
sotto certe altre, né bella qui e brutta lì. Con tali caratteristiche, il bello non
è rappresentabile come qualcosa che abbia un volto o altro di quello che
un corpo possa avere, perché esso è una sola forma, che è in sé e per sé, e
che quindi non nasce e non muore, non aumenta né diminuisce. Per
spiegare cosa sia la bellezza, Platone non indica un concetto definito, ma
descrive un processo, una graduale salita che muove dalla molteplicità
delle cose belle, per tendere verso uno scopo mai raggiungibile. Questo è il
modo corretto di procedere: cominciando dalle bellezze presenti, cercando
quell’ultima bellezza, salire sempre, fino a conoscere quella che questa
bellezza essa stessa è in sé. Se c’è un bìos che si possa concepire come
biotòs, se c’è qualcosa che renda la vita degna d’esser vissuta, è
contemplare la bellezza in sé. Una vita senza ricerca non è degna d’esser
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 10 di 87
vissuta. Ma la rivelazione fatta a Socrate dalla xéne di Mantinea non è
ancora conclusa. Non si tratterà più di contemplare metalli preziosi, bei
vestiti o bei corpi, ma piuttosto di contemplare il bello nella sua purezza e
pienezza, non incarnato. Insomma, una bellezza divina, vista nell’unità
della sua forma, dalla quale non si deve mai distogliere lo sguardo. Solo
così, solo guardando la bellezza con ciò per cui essa è visibile, e cioè con
l’occhio dell’anima, all’uomo accadrà di generare virtù vera, perché è virtù
che è a contatto con la verità. La digressione platonica sulla bellezza è nel
dialogo in cui si narra del simposio svoltosi a casa di Agatone, e in
particolare della cerimonia alla quale parteciparono, tra gli altri, Socrate,
Aristofane e Fedro. Dal simposio vero e proprio erano escluse le donne.
Così succede anche in quello raccontato da Platone, dato che, quando si
decide di iniziare a celebrare il rito, le donne che erano lì presenti, per lo
più serve, o per allietare la serata con la musica dei flauti, vengono
mandate via. Trattandosi di una cerimonia religiosa, iniziatica, durante la
quale saranno affrontati argomenti segreti, la presenza delle donne sarebbe
considerata come un sacrilegio. Rispetto a tale atteggiamento, risulta tanto
più rilevante la scelta platonica, quando affida a una donna il compito di
rivelare la verità a Socrate. A mettere in risalto lo scandalo di questa
scelta, si può aggiungere che Diotima riassume in sé molti aspetti che la
rendono altra, rispetto agli invitati e ai discorsi pronunciati. Ella è
straniera, perché è di Mantinea. Anche perché è assente dal simposio.
Donna, anziché uomo. Diotima è straniera, altra. E proprio a tale figura
dell’alterità Platone attribuisce il discorso che rivela che cosa sia il bello.
Ma il richiamo al personaggio a cui è affidato il compito di guidare
Socrate nella ricerca permette anche di mettere in risalto un aspetto
concernente lo statuto della bellezza. L’alterità di Diotima, e l’itinerario di
graduale ascesa, da essa definito, evidenziano il carattere iniziatico del
percorso, e quindi si riferiscono al fatto che la contemplazione della
bellezza in sé non può essere identificata come un grado di più alta
conoscenza, come acquisizione di un piano gnoseologico più pieno,
rispetto alla bellezza sensibile da cui muove il processo. La ricerca del
bello è di per sé un percorso di cambiamento, una metabolé, non diversa
da quella descritta nel contesto del mito della caverna, raccontato nel libro
VII della Politeia platonica. In entrambi i testi è raccontata la storia di chi,
movendo dall’oscurità della caverna, o dal bello sensibile, voglia salire
alla visione del reale in sé, e cioè della bellezza e della verità. Infatti, il
rimando alla raffigurazione della dimora sotterranea permette di
comprendere meglio un aspetto fondamentale della concezione platonica
del bello, come emerge dalle pagine del Simposio. Arrivare alla
contemplazione della bellezza in sé significa soprattutto entrare in contatto
con la verità, partecipare all’immortalità divina, ottenere una virtù che
sarebbe altrimenti preclusa. Si comprende, insomma, perché la
contemplazione della bellezza di cui tratta il Simposio non sia traducibile
in una sfera estetica, poiché essa ha invece a che fare con un cambiamento
profondo del modo d’essere stesso dell’uomo, legato all’epoptéia, cioè alla
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 11 di 87
rivelazione. Grazie alla bellezza, alla quale solo una straniera può
condurre, si è pro-mossi ad un piano più alto, nel quale si uniscono il
bello, il vero e il virtuoso. Rispetto all’accezione antica, e al nesso
problematico con la nozione di agathòn, emerge come qualità
caratterizzante del concetto di bello il nesso con la verità. Infatti, il punto
d’arrivo dell’itinerario di ascesa iniziatica sta nel giungere a vedere una
scienza unica e fatta in modo tale da avere per oggetto la bellezza, dove il
termine usato da Platone per definire tale scienza fa capire fino a che
punto visione del bello e scienza, bello e vero, formino un’unità assoluta.
Quel procedere per gradi, a cui invita Diotima, definisce quindi il
passaggio dalle molte, ma imperfette, cose belle sensibili, verso una
bellezza in sé; ma segnala insieme un avvicinamento alla verità, alla quale
si volge la vera epistéme. Non si è però ancora detto in cosa consista
l’inizio del processo, dove si possa trarre la spinta necessaria per iniziare
ad esplorare il gran mare del bello, quale forza possa sostenere lo sviluppo
di un’esperienza così pregnante. Nel Simposio, Platone si concentra a
lungo sulla rappresentazione di ciò che è definito il miglior collaboratore
che la natura umana abbia per compiere il percorso che porta a creare vera
virtù. Due discorsi si differenziano, per l’originalità dell’impostazione e la
rilevanza concettuale dell’argomentazione. Prima che parli Socrate,
enunciando il contenuto della rivelazione di Diotima, a parlare è
Aristofane. Il suo profilo, l’attività di commediografo, sembra relegarlo a
un ruolo di intrattenitore, come se la sola cosa di cui egli sia capace sia
fare dello spirito, pur su un tema di grande pregnanza, come è quello
proposto da Fedro, al quale risale l’iniziativa di intraprendere una
discussione su Amore. Ma mentre l’invocazione di Aristofane a mé
komodéses, a non mettere in commedia il suo discorso è accolta dagli altri
invitati, la stessa cosa non sembra accadere agli interpreti moderni, attratti
dall’interpretare la narrazione del commediografo solo come una
dimostrazione del suo talento comico. La natura dell’uomo era un’altra
tempo fa. I sessi erano tre; ce n’era un altro che li sommava ambedue e che
è rimasto solo come nome. L’androgino era un sesso a parte e prendeva
dagli altri due la forma e il nome. L’esordio del discorso di Aristofane ne
definisce subito l’aspetto più caratterizzante: si parlerà d’amore,
riferendosi alla natura cioè a ciò che gli individui sono per la loro nascita,
per il modo in cui sono originariamente costituiti. Fin dall’inizio il
discorso di Aristofane si riferisce al tema dell’amore in una riflessione che
supera il livello delle passioni, da una parte affrontando il problema della
distinzione tra natura e cultura, nei termini del dibattito svoltosi ad Atene
nella seconda metà del V secolo, e dall’altra spostando il centro della
discussione tra gli invitati dal contesto di un’enunciazione convenzionale
delle qualità di Eros, alla più pregnante ricerca sull’origine e il destino
dell’uomo, in relazione al presente. Nessuno è un intero, anche se lo si
crede. La natura di ciascuno è dimidiata, divisa a metà, imperfetta,
parziale. Per riprendere la stessa metafora usata da Aristofane nella
narrazione, all’uomo è successa la stessa cosa delle sogliole: suddivise a
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 12 di 87
metà nel senso della lunghezza, da uno si è diventati due. Di qui, quindi, la
genetica im-perfezione della natura umana, il fatto che ogni individuo, pur
apparendo uno, è in realtà una frazione; di qui, l’im-perfezione, dipendente
dal fatto di essere il prodotto di un taglio originario, intervenuto a punire la
ribellione contro la divinità. Poiché ognuno è solo un symbolon, una metà,
è inevitabile che, per tutta la vita, si ricerchi l’altra metà, con la quale si
possa ripristinare l’intero originario. La forza dell’amore è signora
dell’uomo. Impossibile resistere a ciò che l’amore comanda. Perché non si
tratta di un sentimento qualunque, né di una passione che sia limitata alla
sola dimensione delle pulsioni istintuali. Ciò di cui si parla, è la necessità
di un risanamento che concerne la natura umana nella sua pienezza, alla
cui forza non ci si può opporre. Non per scelta, che si può modificare, né
per capriccio, ma per corrispondere ad una necessità di completezza, per
guarire dalla malattia di essere solo un symbolon, per ritrovare quell’uno
che si era. Le tendenze sessuali sono quindi conformi a natura, tutte
derivanti dalla condizione originaria, tutte dipendenti da quell’originaria
natura che non si è scelto, ma che è la matrice delle tendenze presenti.
Ogni comportamento sessuale è naturale, perché si tratta di far
corrispondere le due metà. Il desiderio che definisce ogni uomo è
rappresentato da Aristofane quando parla di diventare l’uno con l’altro la
stessa cosa, in modo tale da non lasciarsi mai. Naturale non è ciò che si è,
ma ciò che si può diventare, ripristinando la natura originaria. Ciò che si
presenta come fine verso cui procedere, è in realtà il principio. Espiazione,
guarigione dai mali dell’umanità, è al contrario non sottrarsi alla ricerca, in
quanto symbolon, l’altro symbolon, col quale ripristinare l’hòlon
originario. La salvezza dalla condizione di malattia, alla quale la
tracotanza originaria ha condannato l’uomo, consiste nella capacità di
redenzione, nel saper ritornare a ciò che si era, nel riunire il futuro col
passato, nel rovesciare la direzione apparente del tempo, vivendo il
presente come un passaggio continuo dal futuro al passato. La pienezza dei
tempi corrisponde, da tale punto di vista, alla pienezza dell’essere: il senso
di tale storia salvifica, o perlomeno del percorso di guarigione dalla
mancanza originaria, potrebbe dirsi realizzato quando ogni parte ritrovasse
l’altra parte. Si comprende allora, in tale rovesciamento di ciò che
l’apparenza sembrerebbe suggerire, per quale motivo, deviante, non sia
l’assecondare la propria sessualità ma piuttosto il resistervi, o il voler
modificare ciò verso cui, per natura, si è orientati. Uscire dal limite
dell’essere solo un symbolon, per tornare ad essere quell’uno che si era,
finisce così per identificarsi con la navigazione nel gran mare del bello,
mossi da una ineliminabile nostalgia dell’intero. Si comprende, allora,
perché si possa dire che il bello chiama. Sulla funzione della bellezza,
come stimolo verso una guarigione, e sul nesso tra amore e bellezza,
Platone insiste anche nel Fedro, con la trattazione della quarta forma di
divina manìa. Rispetto a quanto scritto nel Simposio, qui si mette in
evidenza un aspetto rilevante, concernente i modi di manifestazione della
bellezza. Kàllos idéin lampròn, la bellezza nel suo splendore; kallous
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 13 di 87
élampen, la bellezza splendeva. Nel Fedro non ci si ferma a mettere in
evidenza con quali modalità la bellezza agisca nella vita, sostenendone
l’ascesa e la purificazione. Il bello élampen, lampeggia. L’intero brano del
Fedro dedicato alla manifestazione della bellezza è costruito sulla
valorizzazione di termini e metafore che rimandano al lessico del vedere, e
quindi anche al conoscere, vista l’equivalenza tra i due verbi nella cultura
greca. Mentre i corrotti non possono innalzarsi da questo mondo a
contemplare la bellezza in sé di lassù e quindi si danno al piacere,
abbandonandosi a ogni eccesso, coloro che invece hanno a lungo
contemplato, quando vedono un volto di apparenza divina, o una qualsiasi
forma corporea bella, rimirando tale bellezza la venerano come divina.
Eros, che possiede la bellezza, è il medico che guarisce i mortali, mentre
per gli dèi esso si chiama Pteros, perché fa crescere le ali. Ma per
approfondire tale passaggio del Fedro, e in particolare le implicazioni
legate al verbo usato da Platone, ci si deve riferire a un altro testo,
interpretato quasi da tutti come un’autobiografia platonica. Nella Lettera
VII, infatti, per mostrare quale sia la natura della scienza da lui indagata, e
come essa si manifesti, Platone usa una metafora, la scintilla che scaturisce
dal fuoco, che corrisponde alla raffigurazione dello splendore della
bellezza divina descritta nel Fedro. La scintilla che scaturisce dal fuoco
appare exàiphnes, improvvisamente. Come la scienza che nasce
all’improvviso nell’anima dopo una lunga relazione con l’argomento, allo
stesso modo la bellezza lampeggia all’improvviso. Già in Pindaro,
riferendosi alla grazia che è propria della chàris, il termine
improvvisamente è usato per indicarne le modalità di manifestazione.
Nell’intreccio tra i passi citati del Fedro e della Lettera VII si conferma
tale caratteristica come modalità di apparizione. La bellezza risiede
altrove, in quel luogo/non-luogo chiamato yperouranòs. L’apparizione
avviene all’improvviso. Come il balenare della luce: solo così si può
rappresentare l’epifania del bello e la genealogia di quel màthema che è la
filosofia. In origine, da Omero e Esiodo fino a Platone, il termine kòsmos
significa due cose. Così, per esempio, nell’Iliade si trova l’espressione eu
katà kòsmon, che significa in buon ordine. Analogamente, nei poemi
omerici, si trova la frase ou kòsmos, che vuol dire non ordine. Si osservi
che con tale significato, cioè come ordine, misura, disciplina, esso si trova
anche nei tragici e nello stesso Platone. Poi, nell’età antica kòsmos indica
l’ornamento. Al contrario, ciò che poi si sarebbe chiamato universo, con i
suoi derivati linguistici, era chiamato tò pàn il tutto, o anche tò hòlon, cioè
l’intero. Si può dire, insomma, che almeno fino a Pitagora per chiamare
l’universo si usava l’espressione la totalità, l’intero, volendo dire le cose
che sono, che esistono, che si vedono. Fino a Platone, appunto. Nel Gorgia
si legge che gli uomini saggi dicono che cielo e terra, dèi e uomini, sono
tenuti insieme in un tutto con la comunanza, l’amicizia, l’ordine, la
saggezza e la giustizia, e perciò questo tutto è chiamato ordine invece che
disordine o dissolutezza. Quando Platone deve indicare un luogo che non è
un luogo, che non sta nell’universo, il luogo nel quale ci sono le idee, lo
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 14 di 87
chiama yper ouranòs, oltre il cielo, che significa che non è un luogo fisico.
Orbene, tutto ciò che è, grazie a qualità morali, più che a leggi fisiche,
come la giustizia, l’amicizia, e la saggezza, si tiene insieme, non si
disperde, e quindi si può dire che tutto ciò forma un kòsmos, cioè un
ordine. Il tutto, l’intero delle cose che sono, quando su di esso agisce la
giustizia, assume la forma del kòsmos. Senza spostarsi di molto dalla
spiegazione dell’etimologia del termine, si può quindi dire che perché si
dia un kòsmos non è sufficiente riferirsi alla totalità di ciò che è. Servono
delle qualità morali per avere un kòsmos. Nel passo del Gorgia citato, si
realizza una svolta platonica, la cui rilevanza può essere apprezzata dopo
alcune considerazioni. Il tutto può essere chiamato kòsmos, in quanto si
concepisca che tra le cose che compongono il tutto sussistano relazioni di
amicizia, giustizia e saggezza. Del resto, la mescolanza tra categorie
morali e leggi fisiche si trova anche nel frammento B I di Anassimandro,
nel quale la storia eterna della nascita e della morte di tutte le cose è
rappresentato come un processo di rendersi giustizia a vicenda
dell’ingiustizia. Non si può parlare di origine, se non riguardo a un cosmo,
cioè a una totalità ordinata, e quindi bella, come è quella che è riassunta
nel termine kòsmos. Non meno notevoli sono i corollari del punto di vista
ora descritto per ciò che concerne quelle che si possono definire arti
verbali, nelle quali, come dice lo stesso Omero, il concetto di kòsmos si
lega all’armonia e alla coerenza. Di un cantore si può dire che canti
secondo i canoni della bellezza se procede katà kòsmon, secondo un ordine
bello, riproponendo cioè in una struttura coerente verbale la successione
reale degli avvenimenti. Nella lirica antica il testo poetico è concepito
come un kòsmos epéon, cioè un ordine bello di parole. Con Platone si
compie quella concezione del bello che sarà preponderante nella tradizione
culturale occidentale. Da una parte, infatti, è riconfermato il nesso antico
tra bello e buono, espresso nella formula tradizionale della kalokagathìa.
Dall’altra si lega il bello al vero. La manifestazione del bello a livello
sensibile si dà quindi come sintomo e richiamo ad iniziare un itinerario
terapeutico, un viaggio iniziatico, un processo di avvicinamento graduale
alla verità. Così come è chiaramente inappropriato parlare di una teoria
della conoscenza, o di una concezione politica, in Platone, allo stesso
modo sarebbe inappropriato individuare nei Dialoghi una teoria estetica,
distinta dalla riflessione sul bene, sul vero, sul giusto. Al contrario, la
particolarità della trattazione platonica va colta proprio nella
dimostrazione di un’originaria indissolubilità di termini e concetti, tale per
cui la riflessione sul bello è in se stessa anche scienza, e quindi ricerca
della verità, movimento di purificazione spirituale, guarigione dalle
malattie che colpiscono l’anima. Il bello è il modo con il quale si esprime
una forma, quella che Platone chiama éidos, e quindi la cosa vista, che si
identifica con la realtà vera, di cui le molte cose sensibili sono apparenze
fenomeniche. In Platone, insomma, non solo, come già nella cultura graca
antica, bello è anche buono, ma esso è anche indissolubile rispetto a ciò
che è vero. In quanto rimanda a un bello in sé, il bello sensibile testimonia
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 15 di 87
un eccesso, segna un divario, che non può essere colmato. Ciò che
lampeggia, non ha la forma di un’espressione piena, ma piuttosto si dà
come balenare di un orizzonte che rimane solo intravisto, al quale non è
possibile accedere in modo definitivo.
Il tragico
Si tratta della poetica in sé e delle sue forme, quale virtualità ciascuno
abbia e come si debbano comporre i racconti perché la poesia sia ben fatta.
Nell’opera che per oltre due millenni è stata considerata il più importante
trattato di estetica, il termine bello appare per indicare le qualità necessarie
perché la poiesis riesca bene, possa dirsi ben fatta. Il trattato aristotelico
sull’arte poetica si apre quindi ribadendo l’accezione non estetica del
termine bello, che anche in questo contesto è usato per indicare qualcosa
che funziona bene, che è ben fatto. Aristotele getta così le basi per liberare
la poesia da ogni riferimento contemplativo di forme privilegiate. Fine
delle diverse specificazioni della poiesis, infatti, sarà quello di suscitare
quel particolare genere di piacere che gli è proprio. Nel caso della tragedia,
cioè di quella forma di poiesis alla quale è dedicato quasi interamente il
trattato aristotelico, il piacere è legato con éleos e phòbos, pietà e terrore.
Veramente bella, ben fatta, sarà quella tragedia che saprà suscitare nello
spettatore paura e compassione. L’elemento più importante della tragedia,
per Aristotele, è il mythos, cioè ciò che si può tradurre con racconto. Vero
è, infatti, che elementi della tragedia sono anche lo spettacolo e la musica,
ma il mythos è predominante sugli altri, in modo tale che si può arrivare a
dire che la virtualità della tragedia resta intatta, anche senza scena ed
attori. Spinta ai limiti, tale affermazione comporta che anche senza vedere,
anche senza l’òpsis, pur in mancanza dello spettacolo, ma solo leggendo il
mythos, esso riesca a suscitare piacere tragico, cioè terrore e pietà. La forte
valorizzazione del racconto, come elemento fondamentale di quella forma
di poiesis che è la tragedia, legato alla svalutazione di ciò che concerne la
vista, permettono di mettere in risalto un tratto fondamentale del
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 16 di 87
ragionamento aristotelico. Il racconto, e più in particolare come esso è
costruito, è ciò che dà a un’opera poetica la capacità di suscitare le
emozioni liberatorie negli spettatori. Ad essere sorgente di pathos non
sono, quindi, elementi accessori, e in ogni caso esterni rispetto alla
composizione del racconto, come sono quelli che colpiscono i sensi della
vista e dell’udito, ma piuttosto un tratto strutturale, che si riferisce alla
razionalità della narrazione, concernente le modalità con le quali i fatti
descritti sono legati l’uno all’altro in una trama ben organizzata. Del resto,
l’accento su principi capaci di mettere in risalto la comprensibilità interna
della narrazione, a scapito di qualità legate al contesto sensibile, deriva
secondo consequenzialità, almeno in Aristotele, da ciò che egli afferma
riguardo alla poiesis. Philosophòteron, quindi, più filosofica è la poesia,
poiché essa si rifà a ciò che è verosimile, e che quindi è in rapporto con
l’universale nella forma della probabilità, mentre la storia si occupa di
cose realmente accadute, in quanto tali particolari. Da ciò che si è detto
deriva, allora, la rilevanza di approfondire l’analisi che Aristotele porta
avanti sulla struttura del racconto che è principio e quasi anima della
tragedia. Molti, e tutti notevoli, sono i requisiti che il racconto deve avere,
perché esso possa essere detto ben fatto. Nelle argomentazioni su quale
debba essere la corretta ampiezza del racconto come base tragica ritorna il
riferimento alla nozione di bello. Notando che in ogni cosa composta di
parti, cosa animata o meno, è fondamentale non solo che esse siano in
ordine, ma anche che corrispondano a una grandezza non casuale,
Aristotele sostiene infatti che ciò che è bello sia tale in grandezza e in
disposizione. Come risulta anche dal libro I del De partibus animalium, la
presenza del bello nella natura è insomma una testimonianza della struttura
finalistica dei processi formativi dell’essere vivente. In tal senso, il bello
non è solo in rapporto allo scopo, ma anche con quella spiegazione dei
fenomeni naturali che procede dal fine, concepito sia come termine del
processo organico di formazione del vivente, sia come manifestazione
dinamica della forma che una data sostanza realizza in tale processo. Il
bello è l’espressione stessa della struttura vivente definita dal nesso di fine
e forma, nei suoi caratteri di ordine, regolarità, conformità alla natura. A
seconda del fine che gli è proprio, per Aristotele, i diversi organi hanno
una diversa collocazione nel corpo. Per tornare ora alle qualità di bel
racconto, è necessario, poi, che i fatti descritti siano tra loro legati con
rapporti di verosimiglianza o di necessità, così da poter dire che è
preferibile un impossibile verosimile, piuttosto che un possibile
inverosimile. Se, infatti, tra i casi, di cui è fatta la trama, non c’è un nesso
di verosimiglianza, ossia quando i casi stessi non provengano l’uno
dall’altro in modo necessario, è necessario che lo spettatore rimanga
freddo, insensibile e a-patico, riguardo alla storia. Non è sufficiente,
quindi, che tra i diversi fatti ci sia una successione temporale, perché anzi
essa può essere persino rovesciata o stravolta, come succede nell’Edipo re,
a condizione tuttavia che sia poi evidente che essi conseguano l’uno
dall’altro, in modo verosimile o necessario. L’esempio aristotelico, in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 17 di 87
apparenza bizzarro, è quello che si riferisce a una tragedia perduta, nella
quale il protagonista, responsabile dell’assassinio del re Miti, è a sua volta
ucciso dalla statua del re che gli cade addosso. Ma, in tema di racconti che
appaiono poco credibili, e che invece risultano verosimili e coinvolgenti
dal punto di vista emotivo, basti pensare al mito di Don Giovanni, nel
quale quelle che sembrano incongruenze, sono in realtà superate da una
concatenazione dei fatti così verosimile, da eliminare ogni possibile
freddezza emotiva nello spettatore. Il quale, proprio per la buona fattura
del racconto, e per la verosimile o necessaria consequenzialità degli
avvenimenti, finisce per prendere per buone quelle che dovrebbero
sembrare come inaccettabili incongruenze, come una statua di marmo
eretta in pochi attimi, che parla, che cammina, che cena, che invita a cena,
che minaccia, che si vendica, che fa prodigi. Anche a tal riguardo, ci
sarebbe la possibilità di menzionare una serie di altri esempi, tratti da
opere drammaturgiche o letterarie, nelle quali la connessione verosimile o
necessaria tra i fatti descritti, per quanto essi possano essere fantastici,
segue un effetto che resta al contrario precluso a racconti realistici, i quali
sono tuttavia mal fatti, proprio dal punto di vista delle modalità connettive
tra i casi narrati. Riguardo al modo in cui è costruita la consecuzione dei
fatti, ancora Aristotele evidenzia che non basta che il passaggio tra le
premesse e i corollari avvenga in modo verosimile, poiché è anche
necessario che esso intervenga contro le aspettative. Da una parte, quindi,
gli eventi devono succedersi l’uno con l’altro in un modo che non sembri
inverosimile, ma allo stesso tempo ciò che sopravviene deve riuscire
imprevisto, parà ten dòxan, contro le aspettative. Se si vuole che i fatti
descritti suscitino pietà e terrore, necessario quindi che si verifichi un
fenomeno improbabile, se non impossibile, da immaginare, cioè che dal
necessario scaturisca l’imprevisto. Deve risaltare il thaumastòn, il
meraviglioso, ciò che può destare stupore nello spettatore. Sia Platone, sia
lo stesso Aristotele, affermano che l’origine della filosofia sta in
quell’esperienza originaria, da entrambi espressa col verbo thàumazein.
Dove il thàuma deve essere concepito non solo con la meraviglia, ma
come quello stato d’animo complesso nel quale convergono la
disposizione intellettuale dello stupore e quella emotiva dello sgomento.
Insomma, una tragedia sarà bella se sarà costruita in modo tale da non
lasciare a-patico lo spettatore, ma al contrario saprà suscitare quel
particolare pathos che si trova anche a fondamento della filosofia, e cioè il
thàuma. In primo luogo ci deve essere la trama o intreccio, cioè quella
parte del racconto in cui si annodano i diversi fatti, rispettando i principi
citati, e quindi secondo verosimiglianza o necessità, e insieme contro le
aspettative. C’è poi la seconda parte, quella dello scioglimento, nella quale
i nodi intrecciati sono sciolti, e il racconto arriva quindi alla conclusione.
Nella buona costruzione di un racconto, è questo l’aspetto più difficile.
Molti, però, dopo aver bene intrecciato sciolgono male, mentre si deve
saper accordare le due cose. Questo vuol dire che lo scioglimento non può
essere casuale, né può essere realizzato con un in-verosimile intervento
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 18 di 87
esterno, rispetto ai casi descritti, ma deve piuttosto corrispondere a una
forma ben determinata, in quanto tale riconoscibile. Orbene, la forma
generale dello scioglimento corrisponde al concetto di metabolé, cioè ad
un cambiamento, che si presenta come un mutamento radicale. Si può dire
di trovarsi di fronte ad una metabolé, quando ciò a cui si assiste non sia
solo un cambiamento, ma sembri piuttosto un rovesciamento, ossia una
vera e propria trans-formazione. Deve trattarsi, quindi, di una nuova
forma, diversa in modo assoluto da quella precedente, e tuttavia da essa
conseguente in modo verosimile o necessario. Per mettere meglio in risalto
la nozione di metabolé, può essere utile ricordare che, mentre il termine in
apparenza sinonimo di metànoia indica un cambiamento che avviene nel
proprio modo di pensare, e quindi segnala un cambiamento che è sia
soggettivo sia debole, metabolé indica invece uno stravolgimento
oggettivo, a radicali fenomeni di mutamento concernenti la realtà in sé. In
tale accezione, si ritrova per esempio il termine nel mito cosmogonico
descritto nel Politico di Platone, dove il processo di inversione nel moto
astrale e nella generazione biologica è descritto come una megìste
metabolé, come una enorme rivoluzione che ha rovesciato il corso naturale
degli eventi. Se si vuole realizzare uno scioglimento dell’intreccio, capace
di suscitare pietà e terrore, realizzando il piacere tragico, è necessario che
esso si presenti con una metabolé. Il capovolgimento deve riguardare il
destino del protagonista, ed è quindi un mutamento oggettivo, visibile e
constatabile, in quanto tale non riducibile a un mutamento di opinione. Per
dare la necessaria precisione alla questione, Aristotele indica anche quali
debbano essere le forme specifiche, con le quali si può avere una
metabolé, distinguendo il rovesciamento dall’agnizione. A queste due
forme egli ne aggiunge una terza le cui caratteristiche non sono ben
definite. Buon poietés, produttore di storie belle, sarà colui che saprà
costruire una trama, intrecciando fatti che conseguono l’uno dall’altro in
modo verosimile o necessario, e che intervengano contro le aspettative, in
modo tale da giungere a uno scioglimento dell’intreccio con un
rovesciamento o un’agnizione, oppure con entrambe queste forme di
metabolé. Infatti, quando lo spettatore assiste a un repentino e imprevisto
mutamento di fortuna del protagonista, a seguito di qualcosa che
improvvisamente gli cade addosso, ossia di un parimenti imprevisto
passaggio dalla non conoscenza alla conoscenza, egli è scosso da un
brivido di terrore e da un senso di pietà. La svolta nella concatenazione dei
fatti, è ciò che suscita il piacere proprio del racconto, a condizione che
essa non sia l’esito di interventi esterni, o del caso, ma scaturisca da una
consecuzione verosimile di eventi, con un cambiamento inaspettato, una
vera e propria transizione di stato. L’esempio aristotelico, per riferirsi ad
uno scioglimento corrispondente ai principi citati, è quello tratto
dall’Edipo re, relativo all’arrivo dell’àngelos proveniente da Corinto.
Nell’acme dell’indagine, portata avanti in prima persona da Edipo, quando
già si preannuncia un possibile scioglimento felice della storia, si colloca
un vero e proprio rovesciamento, qualcosa che cade addosso
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 19 di 87
improvvisamente, e che genera un repentino e imprevisto mutamento di
fortuna del protagonista. Dopo tale svolta, comincia uno scioglimento che
porta a un esito luttuoso della storia, con coinvolgimento patetico del
pubblico. Il tutto, mettendo insieme abilmente verosimiglianza e
imprevedibilità, e soprattutto con una descrizione accurata di ciò che
genera la metabolé. Compiuta tale svolta, la fortuna del protagonista
cambia radicalmente, anzi si rovescia, nel passaggio dalla buona alla
cattiva sorte. La transizione di stato non appare come effetto del caso o di
interventi esterni fuori dall’intreccio, ma è il corollario verosimile, e al
tempo stesso inaspettato, di una consecuzione di fatti annodati in modo
coerente, e poi sciolti in modo appropriato. Per Aristotele si deve
censurare l’esibizione sulla scena di cadaveri o altre atrocità, che vanno
invece tenute al di fuori della scena. Inoltre per Aristotele si deve
distinguere tra ciò che è phoberòn, e cioè capace di destare terrore per
come sono annodati i casi descritti, e il teratòdes, che è invece il
mostruoso, come tale inadatto a suscitare il piacere tragico, poiché anzi
inibisce il processo di immedesimazione. O, ancora, quando evidenzia che
è opportuno cheil cambiamento di fortuna concerna un personaggio che
possa assomigliare allo spettatore, poiché la rappresentazione delle
sventure capitate ai malvagi non è atta a suscitare né pietà né terrore,
mentre dove a subire le sventure siano persone per bene e innocenti, tutto
questo sarebbe ripugnante, anziché phoberòn. Tutto questo non comporta
per niente la formulazione di giudizi di valore, sulla base dello schema
binario vello/brutto, ma semplicemente il tentativo di comprendere come è
costruito il racconto che definisce la trama della tragedia. Philosophòteron
è il dire poetico, rispetto per esempio a quello storico, perché mentre la
poiesis, occupandosi del verosimile, si riferisce a ciò che è universale, la
storia, trattando di ciò che è realmente accaduto, si riferisce al particolare.
In quanto è imitazione di quella forma del fare che è la praxis, la poesia, in
tutte le sue forme diverse, è legata alla conoscenza. Infatti, proprio con la
mimesis, l’uomo è capace di procurarsi le pròtas mathéseis, cioè le prime
conoscenze; inoltre, riferendosi all’universale, piuttosto che al particolare,
la poesia è in sé una cosa filosofica. Evidenziando la necessità che i casi
che fanno la trama siano tra loro legati secondo rapporti di verosimiglianza
e, insieme, siano tali da sopraggiungere contro le aspettative, nella Poetica
si precisa che tale connessione di verosimile e imprevisto è fondamentale
per far risultare thaumastòn il racconto, e cioè tale da destar meraviglia.
Fonte di piacere è guardare le immagini perché coloro che contemplano le
immagini imparano e ragionano su ogni elemento. Orbene, l’imitazione dà
a tutti, anche a coloro che ne sarebbero esclusi, non solo la possibilità di
procacciarsi le prime conoscenze, ma anche l’opportunità di imparare e di
ragionare proprio con la contemplazione delle immagini. Di qui sorge un
corollario, quasi del tutto ignorato dagli studiosi e dagli interpreti, di
notevole importanza, sia per ciò che concerne l’interpretazione del
pensiero aristotelico, sia soprattutto per ciò che riguarda quella particolare
forma di imitazione poetica, che è la tragedia. Si può imparare e ragionare
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 20 di 87
guardando le immagini, meglio è più facilmente, di quanto non possa
accadere con la filosofia tradizionale. La poiesis è cosa più filosofica della
storia, proprio perché mette a contatto con l’universale. Insomma, non solo
l’imitazione non è altra cosa, rispetto a quell’imparare e ragionare, in cui
consiste la filosofia. Ma essa è in sé philosophòteron, la cosa più
filosofica, poiché permette di imparare le prime conoscenze, suscita
meraviglia e consente di imparare e ragionare. Dalle pregnanti pagine
della Poetica emerge quindi confermato quello che non può più essere
considerato un paradosso. Nella cultura greca antica, tra Omero e
Aristotele, il termine bello, è usato per indicare qualcosa che poco ha a che
fare con l’estetica. Il bello non è cdiò che è intrinsecamente tale, non è ciò
che corrisponde a una forma che si ritenga privilegiata. Ma è ciò che
rimanda ad altro, o nel senso dell’integrità etica o nel senso del richiamo a
un eccesso, anche dove essa rimanga indeterminata. E il caso, per
esempio, della tragedia, alla quale Aristotele dedica un’analisi
approfondita. Potrà dirsi bello quel componimento che sia ben fatto,
perché il racconto che lo fonda è costruito rispettando alcune regole
stabilite con cura. Il passaggio dalla prima alla seconda parte del racconto,
dall’intreccio al suo scioglimento, dovrà avvenire secondo alcune modalità
specifiche di metabolé, come il rovesciamento e l’agnizione, concepiti
entrambi come specificazioni di una transizione di stato. Solo così, si potrà
ottenere il piacere tragico, potranno liberarsi terrore e pietà, ai quali è
legata quella purificazione, quella kàtharsis, di origine medica. Si coglie
qui una notevole precisazione, relativa al significato del termine bello.
Non potrà dirsi bello quel racconto, e quindi neppure la tragedia di cui
esso è fondamento, se non sarà capace di coinvolgere lo spettatore,
suscitando in lui intensi pathémata. La bellezza è tale solo se è capace di
attivare quel processo di cambiamento, che avrà il suo acme con l’uscita
impetuosa delle emozioni. Dove un racconto sia ben fatto, ciò che nasce in
colui che ad esso si avvicini è il thaumastòn, quell’emozione complessa
che racchiude la sfera razionale dello stupore e quella emotiva dello
sgomento. Già nelle opere dei tragici dell’età classica si trova espressa la
convinzione che pathémata-mathémata, che le passioni sono all’origine
delle conoscenze. Tale assunzione di carattere generale è ora specificato,
nel senso chele passioni tipiche della tragedia, la pietà e il terrore, sono
capaci di generare quel thaumastòn, in cui si compendia l’originario della
filosofia. Si comprende allora meglio, in tale prospettiva, perché Aristotele
possa sostenere che la poiesis, la cui forma più piena è la tragedia, sia cosa
più filosofica, rispetto alla storia. Perché, sia pur con un processo
articolato in modalità diverse, essa ha a che fare con quello stesso
thaumàzein che crea la filosofia.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 21 di 87
Plotino
Il bello si trova, soprattutto, nell’ambito della vista; si trova poi
nell’ambito dell’udito, secondo la combinazione delle parole, e così pure si
trova nella musica. Col termine bello posto in enfasi, proprio all’inizio del
periodo, inizia quella parte dell’opera di Plotino conosciuta come trattato
Sul bello. La molteplicità delle forme in cui si manifesta la bellezza era già
stata messa in evidenza da Platone, anche con la metafora del gran mare
del bello. Nel testo plotiniano fin da subito si trattano temi assenti o
appena accennati nel paradigma platonico. Vero è, infatti, che sono i sensi
della vista e dell’udito le porte della bellezza, tanto da poter sostenere che
il bello è ciò che diletta con la vista e con l’udito. Pur riproponendo in gran
parte il percorso platonico, Plotino opera una svolta fondamentale nella
storia del concetto di bellezza. Platone censurava i philotheàmones, cioè
coloro che amano gli spettacoli, incutendosi al livello sensibile, mentre si
doveva procedere gradualmente dalla molteplicità delle cose belle alla
bellezza in sé. La struttura del trattato Sul bello ripropone, nel suo
impianto generale, l’itinerario stesso che l’anima deve percorrere, nel
senso che dall’analisi delle bellezze sensibili, compiuta nei primi capitoli
si arriva per gradi al’evocazione della bellezza irresistibile dell’Uno, come
principio primo della realtà. Riproponendo un tema platonico, Plotino
elenca le emozioni che si producono di fronte alla bellezza. Sgomento,
piacevole terrore, desiderio nostalgico, amore, piacevole turbamento. Si
tratta, come si può capire, di emozioni intense. Il terrore è definito
piacevole ma lo stravolgimento della pòesis è accompagnato da piacere.
Se ne ricava, in modo consequenziale, che la visione del bello non è a-
patica, ma è al contrario caratterizzata da un contesto patetico vivace. A
questo si aggiunga che tali emozioni sono così forti, da non poter essere
descritte con un lessico univoco, poiché necessitano invece espressioni
ambivalenti, come quelle usate da Plotino. Tra le emozioni suscitate dalla
visione del bello si segnala il thàmbos. Thàmbos è il termine tecnico per il
senso nobile del divino o, in altre parole, è un sentimento misto di terrore e
meraviglia, un rimanere stupefatti e allibiti, come quando ci si dà contezza
di essere in presenza di tracce della presenza divina. In esso risuona la
stessa radice che si trova in thàuma, e quindi anche la stessa ambivalenza
di significati. La visione della bellezza, soprattutto quando essa si esprima
ad un livello che è altro, rispetto a quello sensibile, crea un thàmbos,
qualcosa quindi che richiama quel thàuma che, secondo il Platone del
Teeteto dà origine alla filosofia. La ricerca della verità ha insomma il suo
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 22 di 87
fondamento, e il suo alimento, in quel particolare stato d’animo che è il
thàuma, che è a sua volta il corollario della contemplazione del bello. Con
la mediazione delle emozioni bellezza e verità sono legate l’una all’altra. Il
nesso che lega insieme l’apparire del bello e la ricerca della verità, con
quella forma specifica di emozione che è definita dal thàmbos-thàuma, si
trova già nel Teeteto platonico. Tale stato d’animo è proprio del filosofo: il
thàumazein. E la filosofia ha questo fondamento. Né si può dire che abbia
descritto in modo sbagliato il processo genealogico colui che ha indicato
Iride come figlia di Taumante. Si osservi, prima di tutto, che in tale
fondamentale passo platonico arché e génesis, il principio e l’origine,
l’inizio eziologico, e il principio temporale, corrispondono. Quindi, la
filosofia non solo inizia col thàumazein, ma da esso trae origine. Essa
quindi discende da quella forma specifica di sentimento che si esprime col
verbo derivato dal sostantivo thàuma. Nella maggior parte dei casi thàuma
è tradotto con meraviglia, cioè con una tra le tante dimensioni che si
condensano nell’originale greco. Secondo tale accezione, per esempio, si
trova il termine non solo nel passo del Teeteto qui citato, ma anche nel
brano, in gran parte parallelo, che apre la Metafisica di Aristotele, dove si
sostiene che gli uomini furono spinti a filosofare dal thàumazein. In
entrambi i casi, l’idealista Platone e il realista Aristotele individuano il
principio della filosofia nel thàuma. Poiché allora, secondo entrambi, la
filosofia nasce da quella forma specifica di sentimento che si riassume nel
termine thàuma, diviene necessario cercare di comprendere quale ne sia il
significato. Thàuma significa anche meraviglia. Ma se ne stravolgerebbe la
polivalenza semantica, rendendo arbitraria la traduzione, dove se ne
eliminasse l’altro significato, quello emotivamente negativo, per il quale il
thàuma è ciò che suscita terrore e sgomento. Se ne ha una testimonianza
essenziale nel libro IX dell’Odissea, dove, descrivendo Poliremo, Omero
ne parla come di un thàum’etétykto pelòrion, un mostro che incute paura.
Anche nei Vangeli sinottici c’è una testimonianza nell’episodio di Gesù e
Pilato. Il fatto che Cristo non risponda alle domande poste suscita in Pilato
un sentimento descritto col verbo thàumazein, alludendo con ciò non solo,
né soprattutto, a una generica meraviglia, ma piuttosto a quel turbamento
che Pilato tra l’altro mostrerà anche successivamente di provare davanti a
Cristo. Insomma, si può sostenere che il sostantivo thàuma, e il verbo
thàumazein, appartengono alla stessa famiglia semantica di un altro
termine conosciuto dai filosofi, quale è deinòs. Fondamento della filosofia,
suo inizio e principio, sua arché e génesis, ciò da cui ha origine e alimento,
è quindi il sentimento; ma non una qualsiasi passione, quanto piuttosto
quella forma tipica di sentimento che stupisce e sgomenta, che indica il
termine thàuma. La filosofia non sarebbe neppure concepibile slegata dalla
polivalente esperienza del thàumazein, dal terrore e dal brivido in esso
compreso. Tutto questo è ribadito anche dalla genealogia richiamata da
Platone nel contesto del Teeteto. Come si legge nella Teogonia di Esiodo,
da Ponto e Gaia, dal mare e dalla terra, nacque Taumante che a sua volta
sposò la figlia di Oceano Elettra, e costei generò Iride e le arpie, Aello e
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 23 di 87
Ocipete, che sanno seguire il soffio dei venti e gli uccelli in volo.
Riproponendo il mito di Esiodo, Platone vuole mettere in evidenza
qualcosa di importante. Come figlia di Taumante, la filosofia è generata da
quell’ampia gamma di affetti e passioni compresi nel termine thàuma,
ossia nel termine corrispondente thàmbos usato da Plotino. Non si deve,
vedendo le bellezze dei corpi, precipitarsi su di esse, ma si deve, sapendo
che sono immagini, orme ed ombre, fuggire verso quello di cui queste
sono immagini. Colui che vuole contemplare quella bellezza irresistibile
che rimane come all’interno del santuario dovrà rinunciare alla visione
oculare e non volgere più il suo sguardo allo splendore dei corpi. Il
percorso è quindi quello che muove dalla bellezza visibile e sensibile che
splende nei corpi, concepiti, appunto, solo come immagini; scopre poi la
bellezza dell’anima virtuosa, e infine si innalza per attingere la bellezza in
sé dalla molte-plicità sensibile all’unità dell’intelligibile, dalle immagini
del bello, meri riflessi corporei di una realtà in-corporea, al bello in sé, che
dà bellezza a tutte le cose e la dà rimanendo in sé senza ricevere nulla in
sé. In tale concezione della bellezza, e della relazione tra il bello sensibile
e quello intelligibile, Plotino usa come esempio istruttivo l’immagine di
Narciso, e il dissidio tra l’atteggiamento del figlio di Liriope e quello di
Ulisse. Se si corresse incontro ai corpi per ghermirli come fossero reali, si
incontrerebbe lo stesso destino di colui che, volendo ghermire una bella
apparenza sulla superficie dell’acqua si inabissò nella corrente e sparì. Si
deve quindi fuggire verso la cara patria. Se l’amore per i corpi, che non
sono che ombre, distoglie dal ricercare la bellezza in sé, e la beatitudine
che alla contemplazione del bello si accompagna, l’amore per il riflesso
del corpo allontana ancora di più dalla cara patria, verso la quale si
dovrebbe fuggire. Diversamente da Ulisse il figlio di Liriope non riesce a
fare della conoscenza in sé uno strumento di redenzione, un modo per
ritornare alla cara patria dalla quale l’uomo proviene. La cara patria
corrisponde al luogo dal quale si è venuti, e lì è anche il padre. Ciò che si
deve fare è, al tempo stesso, facile e difficile: non si deve guardare, ma,
come ad occhi chiusi, cambiare vista, destando quella che tutti hanno, ma
che pochi usano. Come già sosteneva Platone, per poter sviluppare tale
forma tipica di vista è necessario che la vista oculare venga meno, così da
rendere possibile un’altra forma di visione. Per Plotino Narciso e Ulisse
rappresentano due modalità opposte di concepire la relazione con il reale:
l’uno si allontano dalla realtà, per rincorrere i fantasmi del non essere, per
compiacersi in modo vano delle immagini, l’altro resiste alla seduzione
dell’apparenza, agli incantesimi di Circe, al richiamo ingannevole delle
Sirene, pur di non abbandonare quella retta via che riporta alla cara patria.
Opposto a quello di Ulisse, nell’interpretazione di Plotino il
comportamento di Narciso richiama invece la storia di un’altra figura,
anch’essa messa di fronte al dilemma inerente all’immagine riflessa,
anch’essa provocata dall’amore per la bellezza ad un gesto fatale. In
possesso di una bellezza, per la quale non c’è appagamento, Anthropos
non si dà pace per aver infranto il perimetro esterno dei cerchi, né per aver
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 24 di 87
conosciuto il potere di colui che sovrasta il fuoco. In tali termini è descritta
la figura dell’uomo archetipico nel testo che apre i 17 trattati, tramandata
col titolo di Corpus Hermeticum, comprendente scritti forse risalenti a un
periodo compreso tra il I e il III secolo d.C. L’autore del Poimandres,
Ermete Trismegisto, sotto il cui nome circolavano i discorsi componenti il
Corpus Hermeticum, è forse il prodotto di un’interpretazione greca del dio
egizio Toth, presentato da Platone come l’inventore della scrittura. Nel
Poimandres è descritta una storia cosmologica e antropologica, con la
quale Anthropos, reo di una colpa primordiale, e quindi punito con la
copula con la Natura e la conseguente vita nel mondo, seguendo gli
insegnamenti del pastore di uomini riuscirà a liberarsi dalle incrostazioni
di cui si è coperto, e quindi a riunirsi alla divinità. Come Narciso, anche
Anthropos è se-dotto dall’innamoramento per la bellezza della propria
morphé, colta come immagine riflessa nell’acqua; come il figlio di
Liriope, anche Anthropos, andando dietro alla propria immagine, si
allontana dalla cara patria, lasciandosi avvolgere dalla natura. Nella critica
di Plotino, Narciso appare come simbolo di una visione cosmologica
coincidente a quella presente nei testi ermetici. Il giovane innamorato di se
stesso assume, anzi quello stesso ruolo archetipico, che Ermete affidava ad
Anthropos: identico è l’errore commesso da entrambi, analoghi sono i
corollari di tale caduta originaria. Se il dissidio tra il comportamento di
Narciso e quello di Ulisse serve a Plotino per mostrare l’alternativa
dinanzi alla quale si trova colui che entri in contatto con la molteplicità
delle cose belle, un’altra figura appare nel passaggio successivo, dove
Plotino si concentra su quel guardarsi dentro che egli ha raccomandato
come via per tornare alla cara patria. Di tale personaggio ne narra la storia
anche Ovidio, nel libro X delle Metamorfosi. Il personaggio in questione è
Pigmalione la cui vicenda è nota. Tuttavia, nel poema ovidiano si trova
un’espressione, della quale il trattato Sul bello sembra dare al tempo stesso
un commento e una giustificazione teorica. Riferendosi alla perfezione
dell’opera dello scultore, la fanciulla di Pigmalione, tale da rendere la
fanciulla scolpita indistinguibile da una persona vera, Ovidio afferma
letteralmente che ars adeo latet arte sua. Come si nota, nell’emistichio il
termine ars appare due volte, seppur con due significati diversi. La
traduzione che forse meglio rende tale ambivalenza potrebbe essere la
seguente: a tal punto l’arte si nasconde nella sua capacità artiginnale, o
anche tanto la sua arte nasconde l’artificio. La natura deriva dall’arte, ne è
una specie di corollario, come traduzione in un corpo vivente della bella
forma creata dall’arte. Per seguire il consiglio di Plotino, il distacco dalla
molteplicità sensibile, e il viaggio verso la cara patria del bello in sé, non
comporta per nulla la svalutazione dell’arte. Se non ci si vede ancora belli,
si deve operare come opera lo scultore con una stata che deve diventare
bella: da un lato elimina, dall’altro assottiglia, qui leviga, lì ripulisce fino a
far apparire un bel viso sulla statua, così si deve eliminare ciò che è
superfluo, raddrizzare ciò che è storto, purificare e rendere luminoso ciò
che è oscuro e non smettere di scolpire la statua fino a che lo splendore
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 25 di 87
divino della virtù non risplenderà. Per Plotino, quindi, per migliorare
gradualmente se stessi, è necessario trattare la propria anima come se fosse
una àgalma, una statua, su di essa si deve agire con il tektàinein, operando
cioè come un artista, che nulla pro-duce, ma elimina, riduce, cancella. Lo
scopo a cui tende tale lavoro di alleggerimento consiste nel vivere puro
con se stesso, senza che nulla sia mischiato a se stesso nella propria
interiorità. Alla fine di tale lavoro, di tale opera, si potrà ottenere
l’obiettivo a cui tutto il lavoro è stato diretto: diventare interamente una
sola luce, non misurabile, non circoscritta da una figura che possa
diminuirla, priva di ogni misura, maggiore di ogni quantità. L’idea che la
ricerca della perfezione corrisponda con la perdita di ciò che è superfluo,
si trova già in Platone, in un passo del Fedro che fonda il passo delle
Enneadi in questione. L’amante non solo adora il suo amato come una
divinità, ma agisce plasticamente sulla sua anima e sul suo carattere, in
modo tale da renderlo quanto più possibile simile alla divinità. Ognuno
sceglie il proprio amore e se lo costruisce e se lo adorna come se fosse una
statua per onorarlo e celebrarne i misteri. L’amore, quindi, consiste nel
trattare l’altro come qualcosa cheva costruito, come oggetto da plasmare,
modificandolo secondo un disegno ben preciso. Poi, tale atteggiamento
plastico, orientato alla trans-formazione, al cambiamento di forma del
proprio amato, si traduce in un lavoro di eliminazione e cancellazione, il
cui risultato sarà il diventare interamente una sola luce. L’amore non è
fusione statica tra due individui per quello che sono, ma corrisponde ad
una metabolé, adun cambiamento radicale, che coinvolge tutto il loro
essere, il cui fine è l’ottenimento di una perfezione luminosa. Amare
significa non solo esprimere un sentimento, investire l’altro col proprio
desiderio, possederlo sessualmente. Amare significa soprattutto costruire
l’altro, agire plasticamente su di lui, portarlo ad essere ciò che si pensa egli
possa e quindi debba diventare. Per ottenere tale scopo, è necessario fare
come l’artista, esercitare il tektàinein, e quindi ridurre, togliere, eliminare.
Si tratta di portare alla luce la bellezza, di farla emergere, eliminando le
impurità, scrostando le brutture che la celano, in modo tale che essa possa
risplendere in tutto il suo splendore. Per diventare luce pura, senza peso,
leggera, diventare divini, anzi essere divini. Ma forse l’aspetto più
originale della concezione di Plotino sul bello, più di altri destinato ad
influire sulla tradizione successiva, è rappresentato dal nesso messo in
risalto da Plotino tra to kalòn e thàmbos, tra l’apparire del bello e quella
forma di sentimento che è lo sgomento. Sintomo inconfondibile del fatto
che ciò di cui ci si dà contezza è il bello è lo stato d’animo, il turbamento
provocato dall’apparire del bello. Ma più importante è ciò che il trattato
dice sulla natura specifica delle emozioni suscitate dall’epifania del bello.
La bellezza è piacere e sofferenza. Da tale prospettiva, si può dire che
Plotino tramandi l’essenza di ciò che i greci avevano colto sulla nozione di
bellezza. Ciò a cui assomiglia è Armonia, della quale ci parlano Omero ed
Esiodo. Mai solo conflitto, mai solo amore, ma sempre l’una e l’altra cosa
insieme, ella vive della tensione tra la forza distruttrice del polemos e il
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 26 di 87
dinamismo unificante dell’éros. Il suo stesso nome comporta l’aggiogare
l’opposto e il selvaggio. Armonia non è solo l’accordo del molteplice, non
è la con-sonanza contro la dis-sonanza. E condivide il carattere dei fratelli,
Paura e Terrore. Di qui allora, il thàmbos, quell’indefinibile emozione
nella quale si avverte l’inscindibilità della meraviglia dal terrore. Insieme
alle altre considerazioni a cui si è accennato, tutto questo concorre a
spiegare perché nella cultura greca antica, e nello stesso Plotino, il bello
non sia patrimonio dell’arte, e ancor più originariamente perché il bello
non significhi ciò che piace, ma piuttosto ciò che è pieno. Il bello
appartiene ad un livello in cui può succedere che lampeggi l’essere come
avvenimento capace di suscitare quell’emozione complessa che è definita
thàmbos.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 27 di 87
GOETHE
Il mondo storico
Se si paragona l’atteggiamento di Goethe sulla storia con l’attenzione che
egli dà alla natura, si ha un netto dissidio. Nel contesto della ricerca
scientifica, Goethe si ambienta fin da subito, e quanto più egli va avanti,
tanto più si consolida in lui tale senso di affinità; qui non ha incertezze.
Come Goethe si definisce un poeta nato, così si sente naturalista nato. In
un progresso continuo, Goethe passa dalla mineralogia alla geologia, dalla
botanica alla morfologia generale, dall’anatomia comparata alla fisiologia,
dalla teoria dei colori alla fisica. Le scienze naturali, così egli nota, sono le
sole che portano ad un solido fondamento. Quando Jacobi gli mandò il suo
scritto Von der goettlichen Dingen und ihrer Offenbarung, nel 1811,
Goethe gli rispose che quella filosofia della fede non era di suo
gradimento, perché egli era come un orafo efesino che dopo aver passato
tutta la vita a contemplare, ad ammirare stupefatto e ad onorare il
misterioso tempio della dea, non poteva mostrarsi ben disposto verso un
apostolo che volesse imporre ai suoi concittadini un’altra divinità, ancor
più priva di forma. Così per Goethe nel progresso della conoscenza
naturale si pongono nuove questioni, ma tali questioni non gli danno mai
troppi problemi. Perché per lui è certo che ogni domanda che si rivolge
alla natura ha già in sé la certezza della risposta. Ma quando percorre
l’itinerario storico, Goethe abbandona subito tale senso di sicurezza serena
e di abbandono speranzoso. Quando Goethe parla di storia, si esprime in
lui un tono inaspettato. Quando il giovane Heinrich Luden, nel 1806, dopo
aver ottenuto la cattedra di storia a Jena, fece visita per la prima volta a
Goethe, questa diventò una lunga conversazione sui compiti dello storico e
sul valore gnoseologico della storia. Ma tale conversazione, iniziata in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 28 di 87
modo sereno ed obiettivo, diventa sempre più simile alla scena dello
studente del Faust. Goethe abbandona il tono asciutto, e impersona il
diavolo. Luden stesso racconta di non essere certo se a parlare fosse
Goethe o Mefistofele. Luden poi, durante la conversazione, sostiene che la
storia di un popolo è la vita di quel popolo stesso. Goethe ricorda come Sir
Walter Raleigh non avesse compiuto il lavoro storico che aveva
cominciato, ne avesse anzi bruciato il manoscritto, perché aveva assistito
ad un avvenimento che altri testimoni, in dissidio tra loro, avevano
descritto in modo diverso da lui. Non tutto quello che Goethe dice in
questa conversazione con Luden deve essere considerato in senso letterale;
molto deve essere concepito come un’iperbole polemica. Ma del resto egli
si sentiva mosso a tale polemica dalla storia, soprattutto quando diventava
storia politica. Non solo il suo fondamento di verità gli appariva
massimamente problematico, ma anche il suo contenuto destava in lui un
forte disagio. Immondizia e cantuccio. Al massimo un affare di stato. Così
Goethe scrive a Zelter sul fatto che tutto quello che è storico è una bizzarra
e contingente entità e diventa comica quando si riflette sulla possibilità di
accertarsi su un passato ormai troppo lontano. Goethe non ha avuto remore
a sostenere con durezza che il patriottismo che spesso si loda come virtù
dello storico, è la rovina della storia. Di fronte a tutti questi ostacoli ad
un’autentica concezione storica, non resta altra soluzione che smettere di
occuparsi delle singolarità degli eventi storici che non possono che restare
incerti per sempre, e rifugiarsi nella contemplazione della totalità della
storia universale; non collezionare fatti, ma dominare con lo sguardo intere
epoche, e così dominare il destino dell’umanità e le leggi che reggono il
mondo storico spirituale. Non solo nella storia naturale, ma anche nella
storia dell’arte e nella storia della scienza, Goethe ha gettato le basi per
una nuova concezione generale e per una nuova metodologia. La sua
caratterizzazione di Winckelmann resterà un capolavoro eterno nella storia
dell’arte; essa fu arricchita dall’opera su Winckelmann di Carl Justi, ma da
tale arricchimento ne fu solo, per così dire, rafforzata. Lo stesso vale per la
trattazione che Goethe ha esposto nei Materialen zur Geschichte der
Farbenlehre. La gran massa di materiale che si è prodotta dai tempi di
Goethe e l’enorme sviluppo dei saperi specifici, non ha aggiunto niente di
nuovo al quadro d’insieme delle età scientifiche e dei grandi scienziati che
Goethe ha messo in evidenza. Domina qui una notevole intuizione storica
che è quasi pari alla potenza ed alla sicurezza dell’intuizione del Goethe
naturalista. Come se l’allontanamento dalle considerazioni storiche, dalla
storiografia pragmatica, aprisse lo sguardo di Goethe sulla vera storia,
sulla storia spirituale. Perché ora non si tratta più di collezionare fatti, sulla
scia di incerte testimonianze; ora, di fronte allo sguardo di Goethe,
nascono le forme del passato e gli vengono incontro. Tale sorta
d’intuizione storica Goethe l’aveva individuata per la prima volta in
Herder, cosa questa che lo legò sempre a Herder. Ma tale risurrezione, tale
palingenesi storica è retta in Goethe da una legge diversa rispetto a Herder.
Essa è connessa profondamente alla fantasia lirica di Goethe e da questa è
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 29 di 87
sempre nuovamente alimentata. Goethe non solo avverte il passato, ma lo
vede anche; esso non è dietro di lui, ma penetra nella percezione
dell’attimo e ne determina la potenza. Con Lavater e Basedow era arrivato
una volta ai piedi di una meravigliosa rovina, e subito vide in alto, sopra i
merli, l’immagine del signore del castello, ritto, che con un cenno spettrale
salutava la nave che gli passava davanti, augurando buon viaggio. Goethe
stesso avvertiva tale facoltà di vedere passato e presente come se fossero
una cosa sola, come qualcosa di misterioso, di sinistro. In Dichtung und
Wahrheit dice in merito che in poesia essa agisce sempre in modo
benefico, ma nell’attimo in cui si rendesse presente subito alla vita e nella
vita stessa, introdurrebbe nel presente qualcosa di spettrale. Il giovane
Goethe arrivò nei suoi pellegrinaggi, di fronte ad una capanna solitaria, e
quando vi si avvicinò per chiedere dell’acqua, si diede subito contezza
delle rovine di un antico tempio sulle quali era sorta la capanna. Ma
l’aspetto fondamentale di tale sentimento di Goethe verso il passato è solo
in apparenza volto all’indietro e quindi non è romantico, né sentimentale.
Non è nostalgico; in esso si manifesta invece un modo immediato
dell’intuizione del mondo di Goethe. Goethe ha detto una volta
chiaramente di non stabilire nessun ricordo che sia solo un modo
impacciato di esprimersi. Tale fondamentale sentimento poetico-storico si
è dimostrato nel modo più profondo per Goethe, nell’intuizione della sua
propria vita. Ad esso egli deve se può guardare alla vita sempre come ad
una totalità senza cesure, se non deve romperla negli attimi fuggenti. La
certezza di tale struttura è quello che preserva Goethe dalla vecchiaia. Egli
avverte la vita come un cerchio misterioso, che si rinnova sempre, che
comprende in sé la giovinezza e la vecchiaia, e le traspone in una sola
corrente. Tale senso della vita e del mondo agisce così fortemente in
Goethe che spezza anche tutti gli ostacoli generazionali. Quando Goethe,
ormai vecchio, sente sempre più fortemente il desiderio di ricercare i
luoghi della giovinezza, quando si decide a quella Hegire del 1814 dalla
quale è sorto il West-Oestlicher Divan, egli non si avvicina a tali luoghi
con malinconia e col sentimento di aver perso qualcosa di irrecuperabile.
Tale intreccio profondo tra i singoli momenti della vita, diventa in Goethe
una fondamentale esperienza vissuta, e da questa è definita la sua biografia
ed il suo senso della vita. Se si paragona Dichtung und Wahrheit di Goethe
con altre opere dello stesso genere; se si compara tale opera con le più
famose autobiografie, come per esempio le Confession di Agostino e
Rousseau, risalta subito una palese differenza. Il pathos soggettivo di cui
sono pregne e dal quale sono infiammate tali opere, Goethe non lo
raggiunge, né vi aspira. In lui non ci sono quella profonda tensione
religiosa e quegli appassionati slanci interiori che conferiscono all’opera
agostiniana il suo marchio tipico; in lui non c’è quell’insaziabile necessità
di un giudizio sulla propria vita, con l’auto-giustificazione e l’auto-accusa,
che permea le Confessioni di Rousseau. Mai Goethe ha fatto valere la
potenza della sua intuizione concreta e della sua capacità di
rappresentazione concreta come qui, dove mette se stesso come oggetto
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 30 di 87
della rappresentazione. Dichtung und Wahrheit di Goethe non comprende
nessuna peripezia e nessuna catastrofe, nessun estremo drammatico.
Goethe ha rappresentato la propria vita, così come descrive la vita del
genio nel Mahomets Gesang, come una corrente che sorge da una fonte
segreta, che gradualmente attrae a sé sempre nuove acque, si gonfia con
potenza ed infine trascina nel suo moto ogni esistenza e la porta
all’oceano, il padre comune. La trattazione di Goethe mette di fronte il
ritmo interno di questo stesso puro scorrere, non un corollario di eventi
esterni e nemmeno una serie di esperienze interiori. Ancora una volta si
vede qui come storia e poesia siano inscindibili per Goethe. Il titolo
Dichtung und Wahrheit si riferisce a tale legame: il suo vero significato è
in questo, che non si tratta di rappresentare due momenti diversi, messi
l’uno accanto all’altro e legati tra loro solo all’esterno; ma che ci si deve
riferire ad un’unità originaria, dove trattazione storica e poetica
coincidono. E come tale sorta di intuizione poetica apra a Goethe
soprattutto il suo proprio essere, è ancor essa che lo porta alla conoscenza
ed alla comprensione di ogni altro essere. I drammi del giovane Goethe, di
primo acchito, appaiono rivolti alla storia ed essere mossi da questioni e da
interessi storici. Accanto al Goetz e all’Egmont ci sono anche i progetti
drammatici del Cesare, del Socrate, del Maometto. Così quasi tutta la
storia è qui davanti allo sguardo di Goethe e vuole diventare immagine
poetica. Ma tale immagine cambia sempre in un unico motivo, e converge
in un unico punto. Quello che sempre nuovamente attrae Goethe è la
relazione dell’eroe, del genio colo mondo: il modo in cui egli agisce su di
esso e le reazioni che deve subire. Da tale sentimento faustiano nascono
tutte le concezioni drammaturgiche e tutti i progetti drammatici del
giovane Goethe. Nel Maometto si sarebbe dovuti rappresentare come
anche la concezione religiosa più alta, nel momento in cui si rivolge al
mondano e prova a dargli forma, è soggetta alla contaminazione, è mutata
nella comune polvere. Tale fatalità in ogni evento storico interessò sempre
Goethe. Anche la storia politica egli la vide sempre da questo punto di
vista e solo su tale base provò a penetrarla e a darle una forma. Anche qui
egli mise l’accento sul fatto che quello che può attrarlo non sono gli
eventi, ma solo i caratteri. Nell’Egmont, solo l’eroe stesso e le figure
comprese nella cerchia della sua vita personale ed intrecciate col suo
destino personale, acquisiscono concretezza e vitalità; mentre gli
antagonisti politici, come Guglielmo d’Orange e il Duca d’Alba, hanno
qualcosa di vago e d’irreale. Nel momento in cui Goethe non vede gli
individui in quanto tali, ma deve concepirli come seguaci di forze storiche
generali, perde la sua forza poetica. Ma il senso umano della storia di
Goethe ha un nuovo trionfo nel momento in cui egli si rivolge alla storia
della scienza. Egli stesso afferma che un sentimento umano della storia è
fatto in modo tale da comprendere, in un giudizio dei meriti dei
contemporanei, anche il passato. Qui gli è stato utile l’essersi mosso dalla
storia dell’arte e l’avervi ritrovato un interesse sempre più vivo. Goethe
nelle sue opere di storia della scienza, ed in particolare nella parte storica
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 31 di 87
della Farbenlehre, si è attenuto al grande modello della storia dell’arte. Ma
nella trattazione di tutte queste questioni essa sempre è rinviata alla
considerazione dell’artista come suo fondamento. Goethe attua lo stesso
tipo di trattazione anche nel contesto della storia della scienza. Goethe è il
primo storico della scienza ad aver usato tale acuta concezione per le
singole personalità di scienziati. Quello che qui ha ottenuto, quello che, ad
esempio, ha dato nella grande caratterizzazione di Keplero, si ritrova allo
stesso piano delle sue grandi creazioni artistiche. A Cardano, ad esempio,
riconosce di avergli suggerito una maniera più ingenua ritrattare le scienze.
A partire da tale concezione fondamentale si arriva in Goethe ad una piena
trasformazione della teoria della certezza storica. Verso i fatti, verso la
massa di materiale storico tramandato egli rimane nel suo atteggiamento
scettico; al punto di affermare che tra storia e mito non si possa tracciare
un confine. Goethe scriveva una volta a Zelter, sul Napoleone di Walter
Scott, che con la sua trattazione si conoscono meglio gli uomini della
materia stessa e che ci si deve accontentare di ciò, perché se non ci si
atteggia con la storia come con il mito, alla fine tutto si mette in dubbio.
Goethe, anche nel periodo dello Sturm und Drang, non è mai voluto
apparire come un genio originale. Si doveva afferrare il vecchio Vero. Egli
considerava tale massima molto utile nelle scienze per scoprire e far
andare oltre il vero inadeguato che gli antichi già possedevano. Millantare
priorità gli appariva un ‘idiozia, poiché è solo presunzione da imbecilli
non volersi definire plagiari. Così egli afferma che la legge morale
fondamentale, tipica della scienza, consiste nell’imparare a legare la
propria attività e i propri risultati a quello che gli altri hanno fatto:
combinare il produttivo con lo storico. In questa espressione c’è per
Goethe la chiave di volta per capire la storia. Egli rifiutava quello che è
storico quando si presentava come mera materia; lo considerava come uno
strumento necessario per scoprire la forma del suo essere e del suo creare.
In questo senso Goethe ha usato la storia; perché, concepita così, essa non
era più in contraddizione con le qualità produttive, con le quali egli
formava il suo mondo, ma diventava essa stessa una qualità fondamentale
che gli apriva il mondo dello spirituale e glielo offriva in tutta la sua
ricchezza.
Il XVIII secolo
Nella caratterizzazione che in Dichtung und Wahrheit ha dato della
personalità e dell’opera di Johann Georg Hamann, il mago del nord,
Goethe individua il criterio al quale si possono ricondurre tutte le
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 32 di 87
affermazioni di Hamann nella proposizione per la quale tutto quello che
l’uomo prova a fare, sia con l’azione che con la parola, deve nascere da
tutte le qualità riunite: tutto quello che è isolato è da respingere. Mai si
coglie così dolorosamente tale impotenza della parola, tale ristrettezza
necessariamente legata ad essa, come quando si parla di Goethe. Ci si dà
contezza che anche per lui vale in senso più profondo, il criterio che tutto
quello che è isolato è da respingere. Non si può mostrare tale natura in
tutta la grandezza dell’opera di Goethe e nell’insuperabile varietà degli
effetti che ne nascono. Si seguono le diverse direzioni di tale forza, si
prova a comprendere chi fu Goethe come artista, come scienziato, come
pensatore; ma sempre nuovamente, in ciascuna di tali considerazioni , ci si
dà contezza che con tutto questo si misura solo l’ampiezza dell’esistenza
di Goethe, ma non se ne definisce e non se ne misura la profondità. Così
quindi qualsiasi affermazione su Goethe diventa una rinuncia. Si rinuncia a
definire l’unità ultima e la vivente totalità; ci si accontenta di individuare
ogni singolo momento che la mostri in modo mediato, che la indichi con
simboli e metafore. Se, in conformità a tale necessario limite, si dovesse
definire il particolare punto di vista, dal quale si muovono tali
considerazioni, ci si potrebbe riferire ad una necessità che Goetrhe stesso
una volta ha individuato come massima fondamentale, per ogni trattazione
di storia spirituale e di ogni comprensione specifica delle grandi
individualità. Goethe, in un suo saggio, si è scontrato con l’interpretazione
arbitraria della dottrina platonica, che era stata portata avanti nella
traduzione del conte Leopold von Stolberg. Se ne ricava ben poco, così
egli obietta a tale trattazione, quando si loda Platone come precursore del
cristianesimo, quando lo si vuol rendere compartecipe di una rivelazione
cristiana. Ciò che invece sarebbe necessario fare, sarebbe piuttosto una
trattazione critica delle condizioni nelle quali egli scrisse e dei motivi per i
quali scrisse. Così Goethe chiede che Platone sia considerato nella sua
epoca e compreso sulla base dei suoi problemi e dei suoi motivi. Se si
applica tale necessità a lui stesso, ci si pone la questione di come Goethe
stesso si sia messo in rapporto alla sua epoca; di quali premesse, motivi,
problematiche, e di quali decisini le è debitore e, considerati tutti questi
aspetti, cosa le ha dato di nuovo. Non si può slegare in modo arbitrario
Goethe dalle molte connessioni alle quali è legato; non si può metterlo in
uno spazio vuoto, ma si deve considerarlo nell’atmosfera storico-
spirituale, nella storia della cultura del diciottesimo secolo. Ma del resto si
avverte che sempre nuovamente tutte le regole che si applicano a tale
contesto, sono insufficienti, che con esse non si riesce a misurare la
profondità dell’opera di Goethe. Perché l’aspetto fondamentale
dell’esistenza di Goethe e della sua opera sta nel fatto che in esse si
compie un profondo cambiamento ed una riformulazione delle stesse
regole spirituali. L’opera di Goethe, vista da fuori, si trova nell’orizzonte
storico del diciottesimo secolo; ma le regole spirituali adatte a
comprenderla non si esauriscono in tale contesto. Se si paragona Goethe
alla sua epoca, ci si dà contezza non solo che egli la supera
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 33 di 87
quantitativamente, per ciò che concerne l’ampiezza di quello che in essa vi
è, di quello che da essa è conosciuto e accettato, ma che in lui c’è una
produzione qualitativamente nuova. Nemmeno nei più profondi spiriti
dell’ambiente vicino a Goethe, neppure in Lessing e in Herder, e neppure
in Kant, si trova tale trasformazione della materia spirituale, così in
profondità come in lui. Quando Goethe morì, nel 1832, il mondo, a
confronto con l’epoca in cui era nato, aveva un aspetto nuovo; la sua
fisionomia era mutata nel contesto della poesia come in quello della pura
teoria. E tuttavia, proprio tale cambiamento non sembra in alcun modo
voluto da Goethe, sembra non essere da lui in alcun modo ricercato,
sembra essersi sviluppato in modo arbitrario. Esso arriva a compimento in
silenzio, allo stesso modo di come, per Goethe, arrivano a compimento
anche tutte le trasformazioni dei fenomeni naturali. Goethe esclude dalla
considerazione della natura l’idea di un totale sovvertimento, di una vera
catastrofe. Scrive una volta a Wilhelm von Humboldt che questa maniera
di considerare i fatti geologici, come il vulcanismo, e di operare di
conseguenza, era impossibile per il suo sistema mentale. Quindi egli
poteva attenersi alle forme date nella sua epoca, anche quando egli stesso
era coinvolto nella loro trasformazione; poteva sentirsi vicino e lontano e
lontano e vicino alla sua epoca. Tale vicinanza e lontananza, tale continua
connessione col mondo delle idee del diciottesimo secolo, e la distanza
spirituale che Goethe ha avuto nei suoi confronti e che ha alimentato passo
dopo passo, sono i due momenti che vanno individuati e, a partire dai
quali, vanno svolte determinate considerazioni. Proprio Kant, nello scritto
Untersuchung ueber die Deutlichkeit der Grundsaetze der natuerlichen
Theologie und Moral del 1765, afferma che il vero metodo della
metafisica corrisponde a quello che Newton aveva introdotto con buoni
risultati nella scienza naturale. Anche l’introduzione metodologica di
d’Alembert all’Enciclopedia, anche il Traité de Metaphysique di Voltaire
sono in tale numero. Voltaire afferma che alla ragione umana non è
permesso penetrare l’essenza ultima delle cose e comprenderla in concetti
più generali. L’analisi è il bastone che la natura benigna ha messo in mano
agli uomini che sono ciechi; chi non lo sa usare, resterà per sempre nelle
tenebre. Nella fisica il Traité de Dynamique di d’Alembert e la meccanica
analitica di Lagrange; nella dottrina dello Stato e della società l’Esprit des
lois di Montesquieu; nella psicologia il Saggio di una nuova teoria della
visione di Berkeley, il Treatise of Human Nature di Hume e il Traité des
Sensations di Condillac, nei quali la forma fondamentale del diciottesimo
secolo si mostra più chiaramente. Non si può qui seguire tale sviluppo
nella sua interezza; se ne metteranno in evidenza quindi solo taluni singoli
motivi e momenti, particolarmente rilevanti per ciò che concerne Goethe.
Anche la teoria dell’arte poetica, una questione centrale della filosofia del
diciottesimo secolo, si trova sempre sotto il segno della predominante
concezione metodologica fondamentale. In Germania, con Alexander
Baumgarten, tale teoria è sviluppata subito sulle premesse della filosofia di
Leibniz e di Wolff; in Francia sono i principi logici fondamentali di
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 34 di 87
Cartesio e la sua dottrina dei criteri di verità che sono applicati alla
poetica. Qui non può e non deve esserci alcuna differenza di fondo, perché
il vero e il bello, nei loro principi e nella loro causa, corrispondono: rien
n’est beau que le vrai. Lo stesso motivo si trova nell’Art poétique di
Boileau, dove si vuole definire la logica della poesia, così come il
Discours de la méthode di Cartesio aveva definito la logica delle scienze,
ed in particolare la logica della matematica e della conoscenza naturale.
Come Cartesio aveva definito le regole obbligatorie della conduzione dello
spirito, così Boileau prova a mostrare la stessa regolarità nella creazione
poetica, come sua legge fondamentale. Alle regulae ad directionem ingenii
si accompagnano le regulae ad directionem poeseos. Non si deve
interpretare tale razionalismo, come se Boileau rifiutasse in blocco la
fantasia poetica, e come se ne rifiutasse la validità. Che nel processo
creativo poetico l’immaginazione mantenga il suo ruolo necessario, che la
sua cooperazione non debba mancare né nell’invenzione, né nella
rappresentazione e nella composizione, non è da lui mai negato. Ma tale
riconoscimento della sua fatticità psicologica, della sua funzione
psicologica, non conferisce all’immaginazione alcun valore particolare. Il
valore dell’opera d’arte non si fonda sulla potenza individuale e sullo
spirito individuale dell’immagine; esso deve essere commisurato ad una
forma superindividuale, a-temporale e valida in modo universale. Il
pensiero nuovo in poesia per Boileau c’est au contraire une pensée qui a
du venir à tout le monde et que quelqu’un s’avise le premier de l’exprimer.
Un tale essere oggettivo, che il poeta non deve creare, ma solo cogliere
come un dato, è soprattutto l’essere dei generi poetici. La tragedia e la
commedia, l’idillio e l’elegia, l’ode e l’epigramma sono tutte immagini
elementari della poetica che, in quanto forme fisse, non cangianti, statiche,
sono l’una di fronte all’altra. Tra loro non si dà alcun passaggio, perché
qualsiasi passaggio vorrebbe dire una violazione arbitraria, un’offesa alla
legge formale del singolo genere. Così il criterio della costanza delle
specie che è predominante nella biologia della prima metà del diciottesimo
secolo, è applicato anche alla poetica. Nella natura come nell’arte si può
evitare l’arbitrio, solo se si riferisce il fluire e la varietà a qualcosa di
identico e costante, e ci si attiene ad esso come al solo esistente. Quando si
riesce a determinare tale carattere, cioè ad esprimerlo in concetti chiari e
distinti, allora, da quel momento, è segnata la via della creazione artistica.
La legge del genere è, secondo natura, il prius: il pròteron te physei, che
regola tutte le altre forme particolari. La serie dei motivi che sono possibili
in ogni singolo genere, la limitazione della materia, lo stile ed il mezzo
espressivo, tutto questo è racchiuso in tale legge, come in un disegno.
Goethe stesso, nelle note alla sua traduzione del Nipote di Rameau, ha
individuato acutamente le linee fondamentali e lo scopo di tale poetica.
Ora, la concezione di fondo, espressa da Goethe in questo testo, non era
messa in discussione nemmeno dalla cultura francese del diciottesimo
secolo. Il diciottesimo secolo, nella poetica come nella politica, aveva
rifiutato l’assolutismo; anche Boileau è criticato: non lo si considera più
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 35 di 87
un’autorità assoluta. Lessing ha detto di Diderot che, dai tempi di
Aristotele, nessuno spirito filosofico aveva parlato di teatro oltre a lui. Tale
intenzione filosofica si esprime soprattutto nell’autonomia con la quale
Diderot si avvicina alla teoria tradizionale dei generi poetici. E
tuttavia,nonostante tale vivo sentimento per le necessità dell’individuale,
Diderot non è riuscito a liberarsi dai vincoli della teoria dominante. Infatti
egli non ricerca la liberazione nella negazione del concetto dei generi
poetici come l’aveva fondato il classicismo francese, ma nella sua
conservazione, per poterne solo allargare l’estensione. Così la sua poetica
non è una creazione qualitativamente nuova, non è un abbandono della
tradizione; essa vuole solo allargare, in senso quantitativo, il campo
d’azione della poesia e di aggiungervi nuovi contesti. Diderot si ferma alla
teoria dei generi poetici fissi; ma insiste sul fatto che la pratica artistica
passata, che il dramma classico francese, non ha prodotto le forme in sé
possibili del dramma. In tal senso Diderot trova tra commedia e tragedia
un ambito intermedio, mai sperimentato, un reame di mezzo di forme
poetiche in cui da un lato individua la Comédie sérieuse, dall’altro il
dramma borghese, la Tragédie domestique et bourgeoise. Già tale
formulazione mostra quanto poco Diderot si sia distaccato dalla
concezione tradizionale della natura dei singoli generi poetici, come tutto
il rinnovamento della teoria, cui egli aspira, sia rinchiuso entro il suo
contesto. Quindi Diderot non raggiunge il fine dell’individualizzazione
che si era prefissato, né in teoria, né in pratica. Le strutture che egli adotta
nel Fils naturel e nel Père de famille e nelle quali si svolge con molta
fatica in ogni direzione l’azione drammatica, sono schemi smorti, ai quali
egli prova invano a dare un’apparenza di vita. La teoria, che fa fallire i
suoi drammi, insegna che nel genre sérieux non si debba tendere ala
rappresentazione del particolare e dell’unico, alla reale rappresentazione
degli uomini, ma che il compito fondamentale consista nella descrizione
delle condizioni di vita generali, nell’elaborazione di determinate forme
della realtà sociale e civile. L’analisi dei caratteri, così com’è portata
avanti nella commedia, e l’analisi delle passioni, com’è rappresentata nella
tragedia francese classica, implica l’analisi di determinate strutture sociali.
Sono quelle che Diderot definisce circostanze e condizioni sociali. Con
tale necessità Diderot anticipa le future teorie del milieu del
diciannovesimo secolo. Nel Père de famille egli non descrive solo un
padre di famiglia in una condizione particolare, in intrecci sviluppati in
condizioni casuali; egli vuole rappresentare il contesto generale, l’essenza
del padre di famiglia in quanto tale, una forma tipica. Se questo non gli
riesce, così egli afferma nel Saggio sulla poesia drammatica, è una sua
mancanza, non una mancanza del genere, per il quale egli voleva proporre
un modello. Non sono i caratteri che nel dramma borghese il poeta deve
rappresentare, ma le condizioni di vita particolari. Ma quello che il teatro
deve fare è la rappresentazione del finanziere, del padre di famiglia, del
giudice, dell’avvocato, del letterato, del gran signore, del filosofo. Si
danno qui dei soggetti quasi interamente nuovi, purché si consideri che
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 36 di 87
sempre si danno nuove condizioni di vita, che niente è più vicino di tali
condizioni; ognuno ha la sua condizione nella società; ma si ha a che fare
con uomini di tutte le condizioni. Tale premessa e tale ricostruzione storica
erano necessarie, perché solo con esse si può valutare con chiarezza quale
cambiamento radicale si verifica, con l’apparizione di Goethe, nella storia
e nella teoria dell’arte. Goethe non volle tale cambiamento, non lo mise in
pratica coscientemente. Esso non risponde ad un atto libero, sia esso
poetico o teorico, ma si è messo in atto con l’essere di Goethe, con
l’archetipo della sua essenza. Lessing era stato in tal senso un precursore, e
la sua teoria del genio che non sottostà a nessun vincolo di leggi esterne,
ma che, con la sua spontaneità, si crea la regola, ha aperto la via a Goethe.
La critica di Lessing anticipa, nella pura teoria, quel concetto di poesia che
in Goethe diventerà reale. Ma del resto si sa quanto anche in Lessing
agisca la convinzione che la natura dei singoli generi poetici sia
determinata in modo rigido, oggettiva. Neppure Goethe in quanto teorico
dell’arte poetica ha mai rinunciato a tale concezione. E tuttavia tale
separazione delle opere d’arte in singoli cerchi magici vuol dire per
Goethe qualcosa di diverso da quello che aveva voluto dire per la poetica
del diciottesimo secolo. Infatti i generi non sono più uno schema prefissato
che impongano un determinato modo di trattare i motivi artistici, e nel
quale l’esperienza poetica dovrebbe essere ricondotta a forza. Questa sorta
di coercizione ha perso per Goethe la sua forza ed il suo significato. Tale
agire vivente, tale rivelazione dall’interno all’esterno, Goethe per primo
conquistò all’arte poetica in senso più profondo. Per lui non c’è più una
natura separata ed un potere separato dalla mera forma, una cornice fissa a
cui adattare la struttura poetica in fieri. Piuttosto è il processo interno della
struttura stessa che, insieme alla creazione, crea anche la sua forma
poetica, anche la sua misura immanente che da essa nasce. Contenuto
poetico è per Goethe contenuto della vita stessa; così che solo la vita può
determinare la forma adatta a tale contenuto. Così Goethe ha visto anche la
sua creazione poetica, ed ha sempre rifiutato ogni tentativo di valutarla con
un criterio esterno, ricavato dalla poetica dei generi. Nella conversazione
con Eckermann ricorda una volta che Schiller aveva deprecato nel Wilhelm
Meister l’uso del tragico, perché non confacente al genere del romanzo. In
tal senso tutte le opere poetiche di Goethe non sono irrazionali, ma
incommensurabili. Ogni lirica deve essere sensata complessivamente, nei
dettagli un po’ insensata. Ed egli vedeva tutta la creazione poetica dal
punto di vista della lirica e grazie ad essa che, in modo significativo, non
aveva trovato posto nello schema dei generi poetici di Boileau. In tale
nesso, che Goethe non ha definito come teorico, ma ha reso visibile nelle
sue creazioni, c’è la potenza incommensurabile di liberazione che da lui si
alimenta. Egli stesso ha concepito in tal senso il suo compito storico. In
tale affermazione è racchiusa la summa della poetica soggettiva di Goethe.
Goethe, per il quale non c’è nessun oggetto sia naturale, sia spirituale che
egli non tenti di mettere in relazione col suo pensiero e di penetrarlo con
esso, rompe tale relazione proprio dove si tratta del vero fondamento del
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 37 di 87
suo mondo, dove si tratta della qualità creativa originaria della poesia. La
spiegazione di tale paradosso è nel fatto che per Goethe tale qualità era la
reale, tipica fonte di luce che gli rendeva visibile la forma delle cose e la
forma del mondo umano; che egli non poteva, né necessitava di mutare
tale originario organo della vista in oggetto della vista. Goethe non ha mai
voluto elaborare una teoria estetica della creazione poetica, perché una tale
teoria non avrebbe corrisposto con la sua esperienza artistica. Delle sue più
profonde creazioni, come il Werther, egli ha detto di averle scritte in modo
inconsapevole, in una condizione quasi di sonnambulo. Tale interiore
processo del divenire, Goethe non tentò di vederlo dall’esterno, né di
regolarlo dall’esterno. Goethe fa nascere tali concetti dall’interno e quindi
li lascia liberi di agire. Il genio non si nega al legame, ma non lo riceve,
bensì lo produce sempre. In tale determinazione, Goethe ricomprende la
spiegazione del gusto estetico, e con questo dà a tale concetto una
profondità nuova, che non era mai stata raggiunta nel dibattito estetico del
diciottesimo secolo. La dottrina del gusto in Francia era legata all’opera di
Bouhour, Maxime de bien penser dans les ouvrages d’esprit; in Germania
a talune definizioni fondamentali della filosofia di Leibniz. Ad entrambi
gli orientamenti è comune il fatto di definire il gusto come una sorta di
giudizio, come un’argomentazione che non enuncia chiaramente le
premesse sulle quali si fonda e non le considera in particolare; ma che si
accontenta di una composizione immediata, di una rappresentazione
confusa di tali premesse. Così per esempio La Motte definisce il gusto
come un giudizio confuso e semplicistico, e Leibniz spiega che il gusto si
fonda su determinate sensazioni confuse, delle quali non si può dare
interamente contezza e che quindi sono simili all’istinto. Goethe invece, in
un certo senso, innalza il concetto di gusto ad una dimensione superiore
dello spirito, poiché egli non lo ricerca nella semplice contemplazione
dell’opera d’arte, ma lo fa agire nell’atto della produzione artistica. Le
creazioni più alte di Goethe sono nate da tale concezione fondamentale e si
sono espresse in maniera immediata. Certo, non raramente Goethe ha
preteso da se stesso anche creazioni poetiche determinate; quando ne
aveva l’opportunità, egli si ispirava per un’opera poetica, da mascherate,
feste, ecc.; e nella raccolta delle sue poesie c’è una sezione alla quale egli
stesso ha dato il titolo di Avarie persone. Componimenti per ricorrenze
festive . Ma sempre, quando si ritrovava in tale contesto, sapeva che non
era fatto per lui e che non avrebbe raggiunto la sua concezione dell’essere
e dell’essenza della poesia. In tal senso la poesia di Goethe ha una doppia
vita; ma mai si può dubitare dove sia il so vero fondamento. Goethe si è
sempre esercitato nell’arte, e non raramente ha fatto soggiacere la sua
creazione alla massima: siate poeti una volta, allora comanderà la filosofia.
Si avverte che fintanto che si applicano tali regole, sfugge il valore tipico
della poesia di Goethe, e non se ne coglie il significato più profondo. In
Hermann und Dorothea, Goethe ha aspirato alla corona omerica, e essere
omerico, finanche l’ultimo, gli appariva il suo più alto scopo. Ed i
contemporanei hanno polemizzato, mentre ancora era in vita, se il premio,
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 38 di 87
in tale contesa, dovesse essere assegnato a lui o alla Luise di Voss; se
Goethe o Voss fosse arrivato più vicino al modello epico omerico. Non si
paragona lo Hermann und Dorothea con Omero, così come non si
paragonano le Roemische Elegien con Properzio, o i Venetianische
Epigramme con Marziale. Nessuna delle poesie di Goethe può essere
considerata come espressione di un determinato genere; il loro senso ed il
loro valore si definiscono invece con la totalità dell’essere di Goethe e
della sua vita. Così in Hermann und Dorothea on si ricerca più la forma
tipica ed il modello poetico dell’idillio. Il poema è insieme idillio, epica e
tragedia; e proprio in tale insieme si può individuare la sua caratteristica
incommensurabile. Goethe lo definisce un idillio di provincia tedesco; ma
il suo profondo valore poetico è preservato grazie allo sfondo contro il
quale si staglia. Esso non ricerca tale stile che nasce da esso in modo
diretto, dal motivo fondamentale della concezione e dal presente, nel
quale, secondo Goethe, tale concezione scaturiva. Tale potenza del
presente non può arrivare all’imitazione di un modello prefissato; essa si
adatta solo alle vere creazioni simboliche. A queste solo è dato di fissare
l’attimo, di immergersi in esso, e tuttavia di superarlo come mero attimo.
Goethe stesso ha visto l’essenza del simbolo in tale determinazione. La
correlazione che si stabilisce qui tra la vita e la poesia di Goethe, è
misconosciuta, quando la si concepisce, invece che in tal senso simbolico,
in un senso realistico. Si creava così una tendenza della ricerca che non
aveva pace finché non avesse riportato ogni singolo aspetto della poesia di
Goethe a qualche esperienza effettiva ed a spiegare ogni forma cui egli
creava come una ri-produzione, quasi come un ri-tratto, di singole, reali
individualità. Tale interpretazione non si arrstò nemmeno di fronte alle più
pure forme mitiche: Mefisto doveva essere Merk e Faust doveva essere
Herder. Secondo tale concezione, fu sempre solo una somma di
impressioni esterne che definirono la creazione poetica di Goethe, ed alle
quali in un certo senso si avvicinava in modo molto graduale. Per dare ora
un esempio tipico di tale concezione, si consideri il modo in cui Hermann
Grimm, nelle sue lezioni su Goethe, descrisse la natura del Werther. Il
motivo fondamentale della composizione, così egli spiega, c’è già da
molto tempo in Goethe: l’amore per Lotte e il turbamento per la morte del
giovane Jerusalem ne determinano fortemente l’esistenza. A questo punto
la fortuna aiuta il poeta: nella relazione con Maximiliane Laroche e con
suo marito Brentano che era geloso, gli si presentò l’ultimo tassello
mancante per il romanzo. Una tale interpretazione di un così valente
studioso, di un interprete così sensibile qual era Grimm, suscita
l’impressione che la Goethe-Forschung, per un certo periodo, abbia visto
il suo compito specifico ed il suo scopo più alto nhel bandire del tutto la
fantasia dall’opera di Goethe. Gli interpreti di Goethe non raramente si
sono espressi come se si trattasse di quella fantasia per la verità del reale
che egli concepiva come la facoltà più alta, con la quale sostituire la cruda
realtà. Anche l’espressione di Goethe che tutte le sue poesie si originavano
da una determinata circostanza, è stata travisata da tale interpretazione. Ma
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 39 di 87
tale realtà alla quale Goethe si riferisce è quella interna al suo processo
vitale, e non quella esterna delle cose e dei fatti. Goethe non colleziona
eventi e persone reali nella sua poesia, ma rivolge all’esterno quello che
c’è e vive in lui; egli deve dare corpo e cambiare tale divenire interiore in
una forma sensibile. La poesia è come uno specchio che ha la qualità di
creare immagini, che non solo raccoglie i raggi, ma che, da un suo centro,
della vista, li emette e li fa nascere da sé. La concezione
dell’immaginazione poetica come qualità non solo ri-produttiva, ma
originariamente creativa, sintesi produttiva è diventata così comune che si
ha difficoltà a comprendere che, dalla prospettiva della storia spirituale,
non si è trattato di un’idea immediata, ma mediata, nata e alimentata a
fatica. Condillac afferma che sarebbe un errore provare a definire un
confine tra poesia e matematica, a partire da una particolarità della fantasia
poetica. Una volta individuato un tema poetico, che è indicato, come nel
Cid di Corneille, un determinato scontro tragico, lo scontro tra onore e
amore, è ivi racchiuso anche con univocità l’eventuale sviluppo. La
creazione dell’azione, la definizione dei caratteri, l’invenzione di
protagonisti ed antagonisti: tutto questo è questione di calcolo, che in
modo ben definito è comparabile alla soluzione di un problema algebrico.
Così Voltaire spiega che non si deve credere che le grandi passioni
tragiche ed i grandi sentimenti si possano variare all’infinito e si possano
rappresentare in maniere sempre nuove. Goethe, sia in rapporto alla
natura, sia in rapporto all’arte, si è ribellato contro tale concezione che gli
appariva un netto misconoscimento della tipica potenza originaria, della
potenza vitale della natura e dell’arte. A partire da tale considerazione
fondamentale egli si è battuto contro l’espressione composizione artistica.
Così Goethe si volgeva contro la falsa rappresentazione dell’ideale
artistico che crede di poter spiegare il senso dell’ideale, individuandolo
come qualcosa composta da belle parti diverse. Tale necessità, perlomeno,
non è un mero concetto tratto dall’esperienza e fatto di parti raccattate qui
e là; essa è un imperativo che può nascere solo dall’interno; dal centro del
processo creativo del formare. La psicologia poetica divide l’anima in
singoli settori e qualità ben determinati; prova a risalire a determinati stati
fissi, con i quali spiegare ogni fenomeno spirituale ed ogni moto
dell’anima. Goethe rimproverava Crébillion di trattare le passioni come
carte da gioco da mescolare, distribuire, di nuovo mescolare e di nuovo
distribuire, senza che cambino. Ma in tale concezione non rimane
nemmeno una traccia di quella chimica, con la quale i singoli motivi del
processo spirituale si attirano e respingono, si uniscono, si mescolano, si
neutralizzano, di nuovo si dividono e si ri-formano. Tale delicatezza della
psicologia, tale comprensione dell’insieme delle emozioni nel loro
divenire e nelle loro sfaccettature, tutto ciò è ottenuto per la prima volta
nel Werther di Goethe, nel Tasso, nelle Wahlverwandschaften. Napoleone,
in una conversazione con Goethe, aveva affermato, sul Werther, che un
difetto dell’opera sarebbe il fatto che Werther non sia mosso solo dalla
passione per Lotte, ma anche dal morboso desiderio di morire. Una tale
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 40 di 87
miscela di motivi non sarebbe naturale. Tale critica appare del tutto
insensata dal punto di vista psicologico e poetico; ma vale anche solo entro
tale cerchia ed è quindi nei riguardi di Goethe, una vera e propria petizione
di principio. Per Goethe non vale più il dogma che la perspicacia
dell’intuizione psicologica siano possibili solo con la partizione, e
discendano solo dalla separazione dei singoli motivi. L’ideale della
encheiresis naturae ha perso per lui valore, sia in relazione alla natura, sia
in relazione all’anima. Con tale principio direttivo di Goethe è quindi già
arrivato a compimento il passaggio dal contesto dell’arte a quello della
ricerca naturale. In realtà non si è mai avuta qui per Goethe alcuna
separazione. La sua concezione fondamentale è che non si conoscerà mai
la natura finché si proverà a coglierla come un semplice prodotto; ci si
deve spingere al centro della sua produttività, per afferrare la pienezza
delle sue forme o il loro nesso interiore. Ma l’uomo non può comprendere
tale creatività se non sulla base della sua propria creatività. A tale
concezione Goethe non venne mai meno, né come artista, né come
scienziato, e vi si dedicò senza alcuna remora critica; e da Kant egli, alla
fine, si sentì solo rinvigorito in tale convinzione. Per l’attività intellettuale,
come per l’arte e l’etica, rimane fermo che non si possa abbandonare la
speranza di diventare degni di una partecipazione spirituale alle sue
creazioni, contemplando la natura che crea in eterno. Ora soggetto e
oggetto non si oppongono più come cerchie separate dell’essere: infatti
l’attività del soggetto è il solo strumento, nel quale e con il quale si può
cogliere la verità degli oggetti, e tale stessa verità è un processo continuo
in divenire; un accadere ed un fare. Ed in questa sola premessa sono
individuati allo stesso tempo tutti gli aspetti tipici della maniera di Goethe
di trattare la natura. Con questo è messo in luce allo stesso tempo un
notevole parallelismo che non è mai stato notato, né apprezzato nel suo
senso più profondo dalla Goethe-Forschung. Si nota ora infatti come la
critica di Goethe alla scienza naturale del diciottesimo secolo segua
proprio quella stessa direzione che aveva individuato la sua critica della
poetica del diciottesimo secolo. In entrambi i casi egli si ribella allo stesso
difetto fondamentale; in entrambi i casi egli si oppone al rigido modo di
pensare che nulla possa divenire che già non sia, modo di pensare che, egli
afferma, ha attecchito in tutti gli spiriti. Sulla base dello stessa prospettiva
Goethe rifiuta sia la filosofia della poetica di Boileau, sia la filosofia della
botanica di Linneo. Ad entrambi egli rimproverava che con la loro maniera
di ricercare e definire il generale, dovevano necessariamente perdere la
pienezza del particolare. Come Boileau era stato lodato dai suoi
contemporanei come il legislatore del Parnaso, così Goethe individua in
Linneo e nei suoi seguaci i legislatori del regno vegetale. Ed a tali
legislatori egli rimproverava di essersi troppo preoccupati di ciò che è, ed
aver tralasciato ciò che deve essere. A tale disciplina razionale che tende al
riassunto, a semplificare, alla riduzione, Goethe oppone la necessità della
concrezione, dell’individualizzazione, dell’intuizione. Goethe avvertiva
subito la mancanza di tali immagini apparenti, quando le comparava ad
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 41 di 87
altre immagini ri-sorgenti continuamente dal fondo e dal centro del suo
creare poetico che si trasformavano sempre in ogni tipo di determinazioni,
permanendo nel loro divenire vitale. Pertanto egli sostiene che in quanto
poeta nato, gli era impossibile guardare il regno vegetale con gli occhi di
Linneo. Anche della natura, Goethe poteva contemplare solo quello che
era capace di rapportare al suo processo vitale e, sulla base di quello,
interpretarlo e renderlo visibile. Anche la pianta originaria, non era per lui
altro che una forma simbolica. Mai però si potrà pensare nella sua totalità
tale vita, che agisce in tutte le cose che sono, in tutta la sua ampiezza ed in
tutti i modi in cui si esprime. Il naturalista, per quanto si sforzi di restare
semplicemente un empirista e di non superare mai il contesto sensibile,
proprio quando vuole misurare tale contesto, deve nuovamente
immaginare. Infatti ogni conoscenza che non si voglia arrestare a mere
astrazioni, ma voglia divenire intuizione, è già di per sé creativa, e per
quanto i sapienti ricorrano ad espressioni apotropaiche di fronte
all’immaginazione, tuttavia, improvvisamente, devono ricorrere
all’immaginazione creativa. Quello che tale immaginazione disvela è uno
scoprire la forma fondamentale con la quale solo la natura opera e,
giocando, crea la vita dalle molte forme. Perché solo l’idea può legare in
profondità il simultaneo e il susseguente in una vera unità, mentre, dal
punto di vista sensibile, ciascuno dei due momenti resta separato. Ciò che
Goethe ha individuato come il principio metodologico fondamentale dei
suoi studi di morfologia, vale anche per la totalità dei suoi studi
naturalistici. L’esperimento è il principio e la premessa fondamentale; esso
deve essere sempre rinnovato e sempre ampliato; alla fine però
l’esperienza deve finire, deve essere introdotta l’intuizione di qualcosa in
divenire, ed essere espressa l’idea. Poiché non era capace di dargli tale
sorta di idealità, Goethe si è battuto contro la concezione meccanicistica
della natura e contro la fisica matematica, cui rimproverava di aver evitato
l’autentica teoria che non può essere ridotta a mere astrazioni, come uno
spettro, e di essersi rasserenata in un’esperienza frammentaria. Nella sua
battaglia contro la concezione meccanicistica della natura, Goethe non
necessitava certo di allontanarsi totalmente dalla prospettiva del
diciottesimo secolo; infatti nella totalità di tale prospettiva della natura, il
meccanicismo non è predominante. Nella forma in cui esso è elaborato da
d’Holbach e Lamettrie, non è mai stato accettato da tutti; nemmeno nella
cerchia degli enciclopedisti sono mancati pensatori che l’abbiano respinto.
Soprattutto il meccanicismo non è mai riuscito, nella filosofia naturale del
diciottesimo secolo, a battere il suo avversario: la teleologia rivendica, in
opposizione ad esso, il suo spazio e ha un credito quasi sovrano. La prova
teleologica dell’esistenza di Dio, preserva ancora parte della sua forza;
persino il sarcasmo di Voltaire si è, forse solo in parte, arrestato. Pertanto
non è la battaglia contro il meccanicismo, in quanto tale, che allontana
Goethe dal suo tempo. Il tratto tipico estraniante sta nel fatto che Goethe
parte da una nuova impostazione problematica, che erode la cornice nella
quale, fino a quel momento, era stata tenuta la questione. Tale posizione è
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 42 di 87
stata elaborata da Goethe prima di Kant, tanto da constatare poi, con
notevole soddisfazione, all’apparire della Critica del Giudizio, che la
concezione fondamentale che era stata presente in lui fin da subito, si
accordava su tale punto con Kant e che grazie a lui era criticamente
fondata. Ora egli considera un merito senza limiti che Kant abbia ottenuto
per il mondo e per lui, la liberazione del pensiero dalle assurde cause
finali, l’aver accomunato arte e natura, e l’aver conferito ad entrambe il
diritto di agire senza fini, sulla base di principi. Già tale formulazione
mostra come Goethe, anche se nelle conclusioni concordi con Kant,
proceda alla fondazione di una via tutta sua. La concezione, per la quale
un essere vivente è creato per uno scopo preciso e la sua struttura è data da
una originaria forza intenzionale, gli appariva una concezione volgare, che
proprio per questo è comoda per la natura umana. La forma più alta del
fare spirituale non sottostà più al dominio della volontà e dell’intenzione
esteriore. Così quel rovesciamento che compie Goethe, nella concezione
fondamentale della poesia, lo obbliga, anche in rapporto al concetto di fine
in generale, a seguire un atteggiamento nuovo e a mettere in opera una
svolta concettuale. Goethe si è spinto qui anche oltre Lessing. Lessing
infatti, volendo ottenere spazio per la libertà della creazione poetica,
garantì tale libertà, con la dottrina che il genio non è legato da regole
esterne, ma che egli stesso è il creatore della regola. Ma, secondo la
concezione fondamentale di Lessing, che promana dal suo essere
spirituale, tale libertà del genio la si può dimostrare solo nella perspicuità e
nella consapevolezza delle sue creazioni. Ma tale concetto di Lessing
dell’intenzione ha perso per Goethe ogni senso. Infatti sono il modo e la
tendenza fondamentali del Goethe lirico che non si fanno avvincere dal
contesto di tale concetto. Il poeta epico, il drammatico può ritrovare il suo
motivo poetico originario in maniera del tutto inconsapevole; ma quando
comincia a formare tale motivo, è necessariamente connesso ad un
determinato livello di trattazione. Così anche le più alte creazioni epiche e
drammatiche di Goethe, il Wilhelm Meister, le Wahlverwandschaften, il
Faust, mostrano tale potenza spirituale dello sviluppo, della consapevole
struttura, nella loro tensione e nella loro concentrazione. La lirica di
Goethe, invece, non ha tale consapevole formare e perfezionare. Qui non
c’è per Goethe alcuna pianificazione, alcuna volontà; c’è solo un profondo
maturare. Goethe ha usato sempre il paragone tra il divenire delle sue
poesie ed il divenire organico. Le sue creazioni liriche più alte: Die Braut
von Korinth , Gott un die Bajadere, la trilogia di Paria, come egli stesso
afferma, sono in tal modo sorte. Così il concetto di intenzione usciva dalla
creazione artistica e, in conformità all’armonia generale che per Goethe
c’è tra la creazione della natura e quella dell’artista, esso doveva essere
riconosciuto come insufficiente anche per questa. Qui come là non domina
per Goethe una semplice volontà, nel senso che natura ed arte perseguano
uno scopo; domina piuttosto un profondo dovere, al quale entrambe
devono soggiacere. Goethe adora definire tale dovere un dovere
demoniaco. Spesso Goethe, per definire tale demoniaco che deve essere
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 43 di 87
presente in ogni genio veramente artistico, si riferito a Mozart. Quando
respinge l’espressione per la quale Mozart avrebbe composto il Don
Giovanni, questo succede perché qui ci si ritrova di fronte ad una
creazione nella quale il particolare come la totalità sono nati da un solo
spirito, da un solo soffio di una sola vita, in cui il creatore non provava per
nulla, non frammentava, non procedeva in modo casuale, ma in cui lo
spirito demoniaco del suo genio l’aveva in pugno, cosicché egli doveva
fare quello che costui comandava. Il modesto sguardo che Goethe adotta
nei riguardi della natura, va rivolto anche alla sua stessa opera alla quale si
deve guadare come ad una natura che può essere compresa solo nella sua
interezza e nella sua intima pienezza. Sembra quasi che si contravvenga a
tale modestia, quando la riflessione inizia a sezionare anche questo
capolavoro di intrecci, ad analizzare una ad una le sue parti. Dopo aver
compiuto tale scomposizione, che tuttavia è ineliminabile sia per l’analisi
filosofica che storica dell’opera di Goethe, si avverte la necessità di ri-
comporre quello che faticosamente si è scomposto e di considerarlo
un’unità. Goethe stesso lo fa. Ciò succede in quella conversazione che
Goethe, nell’agosto del 1830, dopo lo scoppio della rivoluzione di luglio
in Francia, ebbe con Soret, l’istitutore del principe Karl Alexander. Nel
pomeriggio del 2 agosto, Soret visita Goethe e lo trova concorde
nell’eccitazione. Soret si riferiva agli eventi politici, insistendo in tal
senso; ma con meraviglia si diede contezza che tali avvenimenti non
avevano per nulla colpito Goethe. Ciò di cui egli parlava non erano i
disordini di Parigi, ma una riunione dell’Accademia, nella quale era
arrivata ad un conflitto aperto l’opposizione tra le teorie di Cuvier e quelle
di Geoffroy de Saint-Hilaire. L’uomo rispetto al quale Goethe si espresse
era da poco arrivato a conoscenza dei suoi lavori naturalistici: lo stesso
Soret, dopo tutto, aveva lavorato in quel periodo all’edizione francese
della Metamorphose der Pflanzen. Nonostante ciò Soret riconosce di
essere rimasto del tutto sconvolto dalle parole di Goethe. Il giudizio di
Soret è stato ribadito spesso dalla Goethe-Forschung. Si sorrideva come di
una bizzarria di Goethe, come di un suo capriccio di vecchiaia che, quando
il mondo stava andando in fiamme, egli si inabissasse nelle sue
elucubrazioni teoriche e nella passione per la botanica. Invece tale giudizio
è miope, perché non si dà contezza della più profonda caratteristica del
pensiero storico di Goethe. Anche la storia non è stata vista da Goethe se
non in modo simbolico. Egli pretendeva che dal momento storico fosse
fissata l’eternità, se voleva avere valore; ed egli la riconosceva non
raramente, dove altri occhi, diversi dai suoi, non erano capaci di vedere
alcun contenuto storico. Come per Goethe poeta, il poetico non è un
aspetto che si possa definire oggettivamente, che si trovi in oggetti
determinati e manchi invece in altri, poiché, come egli afferma, nessun
oggetto reale è impoetico, se il poeta lo sa usare. Ogni contesto, ogni
momento ha un valore infinito, perché è il rappresentante di un ‘eternità.
Un tale momento rappresentativo Goethe lo vide nello scoppio del
conflitto tra Cuvier e Geoffroy de Saint-Hilaire, e quindi volse ad esso lo
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 44 di 87
sguardo e fu interessato più in profondità ad esso che ad ogni altro evento
del giorno. Se oggi si ripensa all’epoca di Goethe, ci si dà contezza che
anche qui la visione del Goethe poeta e la sua intuizione di naturalista,
hanno guidato il suo spirito più saldamente di quanto avrebbe potuto fare
qualsiasi semplice interesse pragmatico per gli eventi storici. Quello che
Goethe vedeva in quella conversazione con Soret preserva ancora oggi del
tutto l’aspetto del pieno presente. Secondo Goethe, nella disputa tra Cuvier
e Geoffroy de Saint-Hilaire, non si trattava di una mera polemica tra dotti,
ma della decisione tra il suo metodo sintetico di trattare l’arte e la natura, e
la mentalità analitica del diciottesimo secolo. Per la storia spirituale, è però
molto interessante e stimolante non considerare l’esito al quale Goethe si
riferisce, in quanto tale, ma di renderlo comprensibile anche nel suo
divenire. Tra l’enciclopedismo che nella Francia del diciottesimo secolo
era la forza spirituale dominante e la concezione fondamentale di Goethe
non sembra possibile, di primo acchito, alcuna composizione. Goethe
stesso ha avvertito come estraneo il mondo spirituale degli enciclopedisti,
quando per la prima volta li conobbe da studente a Strasburgo. Ma da tale
giudizio generale, che si riferisce al Système de la Nature di d’Holbach,
Goethe esclude proprio quel pensatore che era stato il fondatore
dell’Enciclopedia e la sua guida spirituale. Di Diderot egli dice che gli era
molto vicino, e aggiunge che in tutto quello che i francesi gli biasimavano,
egli era un vero tedesco. Infatti Diderot, sia nella dottrina dei generi
poetici, sia nella dottrina dei generi naturali, aveva seguito una sua strada.
Nelle sue Prnsées sur l’interprétation de la Nature del 1754, egli,
fondandosi su princìpi di Leibniz, mutuati grazie a Maupertuis, aveva
chiuso col principio della costanza delle specie. Il divenire non si può
cogliere, per Diderot, con lo spirito analitico della matematica; poiché esso
può cogliere il cambiamento solo frammentandolo in elementi fissi e
spiegandolo in rapporto a tali elementi. Quello che hanno ottenuto i
Bernoulli e gli Eulero, i d’Alembert e i Lagrange nelle questioni principali,
non sarà più superato. La scienza naturale descrittiva darà la possibilità di
conoscere la vera ricchezza della natura nella pienezza delle sue forme e
nel loro incessante, reciproco compenetrarsi. Essa non proverà più a
rappresentare la natura come un sistema di generi e specie fissi, ma di
compenetrarsi nel suo vivo divenire; essa la concepirà come un infinito
processo vitale, che si rinnova continuamente, che si può cogliere con
l’intuizione, perché ci si ritrova nel suo centro. Si dà qui un orientamento
metodologico nuovo, tanto che Comte mise i Pensieri sull’interpretazione
della natura di Diderot, subito vicino al Discours de la méthode di
Cartesio ed al Novum Organon di Bacone. Ma è una caratteristica
spirituale di Diderot, quella di non saper proseguire finbo alla fine il nuovo
percorso che egli credeva di vedere di fronte a sé e che aveva individuato
in un aperçu. Per la prima volta nella Histoire naturelle di Buffon si
faceva avanti l’idea dell’evoluzione, per applicarla poi allo studio ed
all’interpretazione dei fatti osservabili. Egli si batte contro il concetto di
specie, creato da Linneo e da lui messo a fondamento della sua filosofia
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 45 di 87
della botanica, ed individua come metodo fondamentale delle scienze della
vita il metodo della descrizione, opponendolo alla spiegazione concettuale
logico-matematica della definizione. Buffon si batte contro quel sistema
della natura quando esso pretende di essere più di uno strumento per
orientarsi. A partire dalla sua concezione fondamentale, Buffon si
definisce, usando un’espressione tratta dalla Critica del Giudizio di Kant,
come uno dei primi archeologi della natura. Nelle parole di Buffon si
coglie già il nuovo ideale della conoscenza della natura che poi Goethe
elaborerà, a partire da altri e nuovi principi. Ed il seguace di Buffon,
Geoffroy de Saint-Hilaire è il primo a gettare le basi, è il primo naturalista
a mettersi dalla parte di Goethe e a lodare la sua opera sulla metamorfosi
delle piante come l’opera di un naturalista geniale. Ora, finalmente,
Goethe vede accettato il suo monito che un secolo che si affida solo
all’analisi e ha paura della sintesi, non è sulla buona strada; perché solo
analisi e sintesi insieme, come espirare ed inspirare fanno la vita della
scienza. In Geoffroy de Saint-Hilaire egli quindi vede un progresso
rispetto a Buffon e dopo tutto ne loda i meriti e la nuova fondazione delle
scienze naturali. Geoffroy de Saint-Hilaire, infatti, così egli lo loda, prova
a penetrare la totalità, ma non come Buffon in ciò che esiste, nel
sussistente, nel formato, ma nell’agire, nel divenire, nello sviluppo.
Secondo Goethe tale tendenza è una dimostrazione del fatto che anche la
conoscenza naturale non soggiace più solo alle leggi dell’intelletto, ma
che, anche in essa, si è già affermato il dominio della ragione. Se si coglie
la totalità di tali sviluppi, si ottiene il giusto punto prospettico dal quale
valutare la conversazione tra Goethe e Soret dell’agosto 1830. Ora si
comprendono quali sentimenti le notizie della disputa tra Cuvier e
Geoffroy de Saint-Hilaire devono aver suscitato in Goethe. L’attimo come
reale punto singolo del divenire per lui è come svanito; con meraviglia,
con sgomento dell’interlocutore, egli sembra estraneo al presente. Un solo
errore sembra aver commesso Goethe in tale visione unificante del passato
e del futuro. Se oggi si guarda all’opera di Goethe nella sua interezza, ci si
dà contezza di essere ancora in mezzo alla lotta per la creazione di tale
opera. Il tempo trascorso dalla morte di Goethe è stato pieno di illusione
sull’aver realmente compreso Goethe e, in particolare nel contesto della
descrizione della natura e della teoria dell’evoluzione, di aver compiuto le
sue aspirazioni. Goethe non è diventato un grande del passato, né nella
scienza, né in poesia. Le domande che egli ha posto sono ancora vive ed
esigono una decisione: le si avverte come nostre, come questioni presenti.
Quando Geoffroy de Saint-Hilaire introdusse in Francia la Metamorphose
der Pflanzen, spiegò che tale opera, di lodevole profondità, racchiudeva un
solo errore, ma un errore che solo il genio poteva commettere. Oggi, i
cinquant’anni d’anticipo sui tempi dell’opera, sembra un intervallo
temporale breve, infatti non si può oggi pensare in generale all’attività di
Goethe come se appartenesse ad un qualsiasi singolo secolo e ad esso solo
fosse legata. Così quindi anche lo studio dell’opera di Goethe non è legato
al tempo e al momento. Già è stato ricordato, sull’opera di Goethe, che per
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 46 di 87
lo scienziato non può esserci maggior felicità, né scopo più alto che quello
di rendersi meritevole, contemplando una natura in eterno creatrice, di
partecipare spiritualmente alle sue creazioni. Tale principio dà anche la
regola con la quale si dovrebbe provare a definire il rapporto con Goethe.
L’azione, però, che solo è opportuna nei riguardi di Goethe, e con la quale
solo si può veramente rendergli omaggio, è quella di compenetrarsi sempre
più in profondità nel suo pensiero, nella sua poesia e nel suo fare; nel
preservare viva la sua immagine, per essere meritevoli, contemplando tale
natura in eterno creatrice, di partecipare alle sue creazioni.
Platone
La profonda relazione di Goethe con Platone e col mondo spirituale
platonico non la si può misurare con la poca documentazione che si ha
sulla sua dimestichezza con gli scritti platonici. Solo al Timeo, come
mostra la Geschichte der Farbenlehre, egli dedicò uno studio
approfondito. Questa è la sola opera che egli sembra aver considerato e
letto in originale; delle altre opere, la biblioteca di Goethe a Weimar
conteneva, oltre all’edizione degli Auserlesene Gespraeche des Platons
nella traduzione del conte Leopold von Stolberg, solo una traduzione
tedesca del Fedone e delle Lettere platoniche. Niente lascia presupporre
che Goethe abbia conosciuto quegli scritti che sembrano fondamentali per
la comprensione del Platone filosofo, logico, dialettico, come il Teeteto, il
Sofista ed il Filebo. Molto più consistenti fluivano per Goethe le fonti
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 47 di 87
mutuate, dalle quali poter attingere la conoscenza del platonismo: per ciò
che concerne la storia spirituale tedesca del diciannovesimo secolo, per far
cenno alla profondità del fenomeno, basti ricordare i nomi di Shaftesbury e
di Winckelmann. Ma per una conoscenza storica, per una conoscenza
filologico-critica degli scritti platonici, Goethe non era molto preparato.
Del resto egli sapeva che un ritratto reale, pieno di Platone lo si poteva
avere solo sulla scia di una tale conoscenza. Al caos critico con il quale
Leopold von Stolberg aveva preteso di considerare Platone come
testimone della verità cristiana e di farne un compartecipe ad una
rivelazione cristiana, Goethe obietta che uno spirito come Platone può
essere compreso solo sulla base del suo tempo. Quello che soprattutto da
tale introduzione platonica si deve ottenere è quindi una descrizione critica
delle condizioni storiche nelle quali nacque la sua opera, e dei motivi ai
quali essa deve la sua nascita. Platone non va letto per edificazione ma per
conoscere un uomo eccezionale. Nel rovesciamento che la definizione di
Goethe sull’essenza della verità mostra, si coglie per la prima volta il
senso di tale definizione. Solo ciò che è fecondo è vero. Qui Goethe
attinge il fenomeno fondamentale ed il segreto vero di ogni concezione
storica: la questione come sia possibile superare la propria individualità e
creare dentro di sé l’intuizione oggettiva di un mondo spirituale estraneo,
solo con gli strumenti della fantasia individuale. Nell’introduzione di
Stolberg di Platone, egli avvertiva lo stesso difetto fondamentale che
sempre aveva avversato in una determinata concezione della natura: il
tentativo di avvicinare cose lontane come il cielo e la terra, avviluppandole
in una fantasia tenebrosa ed in un misticismo pretenzioso. Infatti ogni
grande personalità era per Goethe una natura, come egli si esprimeva, una
natura nella sua profonda verità, consistenza e pienezza. Così anche in
ogni sistema di pensiero, nella filosofia platonica ed aristotelica, stoica e
del criticismo, egli vedeva soprattutto la forma vitale dalla quale si origina
e che esprime in sé. In tale affermazione di Goethe si manifesta nel modo
più evidente la sua profonda relazione e la sua profonda posizione verso
Platone. Per capire tale posizione non si deve provare a cogliere la
concezione della natura platonica e di Goethe come un sistema di dottrine
che, principio dopo principio, dimostrazione dopo dimostrazione, si
oppongono tra loro. La filosofia platonica è soprattutto una dottrina
dell’essere: non solo essa, in opposizione a Democrito ed ai presocratici,
disvela e fonda una nuova intuizione dell’essere, ma definisce, per la
prima volta con chiarezza, il concetto generale dell’essere e quindi la
questione generale dell’essere. Platone stesso definisce in tale contesto il
merito tipico della sua dottrina ed il limite che la separa dai filosofi
precedenti. Ciascuno dei predecessori, così sostiene nel Sofista, ha
discusso sull’essere e dell’essere, ne ha ricercato una definizione, ma
nessuno ha veramente posto l’essere al centro della questione; nessuno si è
domandato cosa voglia dire la determinazione, la predicazione, la
posizione dell’essere in quanto tale. Così ogni filosofia non è stata altro
che una dottrina dell’esistente ma mai una dottrina dell’essere in sé. Non si
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 48 di 87
può pensare e parlare, senza tracciare nel pensiero e nel discorso su quello
che è pensato e detto, il segno dell’essere; ma nessuno ha definito quello
che tale segno voglia dire. Da tale prospettiva per Platone tutta la filosofia
greca, compresa quella di Parmenide, col suo principio dell’identità di
pensiero ed essere, diventa semplice mito dell’essere, al quale egli oppone
la sua dottrina come il primo vero discorso sull’essere. Tale discorso va
però ottenuto per negazione: il nuovo regno dell’essere si apre solo a chi
coglie il mondo sensibile, quello che la concezione comune del mondo
chiama mondo delle cose, come opposizione all’essere, come quello che
non è mai e sempre diviene. Come il Fedone insegna che chi vuole
spingersi fino alla verità dell’esistente, fino all’essere stesso, deve
afferrarlo col pensiero, senza vederlo, e senza usare qualsiasi altro senso
nel processo di successione ed inferenza. Come qui e nella Repubblica i
due regni dell’essere, l’invisibile regno delle entità fisse, e quello visibile
delle cose che non sono mai identiche a se stesse, ma sempre divengono,
nascono e periscono, si oppongono l’uno con l’altro in modo netto. Così
anche gli scritti dell’ultimo Platone, come il Flebo e il Timeo, nonostante
tutte le mediazioni che da questo momento sembrano darsi tra i due regni,
permangono in tale netta separazione tra essere e divenire. Anche quando
Platone si rivolge alla natura, il regno del divenire, anche quando
concepisce il logos nella natura, tuttavia il netto confine tra tale concepire
e quella vera conoscenza, la conoscenza della dianoetica e della dialettica,
resta per lui ineliminabile. Quello che si apre nella natura è sempre solo
un’immagine, una somiglianza del logos; poiché, proprio come prima, il
regno del divenire manca di conoscenza scientifica e resta soggetto alla
dòxa, all’opinione perché il divenire sta all’essere come l’opinione alla
verità. Se si paragonano tali affermazioni platoniche alla concezione del
divenire e alla definizione della ragione in Goethe, sembra non esserci più
tra le due alcun rapporto ed alcuna mediazione possibili, ma solo la più
netta opposizione. Infatti in luogo dell’antitesi tra ragione e divenire, c’è in
Goethe la loro ineliminabile correlazione; in luogo della contraddizione,
subentra il rapporto reciproco. Così nella concezione della natura di
Goethe, il pensiero della metamorfosi si apre come un concetto originario
della ragione, non come manifestazione di un fatto che si possa cogliere
coi sensi e nemmeno come un dato di un processo intellettuale analitico.
La fine dello sviluppo vuol dire anche la fine della comprensione: quello
che non nasce più non si può rappresentare nascente; quello che è nato non
lo si comprende. Goethe spinge tale pensiero fino alla negazione di ogni
scienza naturale inorganica. Come per Platone, conoscente e conosciuto,
soggetto ed oggetto della conoscenza, devono essere dello stesso genere.
Come Platone insiste sul fatto che, se l’essere non fosse mai fisso, ma si
sviluppasse in un cerchio eterno, nemmeno la conoscenza potrebbe mai
arrivare ad una profonda certezza, ad una determinatezza dei suoi concetti
ed enunciati; così in Goethe la stessa premessa formale conduce alla
conclusione opposta. Anche la geologia, alla quale Goethe si era dedicato
molto nei primi anni del suo nascente interesse per gli studi naturalistici, a
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 49 di 87
Weimar, ebbe, poi, la stessa condanna. Anch’essa diventò per il vecchio
Goethe solo una conoscenza dell’intelletto, adatta alla vita pratica, perché i
suoi oggetti sono morti, che non sviluppano più e non sono adatti quindi
ad una sintesi. In tali affermazioni, si coglie nettamente l’opposizione tra
la concezione fondamentale di Platone e quella di Goethe. Il divenire, che
per Platone individuava il limite della conoscenza, diventa in Goethe la
premessa e la forma della conoscenza. Goethe ha concepito tale metodo
che guida l’uomo nel cerchio labirintico del concepibile ed alla fine si
arresta solo ai limiti dell’inconcepibile, come massima fondamentale della
metamorfosi, soprattutto nella sua vecchiaia. Essa era per lui la
dimostrazione del fatto che Dio, dopo i sei giorni di creazione, non riposò,
ma era ancora più attivo del primo giorno. Contro l’empirismo della
concezione sensistica della natura, contro il razionalismo dei semplici
concetti classificatori della natura, che egli avversava soprattutto nella
concezione della botanica di Linneo, egli parteggiava per un modo di
pensare ideale. Quando deve scegliere tra Bacone e Platone, si definisce a
favore del secondo. In un primo momento inconsapevolmente, poi con
crescente chiarezza sul motivo fondamentale della sua ricerca, egli insiste
sul modello originario e tipico, presente in tutte le creazioni della natura.
Ma non vuole definire tale tipicità, altrimenti che in relaziona al divenire e
nel divenire: ed il senso, la potenza e la caratteristica del modo di pensare
ideale, li vede proprio nel fatto che esso consente di vedere l’eterno nel
transeunte. Se quindi per Platone all’acme del regno delle idee c’è l’idea
del bene, se essa è la conoscenza più alta e allo stesso tempo l’origine di
ogni essere, perché in essa il cosmo di essere e conoscenza arriva, in
quanto tale, a compimento, perché ogni cosa singola trae il suo senso e il
suo significato solo in rapporto al più alto fine ultimo; così ogni
considerazione di Goethe sulla natura emerge sempre di nuovo nella sola,
onnicomprensiva idea della vita. E mentre per Platone il bene, poiché egli
lo mette oltre l’essere, va anche oltre i limiti della vita, non c’è più per
Goethe alcun al di là, oltre il fenomeno della vita, alcun’altra trascendenza.
Nessuna pretesa concettuale è stata rifiutata da Goethe con maggior
nettezza di quella di ricercare, oltre il fenomeno fondamentale della vita,
un altro principio esplicativo, diverso da quello che è in essa. Insistendo,
così, sulla vita, Goethe pensa di aver superato quella dialettica con la quale
la dottrina platonica aveva combattuto fin da subito; egli pensa di aver
riunito in una sola intuizione della natura, e di aver così superato le antitesi
di unità e molteplicità, di quiete e di moto. Infatti la norma che regge ogni
fatto organico è fissa ed eterna, ma allo stesso tempo viva, cosicché gli
enti, che certo non possono discendere da essa, possono però perfezionarsi
in essa. Così l’esperienza di Goethe resta anche qui lontana da ogni
metafisica biologica. Goethe infatti è consapevole di avere nel concetto
della vita non la soluzione finale, ma solo un supremo concetto
problematico. Ma ora proprio la forma, intuibile coi sensi, come per
esempio la figura umana, che a Roma gli era apparsa come il massimo di
ogni fare e concepire umano, come l’alfa e l’omega di tutele cose
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 50 di 87
conosciute, lo porta subito ad un limite della contemplazione e del
concetto. Ogni tentativo di pensare l’imponderabile, la vita attiva in
eterno, come in quiete, deve diventare poi un problema. Goethe sembra
riservare un destino particolare al concetto platonico di idea. Definendolo
come intuizione della natura, intuizione del divenire, volendo superare la
separazione tra idea e fenomeno, sembra obbligato di nuovo a riavvolgere
l’idea stessa in nuove contraddizioni, ed a costringerla in tutte quelle
antinomie per la soluzione delle quali era stata in origine introdotta da
Platone. Ma proprio qui si disvela uno dei motivi fondamentali del
platonismo di Goethe. Platone era rifuggito alla contraddittorietà delle
cose, rifugiandosi nel regno dei puri concetti, per vedere in essi la verità
dell’essente. Solo il regno dei lògoi, delle forme incorporee poteva
garantire un rifugio contro l’inganno dei sensi e dell’immaginazione.
Goethe ha detto una volta di saper dare una sola risposta alla domanda sul
come idea e fenomeno possano essere legati nel modo migliore: con la
pratica. Il concetto di pratico racchiude qui il concetto di poietico, nel suo
più universale significato aristotelico, che per Goethe comprende in sé,
allo stesso tempo, il più vicino rapporto col suo mondo particolare, il
mondo della poesia. Qui si raggiunge l’imponderabile: nell’opera d’arte ci
si pone davanti un essere che si origina solo dalla visione spirituale,
dall’interiore attività del formare, che per sua norma e necessità esige di
farsi corpo sensibile. E di qui, dalla creazione dell’artista, diventa evidente
cosa Goethe opponga agli idealisti antichi e moderni, ed in particolare a
Platone e a Plotino: che una forma dello spirito non è limitata, quando si
esprime nel fenomeno, purché il suo esprimersi sia una vera creazione. La
bellezza ha la sua profonda verità non paragonabile a nessun’altra e da
nessun’altra sostituibile, che è la verità dell’immagine, la verità dei
momenti più alti del fenomeno. Tale verità dell’immagine in quanto tale, il
platonismo non la conosce; quindi l’artista Platone, in quanto filosofo, in
quanto pensatore della dottrina delle idee, deve respingere l’arte, perché
non procede dalla natura all’idea, dalla copia al modello, ma si arresta ad
una semplice copia della copia. Pertanto Platone, diversamente da ciò che
è stato detto, non è avviluppato dalla dottrina della copia, dalla sua
gnoseologia, ma dalla sua estetica: di qui ha origine la sua concezione
dell’arte come imitazione della natura, che Goethe ha avversato ed alla
quale ha opposto la sua concezione dello stile, come fondamento e qualità
originaria della creazione artistica. Ma quando Goethe confessa che,
secondo il suo modo di ricercare, conoscere, gioire, può attenersi solo ai
simboli, ha colto con questo anche il pensiero fondamentale del
platonismo, e se ne è impossessato. Anche Platone ha definito due simboli
non transeunti ad espressione della sua dottrina, che sono riuniti in un
famoso luogo: la similitudine dell’idea del bene col sole e l’allegoria della
caverna nella Repubblica. Alla sublimità dell’essere e della conoscenza,
l’uomo non può essere portato da un’estasi o da una visione immediata,
ma solo dal graduale innalzarsi oltre il sensibile, oltre il contesto
dell’opinione, della pìstis ed eikasìa, per arrivare infine, per il regno del
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 51 di 87
pensiero e della ragione, il regno della diànoia, oltre tutte le condizioni e i
condizionamenti del pensiero, nel supremo regno dell’incondizionato,
dell’anypòtheton. Solo quando si passa dalla diànoia al nous, dagli
ordinamenti ipotetici e condizionati, ai principi ultimi condizionanti, dalla
dianoetica alla dialettica, cade anche quest’ultimo limite della conoscenza.
Sembra quindi che l’immagine della Repubblica platonica appartenga a
quegli stessi motivi dei quali Goethe stesso riferisce che gli erano rimasti
impressi nell’animo e a lungo aveva serbati vivi nel suo profondo. Un
primo effetto di tale motivo lo si ritrova nel 1808, nell’introduzione
all’Entwurf einer Farbenlehre. L’antico mistico, cui Goethe si riferisce, è
Plotino, le cui Enneadi egli aveva letto da poco ed al quale nelle lettere di
quegli anni a Zelter, si richiamava, definendolo in tal modo. Ma la
trattazione di Plotino, in tale luogo, altro non è se non una parafrasi di
quella platonica. Ad essa si può rinviare, quando si ritrova il motivo
platonico fondamentale nella sua forma più profonda, in Goethe, all’inizio
della seconda parte del Faust. E tuttavia mai è risultato più chiaro anche il
momento intellettuale dell’atteggiamento di Goethe verso il platonismo. Si
vede di nuovo come la via che Goethe e Platone sembrano percorrere
insieme, non conduce allo stesso scopo. Anche Platone conosce il dolore
che si presenta alla vista quando si prova a fissare lo sguardo allo
splendore insostenibile del sole, ma egli pretende che la vista si abitui a
tale splendore insostenibile. Un’ascesa certa, una ànodos, una méthodos,
un metodo deve portare dal mondo sensibile a quello della conoscenza
matematica, dianoetica, fino alla più elevata conoscenza dialettica, alla
pura sapienza, all’idea del bene come mégiston màthema. Anche Faust,
anche Goethe percorre tale via, in un itinerario mai percorso,
impercorribile, il percorso verso le matrici. E così si rivolge di nuovo alla
terra, per celarsi nel più giovanile dei veli, e tale velo della terra, nel quale
si è celato, è quello stesso che Goethe definisce velo poetico, che riceve
dalle mani della verità. Nell’arte Goethe arriva finalmente alla vera
lontananza e alla vera vicinanza rispetto al mondo. Qui, dove non ci si
ritrova più nella cerchia del sensibile e tuttavia si resta nei limiti
dell’intuibile, Goethe coglie il vero ideale. Questa è la via che Goethe ha
percorso, sia come artista, sia come scienziato, ed essa sola tutti i suoi
concetti teorici hanno cercato di esprimere. Tale rimando si mostra nel
concetto fondamentale che Goethe ha definito per la scienza naturale: nel
concetto del fenomeno originario. Già la forma dell’espressione è un
paradosso, se la si misura con il metro platonico. Infatti per Platone, nella
sconfinata contingenza dell’esperienza, non c’è nulla di veramente
originario, ma solo un qualcosa di sempre più limitato. Per arrivare
all’originario si deve, per Platone, ricercare un altro genere di causa; si
devono abbandonare le cose, i pràgmata, e cogliere la verità dell’essente
nei concetti puri, nei lògoi. Secondo Goethe, invece, il concetto di
fenomeno originario è una sintesi estrema, perché in esso è definito, allo
stesso tempo, un concetto della visione ed un suo limite. Il rapporto tra
l’ultimo del fisico ed il primo del filosofo, sembra riportare di nuovo, in un
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 52 di 87
senso più profondo, da Goethe a Platone. La dialettica, non fa delle
premesse gli inizi, ma vede in esse dei veri fondamenti, dei punti di spinta,
sulla base dei quali, salendo sempre più in alto, aspira ad arrivare al
principio ultimo, senza premesse; dopo averlo raggiunto però si ritira,
attenendosi solo a quello che discende da tale principio, e così ridiscende
fino alla fine, senza tuttavia ricorrere a quello che è sensibile, ma solo alle
idee in sé e per sé, e in esse, nelle idee, termina pure il processo. Così
anche Platone mette vicino all’ascendere, il discendere. Il concetto di
partecipazione del fenomeno all’idea assume un significato diverso in
Platone e in Goethe. Tale partecipazione per Platone non sarebbe possibile
se non ci fosse tra il fenomeno e l’idea un regno intermedio che l’uno con
l’altra, cosicché, grazie ad esso, la totalità diventa un’unità connessa. La
matematica si trova per Platone tra il mondo del divenire e quello
dell’essere, tra il mondo della molteplicità e quello dell’unità. Tra il limite
e l’illimitato c’è il contesto intermedio del quanto, del posòn, il regno della
pura quantità. La natura, che prima sembrava appartenere solo ai sensi e
quindi all’inganno ed all’apparenza, alla sconfinata relatività della
percezione sensibile, ha una nuova determinazione, presentandosi come
oggetto scientifico, della conoscenza matematica della natura. Dal Fedone
il percorso prosegue fino al Flebo e al Timeo. Ora, grazie allo strumento
della matematica, un riflesso dell’idea suprema, un riflesso dell’idea del
bene cade anche sul mondo corporeo. Gli astri sono gli dèi divenuti
sensibili, come il mondo, in quanto totalità, è divenuto Dio. Ed il bene
supremo che conferiscono i sensi ed in particolare il loro mezzo più
nobile, l’occhio, sta in ciò che permettono di partecipare del riflesso di
questo Dio e quindi portano alla scienza, alla filosofia, della quale non ci
fu nessun bene maggiore, né mai ci sarà, per gli uomini, come dono
divino. Il cosmo in generale è composto di forme e numeri: pertanto
partecipa della bellezza. Come archetipi di ogni bellezza restano quindi
per Platone i cinque corpi regolari della stereometria che per la prima volta
furono scoperti nella sua scuola e con i quali egli fa prendere forma ad
ogni cosa visibile. Tutto ciò che è buono, afferma il Timeo, è
necessariamente bello; ma ciò che è bello è ordinato secondo simmetria:
pan dè tò agathòn kalòn, tò dè kalòn ouk àmetron. Anche il Flebo, che per
la prima volta nella storia del pensiero definisce il concetto di godimento
estetico, individuandolo nel piacere per i bei colori e le belle forme, per gli
odori ed i suoni, aggiunge anche che, per bellezza della forma, non si
intende quello che i molti desiderano definire tale, come per esempio
quella dei corpi viventi o di talune raffigurazioni. Di nuovo ci si ritrova ad
un punto in cui il mondo di Goethe e di Platone sembrano essere in
contatto, in cui tuttavia il divario tra i due è ancora più netto. Anche per
Goethe la bellezza, l’arte è la vera mediatrice tra idea e fenomeno. La vera
mediatrice è l’arte. Parlare d’arte vuol dire fare da mediatore alla
mediatrice. Anch’egli sostiene che la legge che penetra nel fenomeno, in
libertà, seguendo sue condizioni, crea il bello oggettivo. L’arte è un’altra
natura, intelligibile, anche se misteriosa; perché nasce dall’intelletto. Ma
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 53 di 87
tale intelletto di Goethe non è il logos platonico. Somma e divisione non ci
sono nella natura di Goethe. Goethe afferma che la prima e l’ultima cosa
che si pretende dal genio è l’amore per la verità, ma la sua verità, la verità
dell’artista, è diversa da quella che si può definire nella forma della
scienza oggettiva, nei numeri dell’aritmetica e nelle forme della geometria.
Anche da un altro punto di vista si può infine cogliere lo stesso rapporto
fondamentale tra Platone e Goethe. Platone non si attiene rigidamente a
quell’isolamento delle singole idee che sembra aver sostenuto nel suo
periodo intermedio; nel Parmenide, nel Sofista, nel Flebo, va oltre con
consapevolezza critica. In luogo della dottrina di Parmenide della totale
immobilità, subentra la pluralità e separazione delle idee; in luogo della
dottrina di Parmenide, per cui tutto è immobile, la dottrina che il
movimento è un momento necessario nella creazione e conoscenza del
mondo delle pure forme. Genesi non vuol dire più indeterminatezza, ma
diventa un modo per avere una determinazione: c’è un divenire verso
l’essere, una génesis eis ousìan. Ora anche il regno delle idee non appare
più un contesto separato; esso anima la totalità dell’essere: dalla
comunanza delle idee, la filosofia platonica va oltre, al pensiero dell’anima
del mondo. Nella natura di Zeus, nella natura dell’universo, risiede
un’anima regale, ed una ragione regale, grazie alla forza della causa prima.
Come si vede è per un problema interno alla dottrina delle idee che
Platone arriva alla sua dottrina della vita, dell’anima del mondo. Già nel
Fedone, Platone mette, vicino alle altre idee, vicino alle idee matematiche
ed etiche, le idee del retto e dell’uguale, del giusto e del bello, l’idea della
vita. Ora invece, dopo aver sviluppato fino alle estreme conseguenze il suo
metodo logico, nel Fedone, nella Repubblica, nel Teeteto, Platone si volge
alla natura, con una nuova mediazione. Per rendere comprensibile la
conoscenza nella sua validità, Platone parte dalla questione fondamentale
del giudizio. Nel giudizio si risolve l’apparente isolamento dei concetti; in
esso diventa chiaro che la verità e con essa l’essere non inerisce mai al
singolo concetto in quanto tale, ma solo alla composizione dei concetti ed
alla loro determinazione reciproca. Ci devono essere una composizione, un
nesso ed una separazione dei concetti, cosicché l’una pone o esclude
necessariamente l’altra, se si vuole conoscere diversamente l’essere. Dalla
questione logica della relazione, dalla questione del rapporto e del nesso
dei concetti nel giudizio, che Platone arriva ad una nuova valutazione del
movimento, del divenire. Dal finalismo formale dei concetti, Platone passa
al finalismo del contenuto, del dato di fatto. Come il sacerdote, in
conformità alle sue regole, sacrifica la vittima, non tagliando in modo
casuale, ma sempre alla stessa giuntura; così anche il dialettico deve
compiere le sue divisioni secondo l’articolazione naturale dei concetti. Si
sa, anche se da racconti indiretti, come Platone, nella sua scuola, si fosse
occupato di tale processo della divisione concettuale, della diaìresis, e
come fosse stato portato anche ad affrontare la questione della
disposizione delle forme naturali, i concetti biologici di specie con i suoi
ordini superiori e sottordini. Ma come nella Repubblica insegna che
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 54 di 87
l’astronomia, che l’ordine e il corso degli astri non sono meritevoli di
considerazione in sé e per sé, ma solo in quanto vi si danno esempi per il
calcolo matematico; così per lui l’intero regno delle forme naturali è solo
un unico grande esempio, un paradigma per cogliere i rapporti delle pure
forme concettuali. Dove Platone parla di connessione e divisione, di
diaìresis e di synagogé dei concetti, Goethe parla dell’eterna sistole e
diastole della vita che si separa da se stessa, per tornare a se stessa, in
sempre nuove creazioni. Dove Platone individua una questione logica,
Goethe parla dell’intuizione della sygkrisis e diàkrisis del fenomeno
originario. Platone considera unità e molteplicità come due momenti logici
necessari al giudizio; Goethe parimenti vede nell’inspirazione ed
espirazione un solo processo vitale. Se quindi Platone era portato dalla
sygkrisise e diàkrisis dei concetti a quella della natura, per Goethe vale
esattamente il contrario. La vita inconcepibile, la cui intuizione per Goethe
è l’ultima cui si possa arrivare, forma un tipico dissidio con l’idea
platonica del mondo e della vita, con i viventi intelligibili, col noetòn
zoon, sul cui modello è formato tale cosmo visibile. Infatti tale vivente
intelligibile di Platone ha in sé le idee di ragione di ogni vivente, così
come tale mondo ha gli uomini e tutte le creature visibili, ed è quindi esso
stesso un contenuto razionale più alto; è la cosa più bella e, sotto ogni
rispetto, la più perfetta in ogni pensato. Il fenomeno originario al quale si
riferisce Goethe è per Platone un supremo pensato, un supremo
conosciuto: una chiusura nel regno dei noumeni. Così si mostra sempre
nuovamente, nel paragone tra Platone e Goethe, come si tocchino due
universi spirituali, e come, del resto, nonostante ogni similitudine, si
oppongano, per determinati motivi oggettivi, due persone capaci, ognuna
delle quali concepisce la totalità delle questioni del mondo e della vita, a
modo suo.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 55 di 87
LA VITA: COSE, MONDO E NATURA
Le cose
C’è un poemetto del I secolo d.C., per molto tempo attribuito a Virgilio,
che descrive bene il clima del presentarsi delle cose nella loro iniziale
indeterminatezza, quando riappaiono sulla scena del quotidiano irradiarsi
della luce, che le distoglie dal nascondimento notturno e le ripropone. Si
tratta del Moretum, in cui un contadino, Simulo, svegliatosi al buio, si alza
sollevando il corpo, scivolato dal misero letto e con la mano esplora le
tenebre e cerca il focolare per ravvivare, soffiando la cenere, il tizzone
ardente. La luce elenca le cose, distinguendo le varie coltivazioni: il
cavolo, le bietole e il ravanello con la zucca. Per definire la riunione con se
stessi dopo il ritorno dal mondo notturno, Proust ha usato un’immagine
che ricorda i soldatini dell’infanzia: un sonno di piombo. E sembra di
essere diventati se stessi, nei brevi attimi che seguono il sonno, un ometto
di piombo. Non si è più nessuno. Quando si pensa nuovamente, non
succede mai che un’altra personalità diversa dalla prima si incarni.
Perché? Risorge l’ordine delle parole e delle cose: si ritorna nel
quotidiano, ci si ricollega a passate esperienze e si risvegliano ansie sopite,
mentre le cose riacquistano la loro apparente inerzia. Si osservi come
Virgilio e Ovidio descrivono il riposo di tutti gli esseri nella natura in
quiete. Dice Virgilio che era notte, e in terra i corpi stanchi riposavano, e si
erano placati i boschi e il mare, quando le stelle si volgono a metà del
corso, e tacciono i campi, le greggi e gli uccelli, e gli esseri acquatici e dei
rovi: dormienti nella notte silente placano le pene e i cuori dimentichi
degli affanni. Ovidio ripropone tale topos dicendo che la quiete profonda
aveva liberato nel sonno uomini, uccelli ed animali e senza rumore stavano
inerti le siepi e le fronde; umida taceva l’aria: solitarie brillavano le stelle.
Molto dopo, nella poesia di Nikolas Lenau il tema ritorna con riferimento
agli uccelli che si agitano nel sonno, immersi nella profondità del canneto,
in un inerte stagno notturno illuminato dalla luna. Per l’evocazione del
risveglio nelle società antiche ci si può riferire a questo passo tratto da La
morte di Virgilio di Herrmann Broch, dove l’arrivo imminente del giorno è
annunciato dal risuonare delle cose passate, dal respiro degli animali e
dagli uomini che vanno al mercato: la fila dei carri avanzava lentamente; si
sentiva il rumore delle ruote sul lastricato, lo scricchiolio degli assali, lo
stridere dei cerchioni contro le pietre, il cigolio delle catene; ma a volte
ansimava un bue, a volte echeggiava un richiamo sonnolente. Il respiro
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 56 di 87
delle creature viventi percorreva la notte e con loro respiravano i campi,
gli orti e i frutteti, e il respiro dell’universo si apriva ad accogliere le
creature. In alcune pagine iniziali della Recherche di Proust, il risvegliarsi
repentino del protagonista in piena notte genera in lui un totale
disorientamento: non sa più dove si trovi e non è più capace di ripristinare
l’unità e la consapevolezza del proprio io. Come traccia impercettibile
resta però il sospetto, generato dalla non subitanea ricostruzione delle
coordinate, che la pretesa stabilità delle cose non sia spontanea, ma rifletta
la rigidità dell’organizzazione mentale umana: forse l’inerzia delle cose è
imposta dalla certezza che sono esse e non altre, dall’inerzia del pensiero
verso di esse. La descrizione di un foglio di carta sul tavolo potrebbe, per
esempio, non finire mai: più lo si guarda, più disvela le sue tipicità. Ogni
atteggiamento nuovo dell’attenzione, dell’analisi, fa scoprire un nuovo
particolare: l’orlo superiore del foglio è di poco rialzato; alla terza riga, la
linea continua diventa punteggiata. Considerando la condiscendenza degli
oggetti percettivi, definire i confini delle cose vuol dire sovente scegliere:
la linea non imita il visibile, ma rende visibile, dice Klee. Si considerino i
valori del focolare o, in altre culture, quelli della stufa, che nella Cina
ottocentesca era stata divinizzata, diventando Dea Stufa, simbolo della
famiglia e del ceto sociale di chi la possedeva. L’italiano cosa è la
contrazione del latino causa, cioè di quello che si ritiene così importante
da muoversi in sua difesa. Respublica non individua pertanto una mera
proprietà comune, ma il fondamento di ciò che riguarda tutti, che merita di
essere discusso in pubblico e, quindi, fonda il senso di appartenenza dei
cittadini alla comunità. L’aggettivo publica di respublica sembra legarsi a
pubes, che individua in latino la maturità dei ragazzi/uomini capaci di
portare le armi, di poter essere arruolati e, per estensione successiva, di
tutti i cittadini occupati nella difesa e nell’implementazione del benessere
comune. Cosa è, in un certo senso, l’equivalente concettuale del greco
pragma, della latina res o del tedesco Sache, parole che niente hanno a che
fare con l’oggetto fisico in sé e nemmeno con l’uso corrente del tedesco
Ding o dell’inglese thing, ma che hanno tutte un nesso necessario non solo
con le persone, ma anche con la sfera comune del dibattere e deliberare.
Pragma, Sache, res rimandano tutte all’essenza di ciò di cui si parla o di
ciò che si pensa e si sente in quanto interessa. Res rinvia nella sua radice a
ciò di cui si dibatte perché è interessante. Il termine pragma ha in greco
una varietà di significati che comprende la questione, la cosa che riguarda,
ciò in cui si è coinvolti nel quotidiano, l’argomento da dibattere e su cui
deliberare in tribunale o in assemblea, il preoccuparsi di qualcosa e
l’affare. I suoi composti più notevoli sono, in politica, l’apragmosyne,
l’astenersi dalla vita politica, e la polypragmosyne. In filosofia, pragma è
introdotto da Aristotele in un’espressione, auto to pragma, cosa stessa, che
assume un significato specifico. Definisce sia i fatti come stanno
realmente, a prescindere dai nomi che si usano in un’argomentazione, sia il
processo con il quale la verità stessa obbliga il pensiero a indagare in una
determinata direzione: quando gli uomini arrivano a questo punto, le cose
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 57 di 87
stesse gli aprono la via, e li obbligano a proseguire la ricerca.
L’espressione hegeliana die Sache selbst è un calco dell’auto to pragma
aristotelico, così come ne è una riproposizione il motto di Husserl zu den
Sachen selbst come invito a tornare alle cose stesse. Il ragionamento di
Husserl ripropone quello aristotelico: non ci vuole accontentare di pure e
semplici parole, cioè di una comprensione simbolica delle parole. Non
bastano i significati ravvivati da intuizioni confuse, da intuizioni indirette.
Si deve tornare alle cose stesse. Tale ritorno presuppone, in ogni caso,
anche l’itinerario inverso, dai contenuti volti all’analisi concettuale,
metafore e simboli che consentono di comprenderli: zu den Sachen und
zurueck. L’auto to pragma aristotelico e la Sache selbst hegeliana sono
entrambi legati all’idea di vis veri, alla sussistenza di un istinto di verità
che muove gli uomini alla sua ricerca. Hegel lo sostiene con forza, citando
Dante, che compara l’intelletto umano a un animale che ritrova da solo la
sua tana. Nel prospettare la vis veri, l’auto to pragma e la Sache mettono
su lo spettacolo del dipanarsi di una matassa di significati sull’essenza di
qualcosa. Tutto questo accade in dissidio con il percorso della coscienza
individuale, che si avvicina lentamente a comprendere l’essenza della
cosa, con un moto a luogo che parte dalla dimensione soggettiva ed è
definito per noi da Aristotele e, con un altro calco, fuer uns da Hegel.
L’auto to pragma e la Sache selbst rappresentano, invece, lo sviluppo
conciso, rettilineo e logicamente consequenziale del ragionamento sulla
base di assiomi non dimostrabili: il rovesciamento del per noi, del tentare e
ritentare della ricerca con tutte le difficoltà di una soggettività non ancora
in armonia col vero. Il modello più consistente di auto to pragma è quello
degli Elementi di Euclide, dove, nella dimostrazione di un teorema, è come
se fosse la cosa stessa, mossa dalla vis veri, a disgelare gradualmente la
sua essenza a chi sia disposto a seguire i passaggi imposti dal metodo.
Nella Fenomenologia anche Hegel mostra come, per cogliere l’auto-
movimento della cosa stessa, è necessario stare a guardare, perdendosi
nella cosa per esprimerne l’essenza profonda: la conoscenza filosofica
necessita che ci si abbandoni alla vita della cosa o che se ne abbia presente
e se ne esprima la necessità interiore. Se, per definire la necessità di una
rottura dinamica dell’equilibrio, Hegel si riferiva negli scritti giovanili
all’unione dell’unione e della non-unione, l’inscindibile nesso di soggetto
ed oggetto è nella Fenomenologia sottoposto al primato della soggettività:
tutto discende dal concepire e dall’esprimere il vero come soggetto. A tale
modello di sviluppo automatico della cosa rinviano anche i detti rem tene,
verba sequentur e res ipsa loquitur: se si è afferrata l’essenza
dell’argomento le parole verranno da sé e la cosa stessa parla. Dopo tutto,
il termine greco ousia, sostanza, definisce in origine il campo da cui il
contadino trae il suo sostentamento. Valore analogo ha oggi lo spagnolo
res, bue, animale fondamentale alla sussistenza della famiglia contadina.
Auto to pragma e Sache selbst si distinguono da pragma e Sache, proprio
perché insistono sul processo di sviluppo automatico di una verità già
raggiunta, che parla in prima persona, mentre gli altri si riferiscono
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 58 di 87
soprattutto alla discussione e alla ricerca, momento in cui la cosa ri-
comprende i suoi attributi e si forma gradualmente in teoria ed in pratica.
In Hegel il senso di Sache e di Sache selbst assume un’altra curvatura, che
preserva però l’essenza dei significati presenti in altri testi e contesti. Egli
mostra come l’individuo si realizzi nel fare, ma anche come, pieno di
presunzione di essere il solo a sfuggire alla corruzione del prossimo,
voglia poi rappresentare la causa comune, mentre in realtà non rappresenta
altro che il suo limitato interesse, la causa privata. La Sache selbst,
risultato del fare di tutti e di ciascuno, è quell’esito anonimo di cui
ciascuno vorrebbe impossessarsi in una specie di guerra hobbesiana di tutti
contro tutti che si combatte sul terreno del regno animale dello spirito,
dove il singolo non si dà contezza di essere condizionato dal mondo
storico e agisce come se fosse in un mero ambiente naturale. Come
mostrano i modelli che Hegel ha in mente, dal perseguimento del proprio
interesse nascono effetti inaspettati, perché l’ostilità reciproca causa il
movimento delle energie individuali e la maturazione dell’individuo.
Quando la Sache selbst ottiene la sua autonomia, svanisce l’autoinganno di
chi voglia promuovere la causa comune. Nel confluire, le molteplici cause
private trascendono la loro tipicità e si elevano al piano comune del Geist.
Esso nasce dalla Sache selbst come suo prolungamento e supera, in un
processo infinito verso il benessere comune, le contraddizioni in cui si
avviluppa il fare individuale. Nella Fenomenologia l’opera di tutti e di
ciascuno confluisce nel darsi della sostanza etica, spazio pubblico, mentale
ed affettivo, che fonda una determinata civiltà. Essa è capace di dirigere il
fare individuale perché, separandosi dalle loro cause private e divenuta
oggettiva, ha ottenuto valore, esemplarità che li trascende. Più in generale,
oltre la sfera etica, la metafisica classica riduceva la cosa agli elementi
logici fondamentali, al suo concetto. Il vero, per tale metafisica, non erano
le cose nella loro immediatezza, ma solo le cose innalzate alla forma del
pensiero. Quella metafisica riteneva che il pensiero non fosse che qualcosa
di estraneo alle cose, anzi fosse la loro essenza, cioè che le cose e il
pensare le cose fossero coincidenti, che il pensiero nelle sue
determinazioni fenomeniche, e la natura delle cose, fossero un solo
contenuto. In Hegel tale metafisica diventa ontologia, sistema capace di
unificare essere e pensiero. Egli non vuole solo conoscere, come in Kant, i
fenomeni che si manifestano ai sensi e all’intelletto per una misteriosa
cosa in sé; vuole conoscere la realtà effettuale, farle acquisire il linguaggio
della Sache selbst. A livello logico, l’ontologia si articola in categorie che
reggono non solo ogni rappresentazione, ma anche ogni contenuto della
mente, perché sono la rete adamantina nella quale si tras-porta il materiale
e con la quale solo lo si rende comprensibile. Oggetto è, invece, un
termine più nuovo, che risale alla scolastica medievale e sembra essere un
calco teorico del greco problema, problema concepito in un primo
momento come ostacolo che frappone per difesa, un impedimento che,
frapponendosi e sbarrando la via, ostruisce il percorso e genera un arresto.
In latino obicere significa gettare contro, mettere davanti. L’idea di
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 59 di 87
objectum comporta quindi una sfida, un’opposizione con quanto impedisce
al soggetto la sua immediata affermazione, con quanto obietta alla sua
volontà di dominio. Nessuna di tali espressioni si riferisce agli oggetti in
modo esclusivo, mentre ciascuna rimanda alla logica, alla ricerca, alla
pratica o alle relazioni umane. Il latino subjectum traduce il greco
hypokeimenon e definisce il sostrato che regge le qualità o gli accidenti
della materia. Da Aristotele alla scolastica, soggetto è ciò cui si
attribuiscono determinazioni o al quale tali determinazioni ineriscono.
Volendo essere più precisi, è l’oggetto reale cui si riferiscono le
determinazioni predicabili oppure la sostanza cui ineriscano qualità.
Ancora in Locke soggetto definisce il substratum o sostegno. Seppur egli
usi i termini soggetto e oggetto ancora in senso scolastico, si considera
Cartesio l’iniziatore della soggettività moderna. In realtà, quando gli si
attribuisce l’inizio della modernità, si pensa al cogito come luogo
dell’evidenza incontrovertibile che fonda ogni conoscenza. Sulla base
della sua ammissione di recitare nel gran teatro del mondo, Cartesio è però
spesso presentato come un Prometeo furbo che dona agli uomini la
razionalità e la libertà di scegliere secondo evidenze razionali. Solo con
Kant e, soprattutto dopo di lui, la soggettività diventa sinonimo di
consapevolezza e autonomia individuale. Oggettivo è l’aspetto non dubbio
del fenomeno, il luogo comune accettato senza discutere, l’apparenza fatta
di dati categorizzati: e cioè il soggettivo; e soggettivo è quello che rompe
tale apparenza, quello che penetra nella particolare esperienza
dell’oggetto, si libera dai pregiudizi e situa la relazione con l’oggetto in
luogo della risoluzione maggioritaria di coloro che, nonché pensarlo, non
lo vedono nemmeno e cioè l’oggettivo. Investiti di affetti, concetti e
simboli che individui, società e storia vi proiettano, gli oggetti diventano
cose, distinguendosi dalle merci in quanto meri valori d’uso e di scambio o
espressione di false rappresentazioni di sé. Analogamente alla tecnica
diagnostica della Quantitative Magnetic Color Imaging del cervello o di
altri organi, sarebbe interessante poter disporre per ogni individuo di
mappe virtuali capaci di rilevare gli aspetti del reale che più interessano.
Parimenti al ramoscello secco descritto da Stendhal in De l’amour,
qualsiasi oggetto è atto a ricevere investimenti e dis-investimenti di senso,
positivi e negativi, di circondarsi di un’aura o di esserne privato, di
ricoprirsi di cristalli di pensiero e d’affetto o di tornare un mero ramoscello
secco, di arricchire o impoverire il mondo aggiungendo o sottraendo
significato alle cose. Si investe intellettualmente ed affettivamente sugli
oggetti, gli si dà senso, li si avviluppa nel desiderio o nel ribrezzo, li si in-
quadra in sistemi relazionali, li si inserisce in storie da ricostruire. Le cose
non solo cose, racchiudono tracce umane, sono un prolungamento. Gli
oggetti familiari sono fedeli, nella loro lealtà. Quanto gli animali o le
piante. Ognuno ha una storia e un significato miscelati a quelli delle
persone che li hanno usati ed amati. Insieme formano, oggetti e persone,
una specie di unità che con difficoltà si può scomporre. La perdita
dell’oggetto amato crea un sentimento di lutto, che genera un vuoto
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 60 di 87
interiore e induce ad una perdita di interesse per il mondo e che, nella
fattispecie della malinconia, si ritorce contro se stessi con processi di auto-
colpevolizzazione. Tale senso di caducità del tutto è espresso da Fernando
Pessoa quando dice di sentire il tempo come un immenso dolore. Egli
abbandona sempre ogni cosa con notevole commozione. La povera stanza
d’affitto dove ha passato pochi mesi, il tavolo d’albergo di provincia dove
è stato sei giorni, persino la sala d’attesa della stazione dove ha trascorso
due ore per attendere il treno: abbandonare le cose buone della vita genera
un male metafisico ed egli pensa, con la sua ipersensibilità nervosa, che
non le vedrà né le avrà mai più, perlomeno in quel momento. Gli si apre
un abisso nell’anima e il soffio freddo dell’ora di Dio gli sfiora il volto
emaciato. Il passato e i morti che lo hanno amato nell’infanzia. Quando li
evoca la sua anima si raffredda e si sente esiliato dai cuori, solo nella sua
notte, piangendo come un mendicante il silenzio sbarrato di tutte le porte.
Succede, ad esempio, che le sofferenze si plachino con i rituali e la
costruzione di monumenti funebri, che, volendo ricordare i morti, li fanno
in realtà dimenticare: con l’espressione del dolore, nelle varie forme del
culto dei morti, si supera il dolore, rendendolo oggettivo. Così, cercando di
non far essere morti i morti, si inizia a farli morire dentro di sé. C’è una
specie di translatio imperii o di metempsicosi che fa sì che gli oggetti
orfani passino di mano e che la loro vita possa continuare anche dopo la
morte o la lontananza di chi li custodiva. Con una sorta di sineddoche, un
abito o una foto si caricano di significato erotico onnicomprensivo, di un
di più di senso, o di significati cultuali e religiosi. Se è nel giusto Lévi-
Strauss ad affermare che, da quando è nato il linguaggio, l’universo deve
caricarsi di significato, articolarsi e diversificarsi, allora proprio perché
l’intelligenza necessita di un minimo di distinzione, è necessario dare un
po’ di vita all’oggetto dell’intelligenza. I feticisti adorano il legno e la
pietra. Non hanno alternative: pensano. Dal feticismo si impara anche che,
nel suo sforzo di conoscere il mondo, l’uomo ha sempre un di più di
significazione. I cipresseti che parlano del Carducci in Davanti a San
Guido, o come quando Cavalcanti fa parlare i suoi strumenti per scrivere e
cancellare. La tipologia e il senso degli oggetti sono già stati descritti da
Walter Benjamin riguardo all’Odradek del racconto di Kafka Il padre di
famiglia, dove diventano l’allegoria misteriosa del graduale oblio cui è
sottoposta la figura paterna, che assume qui le apparenze di un rocchetto
piatto, a forma di stella, che può stare, a seconda dei casi, in soffitta, per le
scale, nei corridoi, nell’andito. A volte, invece, sparisce per mesi: forse in
altre case. Non fa male a nessuno: eppure quasi fa male, l’idea che gli
debba sopravvivere. L’ubiquità del rocchetto e il suo intermittente apparire
si riferiscono alla non situazionalità della figura paterna dopo lasua
scomparsa, mentre il filo spezzato si riferisce a ciò cui sarebbe possibile
riunirsi nel ricordo, ripristinando una continuità affettiva. La tassonomia e
le vicende di tale genere di enti sono state descritte da Francesco Orlando
in Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura e da Umberto Eco
nel romanzo La misteriosa fiamma della regina Loana. Orlando ritrova
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 61 di 87
nell’accozzaglia di oggetti e di cose in apparenza inutili o invecchiate o
insolite, che hanno perso il loro valore d’uso e sono diventate antimerci,
una tipologia che definisce la relazione degli uomini con il mondo fisico
da essi dominato, ai confini tra cultura e natura, nella trasformazione di
quel mondo, nonché il loro rapporto con il tempo, che impone le sue tracce
alle cose: proiettando sulle cose i limiti sia della condizione umana meta-
storica, sia della durata storica delle civiltà. Tra i tanti testi citati da
Orlando, spicca una poesia di Borges intitolata Las cosas: il bastone, le
monete, il portachiavi, la serratura, le note che non leggeranno i pochi
giorni che gli restano, le carte, la scacchiera, un libro e la violetta tra le sue
pagine, monumento d’una sera indimenticabile e già dimenticata, lo
specchio occidentale in cui arde un’aurora illusoria. Quante cose come
schiavi, cieche e stranamente segrete. Dureranno più dell’oblio; non
sapranno mai che si è andati via. Rimanendo nel contesto della letteratura
sudamericana, si consideri qui l’ultima strofa della poesia di Pablo Neruda
Oda a las cosas: il fiume irrevocabile delle cose, non ha amato egli solo i
pesci o gli alberi. Molte cose gli hanno detto tutto. Non solo hanno toccato
il poeta o le ha toccate lui, ma vi è stato accompagnato in modo tale da
aver vissuto con lui mezza vita e moriranno con lui mezza morte. Nel libro
di Eco, invece, i vecchi pacchetti di sigarette, le cartoline, i francobolli o i
giornalini rinviano non solo a ricordi di infanzia o di adolescenza,
ravvivati dalla memoria, ma anche a miti, aspettative, avventure e vicende
comuni a un popolo e ad un’epoca. Sono documenti meritevoli in sé,
capaci di evocare ricordi e informazioni utili per conoscere non solo la
storia materiale, ma la storia in sé. Si deve superare una difficoltà della
volontà, non dell’intelletto. Gli aspetti filosoficamente più rilevanti delle
cose del linguaggio sono celati dalla loro quotidianità. Ovvio si dice
etimologicamente di cosa che si incontra lungo la via o personalmente che
è accessibile, a portata di mano, che non necessita molti sforzi nel farsi
avvicinare o nel dare confidenza. Per accedere al territorio dell’ovvio è
sufficiente scegliere una via non bloccata da problemata, incontrando
quanto già si crede di conoscere o si è capaci di ri-conoscere facilmente.
La liberazione dal noto è da lungo tempo il fine delle più svariate teorie e
pratiche, che hanno sempre ricercato il passaggio dall’obvius all’abvius,
dalla quotidianità a ciò che porta fuori dalla route, la via più battuta. La
meraviglia non priva di sgomento, il thaumazein, si colloca all’origine
stessa della filosofia, dove ha il compito di togliere al mondo la sua
ovvietà senza voler rendere tutto chiaro. Volgendosi indietro, il percorso
appare l’unico giusto, una via regia simile a quella individuata da Euclide
negli Elementi, un esito sempre esistito che bisognava rendere esplicito,
perché tutto era già stato composto, ma non ancora trascritto. Per scoprire
o inventare qualcosa non è sufficiente riconoscere la natura dei fenomeni
che si incontrano. Si deve anche saper dirigersi in modo contro-intuitivo,
rovesciare il senso comune cancellando pregiudizi millenari: come i
fratelli Mongolfier e i fratelli Wright, quando dimostrarono che l’uomo
può volare; come il falegname ed ebanista tedesco Michael Thonet, che
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 62 di 87
riuscì a curvare il legno di faggio riscaldandolo con il vapore in forme di
ghisa; come Thomas Edison, che inventò l’illuminazione a incandescenza,
facendo bruciare in una lampadina dei filamenti metallici nel vuoto,
piuttosto che, come si era sempre fatto, accendendo una fiamma nell’aria
fornita d’ossigeno. In Husserl la cessazione dell’ovvietà è in un primo
momento affidata all’epoche, alla messa tra parentesi dell’atteggiamento
naturale, che modifica non l’oggetto, ma il modo di concepirlo, e invita a
riottenere la meraviglia e l’innocenza dello sguardo. Con la teoria
dell’intenzionalità Husserl si comporta, in un certo senso, come i Romani
nella prima guerra punica: inesperti di battaglie navali, uncinavano con i
rostri le navi puniche, così da poter combattere secondo le tecniche di
fanteria loro note. Analogamente, Husserl traspone l’oggetto sul terreno
della coscienza e la coscienza sul terreno dell’oggetto, creando uno spazio
comune di interrelazione e di indagine. Questo gli permette di opporsi alla
tendenza delle moderne scienze naturali, che hanno fatto astrazione dalla
soggettività. Secondo l’espressione di Merleau-Ponty, esse hanno
applicato il pensiero del sorvolo sull’oggetto, volando sopra le singole
diversità e dirigendosi verso un’universalità omogenea. Rifiutando la
soggettività, la logica che regge tali scienze vuole opporsi all’opacità
dell’esperienza non riflessa, senza darsi contezza del carattere irriducibile
a oggetto della soggettività stessa e senza riconoscere, come Husserl
spiegherà nelle Meditazioni cartesiane, che l’io si sottrae a qualsiasi
oggettivazione, perché capace di trascenderla. Per alcuni critici il piano
fenomenologico di Husserl non è riuscito, poiché egli alla fine non si
sottrae al male che aveva denunciato, immobilizzando le cose
dimenticando quella soggettività che voleva preservare. Come il vecchio
tipo di fotografo, il fenomenologo si veste col panno nero della sua
epoche, ordina agli oggetti di restare fermi e invariati e alla fine realizza
passivamente, senza la spontaneità del soggetto conoscente, ritratti di
famiglia, come quello della madre, che guarda affettuosamente i suoi
bambini. Seppur da un’altra prospettiva, anche Bachelard accusa la
fenomenologia di Husserl di essere ancora pregna di naturalismo, poiché
presuppone che gli oggetti si diano allo sguardo in modo passivo ed
ingenuo, come se il soggetto conoscente non avesse alcun ruolo.
Soprattutto nel periodo più avanzato del suo pensiero, Husserl non corre
però il rischio prospettato da Adorno. Respingendo la teoria della mente
come specchio riflettente una realtà esterna, egli definisce di sicuro, con
l’intenzionalità, un nesso inscindibile tra la coscienza e la cosa, ma
respinge la passività della coscienza e dell’io di fronte al mondo esterno.
La trascendenza dell’io potrebbe riassumersi con le parole che Klee fece
inscrivere sulla sua tomba: io sono inafferrabile nell’immanenza. Con il
continuo sforzo per liberarsi dalle abitudini, appare evidente che gli
oggetti non esistono in sé e per sé, per natura, ma che sono nodi della rete
di coordinate con cui si struttura il mondo, che non è, a sua volta,
separabile dalla coscienza. La percezione, soprattutto quella visiva, è un
processo continuo e inestinguibile, perché lo si percepisce, di volta in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 63 di 87
volta, nella continua evoluzione del vedere, solo da un punto di vista.
Poiché l’oggetto non è mai dato nella sua pienezza, ogni percezione
rimanda alla memoria e all’immaginazione, che lo completa secondo linee
tratteggiate, permettendone la ri-conoscibilità. Anche in Leopardi, tra
l’altro, l’immaginazione aiuta la percezione, fingendo ciò che si colloca
oltre essa. Al posto della vista, lavora l’immaginazione e il fantastico
subentra al reale. L’animo si immagina ciò che non vede, che un albero,
una siepe, una torre gli cela, e vagabonda in uno spazio immaginario, e si
rappresenta cose che non potrebbe fare, se la sua vista si estendesse in ogni
luogo, perché il reale escluderebbe l’immaginario. In Husserl, poiché ogni
io ritrova se stesso come centro, come punto-zero del sistema delle
coordinate, sulla base del quale egli considera, ordina e conosce tutte le
cose del mondo, quelle note e quelle ignote, ne deriva che ciascuno ha
intorno a sé lo stesso mondo e, forse, una molteplicità di io vedono la
stessa cosa, lo stesso pezzo di mondo; ma ciascuno ha la stessa
manifestazione della cosa, per ciascuno la stessa cosa si manifesta in modo
diverso a seconda della diversa prospettiva spaziale. L’esplorazione delle
cose che sono a portata di mano si può allargare da un punto all’altro dello
spazio, senza che ci sia una direzione privilegiata, mentre può muoversi
solo bilateralmente in direzione del passato e del futuro nel tempo. Si può
variare la prospettiva spazio-temporale, dirigere lo sguardo qui e là, avanti
e indietro nel tempo, ci si può procurare percezioni e rappresentazioni
sempre nuove, più o meno ricche di contenuto, o immagini più o meno
chiare, così da rendere visibile quello che nelle forme consolidate del
mondo spazio-temporale è possibile e desumibile. Le cose sono investite
dall’attenzione, che non solo le vede con gli occhi del corpo, ma le
comprende, con il linguaggio, con gli occhi della mente, perché il vedere è
una miscela tra il livello visivo e quello linguistico. Il mondo, infatti, come
dice Husserl, sempre alla mano, e se ne è membri. E si è di fronte ad esso
non solo come ad un mondo di cose, ma, con la stessa immediatezza,
anche come ad un mondo di valori, mondo di beni, mondo pratico. Anche
tali aspetti pratici appartengono agli oggetti in quanto tali, che si presti o
meno attenzione ad essi e agli oggetti. L’elemento attivo è l’io che vede e
interroga le cose, ma sono le cose che indicano il modo per farle parlare.
Andando in un’altra direzione rispetto ad Husserl, Georg Simmel apre nel
1911 una tradizione che si prolungherà, nel 1918, con Ernst Bloch e avrà il
suo acme, nel 1958, con Heidegger. L’attenzione di Simmel è volta, da una
parte, alla distinzione tra lo spazio fisico e quello simbolico delle cose,
dall’altra, alla compenetrazione di interno ed esterno, di simbolo e materia.
I due regni, organico ed inorganico, si compenetrano, dice Simmel, perché
l’anima ha la sua patria in due mondi: quello interiore, che si estende
anche al corpo, e quello delle cose esterne. L’anima stessa arriva alla sua
pienezza quando diventa un braccio che un mondo, reale o ideale,
protende per attingere l’altro. Nelle brocche di Franconia, su cui è dipinto
un uomo barbuto, Bloch riscopre i segni della storia e delle tradizioni
popolari. La sua passione di collezionista di Bartmannkruege, boccali a
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 64 di 87
forma di uomini barbuti, lo spinge a riscoprire in loro la permanenza di
diversi elementi tipici: vi ritrova la forma delle brocche romane usate dai
legionari, soldatesche, rese poi rozze in modo nordico, il ricordo delle
insegne da osteria che in Germania raffigurano spesso un barbaro barbuto
e il nesso con la morte per la loro presenza nei corredi funebri. A sua volta,
Heidegger modifica le analisi di Husserl del mondo della vita grazie,
soprattutto, ai risultati ottenuti riflettendo sul fare dell’artigiano e
dell’artista. Utilizzando il pensiero rammemorante, filosofico-poetico, egli
libera, in modo più radicale rispetto ad Husserl, la filosofia
dall’opposizione di soggetto e oggetto, cosicché anche quello che è ovvio,
a portata di mano possa iniziare a manifestarsi diversamente. La sua
analisi, seppur tardiva, è la più conosciuta. L’atteggiamento tecnico-
scientifico elimina la comprensione della cosa. Impedisce non solo di
vedere che il vuoto della brocca è un virtuale contenere quello che si deve
versare e offrire come gesto ospitale o sacrificale, ma anche di vedere in
tale atto l’ennesima convergenza di rapporti nella natura. Nell’acqua che è
offerta persiste la fonte. Nella fonte persiste la roccia, e in questa il
sonnecchiare della terra, che riceve la pioggia dal cielo. Nell’acqua sorgiva
persistono le nozze tra cielo e terra. Tale matrimonio persiste nel vino, che
proviene dalla vite, nella quale la potenza nutritiva della terra e il sole si
riuniscono. Se si prescinde dalla stilizzazione del Geviert, dal gergo
decisamente irritante e dal tentativo appena abbozzato di trovare la verità
della cosa, è corretta l’osservazione secondo cui per Heidegger non esiste
un mezzo isolato, ad esempio una brocca: come utensile per contenere il
vino, essa non esiste senza il vino, o meglio senza la possibilità del vino, e
quindi non è indipendente nemmeno dalla vite, e di sicuro è posata su uno
scaffale. La critica che Heidegger muove alla fenomenologia di Husserl
ritorna sull’accusa, che sarà poi frequente, secondo cui essa continua,
nonostante tutto, a permanere nella separazione tra soggetto e oggetto,
poiché concepisce la cosa come semplice presenza, essere a portata di
mano. Heidegger tratta invece la cosa come ciò che si dirige verso se
stessi, che vi si rivolge in quanto uomo. L’uomo deve considerare
soprattutto l’utilizzabilità delle cose, il loro essere strumento per un fine, il
loro aprirsi all’uomo nella modalità primaria pratico-poietica, che non si
accontenta della loro semplice presenza. La natura assume senso per
l’uomo solo nel rivolgersi a lui. La foresta è legname, la montagna è cava,
la corrente è potenza d’acqua, il vento è vento in poppa. L’oggetto non
esiste quindi di per sé, indipendentemente dalla sua utilizzabilità: non è
dato nell’impressione sensibile, la sua oggettività non può essere percepita
coi sensi, ma solo nel modo in cui lo si comprende in un mondo nel suo
possibile uso. In uno scritto autobiografico, Il sentiero di campagna,
Heidegger ricorda come, da piccolo, dava senso e funzione alla quercia
che suo padre aveva abbattuto nel bosco. I bambini intagliavano con la
corteccia della quercia le loro navi, che, dotate di sedili e timone,
veleggiavano di primo mattino nel ruscello e nella fontana della scuola.
Nel frattempo, la durezza e il profumo del legno di quercia parlavano in
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 65 di 87
modo più comprensibile della lentezza e della costanza con cui l’albero
cresce. La quercia stessa diceva che, solo nel crescere, è fondato ciò che
dura e dà frutti: che crescere vuol dire aprirsi alla grandezza del cielo e,
allo stesso tempo, affondare le radici nella terra oscura; che tutto quello
che è solido fiorisce, solo quando l’uomo è, fino in fondo, l’uno e l’altro:
disposto a quanto gli è richiesto dal cielo più alto e protetto nel rifugio
della terra che tutto sostiene. Come l’opera d’arte, anche se con meno
potenza e implicazioni, le cose innescano in chi le usa o le contempla un
susseguirsi di rinvii, che scaturiscono da loro come da una sola,
inestinguibile fonte di donazione di senso. I rinvii che si irradiano dalla
cosa non procedono, tuttavia, in modo rettilineo, come raggi di luce, o a
partire da concatenazioni di evidenze, come nella dimostrazione di un
teorema, quanto, piuttosto, secondo il modello del tempo sonoro della
musica, dove, nel tema e nelle variazioni, si ha un ri-suonare, oscillare,
dis-tendersi e con-trarsi, un vagabondare che arricchisce di senso sia chi
fantastica, sia la cosa fantasticata. Diversamente dalla cosa, l’oggetto è
senza aura, della percezione dell’apparire in una forma unica di una
lontananza, per quanto possa essere vicina. Seguire, in un pomeriggio
d’estate, una catena montuosa all’orizzonte oppure un ramo che ombreggia
su colui che riposa, questo vuol dire respirare l’aura di quelle montagne e
di quel ramo. Anche per Heidegger, quando è autentica, la vicinanza
avvicina il lontano in quanto lontano. La vicinanza preserva la lontananza.
Oggigiorno, però, l’annullamento delle distanze spazio-temporali non
allontana dalle cose. Dove si poteva arrivare, una volta, solo dopo
settimane se non mesi di viaggio, l’uomo giunge ora in una notte di volo.
Notizie che una volta si ricevevano solo dopo anni, o che restavano
sconosciute, arrivano oggi all’uomo in un attimo con Internet. Ma tale
fretta di eliminare ogni distanza non realizza una vicinanza; la vicinanza
non consiste infatti nella ridotta misura della distanza. Quello che, in
termini di misura, è il meno distante con i vari media, può restare lontano.
Quello che in termini di distanza è remoto, può essere vicino. Una breve
distanza non è ancora vicinanza. Non senza una certa enfasi Heidegger
arriva a paragonare il rimescolarsi di tutto nell’assenza di distanza
all’esplosione di una bomba atomica, che annulla e fonde ogni cosa, dando
alla scienza la colpa di tale annichilazione. Più sobriamente, Benjamin
vede nell’eliminazione del qui ed ora dell’opera d’arte la scomparsa della
sua verità. La verità è la quintessenza di tutto quello che, fin dalla sua
origine, può essere tramandato, dalla sua durata effettiva alla sua virtualità
di testimoniare la cosa. Certo, solo questa: ma quello che così vacilla è
proprio l’autorità della cosa.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 66 di 87
Il mondo
Le cose hanno fisionomie diverse e ciascuna necessita di essere concepita
nella sua unicità, secondo una speciale tassonomia alla Linneo. Sotto
forma di oggetti tecnologici, di beni di consumo, di effetti personali, di
arredi per la casa, per la strada e la città, oppure sotto forma di oggetti
artistici o di cose desuete, proliferano dovunque nella vita dell’uomo.
Prodotti, scambiati, consumati sempre più e con un’ampiezza mai vista, le
cose diventano fondamentali nell’identità individuale e comunitaria.
Incorporano i ricordi, le aspettative, i sentimenti e le passioni, le
sofferenze e il desiderio di felicità. Da tale prospettiva, Kant, più che
Cartesio, affermerà che l’io dipende dall’oggetto più di quanto l’oggetto
dipenda dall’io. Così, effettivamente, Kant dice che la prova desiderata
deve quindi dire che si ha delle cose esterne non solo immaginazione, ma
anche esperienza: quello che non può accadere se non dimostrando che
l’esperienza interna, indubitabile per Cartesio, è possibile solo nel pre-
supposto di un’esperienza esterna. L’individuo non corrisponde,
naturalmente, con le cose che lo circondano o alle quali è affezionato e la
sua identità non dipende dalle cose: l’identità individuale e la coscienza
non svaniscono anche se dall’organismo nella sua interezza si asporta un
mignolo. Si definisce, con Dilthey, la soggettività spirito soggettivo e il
suo scritto spirito oggettivo, trasposizione in segni, su un sostrato
materiale, di ciò che l’individuo pensa, immagina, sente. Segni rimasti per
lungo tempo incomprensibili sono suscettibili di diventare patrimonio
dell’umanità, disponibili virtualmente a tutti. Si è virtualmente capaci di
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 67 di 87
conoscere tutti i prodotti dello spirito umano perché, in senso vichiano,
verum ipsum factum, questo mondo è stato fatto dagli uomini, dal quale si
possono, perché se ne devono, ritrovare i principi nelle modificazioni della
mente umana. Lo spirito oggettivo non è necessariamente una sola
scrittura nascosta che attende da sempre di essere scoperta e interpretata.
Degli oggetti sociali e delle loro intrinseche ed articolate implicazioni in
norme codificate dà un esempio Maurizio Ferrarsi, riferendosi ad episodi
del quotidiano, come prendere una birra. Searle entra in un bar e dice in
francese: un demi, Munich, à pression, s’il vous plait. Searle osserva che
tale frase attiva un’ontologia invisibile: lo scambio sociale tra lui e il
cameriere, una rete di norme, prezzi, tariffe, regole, passaporti e
nazionalità, un universo complesso che avrebbe fatto rabbrividire Kant, se
solo ci avesse pensato. Ci si ritrova agli antipodi del post-modernismo. Se
il post-moderno faceva svanire tavoli e sedie riducendoli ad
interpretazioni, l’ontologia sociale di Searle afferma che anche cose come
le promesse e le scommesse, i titoli e i debiti, i cavalieri medievali e i
professori californiani, le cattedrali e le sinfonie hanno una loro tipica
realtà. In modo indiretto, fanno riflettere sulla natura, sulla storia e sulla
maniera di trattare specifici materiali come la creta del vasaio. Se si
possiedono le informazioni necessarie, la preparazione specialistica e la
giusta sensibilità, tutto diventa significativo e interpretabile. Ogni luogo in
cui siano stati piantati degli alberi, ogni camera in cui siano state riordinate
delle sedie, diventa comprensibile fin dall’infanzia poiché la posizione di
valori umana, l’opera ri-ordinatrice e la definizione di valore hanno
assegnato a ogni luogo, ad ogni cosa il suo posto. Ed è questo che
distingue l’uomo dagli altri animali. All’animale manca anche lo spazio
del mondo. Un cane può vivere per anni in un giardino e averne esplorato
ogni parte, e tuttavia non sarà capace di costruirsi, a prescindere dalla sua
situazione corporale, un quadro completo di tale giardino, grande o piccolo
che sia, e dell’ordine degli alberi, dei cespugli, ecc. La trasformazione
degli oggetti in cose, presuppone anche un’abilità nel ridestare ricordi, nel
ri-creare ambienti, nel farsi raccontare storie e nel praticare sia la nostalgia
chiusa, che si ri-flette in sé nel rimpianto di quello che si è perso, sia la
nostalgia aperta, capace di elaborare il lutto della perdita, curando le ferite
dell’esistenza, consentendo di guardare in avanti. La cultura materiale ha
conquistato una sua autonomia nel campo della ricerca storica, dove ha
ottenuto il suo posto e la sua dignità. La summa divisio del diritto romano
tra res e persona perde valore nel contesto della cultura materiale, poiché,
quando si separa dai suoi proprietari, la res trasmette la traccia dei
significati che da loro le furono conferiti. La produzione in serie ha ridotto
la qualità e, nel mondo moderno, la durata delle cose, impedendo una loro
più duratura collocazione nei ricordi. Uno degli aspetti fondamentali delle
cose, una volta, era la loro durata. Poi è accaduto il contrario, si è
cominciato a sopravvivere alle cose, che periscono prima degli uomini,
non per deterioramento, poiché oggi si potrebbero renderle immortali;
periscono per obsolescenza. Anzi non periscono: funzionano molto bene,
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 68 di 87
in realtà sono superate da altre cose più avanzate. Diventa problematica
l’affermazione del penultimo verso della poesia di Borges Las cosas:
dureranno più in là del nostro oblio. Sul piano cosmico, per il movimento
ciclico e regolare dei corpi celesti, Agostino aveva individuato nel caos
della materia sensibile una magna rerum constantia. Sapeva però che, nel
mondo sublunare soggetto alla generazione ed alla corruzione, persino le
cose più durature, sopravvissute a diverse generazioni di uomini, decadono
lentamente. Nel ritornare di molti cicli del sole l’anello si consuma nel
portarlo, la pioggia erode la pietra, il vomere si consuma, i lastricati si
deteriorano; le statue si logorano. Le cose si consumano: ma la natura
invidiosa nega di vedere quali corpi se ne distacchino continuamente. Con
lo sviluppo tecnologico, fanno la loro comparsa cose diverse da quelle che
si era abituati a vedere: i materiali venuti fuori dalle profondità della
pietra, del legno, dell’argilla, del ferro. Non c’è più una scomparsa lenta,
ma una perdita violenta delle cose. Il piacere di comprare ossessivo-
compulsivo è la premessa per tale opera di distruzione di ciò che si è
comprato. A Bitti, nella Sardegna interna, le cose locali, fatte per durare e
ricavate da materiali importati ma lavorati localmente, sono state
gradualmente sostituite dalle cose che vengono da fuori, le cosas istranzas,
già pronte all’uso e non più prodotte secondo metodi e forme tradizionali.
Nello spazio-paese tradizionale ci sono pochi forestieri. Non arriva nessun
oggetto-alimento tranne il sale, le conserve, lo zucchero. Tutto quello che
concerne i vestiti, i corredi, oppure gli utensili in ferro, rame e pelle arriva
in paese allo stato grezzo. Non arrivano delle cose ma del materiale da cui
lo stagnino, il fabbro, il sarto e il calzolaio otterranno oggetti lavorati. Per
questo, le cosas istranzas non recano nessun messaggio. Il processo con
cui la cosa acquisisce senso sorge dal rapporto e dall’accordo tra pastore e
artigiano, e si svolge nella comunità del paese. Inoltre la materia grezza
che proviene da fuori deve rientrare in un inventario prestabilito
culturalmente dalle usanze, dai bisogni e dall’affettività del lavoro nel
paese; per cui, per esempio, la stoffa deve essere necessariamente velluto o
fustagno, di cui è selezionato anche un colore particolare. Qualcosa di
similare succede oggi nelle tribù amerindiane della costa del Pacifico, tra
gli Stati Uniti e il Canada, dove il potlatch, la cerimonia rituale in cui si
gareggia nello scambio dei doni in modo da affermare il proprio rango e
umiliare gli avversari, include l’uso e il riutilizzo, una volta imponderabili,
di oggetti in plastica come contenitori dei doni. La distanza di tali oggetti
rispetto alla brocca esaminata da Simmel, Bloch e Heidegger non potrebbe
essere più grande. Il vandalismo, nella sua apparente insensatezza, offre un
esempio di piacere della distruzione in sé, con le città saccheggiate e rase
al suolo durante le guerre, con l’ira che si scarica sulle cose, con le
jacqueries o con le ribellioni popolari. Queste ultime, in particolare,
dettate dal desiderio di eliminare i simboli di un regime, finiscono a volte
in vere e proprie rivoluzioni, come nel caso dell’assalto alla Bastiglia o al
Palazzo d’Inverno. Cose e oggetti sono quello che la massa distrugge più
volentieri. Poiché si tratta di cose fragili, come vetri, specchi, vasi, quadri,
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 69 di 87
si potrebbe credere che proprio la fragilità delle cose stimoli la massa a
distruggerle. Di certo il fracasso della distruzione, il rompersi del
vasellame, il rumore dei vetri contribuiscono ad aumentare il piacere. Sono
i suoni potenti della vita di una nuova creatura, i pianti di un neonato. La
semplicità con cui si suscitano li rende ancora più grati. Tutti partecipano
al fracasso e il grido è l’applauso delle cose. Sarebbe però sbagliato
credere che l’aspetto fondamentale sia la semplicità nel rompere. Si sono
aggredite delle statue di pietra e non si è avuta pace finché non sono state
sfigurate. Così scriveva Canetti. La damnatio memoriae mostra il nesso tra
il piacere della distruzione e il desiderio di far dimenticare nomi, simboli,
luoghi con la violenza di un nuovo potere, pieno di ostilità, sete di
vendetta, voglia di rivalsa, fanatismo e invidia verso ciò cui tolgono
prestigio per stabilire nuove gerarchie tra persone e tra persone e cose. A
partire da più di un secolo e mezzo fa, il mondo è contraddistinto dal ruolo
predominante del consumo nell’economia, nella società e nella psicologia.
Ad aumentare il volume dei beni materiali acquistabili hanno contribuito
talune innovazioni ormai familiari: cinquant’anni dopo la nascita dei
grandi magazzini, i clienti furono attratti al loro interno dalle vetrine,
inventate nel 1902 da un artigiano francese di nome Foucault, che fu
capace di produrre grandi lastre di vetro senza che gli sbalzi termici le
rompessero; negli anni Trenta del Novecento l’americano Sylvan Nathan
Goldman, creando il carrello dei supermercati, indusse i clienti a riempirli
di merci in misura maggiore rispetto ai cestini precedentemente in uso.
Teoricamente, i grandi magazzini nascono grazie ad alcuni economisti
francesi allievi di Bastiat per ridurre la forbice tra sovrapproduzione di
merci, causata dalla capillare introduzione delle macchine, e
sottoconsumo, causato dallo scarso potere d’acquisto di gran parte della
popolazione. La relativa abbondanza di merci ha indotto gli individui a
rompere le barriere della scarsità, causando, secondo alcuni critici, una
regressione della civiltà a stadi primitivi. Le cose non sono né una flora né
una fauna. Tuttavia danno l’impressione di una vegetazione proliferante e
di una giungla, dove il nuovo uomo selvaggio moderno non riesce a
ritrovare i riflessi della civiltà. Si estingue lo stimolo individuale a
educarsi al meglio. Non più trascendenza, non più finalità, non più scopi:
quello che definisce la società moderna è l’assenza di riflessione, di
prospettive su di sé. Se ciò fosse vero, subentrerebbe il paradosso di una
perdita del reale complementare all’incapacità di innalzarsi al di sopra di
esso, e la spinta verso l’alto che aveva definito l’umanesimo sarebbe oggi
priva di forza e motivazioni. Serba la sua validità l’invito del visconte
Georges D’Avenel a ricordarsi che il lusso moderno è sì banale, ma prima
non c’era che miseria. Ed è giusto ricordare che ci sono zone di resistenza,
nicchie, percorsi secondari in cui le cose resistono alla mercificazione e
che ricreano simboli, non necessariamente derivanti dalla pubblicità, che
mostrano la loro capacità di orientare i comportamenti in modo più
originale. Memori del monito secondo cui l’inevitabile non succede mai,
l’inaspettato sempre, sarebbe fuori luogo elaborare qualsiasi previsione,
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 70 di 87
ma di certo gli interrogativi rimangono presenti nella loro forza. La cultura
moderna banalizza l’oggetto e il suo ruolo nella società: ne dimentica il
posto e la funzione, oppure non intende vedervi altro se non la
manifestazione e lo strumento dell’alienazione. Il valore d’uso e di
scambio delle cose ha oggi ceduto il passo alla loro trasformazione in
feticci e alla loro ostentazione come meri indicatori di rango. Nel contesto
di tale logica sorgono i miti d’oggi, che si concentrano su oggetti cultuali
come un’auto particolare, o la borsetta e gli accessori firmati. Alla
concezione delle cose come feticci contribuisce non solo la produzione in
serie, che crea delle repliche indistinguibili da un originale che non esiste,
ma anche il proliferare delle immagini, sia quelle distolte dal qui ed ora
dello spazio e del tempo reali dal cinema, dalla televisione, da internet o
dai nuovi media, sia quelle create dalla realtà virtuale. Sorge poi il
desiderio di liberare la vita dal grasso superfluo: un obiettivo smorto, che
serve a placare la cattiva coscienza solo in modo temporaneo. Più efficace,
da parte del consumatore, è ritenuto lo scopo di costruire un universo
comprensibile con i beni che sceglie, concepiti come elementi della cultura
materiale e tasselli fondamentali della propria identità. La nuova tendenza
della sociologia e dell’economia è, dopo tutto, quella di sminuire gli effetti
collaterali del consumismo, di non considerare più, per esempio, il cliente
come individuo passivo, vittima della pubblicità, ma come soggetto attivo,
che, con le sue scelte, dà valore al mondo in cui vive. In Les choses
Georges Perec ha però mostrato come le momentanee dosi di felicità che si
ottengono aderendo ai valori della società consumistica si pagano poi con
la superficialità delle relazioni umane, come succede ai protagonisti del
romanzo, Jérome e Silvie, una volta ottenuto il desiderato benessere. La
lode delle merci come veicoli di felicitò implica, paradossalmente, la loro
svalutazione, perché le rende funzionali a un ordine sociale esterno, alla
cultura del gusto, teso però non più al disvelamento di un’identità, ma alla
comunicazione del ceto sociale di appartenenza. La lotta per conformarsi a
modelli sociali d’eccellenza c’è sempre stata e Simmel ne ha trattato a
lungo riguardo alla moda, un fenomeno sfuggente, nella sua banalità
misteriosa, perché non coincide con il bisogno di bellezza, di utilità o di
comodità. La moda cela e, allo stesso tempo, esprime l’individuo diventato
opaco a se stesso: I am to myself disguised fa dire Shakespeare a uno dei
suoi personaggi nella Commedia degli equivoci. Nel suo contesto la ri-
velazione ha il duplice senso si dis-velare e di celare nuovamente sotto un
velo ognuno a se stesso, inserendolo in un gioco sociale di reciproca
seduzione. Per comprendere meglio i motivi della nostalgia per la verità
delle cose di una volta e la conseguente ostilità verso le pseudo-cose del
presente, un documento unico è la lettera di Rilke a Withold Hulewicz da
Muzot, del 13 novembre 1925. Ancora per i padri dei padri una casa era
una casa, una fontana una fontana, le cose erano più familiari; in esse si
ritrovava l’umano. Ora, per Rilke, incalzavano dall’America cose vuote,
apparenze di cose, parvenze della vita. Una cosa, in senso americano, non
ha nulla in comune con le cose dei suoi avi. Le cose, vissute, consapevoli,
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 71 di 87
declinano e non si possono più sostituire. Si è gli ultimi, per Rilke, ad aver
conosciuto tali cose. Hanno la responsabilità di conservare non solo il loro
ricordo, ma il loro valore umano e larico. Un atteggiamento similare,
relativo alla storia delle cose banali, si ritrova anche in autori
contemporanei come Roche, che dedica il suo libro a coloro che hanno
conosciuto i geloni d’inverno, a coloro che non potevano leggere quando e
come volevano perché non avevano la luce o perché non avevano petrolio.
Anche nelle società pre-industriali, le cose e la loro proprietà avevano una
rilevanza fondamentale nella dimensione oikonomica, quella basata sulla
casa, prima che il termine economia si estendesse, nel 1613,
dall’amministrazione domestica, all’amministrazione della società.
Dall’Economico di Senofonte alla casa come tutto europea è la donna a
curare gli affari domestici e ad avere, per delega del marito, la cura delle
cose e a coltivare, per loro conto, il piacere di accumularle e ordinarle.
Sino a non molto tempo fa la casa è stata soprattutto immagine di un
tempo pietrificato: condensava il passato e il futuro nello spazio abitato,
costruito in altri tempi e poi trasformato dalle generazioni successive.
Trasformandosi in cose da sottrarre alla dimensione dell’utile e da
ostentare allo sguardo, quelle risorse di tempo e denaro, cioè i gioielli e gli
altri oggetti di valore, non sono state vanamente immobilizzate in imprese
improduttive, ma hanno generato valore, di tipo diverso e più elevato di
quello economico, capace di attribuire prestigio in vita e permanenza nella
morte. Dopo tutto, l’immaginazione è incline a dare un significato
affettivo agli oggetti della casa, concepita, in modo archetipico, come sfera
dell’intimità e primo mondo dell’essere umano, custode di memorie di
pietra e di legno, dalle mura domestiche all’armadio o al letto. Erano i
genitori, i parenti o i tutori a decidere le nozze a partire da considerazioni
di tipo economico o per creare alleanze familiari e politiche: un’usanza
che è rimasta nelle monarchie e nelle aristocrazie europee e che si
riverbera tuttora nello spagnolo, dove il genero si chiama hijo politico e il
cognato hermano politico. A partire da Rousseau nella Nuova Eloisa e dai
romanzieri inglesi suoi contemporanei, come Richardson in Clarissa, nel
decidere la scelta del partner si guarda invece a dare sfogo ai desideri e
alle volontà individuali. Il vantaggio di un certo tipo di organizzazione
dello spazio vissuto si riverbera nella maggior libertà d’organizzazione
individuale e in una ambigua liberalizzazione della funzionalità degli
oggetti, che non libera però dalla loro fruizione. L’oggetto prodotto
artigianalmente, caratterizzato dalla maestria tecnica, dal desiderio di fare
bene il proprio lavoro e dall’ossessione della qualità, arriva a volte a livelli
d’eccellenza che annullano i confini con l’arte, come nel caso delle saliere
di Benvenuto Cellini o dei violini di Antonio Stradivari. L’estetica diffusa
genera bellezza inflazionata, ma, con il design e l’utilizzo di nuove
tecniche e materiali, garantisce sovente la qualità. La pubblicità è diventata
un’arte, capace di manipolare i simboli e di renderli funzionali al target e
alle mode predominanti, ma è fuori luogo immaginare una spontaneità
assoluta delle scelte del consumatore. La pubblicità è uno dei fattori che
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 72 di 87
consentono l’affermazione del fascino dell’inorganico, espressione nata
per indicare l’attrazione della moda come cadavere screziato, morto
involucro del corpo vivente, ma che oggi definisce l’assunzione da parte
dell’oggetto di un elemento erotico così forte da trasformare in cosa
senziente il soggetto che ne subisce il fascino. Con un potere attrattivo
simile a quello esercitato dalla venustas latina, l’oggetto, avviluppandosi
in sogni prefabbricati, dà al soggetto un’identità apparente. Non solo esso
incide sulla sensibilità umana, ma tenendo all’angolo il soggetto, lo rende
sempre più dipendente dalla cosa. Una volta che gli è stata tolta la
responsabilità culturale delle scelte, al soggetto non rimane che il provare
a dar risposta al desiderio esclusivamente culturale della cosa, facendo con
essa un’alleanza sensuale più che razionale, corporea più che spirituale,
emotiva più che logica. Anche se le cose si impregnano di valori simbolici
e anche se ci sono notevoli punti d’equilibrio tra forma e funzione, il logo,
la marca, la ri-conoscibilità globale del marchio tendono generalmente a
prevalere sulla qualità. Per effetto della ricerca, i materiali continuano
tuttavia a subire continui perfezionamenti. I luoghi della qualità sono stati
individuati nella bottega dell’artigiano, nel laboratorio dello scienziato e
nell’officina. Sono posti in cui, improvvisamente, si fondono tra loro
elementi, prima isolati, di tipo tecnico, economico o culturale, creando un
nuovo oggetto che dura finché continua ad esserci l’ambiente in cui opera.
Con le protesi il corpo si satura di protesi metalliche, di silicio o plastica
che ne migliorano, con la salute, anche l’aspetto, mentre, di converso, nei
computer, su cui interviene il design, è imitata l’intelligenza umana e si
profila l’uso di circuiti neuronali per l’elaborazione e la trasmissione dei
dati. Ci si avvia verso il post-human, l’integrazione, sempre più
vincolante, tra materia vivente, ri-progettata dalle bio-tecnologie, e materia
inerte, tra nuove forme e contenuti. Sorge il quarto regno delle cose e
diventa possibile immaginarle non più come strumenti pro-tetici,
prolungamento del corpo o della mente, ma come altri dagli uomini, come
strumenti-partner: esse somigliano sempre più a organismi autonomi e il
mondo delle cose somiglia sempre più a un quarto regno, da affiancare al
regno minerale, vegetale e animale. Oltre ogni rimpianto per il passato e
per la sfera larica della casa e oltre ogni risentimento verso
l’americanizzazione del mondo e il suo paradigma utilitaristico nel trattare
le cose, rimane un serio problema, già individuato da Dilthey: che la
relazione dell’uomo con lo spirito oggettivo possa diventare
incomprensibile, che si rischi di vagare in una giungla simbolica
dell’imponderabile e di cose morte. L’intervento individuale è oggi molto
urgente, perché gli uomini contemporanei delle società più evolute non
sono più capaci di pre-supporre un mondo della vita duraturo, una sfera
implicita cui affidarsi. Si pensi al saggio cinese senza idea, che rifiuta
qualsiasi preconcetta visione gerarchica ed esamina l’uguale ammissibilità
di tutte le cose, o ai giapponesi, che hanno sviluppato una venerazione per
le tazze da tè, e che, in occasione della cerimonia di degustazione del tè,
usano solo oggetti caratterizzati dalla qualità wabi sabi che indica povertà
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 73 di 87
ed essenzialità, ma anche capacità di esprimere il tempo vissuto. L’arte
introduce a quello che sta più a cuore, a uno speciale tipo di pragma,
causa, res, Sache, cioè all’inestinguibile centro di senso delle cose, da cui
risorgono, sulla base dell’individualità di ogni opera, il lavoro,
l’intelligenza e la creatività umane ivi racchiuse. Diversamente dalla
matematica, dalla fisica, dalla logica o dalla filosofia come scienza rigida,
qui non è l’auto to pragma o la Sache selbst a svolgersi more geometrico
in una direzione necessaria, ma sono i significati e i simboli a dipanarsi in
varie ramificazioni per poi fondersi e focalizzarsi in forme sempre
rielaboratesi. Per compensare la perdita delle qualità secondarie stabilita
dalla fisica moderna e dal pensiero cartesiano, una parte della filosofia
novecentesca ha quindi provato a comprendere l’eccesso di senso che le
cose assorbono nell’arte e nella quotidianità. Come mostra la famosa
descrizione della cera nelle Meditazioni cartesiane, le qualità sensibili
svaniscono e resta solo ciò che è concepibile dalla mente. Nella sua
filosofia e nella fisica classica delle cose resta solo la res extensa, lo spazio
quantitativo, neutrale e omogeneo, il solo che la res cogitans può
conoscere secondi i criteri della nuova scienza. Come scrive Merleau-
Ponty, a fondamento di un’ontologia oggettiva, c’è la convinzione che il
compito del filosofo, che riflette sull’essere, sia quello di operare una
emendazione del contatto immediato che si ha con l’essere, così da
discernere ciò che è solido, ciò che resiste all’intelletto. La natura esterna
si riduce allora, per Cartesio, all’estensione. Per quanto abbastanza
conosciuto, ha senso rileggere il testo delle Meditazioni: si consideri, ad
esempio, un pezzo di cera appena prelevato dall’alveare: esso non ha perso
ancora la dolcezza del miele che conteneva; conserva ancora l’odore dei
fiori; il suo colore, la sua figura, la sua estensione sono chiari; è duro,
freddo, lo si può toccare, e, se lo si colpisce, emetterà qualche suono.
Infine, tutte le cose che possono in modo chiaro e distinto far conoscere un
corpo si incontrano in esso. Tutto si riduce a estensione, a ciò che si coglie
solo con una visione della mente, che può essere imperfetta e confusa,
oppure chiara e distinta, secondo che l’attenzione si concentri più o meno
sulle cose che sono in essa, e di cui essa si compone. Sebbene la duplicità
di res cogitans e res extensa sia destinata a finire con la filosofia di
Spinoza, dove il pensiero e l’estensione sono i due attributi della sostanza,
tale duplicità cartesiana introduce una cesura teorica che dividerà la
cultura europea per un quarto di millennio, arrivando fin quasi al
Novecento. Durante tutto questo periodo le qualità sensibili sono, spesso
in maniera implicita, o lasciate all’estetica, alla sfera sensibile del bello, o
ridotte ai qualia, agli stati qualitativi del vissuto psicologico individuale.
Polemizzando in modo per lo più vano contro le scienze e le tecniche, la
filosofia contemporanea ha provato a recuperare la ricchezza di qualità e
di significati che le cose possono assorbire o dare, ridando loro,
teoricamente, la pregnanza di cui la letteratura, l’arte o la storiografia le
hanno già attribuito. La filosofia è stata indotta a dare più spazio alla
fantasia o, meglio, a usare di più quella qualità che comprende l’arte e la
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 74 di 87
filosofia, definita da Kant giudizio riflettente e riproposta da Hannah
Arendt anche sotto forma di giudizio politico. Quando, per esempio, si
vede una favela, una bidonville o una baraccopoli, si inizia a concatenare
una serie di ragionamenti, di ipotesi, di sentimenti e di rappresentazioni. Si
usa il giudizio come il misterioso talento della mente grazie al quale sono
riuniti il generale, che è sempre una ri-costruzione mentale, e il particolare,
che è sempre esperienza sensibile. Entrambe, arte e filosofia, si battono
contro la de-semantizzazione cui il quotidiano, ridotto a deserto del reale,
è stato soggetto e invitano, allo stesso tempo, a ritrovare nelle cose
quell’aura che le rende vicine, pur tenendole a distanza. Si può ora
concepire il contesto della fantasia artistica come a-topia, luogo
indecifrabile, irriducibile allo spazio della res extensa, che non appartiene
né al dominio della realtà in sé, né a quello dell’utopia, del non-esistente
per antonomasia. Questa è una zona non situabile in cui il desiderio, sia
cognitivo che affettivo, ha il suo più forte appagamento. Si esprime in essa
la distanza ravvicinata paradossale rappresentata dalla patria sconosciuta,
di cui parlano Plotino e Novalis, o quell’arrière-pays visto da Yves
Bonnefoy, spazio simbolico in cui non si è mai stati, ma che sembra di
conoscere da sempre, come se fosse un paese straniero interiore, perso e, a
volte, per poco tempo riconquistato. Nessuno vi camminerebbe come su
terra straniera, per dirla con Plotino. Oppure per dirla con Goethe che was
ich besitze, seh ich im Weiten und was verschwand, wird mir zu
Wirklichkeiten: quel che posseggo lo vedo distante e quel che scomparve
diviene per me realtà. Quello che non si è mai vissuto e a cui, tuttavia, si
tende è il mondo del desiderio nella sua insaziabile e paradossale distanza
ravvicinata o vicinanza lontana: quanto si prova invano a cogliere nella
sua pienezza, quanto sta più a cuore comprendere emotivamente, la
quaestio che si dovrebbe discutere al più presto, ma che sempre sfugge e si
esprime solo per rimandi. Si sperimenta un sentimento simile andando via
da un luogo conosciuto. Ognuno conosce il sentimento di aver dimenticato
qualcosa nella sua vita cosciente, qualcosa che non è venuto al mondo.
Ecco perché sembra tanto importante quello che si voleva dire e che
invece è sfuggito. Quando si abbandona una camera in cui si è vissuto per
molto tempo, ci si guarda intorno in modo bizzarro, prima di andare via.
Anche lì è rimasto qualcosa, che è sfuggito. Lo si porta in ogni caso con sé
per ricominciare altrove. Come in un rebus, i messaggi che le cose
veicolano con le loro baudelairiane confuses paroles sembrano però
ridestare centri occulti e misteriosi di senso, così eccessivi da inibire, nel
soggetto che le vive, la loro piena comprensione. Hans Christian Andersen
nel Tenace soldatino di stagno narra come nelle ore notturne le cose
assumano una loro vita: i giocattoli iniziano a divertirsi: si fanno visita,
guerra, e danzano. I soldatini di stagno fanno rumore nella scatola, perché
vogliono partecipare ai giochi, ma non riescono a sollevare il coperchio.
Lo schiaccianoci fa le caprile e il gesso si diverte sulla lavagna. Anche il
film d’animazione Toy Story mostra una comunità di giocattoli che, scesi
dai loro scaffali, discutono il fatto che alcuni di loro possano essere gettati
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 75 di 87
via dal loro giovane padrone. Si è visto nel sottile sospetto di
un’animazione dell’inorganico il disagio dell’uomo verso le cose che egli
stesso ha ridotto a parvenze di cose, ma va detto che si tratta anche dello
sforzo di ridare quanto il predominio dei valori d’uso e di scambio aveva
loro tolto. Heidegger è stato il protagonista del dialogo tra le persone e le
cose nella sua analisi delle scarpe da contadina dipinte da Van Gogh. Nella
gran pesantezza della calzatura è concentrata la durezza del lento
procedere lungo i solchi del campo, battuti dal vento ostile. Il cuoio è
impregnato dal turgore del terreno. Sotto le suole passa la solitudine del
sentiero di campo nella sera calante. Per le scarpe passa il silenzioso
richiamo della terra, il suo dono di messi mature e il suo rifiuto
nell’abbandono invernale. Dalle scarpe promana il timore silenzioso per la
sicurezza del pane, la gioia della sopravvivenza al bisogno, il brivido
dell’annuncio della nascita, l’ansia della vicinanza della morte. Tale
strumento appartiene alla terra, e il mondo della contadina lo custodisce.
Da tale appartenere custodito, lo strumento si immedesima nel suo
riposare in se stesso. Il dipinto raffigura, in realtà, le scarpe di Van Gogh:
si tratta di un oggetto vissuto dall’artista come parte importante di sé, un
oggetto nel quale il pittore si osserva come in uno specchio. Eppure,
nonostante Heidegger interpreti tale quadro in modo erroneo, è certo che
nell’opera d’arte le cose appaiono in una nuova luce, assorbendo
significati cognitivi e affettivi non racchiusi nel loro valore d’uso o di
scambio. Per suo tramite, res ipsa loquitur, come succedeva in modo
eminente nel mondo greco classico, dove le opere architettoniche e
scultoree dei grandi maestri parlavano da sé. Parlavano, cioè indicavano il
luogo a cui l’uomo appartiene; permettevano di cogliere il luogo da cui
l’uomo ottiene la sua determinazione. Nel contesto della fenomenologia,
Merleau-Ponty ha, a sua volta, mostrato come la pittura sia capace di
indicare al pensiero i modi per ancorarsi alle cose stesse, così da ridare
loro quella molteplicità di sensi che il riduttivismo naturalistico ha celato.
Egli spiega come la pittura abbia metaforicamente fatto intuire sia
l’invisibile nel visibile, sia, usando un’espressione di Bloch, il dorso delle
cose, quello che si vede oltre la loro apparenza. Il davanti è chiaro, ma
nessuno sa ancora di cosa sia fatto il dorso delle cose, che si può solo
vedere, né sa di cosa sia fatto il sotto delle cose in cui tutto scorre. Si
conosce solo il davanti delle cose e il lato apparente della loro
compiacenza tecnica, della loro amichevole incorporazione nel mondo
umano. Uno sguardo pittorico, come se si trovasse con le cose in una
relazione di armonia prestabilita, come se le conoscesse prima di
conoscerle, crea situazioni in cui le cose stesse sembrano parlare, tanto che
non si sa più chi vede e chi è visto: non si può dire se sia lo sguardo o
siano le cose a dominare. Nella percezione educata e nella pittura, le cose
passano per l’uomo e l’uomo nelle cose, perché la loro connaissance,
conoscenza, è una con-naissance, un nascere insieme di soggetto e
oggetto. Cézanne, per esempio, è stato capace di far nascere le cose
dall’opacità del vedere quotidiano, di lasciare che si manifestassero senza
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 76 di 87
opporvisi, facendole quasi nascere, scaturire davanti agli occhi da uno
sfondo, come succede quando realizza il suo desiderio di dipingere una
tovaglia bianca come la neve caduta da poco e sulla quale si innalzavano
simmetricamente le posate coronate da panini biondi. Tecnicamente questo
gli riesce seguendo in una modulazione colorata il rigonfiamento
dell’oggetto e segnando a tratti turchini parecchi contorni. Lo sguardo,
rinviato dall’uno all’altro, avverte un contorno nascente tra loro come
accade nella percezione. Il corpo fa parte del mondo, ma, poiché vede e si
muove, tiene le cose in cerchio intorno a sé, le cose sono il suo
prolungamento, sono incrostate della sua carne, appartengono alla sua
definizione piena, e il mondo è fatto della stessa stoffa del corpo. Tali
rovesciamenti, tali antinomie sono modi diversi di dire che la visione è
catturata, o si fa, in mezzo alle cose, dove persiste, come l’acqua madre
nel cristallo, l’indivisa comunione del senziente e del sentito.
La natura
Un esempio notevole di come l’arte non solo preservi le qualità secondarie
degli oggetti, ma li trasformi anche in cose è dato dalla natura morta, in
particolare da quella olandese del Seicento. Gli elementi della natura
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 77 di 87
morta testimoniano allo stesso tempo i piaceri della vita e il desiderio di
approfittarne prima che sia troppo tardi, la soddisfazione di tutti e cinque i
sensi e il loro graduale infiacchirsi, i momenti felici e il loro scorrere,
l’utilità e la bellezza dei beni quotidiani e la loro caducità. Il termine
stilleven nasce in Olanda e si trova per la prima volta in inventari redatti
verso il 1650. L’artista e critico d’arte Joachim von Sandrart ne parla, nel
1675, come di stillstehende Sachen, di cose inerti. I pittori di tale genere,
definiti precedentemente roprografi, operavano già dal III secolo a.C. La
pittura parietale e musiva romana ne dà ampia testimonianza: si veda, per
esempio, il Vaso di frutta di Boscoreale, ora al Metropolitan Museum di
New York. In età moderna, a determinare un nuovo inizio sono considerate
due tavole del tedesco Ludger tom Ring, Vasi di fiori del 1562. Tuttavia è
in Italia, in area lombarda, soprattutto con Caravaggio e Arcimboldo, che
tale genere si afferma. Gli olandesi resero le invenzioni e le idee degli
italiani in modo più diretto, più realistico. Da allora le nature morte ebbero
una fortuna durevole che arriva fino ad oggi: si pensi, per il Novecento, a
Matisse, Ricasso, De Chirico, Moranti, Warhol o Lichtenstein. Stilleven
vuol dire natura inerte e rappresenta un insieme di cose scelte e
tematizzate da un pittore che le separa da contesti che prima prevedevano
la presenza umana. Nel concepire le cose in modo non superficiale,
abbandonando l’analfabetismo verso di loro, esse fanno però parlare in
loro nome, guidando verso il loro graduale dis-velarsi. Usando la
preposizione francese entre, si potrebbe dire che chi guarda un quadro si
proietta dentro l’opera, pur mantenendo, allo stesso tempo, la distanza tra
se stesso e l’opera. La visione delle cose rappresentate nel quadro è,
kantianamente, disinteressata, ma in realtà, se ci riferisce al latino inter-
esse, nello stare tra definisce una relazione di reciproca implicazione. La
pittura fa entrare in un’altra dimensione, definita dalla cornice, porta del
mondo, creando enclaves spazio-temporali. Lo stilleven vince, seppur in
modo graduale, sul pregiudizio per cui era concepito come un genere
minore, distante dalla storia, dalla mitologia e dalle immagini sacre. Si va
con meraviglia di fronte all’insolito; mentre si sarebbe nel giusto di
meravigliarsi ancora delle esperienze comuni, per dirla con Plotino;
oppure per dirla con Eraclito: anche in cucina ci sono gli dèi; o ancora per
dirla con Nietzsche diventando buoni vicini delle cose prossime; come se
ci si sforzasse a guardare le cose comuni da prospettive insolite; o come
se, infine, in riferimento al titolo di un libro famoso, accanto agli dèi delle
grandi cose, si considerasse anche il dio delle piccole cose. Lo stilleven,
destinato al piacere privato, sposta la pittura da ambienti solenni alle case
di mercanti, banchieri, armatori, giuristi, medici. Nella sua età d’oro
l’Olanda, con poco meno di due milioni d’abitanti, è il paese più ricco
d’Europa. Le merci più diverse arrivano nei suoi porti dai più remoti
luoghi del mondo grazie ad una forma vera e propria di globalizzazione:
alla vasta rete di traffici, che copre quasi metà pianeta, istituita dalla
Compagnia delle Indie Orientali e dalla Compagnia delle Indie
Occidentali, una rete sostenuta finanziariamente da investimenti che
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 78 di 87
coinvolgono una buona parte della popolazione, pronta a investire il
proprio denaro nel commercio internazionale. Pertanto si può guardare alle
cose rappresentate nello stilleven anche come a simboli delle merci e della
loro circolazione internazionale, che porta il mondo in Olanda e l’Olanda
nel mondo. La loro varietà e qualità è prodotto dell’importazione di
prodotti come grano, agrumi, vino, ferro, rame, pellicce, tappeti, tabacco,
tè, pepe e dell’esportazione di burro, formaggi, aringhe, porcellane o libri.
La miseria di Simulo nel Moretum è qui sconfitta ed esorcizzata dalla
varietà dei beni. Lo stilleven comprende diverse tipologie e sottoclassi,
tutte legate, nel caso del cibo, alla quotidianità, nelle sue cadenze feriali e
festive: la colazione parca, la colazione normale, il basket, la merenda, lo
spuntino o le tavole luculliane. Ci sono persino dipinti che rappresentano
lo stilleven sotto forma di quadri appesi alle mura domestiche, come
l’Interno con giacca su una sedia di Cornelis Bisschop, ora alla
Gemaeldegalerie di Berlino, dove un astice troneggia accanto a calici di
vino. Nello stilleven le cose sono mostrate, in olandese, al loro toppunt,
cioè nel momento della loro maturità, del pieno dipanarsi delle loro
qualità: nel loro acme, prima del loro necessario decadimento. Le coseno
lodate, santificate, dice Ortega y Gasset in merito alla pittura di
Rembrandt, dove esse rifulgono, nella loro quotidianità, di una luce
soprannaturale. Nei quadri di Rembrandt è usuale che un modesto
fazzoletto bianco o grigio, un rozzo utensile casalingo si ritrovino
avviluppati in un’atmosfera di luce, che altri pittori riservano solo alle
aureole dei santi. Ed è come se dicesse, con un soave monito: siano
santificate le cose, amatele. Santificare le cose vuol dire, non solo in
Rembrandt, opporsi al contemptus mundi che le destina alla caducità e
all’irrilevanza, togliere loro, simbolicamente, la maledizione del
contingente. Si nega così il dominio del respice finem, la tendenza a
proiettare con malinconia il presente in un futuro annichilente, e si coglie
invece il presente in tutto il suo fulgore, nella pienezza del suo esprimersi.
Un esempio di ritratto commovente ed intenso è un ritratto del Museo
civico di Cremona, che rappresenta un bimbo morto prematuramente. Il
bambino, Sigismondo Ponzone, sta in piedi e, con la mano destra, tiene un
cane per il collare, mentre, con la sinistra, mostra a chi guarda un cartiglio
con la scritta: padre che nel formarmi avesti parte, prendimi hor riformato
ancor dall’arte. In Olanda scoppiano le tensioni tra le fazioni dello
Statolder Guglielmo d’Orange e del Gran Pensionarlo Johan de Witt. Ne
saranno vittime quest’ultimo e suo fratello Cornelis, squartati dalla folla
nel ramjaar, anno orribile, 1672. Il piacere del godimento delle cose della
vita non è legato alla sola ricchezza creata dall’operosità dei cittadini nelle
corporazioni e nei diversi rami dell’economia, ma all’ethos complessivo,
che oppone la vita alla morte e il toppunt delle cose alla vanitas.
Cominciano a venir meno le nozioni di sostanza ed essenza e, di converso,
ad essere meglio considerati i modi, gli accidenti, i rapporti che non il
preteso centro immutabile e intelligibile degli enti. La vanitas non
concepisce le cose sub specie aeternitatis, ma nella loro contingenza.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 79 di 87
Nello stilleven, di converso, le cose diventano miniature d’eternità, si
aprono un varco nel tempo verso l’assoluto, che è quasi toccato nel punto
di tangenza tra il divenire e l’eternità, lasciando intuire quanto persiste in
ciò che scorre. L’opera d’arte consente di risolvere l’apparente
contraddizione intrinseca all’espressione vita delle cose, perché la vita, che
si riferisce a quello che nasce e perisce, persiste nelle cose rappresentate
come inerti dallo stilleven. L’aion greco o l’aeternitas latina non hanno
alcun rapporto con la durata. Si riferiscono in un primo momento alla vita
e ai suoi fluidi, come il liquido seminale, le lacrime o il midollo spinale,
poi alla durata della vita concessa agli uomini dagli dèi, poi ancora alla
vita stessa degli dèi e, infine, alla pienezza della vita in sé. Quest’ultima
accezione appare in Plotino, quando definisce l’aion come zoe e, più
precisamente, zoe en stasei, vita in stato di quiete. La definizione
plotiniana è rielaborata da Boezio, che definisce l’eternità plenitudo vitae,
e riformulata, in una variazione che tanto piaceva a Borges, dal vescovo
luterano ottocentesco Hans Lassen Martensen: aeternitas est merum hodie,
est immediata et lucida fruitio rerum infinitarum. Borges stesso aggiunge
che è vero che non è concepibile, ma non lo è nemmeno il modesto tempo
successivo. Negare l’eternità, sopportare il grande annichilimento degli
anni pieni di città, di fiumi, di gioie, non è meno incredibile che
immaginare la loro totale salvazione. La vità è troppo misera per non
essere anche immortale. La concezione dell’eternità definita da Plotino
resta però fondamentale, in quanto punto senza spessore da cui emana la
vita di tutte le cose: vita totale, piena, inestesa, che inerisce all’essenza
dell’Essere. Essa è la sorgente inestinguibile che ne è causa conservante,
che dà e si estende, pur rimanendo sempre identica a se stessa; è la potenza
unitaria creatrice del molteplice. Si potrebbe dire che, nella metafisica
plotiniana, la vita delle cose rappresenti lo scaturire del molteplice
dall’aion, che partecipa dell’immutabilità, ma non è immutabile: non è il
sostrato, ma ciò che dal sostrato stesso si irradia, grazie all’identità che il
sostrato garantisce non rispetto a ciò che sarà, ma rispetto a ciò che già è,
che quindi è così com’è e non altrimenti. Il tempo, di converso, è il
momento della generazione e della corruzione degli esseri, il loro pagare il
fio per essersi distaccati dall’eternità, dalla pienezza della vita, pur
volendo imitarla. Il tempo è miseria, necessità, vana corsa verso
l’inarrivabile pienezza intravista. Si è a volte parlato di possibili affinità tra
la pittura di Vermeer e la filosofia di Spinoza. Sul dominio
dell’individualità aveva però già insistito Simmel in rapporto ai ritratti e
agli autoritratti di Rembrandt. Nella sua vita Rembrandt ha eseguito circa
ottanta autoritratti, registrando, in una sorta di diario illustrato, i graduali
cambiamenti della sua figura. Dalla prima immagine in cui si ritrae fino
agli ultimi quadri del 1669, l’anno della morte, per più di quarant’anni egli
si è ritratto in diverse espressioni e fogge. Nell’ultima serie di autoritratti
della vecchiaia, dipinti dal 1660 al 1669, in un periodo contraddistinto dal
lutto, dalla miseria e dai segni del tempo e del dolore sul suo volto,
spiccano L’autoritratto con tavolozza e pennelli del 1662 e L’autoritratto
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 80 di 87
con mani giunte del 1669. In tali opere, con l’intensità del suo sguardo,
Rembrandt ripropone il passato, lo fa scaturire e lo disvela nelle sue
successive velature, scoprendone, di volta in volta, la presenza. Nei dipinti
il divenire scorre in una inerte res extensa, che preserva però qualità
secondarie e valori simbolici. Più di ogni altro, nei suoi autoritratti
Rembrandt ha mostrato come nel viso il massimo di tempo si concentri nel
minimo di spazio e si dispieghi in immagini che testimoniano tutti i suoi
graduali disfacimenti. Simmel ha creduto di vedere nelle opere di
Rembrandt il riflesso di una concezione germanica del divenire, in palese
dissidio con la tradizione classica, greca e latina, che si esprime
pienamente nel ritratto rinascimentale italiano, fondato, secondo lui, su
una metafisica statica dell’essere. Se la vita si può concepire solo nel suo
divenire, allora il suo scorrere non deve essere racchiuso in forme fisse.
Nei dipinti di Rembrandt sembra che la morte sia l’evoluzione continua
della totalità della vita, così come un fiume, sfociando nel mare, non è
dominato da un altro elemento, ma segue solo il suo corso naturale, che è
tale da sempre. Nel ritratto italiano rinascimentale lo scorrere del divenire
sarebbe invece immobilizzato in forma a-temporale, stabilito da tipi ideali
in cui l’individualità si disperde e i tratti del viso appaiono evidenziati, e
non sfumati, proprio perché rigido è il riferimento a modelli universali. I
momenti del divenire sono però esclusi dalla percezione, così come i
passaggi di un calcolo non contano se si vede solo il risultato. Anche se è
vero che è il risultato quello che conta. Rembrandt, invece, registra
nell’inerte unità della scena tutto il divenire che ha portato ad essa, il ritmo
formale, lo stato d’animo, la tonalità del destino del divenire vitale. Gli
autoritratti di Rembrandt non definiscono, tuttavia, solo un cumulo di
passato. In una lettera al fratello Theo dell’ottobre 1885, Van Gogh nota,
in merito a Rembrandt, che bisogna esser morti molte volte per dipingere
così. Soprattutto nell’ultimo periodo della sua opera, Rembrandt manifesta
effettivamente, per loro tramite, il peso sempre più grave della caducità, il
necessario incontro di ciascuno con la morte. In questo le sue opere della
vecchiaia si differenziano dall’ethos incarnato dal toppunt e dallo stilleven.
Rembrandt ha capito che la morte è nella vita fin dalla nascita, cresce e
matura con essa, si alimenta di essa. Egli è attratto dal disfacimento: la
poesia dell’imperfezione. Amava ricercare i segni del tempo: le rughe e le
cicatrici, gli occhi rossi e la pelle smorta che davano al volto umano una
diversa ricchezza. Chiazze, pustole, macchie, croste erano forme
meritevoli di scrupolosa, amorosa indagine; anomalie da sfumare con
sguardo tattile. Nell’interpretazione di Simmel, Rembrandt applica in
modo intuitivo alle cose che dipinge il modello della individuelles Gesetz.
Rovesciando una durevole tradizione filosofica, per Simmel la forma non
è, infatti, legata all’universale, ma all’individuale. La forma, reale unicità
metafisica, individualizza il suo contenuto effettivo. Non sembra però che
Simmel sia stato consapevole del fatto che l’individuale è inintelligibile:
quando si parla e si pensa, ogni singolo qui ed ora perde la sua tipicità e
diventa universalmente valido per tutti i qui ed ora. La legge individuale di
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 81 di 87
Simmel sembra garantita dal fatto che i concetti universali servono in
Simmel da cornice per in-quadrare l’individualità. Negli autoritratti, in
ogni caso, l’aderenza di Rembrandt alla legge individuale appare piena,
perché l’individualità assume in sé le contingenze della vita. Si è
rimproverata a Rembrandt la mancanza di forma, perché si è formulata
l’equazione forma uguale forma universale. La forma, in cui Rembrandt la
elabora, coincide solo con la vita di quel singolo individuo, vive e muore
con lui, con una solidarietà che non gli permette nessuna validità ulteriore,
universale, capace di tollerare altre individualizzazioni. Spinozianamente è
lo sguardo della mente, che concepisce le cose sub specie aeternitatis, a
modificarne il senso, operando la loro conversione in cose da santificare
proprio per la loro singolarità, al loro essere nodi di relazioni cognitive ed
affettive. Ogni cosa è distolta dal suo isolamento e legata a Dio con l’amor
intellectualis, che racchiude, ama e preserva nel loro essere le singole
cose, le res singulares. Seppur riproponendo le concezioni di una setta
eretica del periodo della Riforma, lo scrittore svizzero Gottfried Keller ha
mostrato in Ursula, una delle Novelle zurighesi, come ogni cosa si leghi,
analogamente, alla vita del Tutto, in questo caso al Dio cristiano
interpretato panteisticamente. Egli è nella polvere della terra e nel sale del
mare. Splende nello sterco, nuota con i pesci e vede con gli occhi del
nibbio. Le cose parlano, da un’altra prospettiva, anche a chi sappia
interrogarle in modo poetico, come nel caso delle pietre o delle erbe
nell’unico racconto di Paul Celan, Gespraech im Gebirge, Conversazione
in montagna. In Spinoza, tuttavia, a parlare è la cosa stessa, secondo rigide
concatenazioni di idee, more geometrico. Le res singulares devono,
invece, essere racchiuse nel contesto della totalità della natura, che
comprende anche l’uomo: le cose singole non possono essere pensate
senza Dio e quanto più si conoscono le cose singole, tanto più si conosce
Dio. Traducendo quest’ultima proposizione in linguaggio comune, quanto
più si conosce e si ama ogni singola cosa, tanto più si conosce e si ama il
mondo. Arrivata al piano supremo dell’amor Dei intellectualis, dove
l’intelligenza si riunisce agli affetti, la mente può concepire le cose sub
specie aeternitatis, vedere in ciascuna di esse un nodo di infinite relazioni
con la natura nella sua totalità. L’uomo non è un autonomo impero in un
impero e ciascuno, a partire dalla sua potenza di esistere, partecipa, in
qualche modo, delle vicissitudini della realtà nella sua totalità. Nel caso
delle nature morte e delle opere d’arte in generale, è poi come se le cose
dicessero: carpe aeternitatem in momento. Il memento mori non è
dimenticato, ma, come ha scritto Thomas Merton, ci sono due modi
opposti di affrontare la caducità: la vita sfugge, ma può sfuggire anche
come sabbia. Di fronte al dis-velamento dell’aeternitas, a vincere è la vita
delle cose, insieme a quella dell’uomo. Tutto quanto coinvolge l’uomo con
la conoscenza affettiva delle res singulares libera, infatti, dal ricatto
istituzionale che fa della caducità e della paura di morire uno strumento
politico e religioso di dominio. In tal senso, l’uomo libero a niente pensa
se non alla morte e la sua sapienza è meditazione della vita. Tale
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 82 di 87
sensazione di plenitudo vitae sopravviene allo strapparsi, improvviso,
dell’opaco velo dell’esperienza sensibile. Allora si avverte di essere eterni,
si avverte in se stessi e nel mondo circostante, pur senza poterlo
dimostrare, la presenza di una pienezza fuori dal tempo: né l’eternità si
può definire col tempo, né può avere alcun rapporto col tempo. Ma
nonostante ciò si avverte di essere eterni. Miglior modo per far parlare le
cose è rielaborare un’arte dell’esistenza simile alla techne tou biou dei
greci, ma capace di includere la vita delle cose. La classica diakosmesis ha
così una potenza supplementare per rompere il nesso perverso tra il
fascino dell’inorganico e il suo correlato, l’uomo in quanto cosa senziente.
Rielaborati oltre il loro contesto originario con l’eccesso di senso che
definisce la filosofia e l’arte, la lezione di Spinoza e lo stilleven sono
ottimi antidoti al consumismo, repentino, senza amore delle merci e
servono come collegamenti teorici e come modelli ideali per ripristinare il
passaggio, rimasto per lungo tempo bloccato, tra persone e cose. A
prescindere da Spinoza e dallo stilleven, con le cose si esperisce il fatto
che non tutto si risolve nel foro interno, in una libertà soggettiva senza
vincoli di dipendenza. Paradossalmente, le cose parlano più dell’uomo, di
quello che definisce l’uomo, quanto più le si lascia esprimere nel loro
linguaggio: quello del pragma, della res o della Sache e, a volte, con piglio
più autorevole, quello dell’auto to pragma e della Sache selbst. Solo la
relativa ineffabilità delle cose può riportare a se stessi e far sentire
quell’aura descritta da Benjamin che riunisce vicinanza e lontananza,
familiarità ed estraneità: tutte le cose necessarie e create con amore hanno
una loro vita, scaturiscono in un paese straniero e nuovo e di qui ritornano
indietro con gli uomini. Da ogni cosa, concepita con cura simpatetica, si
possono allora dipanare diversi itinerari di curiosità e di ricerca: una
bambola di pezza può portare, con l’immaginazione e l’indagine, a
collocarla in un periodo che precede la scoperta della plastica, a in-
quadrarla nella storia dei giocattoli, a discutere sulla diversa educazione
delle femmine rispetto a quella maschile oppure a ricordare episodi di vita
familiare. Come ha notato Max Weber, i bottoni della divisa indossata dal
re di Prussia nella battaglia di Sadowa sembrano in sé irrilevanti, ma se
alla prospettiva della storia militare si sostituisce quella della storia della
sartoria, essi saranno più rilevanti dell’esito stesso di tale battaglia. Si deve
avere cura di un monito simile a quello espresso da Nietzsche nella
Seconda inattuale: come un eccesso di memoria storica rischia di livellare
sul passato e di immobilizzare la spinta verso il futuro, così il voler
comprendere troppe cose, accumulandole a casaccio, rischia di non farne
comprendere ed amare nessuna in profondità. Era nel giusto Aristotele: chi
ha tanti amici, non ha nessun amico. Le cose vivono a determinate
condizioni: se le si lascia sussistere accanto e con gli uomini senza volerle
fagocitare; se si riuniscono le vite degli uomini tra di loro; se, per loro
tramite, ci si apre al mondo per farlo sgorgare dentro di sé e si confluisce
in esso per renderlo più sensato e conforme ad ideali, da discutere insieme,
di interesse comune; se si sviluppa un comportamento capace di superare
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 83 di 87
l’opposizione tra una chiusa interiorità e un’esteriorità inerte e inautentica;
se si rinuncia a privilegiare relazioni di mero possesso e predomino sulle
cose; se, guardando al senso originario di eternità come pienezza della
vita, si abbandona il vivere solo alla giornata; se si passa dall’ostentazione
del marchio e dalla cultura del consumismo ad una relazione parca con le
cose; se si riesce a riconoscere in ciascuna di esse la natura di res
singularis investita in quanto tale di intelligenza, di simboli e d’affetto; se
si estende di continuo il proprio orizzonte mentale ed emotivo evitando di
perdere la consapevolezza dell’ineffabile profondità del mondo, del
prossimo e di se stessi. Quello che affermava Eraclito per la psiche, vale
anche per le cose del mondo: per il loro significato storico e individuale e
per l’ancora inesplorata complessità della materia universale, di cui il
corpo umano e le cose sono fatti e a cui la soggettività umana è
indissolubilmente connessa. La decisione di conoscere e aver cura di
qualcosa, senza precludersi la comprensione di qualcosa d’altro, comporta
non solo un atteggiamento di continua attenzione al mondo e agli uomini,
una volontà di conoscere e un desiderio di amare, ma anche un ethos per
contribuire a fare una respublica della società nella quale si vive e si opera.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 84 di 87
CONCLUSIONE
Concettualmente, anche se non strettamente dal punto di vista linguistico,
ciò a cui più da vicino assomiglia deinòs è quel thàmbos in cui si
manifesta, per Plotino, la specificità dell’apparire del bello nelle cose. Ma
se ci si rivolge alla cara patria, secondo la lezione dell’Ulisse di Plotino, si
deve eliminare tutto ciò che ha a che fare con la bellezza sensibile, si deve
voltar le spalle a Calipso, ci si deve negare a tutto ciò che di bello appare
nelle cose. Il bello è l’apparenza manifesta del reale nelle cose. Il reale
delle cose è la contraddizione.
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 85 di 87
BIBLIOGRAFIA
U. CURI, L’apparire del bello. Nascita di un’idea, Torino, Bollati
Boringhieri, 2013
E. CASSIRER, Goethe e il mondo storico, Brescia, Morcelliana, 1995
R. BODEI, La vita delle cose, Roma-Bari, Laterza, 2009
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 86 di 87
INDICE
INTRODUZIONE pp. 1-2
IL BELLO pp. 4-47
GOETHE pp. 49-97
LA VITA: COSE, MONDO E NATURA pp. 99-150
CONCLUSIONE p. 152
BIBLIOGRAFIA p. 155
156
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4084720…ion=attachment%3B%20filename%3DLapparire_delle_cose.doc 26/02/19, 10H25
Pagina 87 di 87
Potrebbero piacerti anche
- Curi L'apparire Del BelloDocumento53 pagineCuri L'apparire Del BelloguglielmobilancioniNessuna valutazione finora
- Eraclito, La Luce Dell - OscuroDocumento7 pagineEraclito, La Luce Dell - OscuroAlessia BertoliNessuna valutazione finora
- AGOSTINO LONGO Concezioni e Immagini Dell'ispirazione Poetica in OrazioDocumento50 pagineAGOSTINO LONGO Concezioni e Immagini Dell'ispirazione Poetica in OrazioFiorenzo TassottiNessuna valutazione finora
- Sui sentieri della meraviglia: Lezioni di introduzione alla filosofia alla luce della riflessione di Tommaso d'AquinoDa EverandSui sentieri della meraviglia: Lezioni di introduzione alla filosofia alla luce della riflessione di Tommaso d'AquinoNessuna valutazione finora
- Dialogo Con PontiggiaDocumento13 pagineDialogo Con PontiggiaLivia T.Nessuna valutazione finora
- Riassunto La Luce Dell Oscuro FornariDocumento13 pagineRiassunto La Luce Dell Oscuro FornariFederica Di ChioNessuna valutazione finora
- Lezioni EsteticaDocumento6 pagineLezioni EsteticaSara RevelliNessuna valutazione finora
- Paul Valery Et La Grece PDFDocumento14 paginePaul Valery Et La Grece PDFIgnacio PereyraNessuna valutazione finora
- La Scrittura Filosofica Carlo SiniDocumento7 pagineLa Scrittura Filosofica Carlo SiniFederico VirgilioNessuna valutazione finora
- Arte in Europa Tra Ottocento e NovecentoDocumento37 pagineArte in Europa Tra Ottocento e NovecentoIlaria BenciNessuna valutazione finora
- Critica e Verità by Roland BarthesDocumento71 pagineCritica e Verità by Roland BarthesIlaria MarianiNessuna valutazione finora
- Differenza Tra La Filosofia Della Natura Di Democrito e Quella Di EpicuroDocumento23 pagineDifferenza Tra La Filosofia Della Natura Di Democrito e Quella Di EpicuroZenoneDemosteneoNessuna valutazione finora
- Barchiesi Gli Dei Di Ovidio PDFDocumento3 pagineBarchiesi Gli Dei Di Ovidio PDFSamael ZeidNessuna valutazione finora
- EsteticaDocumento11 pagineEsteticaesterperinNessuna valutazione finora
- UNA_DEA_PER MORGANTINA_GrecoDocumento6 pagineUNA_DEA_PER MORGANTINA_Grecogottfreund.veraNessuna valutazione finora
- 12 Percorso Bello PDFDocumento16 pagine12 Percorso Bello PDFIlaria LacasellaNessuna valutazione finora
- 16-Filosofi e ReligioneDocumento111 pagine16-Filosofi e Religioneparsifal11Nessuna valutazione finora
- PlatoneDocumento25 paginePlatoneAndrea RuggeriNessuna valutazione finora
- Gritti Proclo 385Documento46 pagineGritti Proclo 385sheyla3memoryofseaNessuna valutazione finora
- Il Discorso Di Alcibiade IIIDocumento1 paginaIl Discorso Di Alcibiade IIIAlessio GuidaNessuna valutazione finora
- Andreini-Trasmetto, Non CreoDocumento244 pagineAndreini-Trasmetto, Non CreoEmanuele RizzutoNessuna valutazione finora
- Premodernita', Modernita' e Postmodernita'Documento6 paginePremodernita', Modernita' e Postmodernita'MichelaNessuna valutazione finora
- Storia Dell'Estetica Estetica Manuale 1Documento9 pagineStoria Dell'Estetica Estetica Manuale 1luoluoluo100% (1)
- La Nascita Della FilosofiaDocumento10 pagineLa Nascita Della FilosofiaGaia BorliniNessuna valutazione finora
- Costanzo Preve - Elogio Della Filosofia.Documento32 pagineCostanzo Preve - Elogio Della Filosofia.karamrhamNessuna valutazione finora
- 11 Recensione Albanese - 2016 - 2Documento8 pagine11 Recensione Albanese - 2016 - 2lorrisNessuna valutazione finora
- Karl Marx - Democrito E EpicuroDocumento22 pagineKarl Marx - Democrito E Epicurodavis2aNessuna valutazione finora
- Didattica Del GrecoDocumento51 pagineDidattica Del GrecoNatalia DifrancescoNessuna valutazione finora
- Specificita Dellarte Sacra CristianaDocumento27 pagineSpecificita Dellarte Sacra CristianaLaura RamosNessuna valutazione finora
- Bellezza01 PDFDocumento22 pagineBellezza01 PDFrabidusutventusNessuna valutazione finora
- Napolitanognothi SeautonDocumento17 pagineNapolitanognothi SeautonCarlo AnaclerioNessuna valutazione finora
- Terrosi-Storia Del Concetto D'arteDocumento144 pagineTerrosi-Storia Del Concetto D'artenihil_humani100% (1)
- Morfologia e Darwinismo in Ernst CassirerDocumento22 pagineMorfologia e Darwinismo in Ernst Cassirerlucantani100% (1)
- Allegoria. Una Breve Genealogia TeoricaDocumento8 pagineAllegoria. Una Breve Genealogia TeoricabesciamellaNessuna valutazione finora
- BELLEZZA ARTE 1 Lezione CDocumento2 pagineBELLEZZA ARTE 1 Lezione CPaolo TiberiNessuna valutazione finora
- Croce Trattati D' Amore Del Cinquecento.Documento17 pagineCroce Trattati D' Amore Del Cinquecento.Manu PapadakiNessuna valutazione finora
- Filosofi e Oratori. Filosofia Nella Retorica, Retorica Nella FilosofiaDocumento12 pagineFilosofi e Oratori. Filosofia Nella Retorica, Retorica Nella FilosofiaLe RodriguezNessuna valutazione finora
- BODEI L'Estetica Del Bello e Del SublimeDocumento12 pagineBODEI L'Estetica Del Bello e Del SublimeMarco LombardiNessuna valutazione finora
- Evola Julius - La Caduta Dell'Idea Di StatoDocumento17 pagineEvola Julius - La Caduta Dell'Idea Di StatoDennis CardonaNessuna valutazione finora
- La Teologia Che Impara Dal CosmoDocumento4 pagineLa Teologia Che Impara Dal CosmoLaura RivaleNessuna valutazione finora
- Poetica Prof - GuastiniDocumento28 paginePoetica Prof - GuastiniMartina MarzulloNessuna valutazione finora
- Il Sublime RomanticoDocumento9 pagineIl Sublime RomanticoIsabella VidoNessuna valutazione finora
- La Dottrina Della Palingenesi Nell'ErmetismoDocumento7 pagineLa Dottrina Della Palingenesi Nell'ErmetismoSheenky_webNessuna valutazione finora
- Edward Sapir "Culture Genuine e Culture Spurie"Documento21 pagineEdward Sapir "Culture Genuine e Culture Spurie"Cataldo MarinoNessuna valutazione finora
- RicoerDocumento12 pagineRicoerriccardo bassiNessuna valutazione finora
- ELLENISMO Libre PDFDocumento23 pagineELLENISMO Libre PDFronalduamaralNessuna valutazione finora
- Antonello On LeviDocumento45 pagineAntonello On LevinansirueNessuna valutazione finora
- CARLO PETTAZZI, Th. Wiesengrund Adorno. Linee Di Origine e Di Sviluppo Del Pensiero (1903-1949)Documento310 pagineCARLO PETTAZZI, Th. Wiesengrund Adorno. Linee Di Origine e Di Sviluppo Del Pensiero (1903-1949)ghostx93Nessuna valutazione finora
- L'indifferenza Alla Felicità Nel Pensiero Della Cina AnticaDocumento9 pagineL'indifferenza Alla Felicità Nel Pensiero Della Cina AnticaCarlo AnaclerioNessuna valutazione finora
- Etimologia e Linguistica Nove Studi ISBN PDFDocumento298 pagineEtimologia e Linguistica Nove Studi ISBN PDFFrancesca Floris - NadraNessuna valutazione finora
- FedroDocumento8 pagineFedroElena MellàNessuna valutazione finora
- Differenza Tra La Filosofia Della Natura Di Democrito e Quella Di Epicuro - Karl Marx (1841)Documento18 pagineDifferenza Tra La Filosofia Della Natura Di Democrito e Quella Di Epicuro - Karl Marx (1841)estebanponceNessuna valutazione finora
- Settimananews - It-La Formazione Teologica 2Documento4 pagineSettimananews - It-La Formazione Teologica 2juanmanuel.cabiedasNessuna valutazione finora
- 569 1092 1 PBDocumento14 pagine569 1092 1 PBdelucaeleonora53Nessuna valutazione finora
- Introduzione All'estetica - G. VattimoDocumento16 pagineIntroduzione All'estetica - G. VattimoLuan MasieroNessuna valutazione finora
- Cesura o Chance?Documento2 pagineCesura o Chance?Massimo ZambelliNessuna valutazione finora
- In Memoriam Di Armido RizziDocumento2 pagineIn Memoriam Di Armido RizziMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Religione e Coronavirus - 4 Pasqua, Giovedì e Venerdì - 15mbDocumento32 pagineReligione e Coronavirus - 4 Pasqua, Giovedì e Venerdì - 15mbMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Religione e Coronavirus - 7 Mascherina-Persona - 16mbDocumento55 pagineReligione e Coronavirus - 7 Mascherina-Persona - 16mbMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Gesù e Maddalena, Accanto A GiudaDocumento2 pagineGesù e Maddalena, Accanto A GiudaMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Christus Vivit - Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ai Giovani e A Tutto Il P PDFDocumento80 pagineChristus Vivit - Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ai Giovani e A Tutto Il P PDFMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Dal Tempio Alla CasaDocumento3 pagineDal Tempio Alla CasaMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- La Fraternità Universale Degli Uomini e Il Volto Paterno Del Dio Di GesùDocumento2 pagineLa Fraternità Universale Degli Uomini e Il Volto Paterno Del Dio Di GesùMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Religione e Coronavirus - 5 Pasqua, Sabato e Domenica - 11mbDocumento33 pagineReligione e Coronavirus - 5 Pasqua, Sabato e Domenica - 11mbMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- RC - 3 Fratella MorteDocumento29 pagineRC - 3 Fratella MorteMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Dio e SartreDocumento14 pagineDio e SartreMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Religione e Coronavirus - Il RespiroDocumento16 pagineReligione e Coronavirus - Il RespiroMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- La Nuova Ricerca Sul Gesù Storico PDFDocumento4 pagineLa Nuova Ricerca Sul Gesù Storico PDFMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- La Nuova Ricerca Sul Gesù Storico PDFDocumento4 pagineLa Nuova Ricerca Sul Gesù Storico PDFMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Gianfranco Basti OntologiaDocumento7 pagineGianfranco Basti OntologiaMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- CitazioniDocumento1 paginaCitazionialessandroNessuna valutazione finora
- Gianfranco Basti OntologiaDocumento17 pagineGianfranco Basti OntologiaMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Christus Vivit - Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ai Giovani e A Tutto Il P PDFDocumento80 pagineChristus Vivit - Esortazione Apostolica Post-Sinodale Ai Giovani e A Tutto Il P PDFMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Gianfranco Basti OntologiaDocumento17 pagineGianfranco Basti OntologiaMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Gianfranco Basti OntologiaDocumento17 pagineGianfranco Basti OntologiaMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- SatiraDocumento1 paginaSatiraMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Intervista A HitchensDocumento2 pagineIntervista A HitchensMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Volantino Genova 2011Documento2 pagineVolantino Genova 2011Massimo ZambelliNessuna valutazione finora
- Intervista A HitchensDocumento2 pagineIntervista A HitchensMassimo ZambelliNessuna valutazione finora
- L'amore Secondo PlatoneDocumento9 pagineL'amore Secondo PlatoneDavideBordigoniNessuna valutazione finora
- Eros È Il Dio FilosofoDocumento4 pagineEros È Il Dio FilosofoMartina AncoraNessuna valutazione finora
- PlatoneDocumento9 paginePlatoneDavideBordigoniNessuna valutazione finora
- Bessone "Discorsi Dei Liberti e Parodia Del Simposio Platonico Nella Cena Trimalchionis"Documento25 pagineBessone "Discorsi Dei Liberti e Parodia Del Simposio Platonico Nella Cena Trimalchionis"Agustín AvilaNessuna valutazione finora
- Platone SimposioDocumento29 paginePlatone SimposioCesare AngeliNessuna valutazione finora
- TESI Il Sacrificio Di DiotimaDocumento52 pagineTESI Il Sacrificio Di Diotimajoshua80Nessuna valutazione finora
- Simposio Di Platone - I Gradi Della BellezzaDocumento2 pagineSimposio Di Platone - I Gradi Della Bellezzampapa2Nessuna valutazione finora
- SINTESI Di PLATONEDocumento17 pagineSINTESI Di PLATONEmattiasNessuna valutazione finora
- Platone - RiassuntiDocumento19 paginePlatone - RiassuntiAlessandroPinna93% (14)
- CITTI Storia Autori Letteratura Greca 2 p559 659Documento101 pagineCITTI Storia Autori Letteratura Greca 2 p559 659clara ostanoNessuna valutazione finora
- Amore PlatonicoDocumento13 pagineAmore PlatonicoSaraMiliaNessuna valutazione finora
- I Misteri EleusiniDocumento8 pagineI Misteri EleusiniMondo Comune100% (1)
- L'amore Secondo PlatoneDocumento16 pagineL'amore Secondo PlatonegiadaNessuna valutazione finora
- Simposio Di PlatoneDocumento8 pagineSimposio Di Platoneplatoon1982Nessuna valutazione finora
- Platone L'amoreDocumento8 paginePlatone L'amoreSilvia DemontisNessuna valutazione finora
- Il Simposio Di PlatoneDocumento29 pagineIl Simposio Di PlatoneLauraNessuna valutazione finora
- 8 Percorso Amore Filosofia PDFDocumento20 pagine8 Percorso Amore Filosofia PDFLuigi Scognamiglio100% (1)
- Simposio Di PlatoneDocumento38 pagineSimposio Di PlatoneMariela CastrillejoNessuna valutazione finora
- Platone-Simposio Da LeggereDocumento33 paginePlatone-Simposio Da LeggereMared'inverno AnimebluNessuna valutazione finora
- Il Divino Socrate Di PlatoneDocumento17 pagineIl Divino Socrate Di PlatoneAlbert SteffenNessuna valutazione finora
- Marsilio FicinoDocumento6 pagineMarsilio FicinoFrancesca HewaNessuna valutazione finora
- Simposio Nella Grecia Antica. Comunicazione, Politica e Poesia PDFDocumento7 pagineSimposio Nella Grecia Antica. Comunicazione, Politica e Poesia PDFLycophronNessuna valutazione finora
- SimposioDocumento1 paginaSimposionoemimarini04Nessuna valutazione finora
- Casertano PlatoneDocumento19 pagineCasertano Platonecarlos gustavoNessuna valutazione finora
- PlatoneDocumento14 paginePlatonegabriel magoNessuna valutazione finora
- PlatoneDocumento24 paginePlatoneLorenzo PerraNessuna valutazione finora
- M. Carbone, Divenire Innocente, Corso Di Estetica Contemporanea Dato All'Università Degli Studi DiMilano 2006-07Documento197 pagineM. Carbone, Divenire Innocente, Corso Di Estetica Contemporanea Dato All'Università Degli Studi DiMilano 2006-07maurocarboneNessuna valutazione finora
- Mario Regali - Il Poeta e Il Demiurgo. Teoria e Prassi Della Produzione Letteraria Nel Timeo e Nel Crizia Di PlatoneDocumento215 pagineMario Regali - Il Poeta e Il Demiurgo. Teoria e Prassi Della Produzione Letteraria Nel Timeo e Nel Crizia Di PlatoneDrBenway84100% (1)
- PLATONE - SIMPOSIO, DiotimaDocumento2 paginePLATONE - SIMPOSIO, DiotimaRossella SabatoNessuna valutazione finora
- Il Filosofo DimezzatoDocumento169 pagineIl Filosofo DimezzatoJoseph FurgiaruNessuna valutazione finora