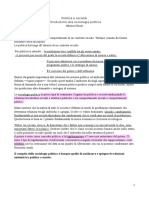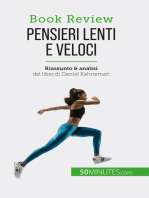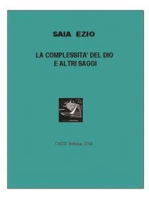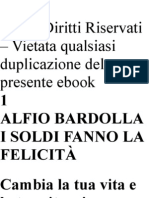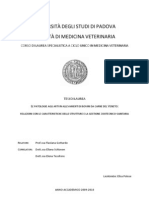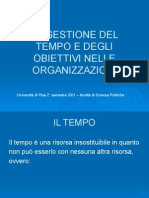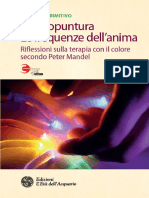Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
8 - Libertà, Capac, Ambien
Caricato da
HankxTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
8 - Libertà, Capac, Ambien
Caricato da
HankxCopyright:
Formati disponibili
argomentare facendo riferimento alla propria posizione all'interno della società: infatti non potendo
sapere quale sarà il proprio ruolo nella società, l'attenzione si sposta (da un immediato tornaconto)
sulla ricerca di un vantaggio generale della comunità.
Sen pur riconoscendo gli aspetti positivi in tale visione contrattualista (che risulta più aperta), si interrogacirca la reale possibilità di
fondare una condotta sociale ragionevole in base alla raggiungimento del proprio tornaconto.
I poteri ed i suoi obblighi.
Il mutuo vantaggio, basato sulla simmetria e sulla reciprocità, non è l'unico fattore che può indurre tenere verso gli altri una condotta
ragionevole, Essere in possesso di un potere reale, con gli obblighi unidirezionali che ne conseguono, può costituire altrettanto
importante ragione per comportarsi in modo imparziale, lasciandosi alle spalle la considerazione del reciproco beneficio.
CAPITOLO 10 – REALIZZAZIONI, CONSEGUENZE E AZIONE
Sen prende in considerazione un poema epico in sanscrito (mahabharata), ed in particolare un interessante dialogo tra due guerrieri,
cioè Arjuna e Krishna, intenti a scendere in campo in una grande battaglia.
La conversazione verte sui doveri degli esseri umani ed è stata oggetto di riflessioni a livello politico e filosofico nel corso degli anni.
Arjuna esprime le sue perplessità sul fatto che prendere parte alla battaglia possa essere la scelta giusta nel suo interesse.
Egli non ha dubbi sulla bontà della causa, tuttavia riflette sul fatto che tale battaglia porterà molti morti, molti dei quali innocenti.
Si sofferma dunque sui risvolti negativi tipici della battaglia ed arriva a domandarsi se non sia meglio abbandonare il campo di
battaglia dandola vinta ai propri avversari, in quanto questo potrebbe rivelarsi il minore dei mali.
Krihsna si oppone a tali riflessioni e la sua risposta si basa sull'importanza di fare il proprio dovere, senza guardare alle conseguenze:
tale atteggiamento è spesso richiamato nei dibattiti indiani in tema religioso e filosofico, tant'è vero che il testo in questione è spesso
richiamato come testo dal valore teologico.
Gli argomenti di Arjuna.
Allla fine del dialogo Arjuna cede davanti alle argomentazioni di Krihsna: ma tali argomentazioni sono davvero irresistibili?
A tal proposito possiamo riscontrare nelle riflessioni di Arjuna almeno tre aspetti diversi:
1 rilevanza del mondo reale - l'idea generale che quanto accade nel mondo deve interessare anche la nostra riflessione
politica e morale; non ci si può limitare solo alla niti;
2 responsabilità personale – egli afferma che un individuo deve assumersi in prima persona la responsabilità degli effetti
delle sue scelte (e quindi non sostiene un con sequenzialismo che prescinde dal soggetto agente);
3 in terzo luogo egli riflette sull'idea di dover uccidere persone, per le quali prova affetto: Si tratta di una preoccupazione
posizionale, che ha che fare con l'idea che induce non possono riconoscersi una responsabilità specifiche regole di qualcun
altro (per esempio figli).
Questi tre aspetti vanno a costituire il nyaya.
Esiti conclusivi ed esiti comprensivi.
Per comprendere meglio i pensieri consequenzialisti di Arjuna occorre definire il concetto di “esito”: per esito si intende la situazione
che risulta da una qualche decisione che stiamo prendendo o che abbiamo preso, sia questa un'azione, una norma o una disposizione.
Il contenuto degli esiti può essere considerato come una realtà che include tutte le informazioni rilevanti relative all'operazione.
Sen ricorda l'importanza di dare attenzione contemporaneamente agli:
• esiti comprensivi – quelli che includono le azioni compiute, le operazioni coinvolte, i processi impiegati ecc..
• esiti conclusivi – esiti puri e semplici che prescindono dai processi.
Questo per comprendere meglio i ragionamenti sulle conseguenze, in quanto le conseguenze sono più in un mero risultato.
Conseguenze e realizzazioni.
Per comprendere il concetto di responsabilità occorre riflettere sulle conseguenze.
Tuttavia la responsabilità personale non è sempre stata riconosciuta a dovere: ciò accade soprattutto nelle versioni dell'etica
utilitarista, la quale ha dimostrato di ignorare tutte le conseguenze non riconducibili all'utilità.
Questa è la conseguenza dello schema utilitarista, che combina
• conseguenzialismo;
• welfarismo (le situazioni vanno giudicate in base all'utilità come la felicità, soddisfazione dei desideri e non in base alle
conseguenze);
• ordinamento-somma (per valutare una situazione, bisogna sommare le utilità dei diversi individui, senza prestare attenzione
alle diseguaglianze).
PARTE TERZA - I CONTENUTI DELLA GIUSTIZIA
CAPITOLO 11 – VITA, LIBERTA' E CAPACITA'
Nel considerare le nostre esistenze non prendiamo in esame solo il tipo di vita che usciamo condurre, ma anche la reale libertà di cui
godiamo nello scegliere tra i diversi stili di vita: dunque riconosce il valore della libertà può ampliare l'orizzonte delle nostre idee dei
nostri.
Il valore della libertà.
Il valore della libertà è stato per secoli oggetto di scontro e stesso si è ritenuto che lo scontro fosse proprio tra “valori asiatici” tesi
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
all'autoritarismo e “valori europei” tesi verso la libertà. In realtà la scriminante non è di ordine
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
geografico, in quanto in entrambe le aree geografiche si possono rinvenire sia autori di detrattori
della libertà.
La libertà: opportunità e processi.
La libertà è importante per almeno due ragioni:
• ci offre maggiori opportunità per perseguire i nostri obiettivi;
• permette di dare importanza al processo stesso della scelta (permettendoci ad esempio di assicurarci che la condizione in
cui ci troviamo non sia frutto di un'imposizione esterna).
Nell'analisi tra opportunità e processi occorre constatare come i possono essere due concezioni diverse di opportunità:
• ristretta: bada solo all'opportunità di scelta, senza tener presenti fattori esterni come i processi;
• ampia (più valida): considera anche fattori esterni che rendono l'opportunità di scelta vincolata, inticiandola.
L'approccio delle capacità.
Per calcolare il vantaggio generale di un individuo vi sono diversi approcci:
• l'approccio utilitarista (inaugurato da Bentham) – occorre focalizzarsi sul piacere individuale;
• teoria economica – si calcola in base al reddito o al suo patrimonio;
• l'approccio delle capacità ( contrapposto alle prime due vie) – si fonda sulla libertà.
L'approccio delle capacità misura il vantaggio in ragione delle capacità che la persona ha di fare quelle cose a cui egli assegna un
valore.
Quindi in termini di opportunità il vantaggio di un individuo è inferiore a quello di un altro individuo con maggiori capacità: tuttavia
il concetto di capacità è strettamente legato al valore della libertà, in quanto è in base alla libertà di un individuo stabilisce cosa
vorrebbe realizzare.
L'approccio delle capacità è una teoria generale concentrata sulle informazioni relative ai vantaggi individuali, concepiti in termini di
opportunità (e non un programma specifico su come organizzare la società).
Le attività realizzabili con le capacità vengono definite da Sen come “funzionamenti” umani: le capacità sono dunque la facoltà di
realizzare diverse combinazioni di funzionamenti.
Tale concezione sposta l'attenzione dall'ambito dei mezzi (Rawls) a quello delle effettive opportunità (esempio del ricco menomato).
Le capacità presenta altri importanti aspetti:
1 contrapposizione tra capacità è risultato;
2 natura compositiva delle capacità ed il ruolo della riflessione nell'impiego dell'approccio del capacità;
3 il posto degli individui e della comunità nel quadro delle capacità.
Dal risultato all'opportunità.
L'approccio del capacità non si cura solo dei risultati concreti, ma anche di ciò che una persona è in grado di fare.
Sen ritiene di dover giudicare i funzionamenti alla luce delle capacità degli individui (contrariamente a quanto sostengono molti e
cioè di dar rilievo al risultato finale, cioè i funzionamenti stessi). Infatti:
• una perfetta corrispondenza di funzionamenti realizzati da individui diversi può nascondere un diverso assetto di capacità e
quindi di vantaggio fra l'uno all'altro soggetto (esempio del ricco che digiuna per motivo politico e del povero che soffre
una carestia – funzionamento uguale a diversa opportunità);
• la capacità di scegliere tra diverse appartenenze nell'ambito dell'propria vita culturale possono del rilievo sia dal punto di
vista personale che dal punto di vista politico;
• la distinzione tra capacità e risultati è utile anche per una questione di natura politica: cioè per determinare le responsabilità
della società nei confronti degli indigeni.
Il timore della non-commensurabilità.
Funzionamenti e capacità sono differenti.
La tradizione utilitarista a contribuito a sviluppare un senso di fiducia nel calcolo esatto basato su un solo fattore quantitativo.
Questa concezione è stata poi ripresa nella pratica di guardare al PIL come all'indicatore delle condizioni economiche di un paese.
La questione è stata avvolta ricondotta alla “non-commensurabilità”: le capacità sono evidentemente non commensurabili quando
sono inevitabilmente eterogenee, ma questo non necessariamente deve portarci a ridurre gli strumenti a disposizione ad un solo
metodo valutativo.
La non commensurabilità indica solo che il processo di scelta non sarà banale e non significa che esso sia impossibile.
Valutazione e riflessione pubblica.
Una valutazione ponderata esige una riflessione su ciò che più o meno importante.
In tal senso può assumere importanza alla riflessione pubblica, la quale può essere vista come uno strumento per aumentare
l'affidabilità e la portata delle valutazioni e renderle più solide.
L'obiettivo principale è dunque quello di arrivare ad una soluzione attraverso giudizi comparativi ricavabili dalla riflessione
personale e dalla discussione pubblica.
Capacità, individui e comunità.
Le capacità sono intese anzitutto come attributi individuali, e non collettivi.
Nel concentrarsi sulle capacità dei singoli, qualche critico dell'approccio delle capacità ha riscontrato l'influsso negativo
dell'individualismo metodologico, cioè il metodo che spieghi fenomeni sociali attraverso ciò che gli individui pensano, scelgono e
fanno.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
Sviluppo e ambiente.
Sulle questioni ambientali va osservato come spesso esse si siano ridotte in termini di tutela e sviluppo della qualità della vita
umana.ancora, l'ambiente non è solo una questione di conservazione, ma anche di intervento attivo, in quanto l'uomo ha il potere di
sviluppare e migliorare l'ambiente in cui viviamo (un esempio ne è la depurazione dell'acqua).
La questione di uno sviluppo sostenibile è stata definita nel 1987 dal rapporto Brundtland, il quale definiva come sostenibile uno
sviluppo che soddisfa i fabbisogni della generazione attuale senza compromettere capacità delle future generazioni soddisfare propri.
Tale concetto è stato ampliato dall'economista Solow per il quale la sostenibilità esige che alla prossima generazione si è lasciato
tutto ciò che è necessario per aver uno standard di vita almeno pari al nostro per tutelare le generazione successiva in base a questo
stesso principio.
Tuttavia, l'idea di sviluppo sostenibile deve essere ulteriormente ampliata assicurando non uno standard di vita ma la libertà propri di
ciascuno.
CAPITOLO 12 – CAPACITA' E RISORSE
Aristotele nell'etica Nicomachea spiega come la ricchezza si un parametro inadeguato per valutare il vantaggio: essa non ha valore
proprio, ma assume valore in funzione di altro (ed infatti una persona ricca ma disabile può comunque incontrare numerosi limiti).
Così l'approccio delle capacità si fonda sulla vita reale delle persone, badando alla loro effettiva facoltà di raggiungere i loro desideri:
l'approccio delle capacità sposta l'attenzione dei mezzi alle effettive opportunità.
La povertà come privazione di capacità.
Nella tradizione la povertà è associata ad un basso reddito. Rawls va oltre concentrandosi sui beni primari in genere, ma di cui fanno
comunque parte il credito ed il patrimonio.
Trasferendo l'attenzione sulle opportunità, occorre constatare come le opportunità degli individui di trasformare il reddito (ed altri
beni primari) ciò che desiderano spesso dipende da diversi fattori (soggetti, ambiente, natura e sociale).
I più importanti fattori di variazione in tal senso sono quattro:
1 differenze personali – gli individui presentano caratteristiche fisiche eterogenee (l'attività di una persona sana può essere
svolta con un reddito che può essere insufficiente per svolgere la stessa attività da parte di una persona disabile);
2 differenze ambientali – la portata di un determinato reddito può dipendere da fattori climatici;
3 differenza di clima sociale – ad esempio la presenza o meno di un sistema sanitario che l'assetto scolastico;
4 differenze di prospettiva relazionale – modelli di comportamento consolidatisi nella comunità e che quindi impongono
degli standard.
La povertà, intesa come privazione di capacità, e dunque più profonda di quanto indichino i dati sul reddito.
Anche la distribuzione dei mezzi in una famiglia può creare difficoltà d'analisi, qualora esse vengano distribuite in modo
disomogeneo fra i componenti del nucleo familiare.
Invalidità, risorse e capacità.
L' handicap al guadagno tende poi ad aumentare se si accompagna ad un handicap alla conversione, cioè alla difficoltà di convertire
guadagni risolse in una vita buona propria causa dell'invalidità.
Concepire la povertà come scarsità di reddito non fa altro che distoglierne ulteriormente attenzione dall'indigenza sociale che
colpisce soprattutto quando si combinano handiccap al guadagno e handicap alla conversione.
L'uso rawlsiano dei beni primari.
Il fatto che Rawls si concentri sui beni primari non significa che egli sia insensibile al concetto di libertà sostanziale.
E gli se ne occupa introducendo correttivi per i “bisogni speciali” (handicap e menomazioni): tuttavia tali sue correttivi sono postumi
rispetto all'allestimento della struttura istituzionale, e sono quindi introdotti successivamente alla fase costituzionale, cioè quella
legislativa.
Il problema sta proprio in questo e cioè che la struttura sociale di base non risulta essere sensibilizzata dai cosiddetti bisogni speciali.
In secondo luogo l'attenzione ai bisogni speciali non è per Rawls occasione per porre attenzione sul problema della conversione delle
capacità in libertà.
Oltre la teoria rawlsiana.
Sen va oltre la posizione originaria (a fondamento di una società giusta)e dell'istituzionalismo trascendentale e quindi propone di
promuovere la giustizia affrontando la questione della conversione è quella delle capacità (approccio comparativo).
L'approccio delle capacità e dunque meglio alla teoria delle risorse in quanto non guarda ai mezzi ai fini ed in questo è più sensibili
alle differenze tra gli individui in termini di funzionamenti.
L'uguaglianza delle risorse di Dworikin.
Dworkin ipotizza che gli individui, sotto un rawlsiano velo di ignoranza di una posizione originaria, entrino in un ipotetico mercato
in cui si vendono assicurazioni contro l' handicap alla coversione. In tale situazione immaginaria nessuno sa se subirà un handicap e,
ammesso che ciò si verifichi, di quale tipo, e tutti si assicurano contro ogni possibile inconveniente (con possibilità dunque, qualora
si verificasse l'handicap, di chiedere e ottenere il relativo indennizzo).
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
Sen è comunque critico segnalando come ancora una volta l'accento cada sulle risorse e non sulle
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
capacità (critica ad un'eguaglianza ottenuta tramite welfare): egli ritiene che l'obiettivo non sia di
ottenere un ugual numero di beni primari ma ottenere la capacità di conversionedi tali beni in
libertà.
Inoltre c'è da considerare che i mercati assicurativi per risolvere per alcuni oggetti piuttosto che altri e quindi potrebbe non esservi
alcuna corrispondenza.
Ancora Sen intende affidare l'accertamento delle differenze tra persone alla riflessione pubblica, mentre Dworkin l'affida al mercato.
Infine Dworkin è talmente concentrato a ricercare una giustizia trascendentale, che omette di dare spunti concreti di giustizia; non
solo, ma elabora una teoria basata su un mercato in concorrenza perfetta, senza tener conto delle variabili del mercato reale.
Tale teoria dunque non è proponibile, ma offre lo spunto per considerare come soluzione al disagio dovuto agli handicap sottoforma
di un trasferimento di reddito.
CAPITOLO 13 – FELICITA', BENESSERE E CAPACITA'
Sen si pone 3 quesiti:
1 porre l'accento sulla felicità cosa comporta in economia politica?
2 Il punto di vista della felicità è utile per giudicare il vantaggio di una persona?
3 Qual è il rapporto tra le capacità ed il benessere di una persona?
Un aumento delle capacità corrisponde sempre ad un miglioramento del benessere?
Se ciò non è così, come può la capacità essere un indicatore del vantaggio personale?
Economia e felicità.
Per molto tempo il concetto di felicità, inteso come soddisfacimento personale è stato usato iin economia: per oltre un secolo
l'economia del benessere è stata dominata dalla teoria utilitarista (Bentham), la quale assegnava la felicità lo status di unico fattore
importante nella stima del benessere del vantaggio umano.
Tuttavia ddati empirici dimostrano come la felicità se in calo anche nei paesi ricchi e sviluppati: dunque il rapporto fra felicità e
reddito è più complesso di quanto si fosse immaginato.
L'interesse probatorio della felicità.
Oltre che alla sua importanza auto evidente, alla felicità possono essere riconosciuti pertinenza e interesse probatorio.
Utilitarismo ed economia del benessere.
Gli utilitaristi ritenevano che per classificare la qualità di una società e per individuare le opzioni da scegliere, fosse sufficiente
basarsi sulla somma complessiva del benessere degli individui: il benessere individuale equivaleva all'utilità individuale, che in
genere assimilavano alla felicità individuale, Essi tendevano ad ignorare il problema dell'ineguale distribuzione di benessere e utilità
tra gli individui.
Dopo una battuta d'arresto, negli anni 40 e 50 la tradizione utilitarista confluì in una nuova economia del benessere, basata
esclusivamente sul utilità.
Limiti informativi e impossibilità.
Mentre si tentava di definire il concetto di benessere sociale, Arrow presentò il suo “teorema dell'impossibilità”, col quale introdusse
nella teoria della scelta sociale.
Egli individuò così un insieme di condizioni che dovevano rappresentare i requisiti minimi di una seria valutazione sociale.
Felicità, benessere e vantaggio.
Il calcolo utilitarista basato sulla felicità o soddisfazione dei propri desideri Horner esiti iniqui per chi si trova in uno stato di costante
privazione. Spesso i poveri tendono ad accontentarsi a che le cose non gli vadano peggio pertanto non aspirano a cambiamenti
radicali nella loro esistenza: ciò permette loro di convivere con uno stato di privazione.
Un simile adattamento ha però l'effetto collaterale di alterare la misura dell'utilità espresse in termini di felicità e soddisfacimento dei
desideri.
L'adattamento delle aspettative gioca un ruolo determinante nella perpetuazione delle disuguaglianze sociali.
Benessere e libertà.
Qual è il nesso tra le capacità ed il benessere di una persona?
Le capacità costituiscono un aspetto della libertà, relativo alle opportunità concrete, Quando si afferma che l'accertamento delle
capacità può essere un ottimo indicatore di benessere di una persona, bisogna distinguere:
• differenza tra azione e benessere – riguarda la promozione del benessere della persona ed il tentativo di quest'ultima di
realizzare, con nella sua azione, i propri obiettivi generali; in questo senso l'azione copre tutti gli obiettivi che una persona
motivo di prefiggersi, le quali possono rientrare anche finalità diverse della promozione del proprio benessere individuale;
• differenza tra libertà di realizzazionee realizzazione stessa – e se si può applicare alla prospettiva del benessere e a quella
dell'azione.
Le due distinzioni danno luogo quattro diverse nozioni di vantaggio, relativamente alla singola persona:
1 realizzazione come benessere;
2 realizzazione come azione;
3 libertà come benessere;
4 libertà come azione.
Ciascuno dei quattro tipi di vantaggio va accertato tramite un'opera di valutazione, la quale però non è uguale in tutti i casi.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
Nella messa a punto degli interventi statali dirette cittadini adulti, poi, la libertà come benessere potrebbe meritare più interesse della
realizzazione come benessere, Lo Stato, per esempio, potrebbe ritenere sensato offrire ad una persona adeguate opportunità per
lasciarsi alle spalle la fame, e tuttavia non insistere perché con la persona colta a tutti i costi l'occasione.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
Avere maggiori capacità in termini di libertà come azione è un vantaggio, ma solo in quel aspecifica
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
prospettiva, non necessariamente nella prospettiva del benessere.
CAPITOLO 14 – UGUAGLIANZA E LIBERTA'
Uguaglianza, imparzialità e contenuto.
L'esigenza di considerare le persone uguali tra loro ha a che vedere con l'esigenza normativa di imparzialità e con le relative istanze
di oggettività.
Capacità, uguaglianza ed altre questioni.
Se l'uguaglianza è così importante e le capacità sono un fattore centrale della vita umana, verrebbe da pensare che è giusto mirare
all'uguaglianza attraverso le capacità. Tuttavia occorre fare alcune osservazioni:
1 le capacità rappresentano un unico aspetto della libertà, relativo le opportunità reali e non possono dare adeguata ragione
dell'equità chiamati in causa dalle procedure essenziali per l'idea di giustizia; dunque le capacità riguardano i vantaggi
individuali e, benché possono implicare qualche aspetto di carattere procedurale, non sono in grado di dirci molto
sull'equità dei processi in questione.
L'approccio delle capacità può rivelarsi prezioso per giudicare le opportunità effettive degli individui, ma ciò non elimina
alcun modo la necessità di prestare la massima attenzione all'aspetto procedurale della libertà, quando si tratta di compiere
valutazioni in materia di giustizia.
2 Possono poi sorgere altre stanze sul fronte dei giudizi in materia di distribuzione, per comprendere le quali potrebbe non
essere sufficiente interpretarle come istanze di pari libertà per tutti gli individui.
3 Quello di capacità un concetto plurimo plurivoco perché può essere definito modi diversi (distinzione tra libertà come
benessere e libertà come azione). Inoltre, la classificazione delle capacità, anche quando fa riferimento un aspetto specifico
non sfocia necessariamente in un ordinamento completo.
4 L'uguaglianza non è l'unico valore con cui ha a che fare l'una teoria della giustizia, nella sola dimensione così utile l'idea di
capacità.
Capacità e libertà personali.
L'approccio che le capacità non va contro il primario principio di libertà espresso da Rawls: Esso sostiene solo che non nell'analisi
del vantaggio individuale e meglio porre l'attenzione sulle capacità piuttosto che sui beni primari.
Sen accoglie il primo principio della teoria rawlsian (preminenza di una libertà personale condiviso da tutti) e si interroga se tale
principio debba considerarsi assoluto.
In realtà vi sono numerose possibilità intermedie tra il non riconoscere la giusta importanza alla libertà e l'assegnarle la supremazia
assoluta.
In molti caratteri della libertà.
Una persona può giungere l'esito desiderato determinando, tramite le protezioni, quello specifico risultato: si tratta del “controllo
diretto”, che non è comunque indispensabile per l'attuazione effettiva.
Vi sono poi casi in cui le scelte di un individuo sono realizzabili tramite l'intervento altrui: in questi casi si parla di ” potere indiretto”,
esercitato da altri attraverso un “potere effettivo” (esempio del medico che prende decisioni per il paziente incosciente, ma che se
potesse darebbe la sua approvazione – in questo caso il benessere del paziente e quello visto dal punto di vista medico coincidono,
ma non è sempre così).
Ancora si può distinguere il caso in cui il conseguimento di un certo risultato si ha in virtù di una determinata preferenza
(eventualmente conforme a quella degli altri soggetti coinvolti) e l'ottenimento fortuito di ciò che si desidera (in quest'ultimo caso
non si può parlare di attuazione effettiva).
Capacità, dipendenza e interferenza.
Sebbene i termini libety e freedom vengono spesso usati come fossero termini dal significato identico, Rawls nelle sue accezioni,
sebbene sia favorevole al primato della libertà (liberty), pone particolare attenzione sul concetto di freedom nella vita delle persone e
specialmente dall'importuna interferenza altrui, tra cui lo Stato.
Libertà è strettamente legato all'approccio delle capacità.
Impossibilità dell'liberale paretiano.
Nella teoria della scelta sociale, interessata alle situazioni che si determinano nelle società, la prassi di guardare alla libertà in
relazione agli esiti è stato oggetto di particolare attenzione.
All'attenzione ha portato al teorema dell' “impossibilità del liberale paretiano”: tale teorema dimostra che se una persona può avere
tutte le preferenze che desidera, allora i requisiti formali dell' ottimalità paretiana possono risultare incompatibili con alcuni requisiti
minimali relativi alla libertà personale.
L'impossibilità del liberale paretiano deve con ciò essere vista come una possibilità di discussione pubblica su questioni che
altrimenti non sarebbero sollevate.
Scelta sociale e forme di gioco.
La questione dell'interdipendenza nella definizione di libertà è particolarmente importante per rilevare le cosiddette “azioni
invasive”.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
Lo schema da seguire consiste in un gioco a ritroso, partendo dai risultati accettabili per risalire alle
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: HanktheT (hank.vontoska@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- 3 Psicologia GiuridicaDocumento31 pagine3 Psicologia GiuridicaMaria grazia creaNessuna valutazione finora
- Intuitivamente liberi: Il contributo della filosofia sperimentale al dibattito sul libero arbitrioDa EverandIntuitivamente liberi: Il contributo della filosofia sperimentale al dibattito sul libero arbitrioNessuna valutazione finora
- Sociologia FerrariDocumento34 pagineSociologia Ferrariocchiazzurri78100% (2)
- 9 - DEMOCRAZIA e DirittiDocumento2 pagine9 - DEMOCRAZIA e DirittiHankxNessuna valutazione finora
- Sociologia Della DevianzaDocumento37 pagineSociologia Della DevianzaSilvia Carra LucchiniNessuna valutazione finora
- BRACALETTI 2017 La Teoria Della Scelta Razionale. Applicazioni e ProblematicheDocumento16 pagineBRACALETTI 2017 La Teoria Della Scelta Razionale. Applicazioni e Problematiched31280Nessuna valutazione finora
- L'utilitarismo 1.odtDocumento77 pagineL'utilitarismo 1.odtGiulia ConversNessuna valutazione finora
- Docsity Corso Di Filosofia Politica 3Documento31 pagineDocsity Corso Di Filosofia Politica 3Tuğçe Aysu AykanatNessuna valutazione finora
- Idolon RiassuntoDocumento35 pagineIdolon RiassuntoArianna ScerboNessuna valutazione finora
- Giorgio Braga - Le Forme Elementari Della Societa PDF'Documento50 pagineGiorgio Braga - Le Forme Elementari Della Societa PDF'Cataldo MarinoNessuna valutazione finora
- Scienze SocialiDocumento9 pagineScienze SocialimatildeNessuna valutazione finora
- Sociologia - I ClassiciDocumento3 pagineSociologia - I ClassiciSilviaNessuna valutazione finora
- Felicità Apparente e Felicità Effettiva: Il Metodo Scientifico Applicato alla Condizione Umana - Volume IXDa EverandFelicità Apparente e Felicità Effettiva: Il Metodo Scientifico Applicato alla Condizione Umana - Volume IXNessuna valutazione finora
- Etica Contractualista J. RawlsDocumento4 pagineEtica Contractualista J. RawlsAliz LopezNessuna valutazione finora
- Le Tradizioni WeberianeDocumento4 pagineLe Tradizioni WeberianeLèderNessuna valutazione finora
- Politica e Societa Introduzione Alla SocDocumento20 paginePolitica e Societa Introduzione Alla SocveraNessuna valutazione finora
- Manuale Di Sociologia - F.ferrarottiDocumento19 pagineManuale Di Sociologia - F.ferrarottiSara GentileNessuna valutazione finora
- Filosofia Morale Lezioni InizialiDocumento3 pagineFilosofia Morale Lezioni InizialiASSIA ZABORINessuna valutazione finora
- S - Petrucciani Modelli Di Filosofia PoliticaDocumento49 pagineS - Petrucciani Modelli Di Filosofia PoliticaMarco Scuderi100% (2)
- La filosofia sociale del pragmatismo: Un’introduzioneDa EverandLa filosofia sociale del pragmatismo: Un’introduzioneNessuna valutazione finora
- Rawls e Sen - Teorie Della GiustiziaDocumento9 pagineRawls e Sen - Teorie Della GiustiziaGiacomo MauroNessuna valutazione finora
- SZ Dial ECO ETICADocumento10 pagineSZ Dial ECO ETICAbeapapinaNessuna valutazione finora
- Psicologia Di Comunita - Programma CompletoDocumento50 paginePsicologia Di Comunita - Programma CompletodavideptraderNessuna valutazione finora
- Riflessioni Su "Una Teoria Della Giustizia" Di John RawlsDocumento19 pagineRiflessioni Su "Una Teoria Della Giustizia" Di John RawlsBenessere ItaliaNessuna valutazione finora
- Pensieri lenti e veloci: Un libro sulle fallacie che possono compromettere il processo decisionale umanoDa EverandPensieri lenti e veloci: Un libro sulle fallacie che possono compromettere il processo decisionale umanoNessuna valutazione finora
- SchutzDocumento7 pagineSchutzfrancescaNessuna valutazione finora
- Ideologie 800 - 900Documento8 pagineIdeologie 800 - 900Francesco LanninoNessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion Pratica - Immanuel KantDocumento3 pagineCritica Della Ragion Pratica - Immanuel KantgiorgiaNessuna valutazione finora
- I DIRITTI DELLA DEMOCRAZIA Anna Pintore RiassuntoDocumento16 pagineI DIRITTI DELLA DEMOCRAZIA Anna Pintore RiassuntoGiovanni PorcedduNessuna valutazione finora
- Manuale Di Sociologia - Ferrarotti (Boris)Documento37 pagineManuale Di Sociologia - Ferrarotti (Boris)Mario Dottor BlueNessuna valutazione finora
- Politiche Della Relazione RevDocumento15 paginePolitiche Della Relazione RevMarco MauriziNessuna valutazione finora
- WeberDocumento5 pagineWebergigiNessuna valutazione finora
- Tesi Di Laurea Alessandra RuffoDocumento37 pagineTesi Di Laurea Alessandra RuffoAlessandra RuffoNessuna valutazione finora
- Il Dibattito Sul Libero Arbitrio Nell'ambito Della Filosofia Analitica ContemporaneaDocumento128 pagineIl Dibattito Sul Libero Arbitrio Nell'ambito Della Filosofia Analitica ContemporaneamichelezanellaNessuna valutazione finora
- Relazione John RawlsDocumento3 pagineRelazione John Rawlsmartinamotti2004Nessuna valutazione finora
- MAGAZZINO-Introduzione, Capitolo 1Documento25 pagineMAGAZZINO-Introduzione, Capitolo 1luigixv80Nessuna valutazione finora
- Introduzione Alla SociologiaDocumento5 pagineIntroduzione Alla SociologiaDaniele PulvirentiNessuna valutazione finora
- Dispensa Organizzazione AziendaleDocumento40 pagineDispensa Organizzazione AziendaleRiccardo Maria BertoniNessuna valutazione finora
- PetruccianiDocumento18 paginePetruccianiSara PiccoliNessuna valutazione finora
- Smelser-Manuale Di SociologiaDocumento54 pagineSmelser-Manuale Di Sociologiadarlenelilley100% (2)
- Rush - "Politica e Società"Documento21 pagineRush - "Politica e Società"Matteo MiriglianoNessuna valutazione finora
- Bruno CelanoDocumento31 pagineBruno CelanoJussara NozariNessuna valutazione finora
- Sociologia Libro CroteauDocumento30 pagineSociologia Libro CroteaudeboraNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO-SCIENZA-POLITICA 1 PDF PDFDocumento28 pagineRIASSUNTO-SCIENZA-POLITICA 1 PDF PDFDavide PinnaNessuna valutazione finora
- Giustizia sociale: Aspetti teorici e assetti istituzionaliDa EverandGiustizia sociale: Aspetti teorici e assetti istituzionaliNessuna valutazione finora
- Ripperini RipperoniDocumento6 pagineRipperini RipperoniGiuseppe Di MartinoNessuna valutazione finora
- Lezione 2 - 05 Marzo 21Documento10 pagineLezione 2 - 05 Marzo 21Anna CirilloNessuna valutazione finora
- IL POSITIVISMO GIURIDICO - VillaDocumento44 pagineIL POSITIVISMO GIURIDICO - VillaNuccia MaltaNessuna valutazione finora
- Luisa Avitabile PDFDocumento31 pagineLuisa Avitabile PDFGonzaloNessuna valutazione finora
- MILL Appunti e RiassuntoDocumento8 pagineMILL Appunti e RiassuntoLaurence CampbellNessuna valutazione finora
- STATO DI DIRITTO, Di Bruno Celano.Documento89 pagineSTATO DI DIRITTO, Di Bruno Celano.bentospinozaNessuna valutazione finora
- Sociologia Dei Processi CulturaliDocumento40 pagineSociologia Dei Processi Culturalisabattini.ireneNessuna valutazione finora
- LE LOGICHE DELLE ORGANIZZAZIONI Potere, leadership, cultura, comunicazione e gruppiDa EverandLE LOGICHE DELLE ORGANIZZAZIONI Potere, leadership, cultura, comunicazione e gruppiNessuna valutazione finora
- Sociologia - Prospettive Sociologiche A ConfrontoDocumento2 pagineSociologia - Prospettive Sociologiche A ConfrontoSilviaNessuna valutazione finora
- 1 Capire La PoliticaDocumento13 pagine1 Capire La PoliticaMati BadoniNessuna valutazione finora
- L'UGUAGLIANZA DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI, ovvero dell'origine dell'UGUAGLIANZADa EverandL'UGUAGLIANZA DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI, ovvero dell'origine dell'UGUAGLIANZANessuna valutazione finora
- Pieghevole Residenza Anni Azzurri Beato Angelico PDFDocumento2 paginePieghevole Residenza Anni Azzurri Beato Angelico PDFGiorgio IncrocciNessuna valutazione finora
- Catalogo General 2015 It PDFDocumento173 pagineCatalogo General 2015 It PDFHolmann Erick Acevedo100% (1)
- CosmeticaItaliadigitale DEFDocumento236 pagineCosmeticaItaliadigitale DEFMarella ItriNessuna valutazione finora
- Sintesi Leggi Della SemplicitaDocumento7 pagineSintesi Leggi Della SemplicitaMark MeanNessuna valutazione finora
- I Soldi Fanno La FelicitaDocumento1.806 pagineI Soldi Fanno La FelicitastoccolucaNessuna valutazione finora
- La Salute Sostenibile, Marco Geddes Da Filicaia (Riassunto)Documento10 pagineLa Salute Sostenibile, Marco Geddes Da Filicaia (Riassunto)Diana d'Alessandro BulsaraNessuna valutazione finora
- Tesi PoleseDocumento136 pagineTesi PoleseNicola Simonella100% (1)
- Psicologia Di ComunitàDocumento40 paginePsicologia Di ComunitàAlice BenassiNessuna valutazione finora
- Modelo Tecnico ProgamaDocumento156 pagineModelo Tecnico ProgamaYo VyNessuna valutazione finora
- Descrizione Massaggi Accademia Olistica Relax and DreamDocumento44 pagineDescrizione Massaggi Accademia Olistica Relax and DreamStany De CocinisNessuna valutazione finora
- LA GESTIONE DEL Tempo e Degli ObiettiviDocumento46 pagineLA GESTIONE DEL Tempo e Degli Obiettivicrezero100% (2)
- Cromopuntura ItalianoDocumento158 pagineCromopuntura ItalianoJessicaNessuna valutazione finora
- XCAT00004-Catalogo Unico Rendition2Documento186 pagineXCAT00004-Catalogo Unico Rendition2MichealNessuna valutazione finora
- Progettazione Edilizia Scolastica Normativa 9788857902708Documento45 pagineProgettazione Edilizia Scolastica Normativa 9788857902708Ilias ZogosNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di Psicologia Di ComunitàDocumento15 pagineFondamenti Di Psicologia Di ComunitàAnna MalgieriNessuna valutazione finora
- Resort FORTE VILLAGE A Santa Margherita Di Pula in SardegnaDocumento18 pagineResort FORTE VILLAGE A Santa Margherita Di Pula in SardegnaECYBNessuna valutazione finora