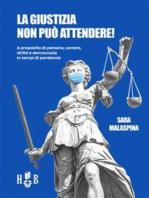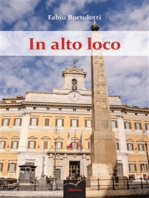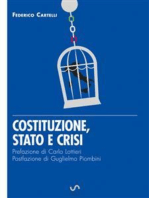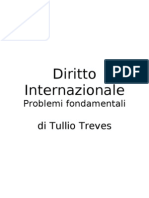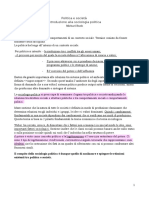Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Luisa Avitabile PDF
Caricato da
GonzaloCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Luisa Avitabile PDF
Caricato da
GonzaloCopyright:
Formati disponibili
"Modernità e pensiero
giuridico - persona, sistema,
testo" L. Avitabile
Filosofia Del Diritto
Università degli Studi di Roma La Sapienza
30 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
<< MODERNITA'
E PENSIERO
GIURIDICO -
PERSONA
SISTEMA
TESTO>>
L. AVITABILE
Appunti di Marta PascarellaPagina 1
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
1. Prefazione
Le caratteristiche del <<moderno>> hanno subito significativi cambiamenti rispetto al momento in cui si è
cominciato a definirlo. Per i padri dell'economia classica ma anche per Marx che fonda la propria teoria sulla
critica dell'economia politica e sulla determinazione delle forme specifiche della produzione capitalistica, la
modernità è legata ad un sistema di creazione della ricchezza basato sulla trasformazione della materia. Vi
sono nuovi modi di produzione della ricchezza e della stratificazione sociale. Gorz analizza il ruolo
crescente esercitato dai beni immateriali nell'economia dei paesi sviluppati.
Trasformazione del lavoro e della vita associata moderna. Castells evidenzia l'apparizione di una nuova
economia, di una nuova rivendicazione dei diritti, di una nuova politica nella <<Galassia Internet>>.
Per Stein i diritti non possono essere radicati sull'interesse individuale (la libertà-di, la facoltà di operare) o
sul bisogno delle masse (libertà-da, l'emancipazione collettiva dalla paura e dalla necessità) ma devono
garantire una <<convivenza dignitosa in una dimensione della libertà-con>>. Lei dice che il diritto viene
affermato quando si attribuisce una posizione predominante alla dinamica ed alla vita della comunità nella
guida dell'opera normativa o nella definizione dei princìpi di giustizia.
Rodotà definisce il ruolo attribuito alla proprietà negli ordinamenti moderni,ma devono tutelare la dignità
umana attraverso l'apprezzamento di passioni e di aspirazioni condivise, attraverso il rispetto della comunità,
attraverso un'opera e un atteggiamento di empatia.
Stein e Tonnies sono molto simili ma diversi. Entrambi vivono nella nostalgia per una società tradizionale.
Vivono in un'Europa coinvolta in una veloce affermazione dell'agire societario e gravata da grandi
spostamenti di comunità e popolazioni. La differenza è tuttavia netta e significativa. Nell'opera di Tonnies la
comunità assume a volte una configurazione terribile. Essa appare come un luogo di relazioni essenziali ma
anche come ghetto e come teatro della marginalizzazione. In Stein la comunità rappresenta uno spazio nel
quale viene superata la discriminazione orientata a disegnare il futuro.
Internet non solo ha velocizzato i tempi della innovazione ma ne ha anche mutato le procedure. Siamo nel
bel mezzo del cambiamento che trasformerà il modo in cui si costruisce il sapere. Oggi l'aspetto più aspro del
conflitto nella globalizzazione si manifesta sul diritto esclusivo all'utilizzo di alcune scoperte scientifiche
fondamentali per la vita: ad esempio quelle in campo farmaceutico o biochimico. Nella Galassia Internet in
materia di "scoperta" scientifica e tecnologica si manifesta uno scontro all'ultimo sangue tra due princìpi
contrapposti: quello della proprietà intellettuale e quello dell'accesso illimitato al bene comune rappresentato
dal sapere.
2. Premessa
Il moderno si struttura come analisi e posizionamento di questi momenti essenziali che passano
dall'antropologia giuridica, alla riduzione sistemico-funzionale, alla formazione della testualità delle norme,
a partire dal testo sociale con attenzione alle forme del linguaggio, non intese solo come linguistica di tipo
strumentale, ma come luogo originario delle relazioni giuridiche. Il giurista ha il volto rivolto alla modernità
e i piedi piantati nella globalizzazione.
3. Fenomenologia della dignità e persona (parte I)
3.1 Persona, dignitas, diritto
Appunti di Marta PascarellaPagina 2
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Dignità: principio primo di ogni vivere sociale, si manifesta in quanto fonte del diritto, autonomo e
multiforme perché appartiene alla pluralità delle culture, ma è allo stesso tempo inscindibile dalla persona,
rinviando all'affermazione kantiana di non trattarla come "mezzo" ma come "fine".
Nell'opera di Stein, il concetto di soggetto è discusso sulla base di una sospensione del giudizio che trova
una sua matrice genetica nella fenomenologia di Husserl. Fenomenizza l'essenza del soggetto come persona
che acquista una valenza giuridica come significante di dignità: ogni soggetto si rapporta all'alterità,
esercitando la propria libertà realizzata non come libertà-di o libertà-da, ma come convivenza dignitosa in
una dimensione di libertà-con, secondo il plesso responsabilità-dignità priva della fuga idealistica di una
libertà purificata dalle sue contaminazioni con il "reale". La persona è l'unico epicentro del diritto, solo a
partire da essa si articola la morfologia della testualità giuridica, sottoforma di leggi, e dello Stato, con la
mediazione della comunità sociale.
Diritto positivo: il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato spazio di
tempo posto dal potere sovrano dello Stato mediante le norme. Per essere attualizzato vi devono essere due
condizioni, il potere costituito e la pluralità di persone.
[ La dignità non è costituita sulla dicotomia comunità/società]
Non bisogna mirare all'interesse del singolo nello status sociale, ma alla specifica ed empatica reciprocità
della coesistenza. La persona non si trova in una condizione di passività, ma la sua dignità è costituita da
un'attività in cui si specifica empaticamente la reciprocità della coesistenza.
Ricerca della dignità -> relazionarsi in modo empatico. Dignitas -> comprensione reciproca in una
dimensione di esercizio della dignità.
[ La persona attraverso il diritto esprime la sua dignità entrando in una dimensione oggettiva
determinata dalla <<realtà giuridica>>.]
Nelle istituzioni giuridiche, non è rilevante la questione connessa all'ambizione dei singoli, che pure assume
contorni definiti, piuttosto l'espressione del vivere in comunità/società marca l'interesse in comune, diretto a
degli scopi, in cui la persona è il fine; la fenomenologia di Stein è rivolta a questa qualificazione della
relazione interpersonale per cui due o più persone, in un ambito di coesistenza, entrano in un rapporto di
empatia e formano un inizio di comunità destinata ad altre situazioni di convivenza e di associazione che non
risultino causalmente macchiniche, ma convergano verso il reale significato della relazione dignitosa.
Società che tende all'utile => uomo come la monade di Leibniz
││
Non si produce una convivenza, ma solo criteri di sopravvivenza autoreferenziale; non istituisce una
legalità finalizzata alla custodia e alla garanzia della dignitas.
Non c'è una priorità gerarchica nelle forme di coesistenza. Le strutture comunitarie sono possibili anche in
assenza di un utile che non può pretendere di segnare esaustivamente la formazione della comunità.
Scheler afferma che esiste in determinate condizioni una comunità senza società, ma non esiste società senza
comunità. La priorità dello spirito di comunità diventa motivo di esistenza delle relazioni interpersonali. La
società si fonda su un coacervo di interessi utilitaristici che il concetto di comunità tende ad escludere, ma
non ad archiviare, nella consapevolezza che anche l'economia, primaria fonte dell'utile, è alla base dei
rapporti interpersonali. Ogni Stato seleziona quindi alcuni elementi finalizzati alla sua strutturazione. In
uno Stato di diritto tutto è possibile ma è allo stesso tempo limitato dall'orientamento al "giusto", alla
dignità della persona. Quel che può essere realizzato deve avere i caratteri di conformità con la dignità
del soggetto.
Appunti di Marta PascarellaPagina 3
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Una selezione sulla base di presupposti pregiudiziali lede tale dignità e viene percepita come un itinerario
verso l'ingiusto, è il caso esemplare della nozione artificiale di <<razza>>. Il realismo costringe a pensare
che storicamente gli Stati sono entità influenzabili da una pluralità di gruppi sociali interni ed esterni: le
lobbies.
Nelle sue disposizioni applicative, lo Stato non è assolutisticamente libero, ma assolve a rapporti di
dipendenza. Soltanto da un'istituzione promissoria che si radichi nelle strutture relazioni dell'empatia come
<<atto sociale>>, può emergere la volontà di rinvigorire il concetto di soggetto o eludere semplicisticamente
gli effetti delle scelte. Un gruppo sociale può operare per ripristinare le priorità dello Sato senza ledere gli
altri.
Stato: forma associativa disciplinato dal diritto ed è determinato dalla presenza costitutiva delle persone che
realizzano l'esperienza storica delle istituzioni. I soggetti vivono e svolgono delle funzioni; lo stato deve
riconoscere la dignità delle persone in quanto tali.
Scelte delle singole persone che convergono nel "governo", in cui si ha una ripartizione delle funzioni.
L'azione costituisce il preludio alla costruzione dello Stato, in quanto sua elaborazione di base. I problemi
reali diventano un presupposto esiziale per configurare nella genesi dello Stato moderno la motivazione
dominante della dignità umana.
In Stein la "ricerca del giusto" si nomina con "diritto puro". Il legislatore non deve stabilire "a priori".
massa: si organizza come un momento aggregativo, motivato da un interesse transitorio, da non confondere
con le rivolte di massa che portano in piazza i problemi definiti reali, ma non sono in grado di progettare una
loro soluzione finalizzata alla garanzia della dignità come riconoscimento di un diritto. Lo spirito della massa
è quello di un gruppo informe non definito nelle sue componenti, non istituzionalizzato, dove l'azione può
assumere caratteri contro-giuridici, lesivi proprio della dignità, e dove i componenti si muovono sull'onda di
un sentimento contingente imitativo. caratterizzata da una passività spirituale.
PERSONA X -> PRESUPP. DI COMUNANZA SENZA UN'EFFETTIVA PROGETTUALITA'<-
PERSONA Y
ex. presupposto ideologico, politico,
economica
NB: appena questi presupposti terminano, la massa perde vigore. Dunque, ha una limitata
durata temporale. Alcuni fenomenologi negano la dignità come incipit della massa.
▲ La ridimensione dell'energia della massa -> nascita di un'iniziale comunità come portato di
spiritualità (persone motivate e coscienti)
Allo Stato si attribuiscono formalmente gli stessi elementi distintivi attribuiti alle persone, ma ovviamente lo
Stato non pensa ecc. Solo le persone che fanno parte degli atti statali sono capaci di sperimentare condizioni
quali tristezza, angoscia, gioia ecc. attraverso l'esercizio della parola stessa. Lo Stato si serve delle persone
con la finalità di promuovere e garantire la dignità e sollecitare le persone ad impegnarsi in questa
direzione: lo Stato sono le persone e non viceversa. -> La persona diventa l'origine del percorso
formativo della comunità che permette di discutere di dignità. Le persone coesistono con la
consapevolezza di essere parte di un tutto.
• SOGGETTO: chi è in grado di compiere atti giuridici. La persona è tale solo nel momento in
cui manifesta il suo carattere di dignità attraverso la parola e si riconosce empaticamente
nell'altro.
Appunti di Marta PascarellaPagina 4
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Comunità -> relazioni a statuto empatico. -> modello organizz. più vicino alla realizz della dignità
della persona nella forma statale.
Massa -> momentaneità del moralismo
• STEIN -> quando la massa si afferma in modo duraturo, a differenza nella comunità, si ha un
soggetto che si trasmuta in un oggetto in senso specifico, ossia un << soggetto obiettivato>>.
Ciò non significa che si ha lo svuotamento della personalità, ma si chiarifica la tensione tra
soggetto e oggetto.
La società per STEIN è un elemento più vicino alla comunità che alla massa ed afferma che la società
è una declinazione della comunità, ossia una sua variante razionale. Al contrario della società, la
comunità è istituita e dunque ha un pieno carattere di consapevolezza. Le forme della società sono
prodotte. LA COMUNITA' PREVEDE OGNI VOLTA UNA SCELTA LIBERA, VOLONTARIA E
CONSAPEVOLE DETERMINATA DI RENDERE CONCRETA LA POSSIBILITA' PER LA
PERSONA DI ESSERE RICONOSCIUTA COME DEGNA.
3.2 Stato-legislatore e dignità
La dignità è un vincolo nella relazione sociale. Il concetto di sovranità deve essere reinterpretato perché la
sovranità dello Stato e la dignità della persona sono implicitamente connesse attraverso il medium della
libertà.
ENTITA' SOVRANA: si può definire tale solo un'entità formata da persone libere e dignitose nella
manifestazione concreta di se stessa attraverso l'esercizio del potere che nel caso della persona
rappresenta la dimensione del logos.
▲ LA PERSONA E' DUNQUE IL FULCRO DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE
FORME DELLE ISTITUZIONI GIURIDICHE, LE QUALI SONO DIRETTE ALLA
GARANZIA DELLA DIGNITA'.
Ci possono essere due tipi di comunità nella trattazione della dignità: la statale e quella del popolo. La
comunità statale viene marcato il concetto di sovranità, mentre nella comunità di popolo manca perché
questa non ha bisogno di una legittimazione attraverso l'esplicitazione della sua sovranità.
POPOLO -> (STEIN) i popoli sono persone che hanno una loro vita, un loro divenire, crescono e
scompaiono. In un primo momento, il popolo sembrerebbe costituire una deminutio dell'elevato momento di
formazione della comunità come luogo privilegiato per la manifestazione della dignità e compaiono nella
lettera scritta da Stein numerose affermazioni sul popolo tese ad umiliare coloro che affermano la grandezza
di un popolo a scapito di altri.
Il popolo si organizza in Stato quando si ha la presa di coscienza con il tutto a cui apparteniamo -> volontà
statale sovrana -> la dignitas della persona pervade l'essere popolo.
!! IL POPOLO PUA' ANCHE NON TROVARE LA CONFIGURAZIONE IN UNA VOLONTA' STATALE
SOVRANA. CIO' E' MOTIVO DI PROPOSIZIONE DELLA DIGNITA' DEL POPOLO COME INSIEME
DI PERSONE E NON COME AGGLOMERATO CHE CONFLUISCE IN UNO STATO. !!
La comunità di popolo infatti sussiste anche nel momento in cui viene meno la dimensione della sovranità e
quindi quella dello Stato. Inoltre, la struttura della persona deve potersi esprimere su due versanti: la
struttura statale (che comprende una pluralità di popoli) e la comunità di popolo (che decide di non dotarsi
di un'organizzazione statale ma che comunque è necessaria alla costituzione dello Stato). La pluralità di
Appunti di Marta PascarellaPagina 5
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
popoli non tralascia la molteplicità di culture e di interessi. La dignità della persona riguarda sia la struttura
statale che le relazioni internazionali.
DIRITTO STATALE + DIRITTO INT. = centri di riconoscimento del "diritto ad essere riconosciuto come
persona" e conducono all'affermazione della dignità implicata nella struttura della persona.
NO IDENTITA' 1 STATO = 1 POPOLO E VIENE ANCHE ARCHIVIATA LA POSSIBILITA' CHE
LA DIGNITA' DIVENTI MONOPOLIO DI 1 COMUNITA' STATALE O DI 1 POPOLO.
Stein, a seguito dell'interpretazione dell'opera di Aristotele, mutua il concetto di filia come vincolo
rafforzativo della relazione tra persone, ma anche tra popoli e Stati ed è la <<coscienza della
comunità>> che prescinde dalla qualificazione da essa in statale o di popolo. La motivazione è
avvicinabile al concetto di sovranità e di terzietà dello Stato-legislatore che ha il dovere di garantire
l'affermazione della dignità di essere persona dei singoli componenti. Stein inoltre afferma che lo Stato è
padrone di se stesso ossia è responsabile degli effetti delle promesse che ha deciso di mettere a fondamento
della sua legislazione. Le persone sono legate da un idem sentire che è rappresentato dal principio della
dignità che è contestuale all'essere persona, come a priori del diritto puro. Le persone rappresentano l'energia
e la motivazione prima della formazione della struttura della coesistenza, sono ossia lo spirito della
comunità.
La comunità di popolo e statale-> designano un proprio compito da assolvere; nel caso del popolo c'è
l'opportunità che manifesti una sua unitarietà nell'espressione di una cultura che rinvia alla spiritualità del
popolo nella comunità e quindi al suo asso creativo.
CULTURA--> creatività delle persone che vanno a formare un universum, ad esempio il popolo, che si
differenzia da altre formazioni perché solo ad esso spetta il compito massimo di creare la cultura dignità e in
questo scambio culturale la comunità trova la sua ragione di formarsi, in virtù di una <<autonomia
culturale>> che, nel caso della comunità statale, diventa effetto della sovranità. Essa e l'autonomia sono
elementi che vengono trasposti nella formazione delle leggi da parte dello Stato nella sua qualifica di
legislatore e allo stesso modo la comunità di popolo è in grado di darsi una disciplina giuridica pur non
caratterizzata da forme legali che permangono nella promessa del legislatore statale.
KANT--> afferma che discutere lo Stato moderno significa teorizzare la divisione dei poteri che la
struttura giuridica impone.
Lo STATO DI DIRITTO non esiste se alla base non vi è una comunità che ha insito il presupposto creativo-
qualitativo e non solo quello formale, cioè quando si basa sul concetto di dignità, vale a dire sulla
complementarità di diritti e doveri di fronte allo Stato.
3.3 Grundnorm e dignitas
L'equazione STATO = DIRITTO chiarisce la legittimazione della formazione delle leggi ed è un
riconoscimento autorevole attraverso le forme statali. La gradualità nella formazione statale diventa
procedura necessaria per la sua costituzione legislativa che così si distanzia dalla possibilità di selezionare o
imporre una Grundnorm, priva del riferimento essenziale all' a priori della dignità della persona, fulcro
intorno al quale ruotano i poteri dello Stato o di qualunque altra organizzazione si intenda scegliere per la
formazione delle leggi.
Tonnies ha contribuito a differenziare le formazioni comunitarie da quelle sociali, ma la preoccupazione che
può essere letta nelle pagine di Stein è relativa a che la società, intesa in modo restrittivo, possa contribuire
a svilire, senza l'apporto degli elementi esiziali della comunità, il concetto di dignitas. Se per società si
possono intendere quelle formazioni che vengono istituite dalla volontà dei partecipanti, in qualità di persone
libere. La comunità ha uno statuto temporale non vincolato all'interesse momentaneo e contingente, ma
Appunti di Marta PascarellaPagina 6
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
ambisce a che l'interesse in comune permanga sotto forma, non di portato assiologico, ma di condivisione
empatica dell'essere pesona che è un altro modo per affermare la dignità. La pluralità comunitaria è la
dimensione interpersonale che assume rilievo sia nella sua dimensione di comunità di popolo che in quella di
comunità statale, però solo quella statale è formalmente idonea a istituire le leggi, il che vuol dire istituzioni
di un diritto positivo, dunque di un ordinamento giuridico con al centro l'a priori della persona ed è sempre
in formazione. Se si può parlare di una prospettiva teoretica proficua in Stein, si deve dire che questa è
implicitamente presente nel concetto di persona estensivo di dignità e di una formazione concreta di
comunità affinché si permanga nella consapevolezza di essere primariamete un insieme di persone.
• NON si può tralasciare la singolarità della persona -> INDIVIDUALITA'
• il singolo si trova in relazione con gli altri -> ALTERITA'
SCHELER considera la persona come un insieme fisico e psichico. Quest'ultima dimensione viene
sperimentata in un mondo condiviso: le persone si relazionano tra loro consapevoli di essere l'inizio di una
comunità; ciò comporta il riconoscimento della dignità.
STEIN afferma che il soggetto che si sviluppa in modo empatico e creativo non esclusivamente
esecutivo=produttivo da origine alla genesi dello Stato di diritto.
La dignità si manifesta nelle istituzioni giuridiche e sociali, le quali sono formate da un atto libero. La teoria
contrattualistica non viene rifiutata pregiudizialmente come atto fondativo dello Stato, ma perché:
contratto -> persone : comandanti o comandati -> possibilità dell'esclusione della dignità, sottratta in egual
misura ad entrambi.
STATO: formazione sociale alla quale sono legate le persone libere in modo che una o più di esse (al limite
tutte) esercitano un potere sulle altre in nome della stessa formazione sociale. C'è un a priori nell'atto sociale
della promessa alla base di questo esercizio di potere. STEIN CON <<POTERE>> NON INTENDE UNA
ISCRIZIONE DI ESSO IN UNA CONDIZIONE FATTUALE. RILEVA CHE L'AUTORITA'
ESERCITANTE IL POTERE SIA IN GRADO DI EMANARE LEGGI CHE DEBBANO RICONOSCERE
LA DIGNITA' DELLE PERSONE ALLE QUALI LA LEGALITA' E' DESTINATA. Lo Stato è dunque
dotato di autorità e potere(sovranità).
LA LIBERTA' -> declinazione del diritto positivo. Le persone esercitando la propria libertà tendono ad una
aggregazione diretta ad uno Stato che legiferi, vale a dire una struttura statale che nell'istituire il diritto
eserciti l'attività di un terzo.
Stein sceglie la struttura comunitaria del popolo per avviare la genesi statale perché unica nella quale
possano aderire liberamente i consociati. Nella comunità, la strutt. statale ha una propria dinamica che la
conduce ad esercitare la sovranità attraverso gli strumenti raffigurabili nella forma di comandi e disposizioni.
critiche verso le teorie giusnaturalistiche, contrattualistiche, imperativistiche -> lo Stato è investito di
un ruolo di assolutezza che oscura il concetto di dignità della persona perché la libertà del singolo nella res
publica diventa secondaria e ha i caratteri meramente esecutivi di una volontà che risulta preordinata dalla
natura o dalla "legge del più forte".
Le formazioni statali vicine al concetto di società "industriale" -> producono atti (sotto forma di
disposizioni e comandi) che sono discordanti con l'essenza dello Stato moderno perché queste attività
potrebbero portare al fallimento le finalità poste come a priori del diritto puro- ove al centro vi è la persona
stessa- e la stessa stabilità che mina la struttura perché è al servizio di un diritto positivo che viola i diritti
della persona.
Appunti di Marta PascarellaPagina 7
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
La dignità della persona è un concetto completamente emancipato dalla storia pregressa della vita
delle persone. (Emancipazione intesa come impegno nelle forme che interessano direttamente la persona in
comunità)
3.4 Dignità e fondazione del diritto
C'è la necessità di far emergere un'alternativa alla nuda metafora contrattuale. Se la contrattualizzazione
dello Stato è rivolta al contenuto della negoziazione, alla cui base vi è un a priori insito nel concetto di
dignità della persona, ne deriva che il patto è una modalità di contrattare che si avvale di forme che sono
capaci di dare priorità ai contenuti.
La critica è rivolta a quegli Stati che hanno sfruttato la loro potenza per conquistare i territori e preteso
l'unione coatta con popoli eterogeni, con l'esclusione della garanzia della dignità della persona. -> diritto
auto-riconosciuto da parte del vincitore che si arroga di tutti i diritti non condivisi che ledono la genesi dei
diritti della persona, ossia la dignità. I termini contrattuali sono intesi nel binomio vinti/vincitori.
comunità e società ≠ passaggio per la forma statale. Gli Stati possono nascere da entrambe le formazioni.
Comunità-> sviluppo della dignità come elemento di spiritualità, che tenta di perseguire la legalità a statuto
personale, prima che economico. Comunità spirituale-> forma associativa di riferimento e sovra-ordinata,
sulla base di essa sono strutturate quelle reali. Stein afferma che la comunità detta "sovra-ordinata" non ha
ambizioni gerarchiche autoritarie; rappresentano solo il nocciolo di un altro tipo di comunità. Stato che è
costruito sulla base di un ideale e di un potere: persona che esercita la libertà di parola e che diventa
esperienza concreta nel momento in cui pone le basi nella dignità della persona per fondare se stesso.
SI TEORIZZA UNO STATO AUTONOMO RISPETTO A POSSIBILI GERARCHIE-> potere che lo
spinge ad agire in relazione alla dignità. Nessun soggetto può pretendere che lo Stato di diritto agisca
in modo parziale ed interessato. Ciò avviene solamente se abbia tralasciato il concetto di persona.
[ il riconoscimento del diritto int. è un segno di autolimitazione perché sancisce il rapporto di uno Stato
con altri e per Stein assume il concetto di giustizia solo se afferma la dignità della persona.] ->
affermare il potere illimitato statale non è possibile. La garanzia dell'esistenza dello Stato si trova nel suo
interno, grazie alle persone che lo compongono formando l'esteriorità, nel riconoscimento degli altri Stati.
PIU' CHE ESSENZA DI GRUNDNORM E' CENTRALE QUELLA DI DIGNITAS, LEGGE GARANTE
DEL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI PERSONA.
Lo Stato non è rappresentato né da una singola persona né da un insieme, ma da un insieme di persone
relazionate empaticamente che rinviano ad una comunità detta sovraordinata, ove nominare lo Stato significa
marcare il concetto di potere della dignità. -> porre le basi dello Stato significa specificare la forma dell'atto
su cui esso è edificato. L'atto è valido solo se attualizzato da chi è egli stesso organo dello Stato,
rappresentativo delle decisioni prese al suo interno.
PERSONA-> STEIN afferma che sia necessaria la sua qualifica come un individuo concreto. Prima di
essere "io puro", la persona è parte di una comunità vitalistica, emancipandosene riesce a significare una
serie di relazioni empatiche. il diritto on nasce da un' IO PURIFICATO dal reale, dall'empatia come
premessa biologica. il vissuto dell'io segnala il suo essere e la relazione con gli altri la sua dignità. l'IO
calato nella prassi ha la traccia dello spirito, ogni volta ripristinato dalla volontà.
Parafrasando Sartre, la persona si trova in una prigione quale l'istituzione giuridica nel senso che è
condannata a pretendere dalle istituzioni, che va a formare, il riconoscimento della dignità.
3.5 Dignitas = sovranità
Appunti di Marta PascarellaPagina 8
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Stein analizzano alcune forme di governo ritiene opportuno discutere del sovrano e del popolo, come forme
di unicità e plurivocità. Proprio in base a ciò, è possibile definire il concetto di sovranità e la sua stessa
motivazione secondo la diversità delle forme di governo.
IL PRINCIPIO DI SOVRANITA' appartiene alla struttura statale e non al potere statale. Ciò significa
escludere la possibilità di eventuali manipolazioni del concetto che escludano il carattere di dignità. Si
afferma che la sovranità non appartenga a nessuno, pur nascendo dalle persone per le persone, e ciò significa
spingere essa verso un principio di imparzialità che diventa così intrinsecamente strutturale. Stein definisce
le forme di governo come una espressione di una scelta proveniente da una comunità, non come marcatura
essenziale.
Il fatto che la sovranità appartenga allo Stato è una riflessione del pensiero moderno e il fatto che la forma di
governo non debba essere parziale ma imparziale è un'attribuzione derivante dalla prerogativa della comunità
attribuisce alle forme di governo: ciò emerge dall'opera di Stein. Non ha un'importanza significativa che
la sovranità appartenga alla comunità di popolo o statale, infatti ogni comunità sceglie a chi affidare il
riconoscimento civico dei propri diritti a cui riconosce la sovranità finalizzata al riconoscimento della
dignità della persona. Per Stein dunque sembrerebbe che non ci sia una forma privilegiata di Stato: la
sovranità non deve essere finalizzata al riconoscimento della dignità solo perché esercitata dallo Stato,
ma ha il carattere di autenticità, indipendentemente dalla forma, solo quando riconosce un diritto
positivo nei fatto strutturato secondo le maglie della dignità.
STATO COME PERSONA-> Ovviamente, solo l'uomo in quanto individuo è persona e dire che lo Stato sia
tale significa, in quanto entità formata da persone, che è in grado di esercitare una sovranità diretta alla tutela
della loro dignità. La personalità dello Stato deriva dall'agglomerato di persone che convergono in esso
liberamente per esprimere e realizzare la propria dignità secondo procedure empatiche. La libertà,
concretizzata in un atto di scelta, che porta le persone ad aderire ad uno Stato, rappresenta la motivazione
della sovranità, attraverso <<atti spontanei>>. La libertà è una condizione per le forme di governo.
La sovranità è terza nella garanzia istituzionale della dignità della persona e si manifesta nella terzietà
della funzione legislativa dello Stato( a priori non solo del diritto positivo, ma anche dello Stato stesso).
Stein impone l'attenzione sullo Stato come legislatore. Nel caso della sovranità popolare, il popolo
costituisce la base a partire dalla quale discutere di potere costituito, il che significa che la sovranità
risiede nello stesso popolo. --> la sovranità è autentica solo se rispetta la libertà. Quest'ultima è definibile
solo in relazione alla persona.
Persona libera-> persona che compie <<atti spontanei>>, ove la spontaneità è misura della libertà perché
attraverso gli atti spontanei la persona è in grado di <<governare se stessa>>. La libertà misura della
spontaneità, condizione per l'autogoverno a partire dalla libertà esercitata appunto dalla persona.
Statalità-> nucleo della struttura statale. Stato senza statalità è alla stregua di un individuo che privato della
sua spontaneità si sottomette alla volontà e alla personalità di un altro individuo, in questo caso di un altro
Stato più forte. --> PERSONALITA' e VOLONTA' sono parte intrinseca ed essenziale di un uomo; se
questo è privato di queste due allora si svuota della sua stessa essenza di uomo degno, così come lo Stato
privo di personalità e volontà permane solo nella sua componente formale.
Costruzione statale-> quadro di riferimento dell'habitus della dignità, come a priori del diritto puro.
L'appartenenza allo Stato non significa però condivisione assoluta e permanente dei suoi a priori. lo stato non
ha bisogno di un popolo, ma si fonda su di esso, nelle sue espressioni comunitarie; quando il popolo manca
totalmente appare chiaro che lo Stato non possa definirsi tale. La dignità della persona- al centro dei concetti
di Stato e statalità- ha una struttura interpersonale che esige l'istituzione di regole giuridiche significate
dall'empatia.
Appunti di Marta PascarellaPagina 9
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
4. Sistema giuridico (parte II)
4.1 Questioni che attengono al periodo storico della modernità
Nel tempo della modernità l'analisi si concentra sui concetti come:
✓ persona
✓ dignità questione antropologica-giuridica facendola convergere in un
✓ diritto trascendimento del concetto di giustizia espresso nella riduzione
sistemico-funzionale.
Luhmann riscrive la storia della modernità, mediata dalla distinzione tra società (definita nelle sue strutture)
e la semantica che contiene la totalità del moderno. -> la sua è una critica alla complessità del sistema che si
avvale della dimensione normativa come ulteriore strumento che garantisce la riproduzione della complessità
attraverso il suo decremento.
✓ ragione illuminata;
✓ elementi funzionali congiunti al tentativo di non tralasciare
la pressione della temporalità, le possibilità a disposizione costituzione della
e la varietà. società moderna.
✓ presenza dell'umanità, che assume delle decisioni per
uscire dallo stato di minorità;
Società moderna-> moderno come iato temporale differenziatore tra un 'prima' e un 'dopo'. La costruzione
dei sistemi sociali è in grado di alimentare una 'distanza temporale' creando una differenza tra <<in>> e
<<out>> come propedeuticità dei flussi programmatici.
Appunti di Marta PascarellaPagina 10
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Il sistema diritto emerge destinato a ridurre la complessità ma anche a garantire un livello di stabilità,
attraverso la funzione immunitaria del suo apparato per arrivare ad un grado di stabilizzazione nel convertire
le aspettative da cognitive in normative.
NB: immunitarietà del diritto: cellule in biologia, apparati, biologia giuridica.
normativa: s. f. [femm. sostantivato dell’agg. normativo]. – L’insieme delle norme che regolano una
determinata materia o presiedono alla disciplina di un istituto, di un ordinamento giuridico, e
sim.: applicare, seguire la n. vigente (in fatto di ...).
aspettativa cognitiva: possibilità astratta di acquistare un diritto in base a circostanze che devono ancora
maturare. Per cognitivismo si intende studio dei processi cognitivi (percezione, memoria, ragionamento,
linguaggio, ecc.) con cui l’individuo acquisisce e trasforma le informazioni provenienti dall’ambiente,
elaborando conoscenze che influiscono in maniera determinante sul comportamento
L'uomo moderno è colui che è in grado di osservare il suo osservare. Luhmann a partire da questa
osservazione nella descrizione del moderno fa convergere le proprie riflessioni sul binomio <<tecnica-
individualità>>. -> ciò è utile a non urtare contro il principio di complessità che designa un insieme
appartenente ad un sistema specifico e all'ambiente. La complessità, per la sua impossibilità di un
collegamento che sia diretto ed immediato tra i diversi elementi dello stesso sistema, è percepita come fonte
di disorganizzazione da gestire dall'osservazione, individuata come una opera altamente selettiva. Opera di
catalogazione e di organizzazione intensa e capillare attraverso un'opera di controllo che soddisfi lo stesso
sistema giuridico.
Le strutture hanno una differenza tra autoreferenza e eteroreferenza che caratterizza il processo decisionale
per impedire che qualsiasi sistema venga assimilato al suo ambiente e quindi ad altri sistemi e corra il rischio
di una perdita di 'identità' cospicua. Subentra qui la questione dell' osservazione di secondo grado per
arrivare a definire meglio la differenza tra 'referenza e codificazione'. Una tipologia che emerge dalla
'contingenza' (circostanza, possibilità) e quindi non definito e prestabilito ontologicamente, che si interroga
su cosa possa vedere un osservatore con le sue distinzioni ed è dunque in linea con la mancata
immediatezza della società moderna. -> la totalità è mediata dalla differenziazione, così come
l'osservazione primaria da quella di secondo grado che rende visibile la contingenza.
NB: autoreferenza: determinare i propri stati internamente, mediante un processo di interazione circolare tra
gli elementi che li costituiscono e in modo essenzialmente indipendente dall’ambiente esterno. La teoria dei
sistemi autoreferenziali si fonda sull’assunto generale che i sistemi complessi non sono definibili se non
rispetto ai propri componenti.
L'ego ha bisogno dell'alter per istituire la norma in una situazione di doppia contingenza. L'alter
semplifica la norma ed è funzionale solo nel modo di rappresentare la molteplicità che incanala la
proiezione di nome verso la produzione seriale, ridondante e varia.-> Luhmann analizza e fonda il diritto
su una teoria dei sistemi come un'idea che mette in crisi i criteri e gli a priori classici della filosofia del diritto
e della fenomenologia anche giuridica, individuati in verità e giustizia. Luhmann rivolge l'attenzione alla
'realtà fenomenica' in quanto 'vera realtà'. Discute della realtà già codificata, perché porta al fallimento della
riduzione della complessità, e vuole far emergere l'autocoscienza e la contingenza.
Luhmann espone inoltre le dinamiche del diritto positivo, scegliendo due momenti: l'istituzione del diritto
e l'ideologia, rispettivamente un elemento proprio del sistema-diritto e uno del sistema-politica ed afferma
che questi due momenti, nell'ambito della concatenazione dei momenti sociali, assolvono la funzione
primaria di ridurre la complessità sia ambientale che sistemica. -> il diritto positivo e l'ideologia diventano
dunque il clinamen del sistema, capace di orientare il vissuto di ogni uomo e la sua relativa azione.
riflessioni per capire tra diritto positivo e ideologia quale sia quello prioritario.
Appunti di Marta PascarellaPagina 11
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
NB: la questione posta dal giurista nel rileggere Luhmann è che verità e giustizia impongono l'opzione di
dara una priorità o all'una o all'altra per affermare l'ideologia e il diritto positivo. Inoltre, il giurista afferma
che questa analisi confluirà totalmente nell'operazione dell'osservazione a cui si attribuiscono i caratteri della
selezione fino ad arrivare alle osservazioni di secondo grado, proposte e discusse in modo specificamente
giuridico nel sistema diritto, in quanto attivate dal legislatore e dal giudice.
OSSERVAZIONE DI SECONDO GRADO: avvia la differenziazione a livello di sistemi sociali
particolari. Osservare significa nel senso ormai noto della teoria sistematica qualsiasi tipo di operazione in
grado di effettuare una distinzione selettiva.
In conclusione-> La critica di Luhmann rivolta affinché i vecchi principi vengano ripristinati si trasforma
nella sostituzione di quei principi stessi con concetti alternativi come funzione, programmi, osservazione,
autoorganizzazione, doppia contingenza, stabilità, codice binario.
Ogni sistema, inoltre, funziona con un codice binario: così, il sistema giuridico funziona con la dicotomia
giusto/ingiusto, il sistema scientifico con la dicotomia vero/falso, quello politico con la dicotomia potere/
non-potere, e così via. Non devono verificarsi interferenze o ingerenze di sistemi, pena l’estinzione di alcuni
sistemi.
Il dialogo della tradizione resta salvo e viene auspicato affinché sia in grado di reinterpretare una
modernità che si avvia ad una fine ingloriosa.
L'ambiente si proietta nel sistema per essere organizzato ed il sistema stesso osserva se stesso come sistema
distinto dal proprio ambiente, cioè osserva la distinzione sistema/ambiente. Si dice allora che nel caso della
riflessione, la distinzione sistema/ambiente rientra nel sistema, il quale può vedersi così come se si vedesse
da fuori. In questo si concretizza il re-entry: il sistema osservato si differenzia nella relazione con i
sistemi che servono per reimmettersi nell'ambiente.
La critica di Luhmann è volta anche a criticare i paradigmi ermeneutici classici che non colgono la moderna
dialettica tra ideologia e diritto. -> Dalla ideologia dei sistemi nasce la dialettica politica del diritto, che
sarà elaborato fino all'affermazione che i programmi condizionali di altri sistemi controllano il sistema
diritto. La proliferazione di istituzioni è relazionata al fatto che ciascuna di esse ha un compito
consistente nel selezionare la cospicua complessità.
Luhmann avverte la necessità di sostituire in maniera fittizia il nesso causale con quello di equivalenza,
preparando una logica incardinata nella funzione immunitaria con al centro la formazione di nuove
connessioni. In una crisi politico-giuridca come quella attuale si avverte la speranza di Luhmann, già
anticipata da Nietzsche, ossia di una trasmutazione di valori colmati da una ideologia che riveste il fatto che
il diritto positivo si consegni al sistema politico-sociale perché da esso sembrerebbe provenire nella
traduzione della forza in coercizione normativa di coloro che rivestiranno il ruolo di osservatore primo
(legislatore) e secondo grado (giudice). --> modernità come situazione storica produttrice di sistemi e
subsistemi ove vi è un sistema connettivo tra ideologia e diritto.
il valore ideologico come direttore dell'opera del legislatore non è ascritto alla politica! L'elemento che
unifica il valore ideologico e il diritto è la forma della presa di distanza da sè, ossia dal diritto non
positivizzato e dalla politica come idea.
Positivizzazione del diritto--> formula con la quale si indica la possibilità di attribuire legittimità giuridica
a contenuti variabili a seguito di una ragione che fonda la disposizione legale, legittimando la variabilità
della funzione del diritto che permette di modificare le situazioni in modo indifferente rispetto alla
controgiuridicità. NON si decide solo in base alle azioni, ma anche a proposito di decisioni:
Appunti di Marta PascarellaPagina 12
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
un'autoreferenzialità tautologica (un 'idem per idem'). Da ciò deriva una chiusura autoreferenziale e ciò che
consente la positivizzazione del diritto è la normazione relativa alle procedure adottate per emanare le
norme.
Luhmann dunque afferma:
Società secondo un diritto positivo e secondo una stratificazione di norme -> organizzazione
decisionale (legislatore) -> istituzione di un minimum -> concetti/fatti/atti/circostanze emergono come
norme.
Le procedure : norme sulla normazione. Diventano così diritto positivo. La funzione che struttura le norme
procedurali esige solamente che esse siano trattate come norme fisse all'interno del processo di normazione,
indipendentemente che possano essere modificate con un'altra istanza. Non vengono definite né come giuste
né come vere, alimentano semplicemente il sistema di diritto.
L'evoluzione del diritto, il processo decisionale, è frammentato in una pluralità di decisioni, ciascuna delle
quali scaturisce da premesse decisionali. Ne consegue un modello organizzativo elaborato, diviso,
specializzato e parcellizzato. Luhmann riflette sul fatto che se si deve abrogare una norma non si possono
fare diagnosi e prognosi e per quanto riguarda l'interpretazione non ci si può interrogare sulle alternative
considerate nel passato. Per quanto riguarda le decisioni inerenti sull'istituzione delle procedure non ci è
un'alternativa tra più elementi, ma la perpetrazione di una via già predefinita.
4.2 Stabilità, logica immunitaria e sistema giuridico
La produzione di effetti, mediante gli equivalenti funzionali, occulta l'importanza della qualifica
antropologica, tanto da diventare un uso funzionale della coscienza come un elemento addizionale
dell'apparato immunitario.
NB: Abbiamo già detto precedentemente che il nesso causale scompare e che è di rilievo solo l'uguaglianza
tra gli elementi (a1,a2,a3...) affinché siano equivalenti tra loro e ad un altro elemento (B) nella produzione di
un effetto.
Questa teorizzazione non è applicabile in riferimento alla libertà, come non è possibile una
contestualizzazione sistemico-funzionale dei principi di uguaglianza, giustizia e verità come tali, ma come
poli positivi di una forma a due versanti, ove quello negativo è rappresentato da una non-uguaglianza, non-
giustizia, non-verità.
Per quanto riguarda la funzione, il diritto soggettivo è considerato ingiusto solo perché così è possibile
ristabilire un equilibrio: il diritto soggettivo è ingiusto in quanto definito come 'istituzione paradossale'
perché la costituzione del diritto non attiene al soggetto, ma alla partecipazione di esso al procedimento di
istituzione giuridica. Il paradosso si evolve con l'introduzione del versante negativo non-soggetto=oggetto.
Il diritto soggettivo è sempre un diritto oggettivo. La libertà di coscienza è l'unico diritto, secondo
Luhmann, che sfugge all'elaborazione giuridica. Essa è catalogata tra gli affari strettamente personali,
ascrivibile al "polo coscienza", nel binomio coscienza/non-coscienza.
NB: GIUSTIZIA = SISTEMA ASSORBITO NELLA FORMULA DI CONTINGENZA. Per
contingenza si intende una sorta di schema di ricerca capace di promuovere l'uguaglianza come forma/norma
della ricorrenza delle operazioni uguali da trattare in modo uguale e di quelle diseguali da trattare in modo
diseguale. (concerne dunque le diverse fattispecie).
Il sistema di diritto è costruito su una base affinché si garantisca una stabilizzazione. A primo impatto, il
concetto di stabilità, riferito all'ordine sociale e riconosciuto a livello giuridico, sembrerebbe essere
Appunti di Marta PascarellaPagina 13
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
assicurato da eventi politici. Il concetto di stabilità è in realtà uno dei più complessi dell'intera
costellazione sistemico-funzionale.
Si viene a sviluppare questo tipo di organizzazione:
✓ La politica prepara il materiale da ascrivere al sistema giuridico
✓ il materiale è finalizzato alla pianificazione di concetti, elementi, principi destinati all'attività
parlamentare
✓ la produzione dell'attività parlamentare consiste nella legalità
NB: Questa situazione precede la vera e propria realizzazione della stabilità, in termini fattuali. Ne deriva
che il concetto di 'stabilità' si possa identificare con quello di organizzazione.
La stabilizzazione attiene anche ai processi decisionali e proprio questi suscitano una riflessione sulla
disuguaglianza tra complessità e stabilizzazione: le modifiche nell'ambito dell'ordinamento giuridico e del
diritto vigente devono considerare lo stesso diritto positivo. I diritti soggettivi sono diritti oggettivi e hanno
rilevanza anche sotto il profilo economico.
L'emancipazione dal concetto di Grundnorm, che sia artificiale o naturalistica, comporta una tutela dei diritti
soggettivi che rappresenta anche l'evolversi della civiltà giuridica occidentale, che ha come scopo una
positivizzazione del diritto. Luhmann, riguardo la definizione di valore, ne discute come di un punto di vista
selettivo diretto all'opzione tra una serie di azioni. Il funzionamento di un tale apparato destinato ad essere
scelto per attuare il funzionamento è il metro di valutazione.
I valori acquistano una funzione ideologica, ma bisogna tener presente che secondo quanto concerne
l'ideologia vi è una valutazione che afferma che ogni valore, intercambiabile con gli altri per il concetto
dell'equazione dapprima esposto, è motivo di funzionamento e valutazione dei restanti valori.
Luhmann evolve il suo pensiero a partire dalla sua opera "Il diritto della società". Dapprima infatti
pensava che la stabilizzazione diventasse un processo di adattamento. Ora, la stabilizzazione della
complessità, per quanto riguarda il profilo della differenziazione funzionale-strutturale, fa sì che
emergano i sistemi attraverso l'aiuto della realizzazione microsistematica: lavoro, produzione,
religione ecc.
A fronte di questi sistemi, altri assolvono la loro funzione nominalistica di sistemi (diritto, arte, scienza,
economia ecc.). Luhmann continua la sua riflessione, giungendo al concetto che vi sono una quantità di
sistemi parziali che vanno ad incrementare la riflessività di ogni sistema. La funzione di stabilizzazione è
offerta dal sistema diritto attraverso la logica immunitaria. Il sistema giudiziario diventa centrale con la
logica immunitaria, i codici, equivalenti funzionali ecc. con l'unico obiettivo della stabilizzazione della
concatenazione dei sistemi sociali. L'unica regola è il funzionamento della funzione immunitaria.
La variabilità, come elemento prioritario della decisione, emerge dall'insieme dei meccanismi di potere,
produzione e della gestione decisionale, che a loro volta devono riprodurre elementi di potere, consenso,
comunicazione ecc.
NB: la differenziazione funzionale diviene la chiave di lettura della stabilizzazione dei sistemi: si inserisce
come un elemento di equilibrio nella complessità. Una volta considerata la complessità della condizione di
stabilità, bisogna sottolineare come sarebbe totalmente inutile questa se non fosse coadiuvata dalla
programmazione. E' così che ideologia e diritto sono accumunate da due tipologie programmatiche: la
finalistica e la condizionale.
Appunti di Marta PascarellaPagina 14
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
La programmazione è una forma di selezione che viene elaborata attraverso il modello input/
output. A partire da output ha effetti invarianti e lo scopo è prodotto e il programma viene definito finalistico
(motivazione ideologica). Se viene avviata da input vi è la necessità di una relazione causa-effetto e il
programma è definito condizionale e può essere giuridicizzato. Solo i programmi condizionali sono riferiti
al diritto e non implica automaticamente l'esclusione delle ideologie perché la loro attivazione è
ascrivibile a loro stesse e esse stesse controllano la selezione.
Se si parla di <<certezza>> di diritto significa far aderire la questione della permanenza a quella del
funzionamento stabilizzante. Allo stesso modo, opporre la questione della giustizia come virtù e
l'ermeneutica(analisi) del giurista come esercizio della virtù stessa significa astrarsi da uno schema
concettuale e conseguenziale "se...allora" che non esclude la combinazione tra ideologia e diritto e quella tra
programmi finalistici e programmi condizionali.
4.3 Il diritto come 'rappresentazione'
Trattando gli effetti funzionali, Luhmann costruisce dagli elementi del vivere sociale un campo specifico-
sistemico. Esso è applicabile sia al diritto stesso, sia ad altri momenti di convivenza come la religione o
l'economia.
Il 'sistema religione' ha delle analogie con quello giuridico. La religione deve infatti <<rappresentare
l'appresentato>> come stabilito nelle opere di Husserl. Luhmann intende rappresentare un concetto di
'appresentazione' di cui conserva la forma, rispetto al concetto di Husserl, volto a indicare l'accessibilità
dell'altro in quanto tale, implicita in ogni tematizzazione riguardante il senso.
NB: Con il termine 'appresentazione', Luhmann indica il fatto che l'<<intero>> si lascia cogliere
nell'esperienza del qui e adesso solo attraverso dei frammenti. Significa dunque attribuire all'esperienza
immediata un surplus di significato; immaginare dunque maggiori possibilità di quante se ne possano
attualmente riprodurre nell'esperienza vissuta e nell'agire. Un connubio di possibilità e realtà rinviante
continuamente ad altre possibilità. Il surplus risulterebbe dunque il riferimento all'ambiente e al sistema. Il
senso serve a costruire l'ambiente, mondo di vita per ogni sistema, per ogni vivente e per ogni azione.
Il mondo si 'appresenta' pur non potendo essere completamente rappresentato. La religione, discussa in
questa versione, prevede un ambiente che è per definizione in quanto composto da credenze, fede,
trascendenze e allo stesso tempo <<accessibile e inaccessibile>> rendendosi così più complesso rispetto a
situazioni che prevedono l'intellegibilità ad ogni costo. La religione deve rappresentare ciò che non è
rappresentabile, in una parola <<l'appresentato>>: l'essere-altro del sistema.
La religione si presenta dunque come l'unica funzione di rendere sopportabile la realtà e trasformare in
contingente quel che qualunque altra dimensione farebbe permanere nell'inaccessibile. La religione rispetto
agli altri sistemi sociali acquista una direzione principale e tangibile nella giustificazione e nella
tollerabilità di ogni formazione di aspettativa, permettendo così l'accesso a forme di senso che di fatto
siano comprensibili; allo stesso tempo si caratterizza assumendo la binarietà trascendenza/immanenza,
Dio/mondo, credente/ateo negando ogni equivalente funzionale diventando così un polo attrattivo di
ogni formazione ascetica. ---> La religione deve dunque trasformare una complessità indeterminata in una
complessità determinata.
Anche se come ambizione la religione ha la trascendenza, l'esperienza religiosa rimane contingente e rimane
in essa nascosta la sua funzione primaria che non è tematizzata ma permeata da concezioni fideistiche. La
stessa dogmatica religiosa è caratterizzata da una metadifferenziazione.
NB: LA RELIGIONE NON DEVE DARE RISPOSTE ALL'UOMO, MA COSTRUIRE UNA FORMULA
DI CONTINGENZA. in modo tale da rendere anche tollerabili i cosiddetti sacrifici, gli eventi negativi ecc.
Per il fedele, osservatore sistemico, Dio è ridotto ad una essenziale contingenza, nella consapevolezza che la
Appunti di Marta PascarellaPagina 15
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
sostituzione e l'intercambiabilità delle forme della contingenza è sempre possibile; con l'evoluzione della
società la sostituzione è presto effettuata dal denaro.
Luhmann afferma che la religione non può entrare in modo essenziale nella tradizionale relazione con la
cultura e con lo Stato di diritto.
La cultura è materiale proficuo per lo sviluppo di paradossi, opposta per questo allo sviluppo del sistema di
diritto. La cultura come paradosso può risolversi solo attraverso l'introduzione di una nuova identità,
rappresentata dal polo non-sapere. In comune, diritto e religione hanno il fatto che vi è nel diritto la
possibilità della trascendenza come concretizzazione della giustizia; al pari che nella religione, ove la
giustizia è esplicitata come formula di contingenza.
Il concetto di contingenza trascende le cognizioni(idee) classiche e formula il diritto come passività. L'uomo
è soggetto al diritto, ma non può effettuare una decisione se abbandonato alla funzione della logica
immunitaria che garantisce la funzionalità dei programmi condizionali, al solo scopo di rendere funzionale il
codice binario diritto/non-diritto, permutato in legale/non-legale.
La complessità giuridica si risolve nell'ascrizione alla binarietà codicistica riguardo ciò che è omogeneo o
meno alle aspettative normative in cui ciò che è definito come 'indefferenziato' è rappresentato nel polo
<<non-diritto>>. Nella teoria dei sistemi, la soggettività è incompatibile rispetto alla determinazione dei fini
e dei mezzi che l'uomo si trova a dover fronteggiare in una situazione di semplice imputazione --> Per
Luhmann, le logiche del sistema dominano su quelle del mondo della vita, ovvero su quelle soggettive.
4.4 Conclusione
▲ Norme stabilizzazione riferita alle aspettative.
▲ Cognizione
Le norme definiscono dei comportamenti che implicano l'attesa come aspettativa. Il passaggio dalla
cognizione alla normazione costituisce l'epicentro dell'aspettativa normativa che si manifesta sotto forma di
pretesa.
La differenza sta nel fatto che:
▲ Aspettativa normativa--> codice binario del diritto/non-diritto
▲ Aspettativa cognitiva--> codice binario del sapere/non-sapere, presa d'atto o meno ecc. Intrinseco è
il meccanismo automatico dell'apprendimento, per arrivare ad un appagamento dei contenuti.
L'eventualità che tutte le aspettative vengano generalizzate normativamente è remota. Luhmann è
sicuramente una voce contrastante per quanto riguarda la ripresa di questioni che indicano le moderno Stato
di diritto un modello di organizzazione politica, realizzato in modo parziale nella società globalizzata che è
perennemente in crisi nella società moderna, sottoposto nella prassi politica a sensibili orientamenti rispetto
alle sue possibilità.
La pretesa reale di costruire uno Stato/sistema nella contingenza si afferma solo come principio di
stabilizzazione delle divergenze. E' dunque possibile anticipare gli stessi conflitti ed è opera del diritto che li
considera risolvibili attraverso il ricordo allo schema legale/non legale.
NB: Le connessioni tra diritto e politica come attendibilità dell'ordine funzionale comportano che la
questione del primato sia affidata alla politica e implicitamente all'ideologia.
Appunti di Marta PascarellaPagina 16
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
2 concetti + apparato strumentale fornito a priori La contraddizione da cui nasce il
dall'emersione dei sistema giuridico, ma non è
disfunzionale ad esso, si manifesta
sistemi = aumento della complessità sociale come nella condizione di selezionare e
conseguenza di un rapporto tra politica e società accettare i mutamenti provenienti
dalle relazioni intersistemiche. Il sistema è costituito anche dal ''non-diritto'', concependo la sua identità
specifica proprio in queste differenze che permettono la circostanza di apertura e chiusura dei sistemi.
L'apertura dei sistemi sociali permette di far conoscere all'esterno le operazioni autoreferenziali che in questo
modo non favoriscono la globalità totalizzante. L'autoriferimento è praticato anche attraverso la chiusura
operativa ed è una condizione per la differenziazione del sistema dall'ambiente che è l'autoriflessione del
sistema e l'eteroosservazione.
Lo Stato si identifica con il potere politico e non è nuovo che la struttura del senso è basata su una
interconnessione operazionale, alla quale si alimentano i sistemi parziali e la costellazione dei sistemi
sociali.
L'operazionalità equivale a quella comunicazione che rende possibile il sistema e il caso eccezionale,
definibile società, è costituito semplicemente da un nucleo di informazioni che ne produce altre,
rinviando ad altri processi informazionali.
In Luhmann è importante la valorizzazione funzionale del concetto di politica che si costituisce come
sistema eterarchico (dominio sull'altro).
Lo schema di Luhmann è delineabile attraverso due concetti:
✓ contingenza
✓ selezione della complessità
La conclusione--> la politica non può subire giudizi valutativi, ma deve essere l'affermazione esclusiva della
contingenza del sistema politico, poiché unicamente con queste premesse si impedisce la fusione tra sistema
politico e altri sistemi. Vi è una concatenazione articolata: la complessa costellazione dei sistemi sociali
differenzia al suo interno il sistema politico. Si costituisce inoltre come struttura sociale nel momento in cui
concretizza interconnessioni di tipo politico ed involve, in qualità di subsistemi, operazioni di ordine non
politico per organizzare e gestire un controllo sistemico-funzionale.
La politicizzazione, emersa come un sistema distinto dall'ambiente, non è considerabile come una
procedura sociale di condivisione di una ideologia. Le strutture politiche rinviano a concezioni di tipo
burocratico-politico che veicolano i problemi di ordine economico. Non è più un orientamento del
diritto positivo, ma come seguace dell'eterarchia funzionale.
La società sistemica-funzionale alimenta più del necessario le operazioni e l'interconnessione serve a
semplificare la complessità. Il potere politico è ormai definito da quello finanziario, le competenze
decisionali fungibili a seconda della capacità di produrre profitto. La politica perde il suo versante ideologico
per promuovere quello economico-finanziario, più rapido ed efficace in virtù del denaro.
Programmi condizionali e programmi finali rimangono una fantasia illusoria.
La conflittualità sociale non può rintracciare una soluzione immediata e definitiva in ambito politico, ma
solo attraverso la costituzione degli apparati legislativi e giurisdizionali, nonché di polizia. La presenza del
Appunti di Marta PascarellaPagina 17
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
scompaiono nella convergenza verso il sistema diritto in potere politico si dissemina nelle
cui consiste una logica immunitaria diretta alla istituzioni a causa della sua
stabilizzazione e alla ricorsività. incapacità di cooperazione che
trascende gli apparati burocratici,
di cancelleria, di polizia. La forza politica è esercitata nella divisione decisionale che non consente una
ideologia omnicomprensiva --> ciò potrebbe emergere come una priorità del sistema giuridico attualizzata
attraverso i programmi condizionali che invece viene condizionato fortemente dalla politica.
In Il diritto della società il diritto è sottoposto alle coercizioni economiche sulla base di un'astrazione perché
solo così si realizza il nesso interscambiabile diritto-ideologia. L'ideologia assume di volta in volta contenuti
diversi a seconda della contingenza che la attraversa.
Per Luhmann:
Stato= formato da molteplici funzioni nel loro differenziarsi; costruzione artificiale fonte di oggettività
funzionale che si distanzia dall'ordine naturale delle cose.
Illuminismo= espediente per avvalorare la condizione sistemico-funzionale come unica opera
fenomenologica che può essere fonte della costruzione di sistemi.
• Stato
• diritto
Nella modernità, nonché 'nuovo Illuminismo', la stabilizzazione non si identifica con il principio di
sicurezza, ma è un prodotto del sistema che attraverso il codice binario diritto/non-diritto seleziona i
materiali provenienti dall'ambiente per assegnarli ad uno dei due versanti del codice binario.
NB: Se Luhmann dovesse rielaborare l'idea di Stato moderno la collegherebbe all'idea di autorità legislativa,
in cui vi è la pretesa dell'obbedienza. Cercherebbe inoltre di discriminare il diritto dalla legalità, le legge
giuste dalle ingiustizie legali ecc.
Questa differenza manca in Luhmann manca ed è in contrasto con tutto il contesto funzionale e risulta priva
di senso. La legalità ingiusta deriva da uno Stato criminale, ossia uno Stato che non stabilisce né riconosce
alcun ordinamento giuridico, ma soltanto delle operazioni omogenee ad una funzione qualsiasi che si afferma
in modo vincente.
Nell'ambito della stabilizzazione permessa dalla logica immunitaria, la libertà viene assorbita dalle
operazioni intersistemiche, diventa un vuoto nel calcolo, ma può operare solo mediante lo sviluppo di
operazioni funzionali.
Le considerazioni riguardanti su Stato e diritto conducono ad una valutazione illuministica in
Luhmann che cerca di dimostrare che distinguere morale ed etica significa basarsi su 'un artefatto
storico', reso possibile dall'incremento della complessità sociale che si interroga sulla propria morale.
Affermare che la morale si fondi sull'etica comporta che l'azione di fondazione comporti la presenza di altre
possibilità e dunque è necessario che vi sia un 'autosabotaggio' in quanto vi è un'apertura verso altre
possibilità, mentre vorrebbe chiuderle. Fondare la morale diventa un'impresa paradossale e Luhmann la
sostituisce con la teoria riflessiva della morale stessa. --> l'etica non fonda la morale ma la inventa, nel
senso latino invenio.
Appunti di Marta PascarellaPagina 18
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Nominare lo Stato di diritto equivale affidarsi alla valutazione democratica in cui la comunicazione è il
fulcro del vivere sociale e nel riconoscimento di leggi diritti ecc. La democrazia secondo Luhmann configura
la continua ricorsività della decisione.
In Luhmann i criteri sono generali e destinati ad optare per una preferenza in una selettività funzionale. I
valori non possono fondare la verità in senso tradizionale ma assolvono all'orientamento imposto da
un'ideologia. Quando si fissa un sistema generale di valori o più sistemi, si organizza in modo sistematico la
sfera delle conseguenze dell'agire. I sistemi dei valori ordinano una graduatoria di conseguenze.
5. Testo e testualità giuridica (parte III)
5.1 La testualità giuridica
Appunti di Marta PascarellaPagina 19
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Legendre riflette sulla modernità sostituendo al concetto di diritto artificiale quello di diritto istituito
attraverso i testi, fonte di produzione giurisdizionale e legislativa. Il suo progetto si basa sul discutere il
diritto - come discorso -, il riferimento primario e il concetto di terzietà che motivano congiuntamente
l'interrogativo sul rispetto delle leggi e sulla loro presenza nella vita dell'uomo.
Il giurista, come legislatore e giudice, ha il compito di trasmettere un capitale di saperi che rinviino al diritto
romano e canonico, base dell'architettura normativa formale della modernità. Il diritto è dunque un momento
rappresentativo, inteso come la struttura della parola, della celebrazione dei riti e delle procedure per la
formazione delle leggi e per la loro esecuzione.
Legendre --> modernità come teatralizzazione delle procedure rituali, espresse nel processo, che si
sviluppano a partire da una modalità giuridico- formale, che emerge nella società come prodotto. Così si
presenta l'istanza della parola che si identifica con l'affermazione e la garanzia dei diritti umani.
• ISTITUZIONI PUBBLICHE RIGUARDANO:
- Complessità del linguaggio;
- Interpretazione e la trasmissione dei testi giuridici;
- Riproduce circostanze, situazioni, miti, leggende e immagini mediate dall'ermeneutica giuridica,
oltre uno status fattuale.
NB: Riflessione sul diritto che trova una struttura prioritaria in alcune strutture linguistiche come quelle
grammaticali, dove il ruolo della parola è l'analisi linguistica dei testi che risale alle tecniche dei
glossatori medievali. Insieme di regole che attribuiscono un posto alle parole nella struttura discorsiva,
nella formazione del testo giuridico e nella destinazione di esso a soggetti diversi nella variabilità delle
fattispecie dell'ordinamento sociale.
Isidoro di Siviglia considera la grammatica come una scienza della "scrittura" che si rivolge ad una
discorsività dove le affermazioni sono ordinate come oris ratio, che diventa ratio iuridica, quindi logica
della regola linguistica, trasmessa attraverso la testimonianza dei testi giuridici. Il ruolo ed il servizio della
scienza grammaticale - ossia l'analisi, la gestione, la classificazione della semantica - rappresenta solo l'inizio
dell'interpretazione giuridica. --> sorta di ermeneutica
Il Grammatico: saggio che organizza parti di un discorso, secondo un metodo 'scientifico', qualificato
dall'attribuzione di senso e di significato, oltre una classificazione meramente sintattica. L'erudizione che si
afferma nel moderno è un processo che ambisce alla ricostruzione del passato come testualità ordinata
secondo un principio di legittimità.
Evoluzione nelle spiegazioni grammaticali che prendono il posto delle procedure, imponendosi come
metodologia oggettivista, tecnica atta a rendere chiaro il materiale del capitale ereditato dal diritto
romano e canonico. Poi ci sarà l'explicatio litterae, che ambisce ad ottenere risultati funzionali.
Legendre afferma che l'interpretazione della modernità è anche il risultato dell'attività di comprensione del
Corpus iuris come fonte di essa, attraverso una sfera tecnica dell'interpretazione e della grammatica come
scienza; il diritto si manifesta e appare in testualità manipolate da una serie di elaborazioni tecniche che
finanziano pratiche normative non interessate alla domanda sul senso del giusto.
Cos'è dunque lo Stato moderno? Diventa una fictio ossia non più un'entità territoriale circoscritta da
confini, ma soggetto di finzione, sintetico perché evocatore di diritti singolari, in riferimento ad una globalità
giuridica che dimostra la sua universalità. Abdica alla capacità rappresentativa di garanzia, istituendo così la
fase della specializzazione nell'applicazione e nell'elaborazione tecnica di un testo e segnalando
contestualmente la soppressione del legame diritto, norme e linguaggio giuridico. --> il diritto si lascia
Appunti di Marta PascarellaPagina 20
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
trafugare dal potere come istanza del più forte, non garantendo più l'universalità e
l'incondizionatezza.
Legendre nella critica della modernità, afferma che il problema radicale ha una sua derivazione dal lavoro
giuridico svolto dai glossatori medievali. Il diritto, in una direzione referenziale, che custodisce l'imparzialità
del terzo, non è rappresentabile come pure tecnica in un segmento spazio-temporale delimitato da pretese di
purezza, non può essere assimilato solo al versante tecnicista o solo a quello idealista.
NB: Svolta interpretativa nel diritto che coinvolge soggetti, situazioni plurime che si impongono
all'attenzione del giurista. La testualità giuridica si impone come momento che non può essere rimosso in
favore della contingenza normativa.
La genesi del diritto è discussa attraverso la proposizione di uno schematismo dei due Corpora che sono
formati entrambi da racconti delle origini, da frammenti e da glosse. Non si evidenzia la differenza tra i due,
ma piuttosto il fatto che la questione dei testi si imponga come problema impellente nelle aspirazioni di un
diritto universale. In entrambi sono presenti rapporti regolati, regolanti e collegamenti normativi.
Ad una attenta lettura si evince che i due Corpora, ossia quello civile e il canonico, delineano un paradigma
testuale che impone all'attenzione del giurista la questione del rinvio genealogico come riferimento non
esauribile in un testo sedimentato ed elaborato. Il pensiero di Legendre rappresenta una riflessione su quello
che ancora dicono i testi della romanità e del medioevo nella modernità.--> Nella lettura dei testi giuridici
attuali è necessario un riferimento che nell'interpretazione dei due Corpora è definito come 'principio
genealogico'.
Il diritto è considerato puro nel momento in cui viene privato della ratio giuridica razionale, quando non
considera gli effetti dell'esperienza giuridica, sia nella dimensione endoreferenziale che eteroreferenziale; un
diritto che non si riferisce ad una ratio relazionale discorsiva diventa inespressivo sotto il profilo della
giuridicità; un diritto che non si riferisca ad una ratio relazionale discorsiva diventa inespressivo sotto il
profilo della giuridicità. La specificazione della ratio in riferimento alla communitas istituisce la giuridicità
'dogmatica' espressa nella testualità normativa.
5.2 La rivoluzione dell'interprete
Il principio genealogico diviene il centro della dialettica ermeneutica tra soggetto e struttura della parola.
L'attività tecnica effettuata dal glossatore medievale comporta la rimozione della parola come discorso
giuridico e di conseguenza quella del soggetto che si realizza attraverso meccanismi che hanno come esito la
pretesa totalitaria della parola che segnala la burocratizzazione, in cui si converge l'attenzione rigorosa alla
forma tecnica del discorso a scapito dei contenuti del testo.
Le istituzioni pubbliche rappresentano il luogo dei testi giuridici. La loro destituzione avviene in primo
luogo nella parola. --> l'interrogativo che sorge è se è possibile destituire completamente il senso della
parola a favore del significato letterale. La destituzione concepisce la realtà come momento da assoggettare
affinché l'azione giuridica si limiti ad essere esecuzione, svuotata dell'ordine discorsivo.
Il logos è alla base della costruzione delle istituzioni ed è destinato ad avere un'esistenza giuridicamente
organizzata. La destituzione indica l'adeguamento ad un 'mondo di vita'. Infatti, la testualità giuridica muove
da quella sociale che, a sua volta, progredisce dalla ratio che istituisce la relazione tra parola e cosa. Centrale
è il discorso della rappresentazione che è la base per la scissione logos/res.
Nell'argomentare l'istituzione del diritto, Legendre procede dalla 'funzione' della genealogia nell'ambito
della res tradita che rinvia in modo del tutto razionale alla testualità giuridica. L'organizzazione della
testualità ereditata si basa su un principio istituzionale, al di fuori del quale cessa persino la riflessione sui
principi giuridico-normativi.
Appunti di Marta PascarellaPagina 21
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
NB: Organizzare la complessa macchina del diritto:
• ridimensionare il narcisismo della parola
• il tecnicismo della parola
L'istituzione si fa messaggera di tale principio sino ad affermare che, l'uomo privato della libertà di rinvio al
principio genealogico, non assume su di sé il compito di partecipare alle istituzioni, ma ripristina una
subordinazione al dato naturalistico, abdicando ad un'antropologia giuridica in grado di gestire un insieme di
elementi che vengono proposti dal processo di simbolizzazione come seconda vita, funque come esclusiva
pertinenza dell'uomo, radicata nell'analisi e nell'uso della parola.
All'uomo moderno si chiede di differenziarsi non solo dall'animale, ma da un modello di humanitas
neurobiologica. --> il linguaggio diventa organizzazione del diritto a partire dalla grammatica, genesi della
regola relazionale giuridicamente qualificata. Se questo principio viene rimosso, emerge il narcisismo
giuridico estremizzato da una fattualità non condivisa, ma imposta attraverso una sorta di 'forza normativa
del fatto', fisso in un'immagine della normatività che esclude una 'chiarificazione' e che si propone come
nuovo 'illuminismo' della modernità.
TESTO GIURIDICO--> Presenta il doppio versante dell'antropologia relazionale attraverso
• parola
• istituzione. L'opera che è presente nelle istituzioni rinvia alle procedure giuridiche come
affermazione di un'antropologia implicita simbolicamente nella 'seconda vita', intesa come
possibilità relazionale.
Questione antropologica --> riflessioni con implicazioni normative, che portano ad un'osservazione
sull'uomo ad opera del principio genealogico che rinnova il concetto di filiazione e delle categorie che lo
costituiscono (linguistiche e giuridiche).
Ciò scaturisce dal rapporto logico tra il soggetto - individuato come parlante - e la struttura degli esiti
normativi - rinviano al principio genealogico, incluso il racconto delle origini di ogni popolo. Legendre
ritiene che un possibile inizio di questa genealogia specifica si può ravvisare solo a partire da una
concessione del diritto con un suo inizio storico nel Corpus iuris civilis, la cui interpretazione e rinascita
ermeneutica permettono una prospettiva particolare in cui, il legislatore, in quel caso l'imperatore, viene visto
come archivio, 'scrinio' custode di tutti gli iura.
Trasposizione che prevede che nel legislatore lo scritto vivente: testualità identificata con la corporeità
giuridica.
realizzare l'idea moderna di Stato = NO aspetto volontaristico; proposizione normativa che apre una
prospettiva storico-teoretica che è caratterizzata da un evento storico, chiamato rivoluzione dell'interprete
in cui vengono capovolti i paradigmi di una logica formale, insita nell'attività interpretativa, ma è motivo, da
parte del diritto romano, per rappresentare le origini primitive della giuridicità e mettere così in scena i
principi del diritto.
Qualifica di interprete:
• sovrano
• imperatore
• pontefice
Appunti di Marta PascarellaPagina 22
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Rappresentante imparziale, al di sopra di tutti gli interpreti, l'essere custode dei diritti non gli attribuisce
la prerogativa di concederli o manipolarli. Nei testi giuridici, secondo Legendre, viene definito viva vox
iuris ossia voce del diritto. E' intermediario tra il diritto e i destinatari, mediatore tra il linguaggio e
l'elemento soggettivo. --> SORTA DI POLITICIZZAZIONE DELLA TESTUALITA'; GERARCHIA CHE
PREVEDE UN PRINCIPIO AUTOREVOLE TRA I TESTI PER EVITARE IL CONFLITTO DI
INTERPRETAZIONI E STABILIRE UN PRINCIPIO DI ORIENTAMENTO.
Peculiarità propria del testo giuridico: attività maieutica e genesi di un senso giuridico delineabile solo
nella ritualità interpretativa dei testi giuridici e di conseguenza nella questione gerarchica testuale tra le
molteplici autorità interpretanti.
Sorgono tre questioni:
♦ Necessità di un principio unificatore che rischia di avere una sorta di monopolio interpretativo;
♦ Rappresentazione oggettivista del testo;
♦ Simbolizzazione nel diritto per evidenziare le lacune testuali che si manifestano in qualunque attività
interpretativa.
SIMBOLIZZAZIONE-> Presa di distanza dall'oggetto interpretato e quindi della struttura che regge la
qualificazione della terzietà e di un antico patrimonio storico dell'opera ermeneutica. Simbolo che converge
su di sé la rilevanza dell'interpretazione che è significativa perché il soggetto partecipa della propria
corporeità come soggetto e come spazio in cui opera.
Viva vox iuris -> avvia il rapporto corporeità-testo giuridico. Il soggetto iscrive se stesso nel 'corpo del
Testo'. Il processo di simbolizzazione, quindi l'ermeneutica, marca la distanza dal discorso oggettivista e
riconduce l'uomo alla sua temporalità, in cui l'attualità deriva da un 'prima', non per visione antropocentrica.
NB: Compito ed impegno del giurista e del diritto diventa così riconoscere il carattere assolutamente
prioritario dell'uomo. Il carattere simbolizzante dell'interpretazione impone al giurista di rivedere alcuni
aspetti di un'ermeneutica solo funzionale in direzione di un utilizzo della tecnica normativa che elabori una
struttura architettonica in grado di sostenere la complessità della questione del riferimento, come struttura
reale, posta nell'articolazione della testualità di un ordinamento giuridico.
Alla base vi è la questione dello scambio che, a differenza dell'economia, nel diritto prevede un do ut des
simbolico mediato dalla possibilità di un ripensamento della problematica economicistica senza attribuirle il
ruolo primario genealogico produttivo degli effetti normativi e procedurali.
La responsabilità del giurista risiede nella responsabilità ascritta alla rappresentazione del principio
genealogico, che rimette in questione la qualità degli scambi; lo scambio rappresenta il luogo simbolico
modellato sul paradigma genealogico-antropologico della comunità intesa come dimensione delle relazioni
reciproche ed incondizionate.
Luogo istituzionale e logos -> si somigliano attraverso alcune caratteristiche come:
♦ comunanza (bene comune, appartenenza alla comunità, espressione del diritto dell'uomo);
♦ l'indicibilità (non strutturato secondo il sapere totale);
♦ la necessità di intermediazione (fautore della distanza che significa coscienza di sé e del giusto).
Appunti di Marta PascarellaPagina 23
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
In queste ipotesi, il testo si manifesta come discontinuante, sempre teso a mettere in discussione gli
elementi della testualità giuridica. Come ogni scambio, quello all'interno dell'edificio giuridico mira ad
un oggetto specifico; la determinazione oggettiva dello scambio è complessa e difficile da chiarire, un
intreccio di legami, in cui il parlante occupa una posizione prioritaria nella struttura istituzionale, in quanto
costituita della parola.
Istituzione che realizza il fondamento della struttura che a sua volta designa il legame con la dinamica
dello scambio, servendosi della simbolizzazione della parola creatrice nel patrimonio di immagini con
le quali il soggetto umano si identifica. -> Nel caso dell'interpretazione si deve precisare che l'attività di
simbolizzare implica il vincolo con le 'categorie normative del linguaggio' il che significa anche
l'orientamento secondo il principio genealogico.
L'attività ermeneutica rinvia al linguaggio, in quanto logos antropologico riferito al soggetto. La funzione del
principio genealogico dunque diviene sempre più marcato nella pratica della costruzione della testualità
giuridica: discorso, parola, testualità; identificando così la testualità giuridica come la comprensione delle
parole orientate dal principio genealogico.
NB: Il diritto ha bisogno di un luogo in cui manifestarsi: le istituzioni giuridiche. La giuridicità da una parte
realizza un vinculum reale, dall'altra proprio perché si avvale ed è esso stesso attività simbolizzante, istituisce
il nesso inteso come vincolo che garantisce l'attività interdittiva (Nel linguaggio giur., esclusione della
capacità di agire o dell’esercizio di determinati diritti, che consegue a uno stato d’infermità mentale
accertata dal giudice o a una sentenza di condanna) della terzietà giuridica.
Si entra in una dimensione simbolica che attribuisce all'uomo la qualifica di colui che è principio
genealogico perché proprio il concetto di temporalità chiarifica quello di simbolo, inteso come attribuzione
di un senso che rinvia alla dimensione del futuro. Il diritto elabora una incidenza temporale in cui la norma
sintetizza un'affermazione del principio genealogico, coadiuvato dalla dialettica ermeneutica.
Simbolizzare--> istituire un senso razionale, senza pretese romantiche con l'intento di costruire la comunità
giuridica. Legendre così afferma che la dimensione principale della filosofia è costituita dalla filosofia del
diritto. Nella struttura giuridica si delinea il rapporto tra techne e logos, secondo una realizzazione che
ribadisce la direzione del diritto, in una prospettiva 'giuridica'.
Costruzione del senso:
♦ responsabilità del formalismo;
♦ responsabilità del funzionalismo;
♦ responsabilità del contrattualismo;
♦ responsabilità dei loro effetti sulla dimensione simbolica della giuridicità.
Che il diritto possa essere definito brevemente come diritto sociale significa rinunciare ad entrare nella
riflessione come 'rappresentazione della causalità'---> emancipazione delle immagini (causa presa di
coscienza che il diritto non è una circostanza particolaristica).
Metodologia riflessiva, alla base della emancipazione delle immagini -> costruire un senso oltre il
significato strettamente normativo dettato dal legalismo. L'uomo è sottoposto ad un processo di
emancipazione con le immagini di una testualità giuridica sedimentata. Da qui, deriva una società come
luogo antropologico che supera le singole figure al suo interno, elaborando una dimensione da cui dipendono
gli effetti giuridici applicativi del principio genealogico della filiazione.
Appunti di Marta PascarellaPagina 24
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Alla base vi è il riferimento causale, come terzietà garante della permanenza della struttura legale, non
concentrata nella tecnica delle forme testuali.
Come sono strutturati il concetto e la definizione di società giuridica? Sono costruiti sul potere della
stessa società di gestire la negatività, basata sull'idea profonda di divisione indissociabile della costruzione e
della costituzione del principio di identità e di soggettività. --> Genesi della società: costituzione
dell'identità, in quanto compito che ogni singolo parlante persegue nella comunicazione con gli altri.
L'equilibrio giuridico è orientato da una considerazione dell'uomo come unico soggetto di diritto. Mediante il
concetto di principio genealogico, il soggetto acquista una sua dimensione di soggetto differenziato
simbolicamente. Discutere il principio genealogico non significa spiegarlo banalmente come la
Causa Prima, come lo è la Grundnorm per ogni ordinamento giuridico, perché si rischierebbe una sorta di
copertura per il soggetto.
5.3 Riti e testi giuridici
Legendre, nella costruzione dell'architettura normativa, costruisce una sorta di fondo di riserva 'iconografico'
significativo per la filosofia del diritto, per l'ermeneutica giuridica e per la storia del diritto. I riti, le liturgie,
le celebrazioni sono riconducibili a modelli ricorsivi che, nella destituzione della soggettività, possono
rivelarsi distruttivi, ma l'ermeneutica come attività di comprensione di un discorso, dunque anche di quello
delle immagini, non può presentarsi attraverso il perfezionamento di una tecnica che cristallizza momenti
contingenti sino a ridurre la ritualità ad un sedimentato paradigma procedurale. Il principio genealogico
dell'autorità dal quale promanano i riti si differenzia nettamente dalle tecniche totalitarie di addestramento
del genere umano.
Vi è un'attribuzione di ruolo gerarchica tra il soggetto di diritto e il terzo storico (legislatore, giudice,
forza pubblica). --> tipologicizzazione della funzione prima dell'autorità della ragione, rimando ad un nesso
di causalità distante dal nesso causa-effetto, che ogni volta rimette in discussione l'affermarsi del diritto
positivo.
La riflessione sulla modernità di Legendre si concentra su alcuni elementi:
✓ testo;
✓ ragione;
✓ rito;
✓ simbolo.
Intensità del termine 'ratio', motivata dall'attraversamento del 'logos' di derivazione bizantina.
Interpretazione che chiarifica che la sedimentazione delle strutture giuridiche industriali e politiche è
dovuta dalla declinazione dello ius secondo una traccia dove sono segnalate le priorità dell'humanitas.
Umanità nella comunità dogmatica, dove è reperibile una testualità giuridica mediata dalla ritualità simbolica
e razionale. Il diritto diventa così un effetto, ma non il polo determinato da una causa, la sua qualifica di
effetto è giustificata dall'essere in un rapporto istitutivo con la società definita da Legendre anche
'monumentum'.
Il discorso sulla modernità può essere articolato in tre registri:
• società;
• comunità; comunità dogmatica che definisce l'insieme di una pluralità.
Appunti di Marta PascarellaPagina 25
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
• soggetto monumentale.
Soggetto monumentale--> soggetto a cui è imputabile la testualità giuridica, sotto forma di produzione
normativa.
NB: il diritto assume su di sé una funzione simbolica unificante, non è ravvisabile solo nella società, non è
istituibile unificamente dalla comunità, non è imputabile esclusivamente al soggetto monumentale pur
essendo quest'ultimo il 'vero soggetto'.
Legendre manifesta l'inquietudine del soggetto del discorso attraverso la domanda mai archiviabile "perché
le leggi?" --> Il diritto non è un pactum ma deriva da un'architettura genealogica, alla quale ogni uomo
partecipa simbolicamente. La società stessa è un soggetto che, attraverso l'istituzione del limite giuridico,
replica al dià-logos. Nessun pactum, nessuna forma fondante può presumere di negoziare l'ingiustizia: la
Grundnorm non è capace di rappresentare lo 'statuto antropologico' del linguaggio e della parola.
Qualsiasi legge fondamentale istituita secondo il paradigma kelseniano comporta una formazione a gradi che
trascura la funzione discorsiva del diritto, evitando così di riproporre il logos come nomos, ma istituire il
diritto comporta un'estensione sinergica tale da investire il normativismo in senso stretto.
Nessuno può identificarsi con l'immagine della norma fondante, pur essendo parte del materiale
'iconografico', essa rappresenta 'il dramma della ragione' (paradigma i cui contenuti possono
rappresentare una conquista della follia sulla ragione).
Il ''perché le leggi?'' implica una qualificazione della ragione che non converga nella fusione dell'io con
l'assoluto. I testi possono essere classificati come razionali/irrazionali, dunque ciò che assume rilevanza
è il concetto di ratio; di volta in volta, si è assistito ad una ragione fragile che ha trovato il fondamento
in diramazioni totalitarie, senza riferire la questione del senso. La ragione diventa 'conquista sulla
follia' solo nel momento in cui l'uomo dà spazio ad un epicentro antropologico di ricostituirsi
attraverso il rinvio al principio genealogico del diritto.
5.4 Ragione e testualità giuridica
Nella testualità giuridica, la ragione acquista una sua identità. --> anche se si esprime come un'icona
(attività istituente che non si sedimenta in una immagine definita).
Il legislatore, soggetto monumentale, opera mediante la ragione. La ragione che produce i testi è un polo a
due versanti, in testi sempre trasmissibili e interpretabili:
■ svela se stessa attraverso la struttura dei testi;
■ si vela attraverso l'interpretazione che dei testi può essere data.
La stessa può assumere connotazioni negative, se non conserva la sua essenza critica. L'uomo è latore di
ragione, allo stesso tempo può essere prodotto della ragione. In questo modo si ha la traduzione
dell'imperativo antropologico- genealogico e si giunge ad un'universalizzazione della ragione.
Interpretare il principio genealogico in funzione del testo giuridico implica il desiderio di comprendere il
fenomeno giuridico sulla base del quale è costruito il concetto di ragione.
La questione dei testi è volta a comprendere il legame simbolico e indissolubile tra:
• testo giuridico
• parola
Appunti di Marta PascarellaPagina 26
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
• soggetto
La metodologia per l'interpretazione dei testi non è la tecnica del glossatore medievale. L'impegno
del giurista è nel rendere visibile la parola intenzionale del legislatore che, attraverso la struttura
razionale e relazionale, garantisce la libertà del logos in capo alla comunità dei soggetti di diritto.
Filtro tra l'uomo, immesso nella comunità dogmatica, e la propria imago: rappresentare se stesso in presenza
dell'alterità lo conduce ad un confronto che solo la regola giuridica rende accettabile. Alterità che presenta un
duplice versante: estremizzazione del soggettivo o assolutizzazione dell'oggettivo. All'uomo spetta l'impegno
della scelta.
La dogmatica 'illuminata' della filosofia del diritto pone la questione della ricerca della verità,
attraverso la peculiarità della genealogia, delle origini. Ratio nella ratio scritta, ermeneutica del diritto
testuale trasmessa genealogicamente. La questione della testualità giuridica ha rilevanza in quanto ha
un immediato rapporto con il linguaggio.
Filiation--> termine con il quale si indica la provenienza dei testi, rilevante nei testi giuridici romani, in
particolare in quello giustinianeo. Concetto di provenienza inteso inmaniera simbolica, non autoreferenziale,
ma relativo al principio genealogico, alla terzietà, al dovere dell'interprete.
Il nesso tra simbolo - ratio - origine è costituito dal nome, la cui funzione esprime la carica simbolica
che conduce il soggetto alla presenza di una questione radicale e ricentrata nell'humanitas. La legge
umana come limite non rappresenta l'impoverimento del soggetto, mediante il castigo o la costrizione
a vivere secondo una ''legge del sistema'', ma è la caratterizzazione socio-giuridica dell'identità
soggettiva.
Non esiste una società che non si muova sulla doppiezza di un binario, per ricomporlo è necessaria
l'istituzione del pactum dogmatico, fonte dello statuto normativo. Il dogma manifesta ed istituisce il legame
normativo tra soggetti e nella sua capacità di apertura e rinvio al simbolico. Il diritto ha il dovere di
introdurre il limite tra gli scambi come momenti determinanti dell'economia e il diritto che diventa il
momento di comprensione del 'valore dogmatico della tecnoscienza'.
Testo + società (attraversati dal principio antropologico del vitam instituere) = spartiacque tra deriva
gestionaria e la tensione tra soggettività e oggettività.
EX. statuto della cittadinanza : testo di iscrizione di senso, ma anche attributo di un particolare status di
appartenenza.
Questione della testualità come dogma--> ove per dogma si intende l'apertura alle iscrizioni di senso. La
parola 'dogma' assolve ad una incondizionata apertura e congiunta al concetto di metodo e metodica. La
relazione dogma/metodo, si avverte anche nella medicina e fa comprendere l'origine della Legge: da dove
inizia l'ordine legislativo?
La nascita della regola come disciplina voluta da un testo che significativamente Legendre denomina società
che rinvia genealogicamente all'humanitas: la legge diventa testo e ha una sua genesi in un Testo. Nella
giurisprudenza come nella medicina, il testo funziona come trasmissione dei saperi.
Ogni organo ha una sua posizione, una sua funzione, una sua grammatica biologica che deve rispettare
implicitamente. Il paragone tra la dimensione del corpo legislativo e quella del corpo umano, quindi il
confronto teorico tra legge e medicina è avviato dalla considerazione che la disciplina medica ha come
obiettivo il corpo: rendere funzionali i corpi perché la dimensione giuridica passa dai corpi.
Appunti di Marta PascarellaPagina 27
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Vi è dunque un nesso tra la finitezza biologica e quella normativa: entrambe possibili solo nel riferimento ad
un principio genealogico che nel caso delle regole mediche è rappresentato dalla scienza che si pone non
come tecnica del corpo in sé, ma come ascolto di ciò che il corpo dice, non solo attraverso i sintomi, ma
mediante il racconto e l'interpretazione di essi; per le regole giuridiche, il corpo è rappresentato dall'insieme
delle persone che formano la comunità e dalla legge (Corpus Iuris); il diritto è una macchina normativa, a
sua volta testo 'trovato' nell'esemplare universum rappresentato dalla natura, ma in modo analogo al copro
fisico, è strutturato in modo tale che il portatore di esso non sia oggetto di una riduzione organicistica, ma si
faccia latore della ricerca della verità nel darsi leggi che si emancipano da un paradigma biologico
omologabile alla gestione prassistica.
Testualità giuridica--> deve essere differenziata come organismo e testualità come patto. Ciò implica che
nasca l'idea per la quale la società come testo è una dimensione funzionale in cui si discute il logos come
ragione.
Socius ('colui che segue') per atto di scelta che costituisce e vivifica ogni volta la testualità giuridica. Come
la corporeità (testo biologico) si avvale di regole non istituite, così la società possiede elementi intrinseci
come l'essere nati uomini. Il logos serve nel primo caso a costruire la cura come momento umano, nel
secondo il diritto, quindi creare un progetto in cui è presente il potere di parlare, unico diritto in condizione
di uguaglianza per tutti gli uomini. Solo così, la società costruisce il luogo dell'esistenza in cui l'uomo
iscrive un proprio senso (testo).
5.5 Testi/testo
Le questioni sollevate da Legendre sulla lettura moderna della 'dogmatica' necessitano del principio
genealogico che rinvia a formazioni precedenti come il corpus iuris o legis, in cui incide la parola scritta, le
interpretazioni, le divisioni, i conflitti, la libertà. La validità del dogma è subordinata alla trasmissione dei
testi e dei saperi come capitale simbolico di ogni società, soprattutto quelle occidentali moderne.
Quando emerge una discussione sul testo, si palesa il problema della scrittura, che condensa in sé il visibile
e l'invisibile, testo scritto e trasmissione orale ecc. La testualità non si esaurisce nella momentaneità. Le
forme della scrittura apportano rinvii simbolici e aprono lo spazio terzo dell'ermeneutica come modalità che
iscrive il proprio significato attraverso l'emblema.
Momenti della testualità giuridica:
✓ grammatica
✓ interpretazione
Nomogramma--> istituzione del segno nel testo; così è definibile la società.
La specificazione del testo giuridico è in direzione di una società multiculturale, di appartenenza per statuto
all'humanitas. Dunque, è impossibile far promanare la testualità giuridica da scritti religiosi o politici,
riferendosi così ad un'entità trascendentale, e proprio questo pone la società come testo di fronte alla
possibilità di non incoraggiare un riferimento diverso dal principio genealogico.
NB: Il testo giuridico, poiché nomogrammatico, si presenta come segno e come parola interpretabile e
rinviabile ad altre formazioni di senso. La società, come testo, riguarda una pluralità di discorsi e scritture
istituite dall'uomo, dotato della libertà di parola con la quale segnala in modo significativo ed unico il nesso
tra istituzioni, società e testi in senso proprio.
Appunti di Marta PascarellaPagina 28
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Il testo giuridico presenta un carattere di specificità che altri testi non estrinsecano istituzionalmente:
la terzietà (testo privo di autore); la vera energia proviene dalla trasmissione a statuto simbolico che è
essenzialmente quella della tradizione giuridica.
I testi trattati da Legendre si possono classificare in due tipologie :
• società come spazio testuale produttivo di testi (affinché il diritto si manifesti concretamente);
• forma di rappresentazione della parola.
Società--> luogo dell'uomo che istituisce la seconda vita attraverso la regola che nella sua qualificazione di
diritto diventa ars boni ed equi; luogo di quella ragione che fa uscire l'uomo dallo stato di minorità, di
kantiana memoria.
Il linguaggio non ha un ruolo funzionale, né marginale, ma è l'inizio dell'istituzione di una struttura
comunicazionale che può perdersi o lasciarsi imbrigliare da una certa contingenza, determinando la propria
fine. Solo attraverso il linguaggio è possibile trasferire il significato dell'istituzione oltre il vinculum della
fine. In questo modo si costituisce una tipologia testuale ad uso delle generazioni successive.
Apparente celebrazione di una 'ragione illuminata' all'interno del tessuto sociale --> progetto
dell'istituzione come fenomeno distinto da una sfera prettamente privata poiché altrimenti il soggetto ne
sarebbe interessato in una funzione puramente intimistica. L'instituere giuridico esprime un fenomeno
pubblico che investe la società, in quanto res publica. Il testo giuridico rappresenta il legame tra l'uomo e la
società, tra il soggetto e l'oggetto che si incontrano in uno spazio vuoto del nulla, ove il vuoto rappresenta un
vuoto che rende possibile costruire il senso nella possibilità di significare i testi.
La ragione del moderno porta con sé l'imperativo istituzionale, messa in parole mediante un Testo
privo di soggettività che deriva da un passato attraverso l'opera di trasmissione, questo testo
dell'attuale cultura giuridica occidentale moderna riprende il testo del diritto romano in quanto
discorso inaugurale che autentica la verità.
Il testo giuridico rappresenta il patto giuridico all'interno della società che sintetizza vari piani individuabili
nel soggetto e sul piano della cultura come riferimento, genesi ed evocazione della metafora fondatrice;
coincide con l'inizio dello spazio della società e con esso si identifica per la 'formazione dello spazio
normativo'. Questo non è dato da un accordo convenzionale, ma qualifica il rinvio alla terzietà per una serie
di elementi posti dalla parola intesa quale istituzione dell'uomo parlante che tende alla conservazione della
specie.
L'autore dell'istituzione è il garante della terzietà del diritto 'dogmatica' ed invita ad elaborare la
rappresentazione del patto giuridico come scambio, patto 'dogmatico' conforme alla logica del terzo. Le
procedure giuridiche nella società dogmatica costituiscono il filo 'vero l'essenziale' rappresentato dal
giuridico.
5.6 Il potere della parola
Il soggetto, dotato di potere della parola, istituisce una normatività già a partire dalle regole discorsive
realizzate attraverso il legame sociale e dunque intersoggettivo. Il principio istituzionale a matrice
genealogica è situato in modo simbolico nel logos come momento iniziante: l'uomo infatti si avvia ad
essere tale a partire dalla parola, allora il vitam instituere acquista il significato di interpretare nella visione
della rivoluzione dell'interprete, non significa rovesciamento dell'ordine costituito, ma comprensione
dell'alterità sociale.
Appunti di Marta PascarellaPagina 29
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Il logos assume una rilevanza principale come discorso interpretante ed istituente l'ars boni et aequi.
La parola come nomos è la conquista della ragione sulla follia, in cui l'impegno è attribuito all'uomo ed
in particolare a quell'homo juridicus, che rende possibile la rappresentazione attraverso l'istituzione
del limite non come divieto, ma come garanzia della divisione tra parole e cose.
La società vive della continua dialettica tra divisione - capacità di non identificarsi con le cose, con
l'ambiente - e desiderio di unità. Nella testualità giuridica simbolizzare significa attribuire il giusto posto alle
parole e all'uomo per ristabilire la dimensione terza del 'giuridico'.
In quanto divieto/limite indica la realizzazione di una seconda vita per l'uomo collegata al fenomeno della
parola attraverso la struttura linguistica. --> uomo come soggetto parlante = soggetto di diritto.
Nel giuridico, soggettivo e oggettivo passano dalla dimensione terza, in cui si realizza uno scarto tra un
'prima' e un 'dopo' che, attraverso l'eredità testuale trasmessa, rinvia alla definizione di diritto come
istituzione.
Appunti di Marta PascarellaPagina 30
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: amm1234mar (ammart03@ucm.es)
Potrebbero piacerti anche
- Sociologia - I ClassiciDocumento3 pagineSociologia - I ClassiciSilviaNessuna valutazione finora
- Mancini - Manuale Di Comunicazione PubblicaDocumento23 pagineMancini - Manuale Di Comunicazione PubblicaLarnè Marco100% (1)
- Sociologia-Riassunto Il Mondo in QuestioneDocumento25 pagineSociologia-Riassunto Il Mondo in QuestioneSilvia Momo d'OvidioNessuna valutazione finora
- Il LiberalismoDocumento3 pagineIl LiberalismoNANCYNessuna valutazione finora
- Riassunti Di - Manuale Di Comunicazione PubblicaDocumento25 pagineRiassunti Di - Manuale Di Comunicazione PubblicafpttmmNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Filosofia Del Diritto Libro RiassuntoDocumento44 pagineLezioni Di Filosofia Del Diritto Libro RiassuntoAliceNessuna valutazione finora
- Sociologia Dei Processi CulturaliDocumento50 pagineSociologia Dei Processi CulturaliperonigiadaNessuna valutazione finora
- Comunicazione PubblicaDocumento34 pagineComunicazione PubblicaPescedargento100% (3)
- Mario D Addio Storia Delle Dottrine Politiche Riassunto 1Documento68 pagineMario D Addio Storia Delle Dottrine Politiche Riassunto 1tanina.chiappettaNessuna valutazione finora
- Linee guida per l'attuazione dei diritti umaniDa EverandLinee guida per l'attuazione dei diritti umaniNessuna valutazione finora
- Il Mondo in Questione PDFDocumento88 pagineIl Mondo in Questione PDFValentinaCersosimo75% (4)
- Alain de Benoist - Comunità e IdentitàDocumento3 pagineAlain de Benoist - Comunità e Identitàmrccrs00Nessuna valutazione finora
- Storia Dei Diritti Umani FLORESDocumento56 pagineStoria Dei Diritti Umani FLORESFrancesco FerraroNessuna valutazione finora
- Idolon RiassuntoDocumento35 pagineIdolon RiassuntoArianna ScerboNessuna valutazione finora
- Sociologia Dei Processi CulturaliDocumento40 pagineSociologia Dei Processi Culturalisabattini.ireneNessuna valutazione finora
- La giustizia non può attendere!: A proposito di persone, carcere, diritti, democrazia in tempi di pandemiaDa EverandLa giustizia non può attendere!: A proposito di persone, carcere, diritti, democrazia in tempi di pandemiaNessuna valutazione finora
- Il Principio Liberta Nello Stato CostituzionaleDocumento49 pagineIl Principio Liberta Nello Stato CostituzionaleMario LibertiniNessuna valutazione finora
- Karl MarxDocumento12 pagineKarl MarxFederico NicotraNessuna valutazione finora
- L'UGUAGLIANZA DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI, ovvero dell'origine dell'UGUAGLIANZADa EverandL'UGUAGLIANZA DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI, ovvero dell'origine dell'UGUAGLIANZANessuna valutazione finora
- Il Realismo Politico Mosca RiassuntoDocumento35 pagineIl Realismo Politico Mosca RiassuntoAnastasia PloccoNessuna valutazione finora
- Schemi Esame SociologiaDocumento66 pagineSchemi Esame SociologiaMattia PivariNessuna valutazione finora
- Costituzione, Stato e crisi - Eresie di libertà per un Paese di sudditiDa EverandCostituzione, Stato e crisi - Eresie di libertà per un Paese di sudditiNessuna valutazione finora
- Marcello Flores - Storia Dei Diritti UmaniDocumento24 pagineMarcello Flores - Storia Dei Diritti UmaniAmeliaAntonelaNessuna valutazione finora
- RawlsDocumento6 pagineRawlsf.ragni03Nessuna valutazione finora
- Il Potere, Lo Stato, Le Norme, Le Istituzioni, La Devianza, Il Welfare StateDocumento4 pagineIl Potere, Lo Stato, Le Norme, Le Istituzioni, La Devianza, Il Welfare StateAnnaNessuna valutazione finora
- Un Lessico Giuridico CompletoDocumento24 pagineUn Lessico Giuridico Completomartina rispoliNessuna valutazione finora
- In attesa dell'homo donans - Introduzione alla Dottrina sociale della ChiesaDa EverandIn attesa dell'homo donans - Introduzione alla Dottrina sociale della ChiesaNessuna valutazione finora
- Psicologia Di Comunità AppuntiDocumento34 paginePsicologia Di Comunità AppuntisarazNessuna valutazione finora
- Riassunto - Teorie Delle Comunicazione Di Massa BentivegnaDocumento45 pagineRiassunto - Teorie Delle Comunicazione Di Massa Bentivegnacaligiuric977082% (11)
- Storia Delle Dottrine Politiche - MioDocumento55 pagineStoria Delle Dottrine Politiche - MioSara MerelloNessuna valutazione finora
- DemocraziaDocumento14 pagineDemocraziaSabrina Amatulli100% (1)
- Maritain e LeviDocumento5 pagineMaritain e LeviEleonora SaracinoNessuna valutazione finora
- Hespanha Introduzione Alla Storia Del Diritto EuropeoDocumento39 pagineHespanha Introduzione Alla Storia Del Diritto EuropeoErion Eri CikoNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto Medievale e Moderno Libro Tempi Del Diritto PDFDocumento130 pagineStoria Del Diritto Medievale e Moderno Libro Tempi Del Diritto PDFhosni amiraNessuna valutazione finora
- Democrazia e DemocratizzazioniDocumento181 pagineDemocrazia e DemocratizzazioniLorenzoNessuna valutazione finora
- L'uomo A Una DimensioneDocumento2 pagineL'uomo A Una DimensionebentospinozaNessuna valutazione finora
- Introduccio A La SociologiaDocumento26 pagineIntroduccio A La Sociologialucatinaro1997Nessuna valutazione finora
- Diritto InternazionaleDocumento62 pagineDiritto Internazionalecaracall99Nessuna valutazione finora
- Dispense Short Processi Culturali 2014Documento30 pagineDispense Short Processi Culturali 2014Natalina Dass Tera LodatoNessuna valutazione finora
- La Legge Naturale e Il Bene Comune Della CittàDocumento5 pagineLa Legge Naturale e Il Bene Comune Della CittàMario RossiNessuna valutazione finora
- KantDocumento3 pagineKantstefanolanero2002Nessuna valutazione finora
- Beck, I Rischi Della LibertàDocumento19 pagineBeck, I Rischi Della LibertàFabio InfantinoNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto II Sbobinature 1Documento142 pagineStoria Del Diritto II Sbobinature 1Nadia BattafaranoNessuna valutazione finora
- Weber: Comunità, Associazione Ed Economia Di MercatoDocumento3 pagineWeber: Comunità, Associazione Ed Economia Di MercatoagnesevardanegaNessuna valutazione finora
- Giustizia e Uguaglianza in PlatoneDocumento3 pagineGiustizia e Uguaglianza in PlatoneMonica MoresiNessuna valutazione finora
- Teorie Comunicazioni Di MassaDocumento20 pagineTeorie Comunicazioni Di MassaDaniela CoriNessuna valutazione finora
- Pulcini - Oltre Il ContrattoDocumento12 paginePulcini - Oltre Il ContrattoAnonymous 28AYvphsTfNessuna valutazione finora
- Politica e Societa Introduzione Alla SocDocumento20 paginePolitica e Societa Introduzione Alla SocveraNessuna valutazione finora
- Felicità Apparente e Felicità Effettiva: Il Metodo Scientifico Applicato alla Condizione Umana - Volume IXDa EverandFelicità Apparente e Felicità Effettiva: Il Metodo Scientifico Applicato alla Condizione Umana - Volume IXNessuna valutazione finora
- PAOLO GROSSI Completo RiassuntoDocumento15 paginePAOLO GROSSI Completo RiassuntoFrancesca EspositoNessuna valutazione finora
- Poggi SciortinoDocumento45 paginePoggi SciortinoShady DaysNessuna valutazione finora
- FILOSOFIADocumento26 pagineFILOSOFIAcarmcantNessuna valutazione finora
- Zagrebelsky Gustavo - I Dieci Comandamenti Del Buon RepubblicanoDocumento3 pagineZagrebelsky Gustavo - I Dieci Comandamenti Del Buon RepubblicanoLo OrboNessuna valutazione finora
- Riassunto R Bin G Pitruzzella Diritto Pubblico Giappichelli Ult EdizDocumento17 pagineRiassunto R Bin G Pitruzzella Diritto Pubblico Giappichelli Ult Edizkawther SlimenNessuna valutazione finora
- Lezione 15-16-17 - Lepore - DEFDocumento68 pagineLezione 15-16-17 - Lepore - DEFAlessandro De LucaNessuna valutazione finora
- Banca D'italia e Tesoreria Dello StatoDocumento173 pagineBanca D'italia e Tesoreria Dello StatocarlobooksNessuna valutazione finora
- Noam Chomsky. Il Bene Comune - OdtDocumento14 pagineNoam Chomsky. Il Bene Comune - OdtElenoireshNessuna valutazione finora
- LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - Sinagra Bargiacchi PDFDocumento95 pagineLEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - Sinagra Bargiacchi PDFTrayNessuna valutazione finora