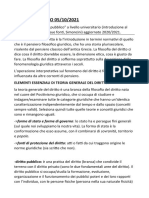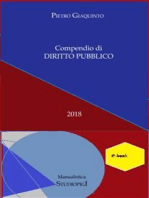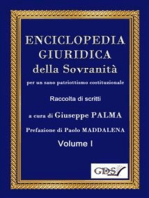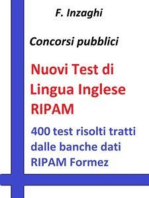Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lezioni Di Filosofia Del Diritto Libro Riassunto
Caricato da
AliceTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Lezioni Di Filosofia Del Diritto Libro Riassunto
Caricato da
AliceCopyright:
Formati disponibili
Riassunto libro I,-D'Agostino
Filosofia Del Diritto
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
43 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
LEZIONI DI FILOSOFIA DEL DIRITTTO
(PROF. FRANCESCO D’AGOSTINO)
CAP. I: LA FILOSOFIA DEL DIRITTO
A differenza delle altre forme del sapere, la filosofia, e quindi anche la fisolosofia del diritto, non
ha un oggetto precostituito ma deve sempre, come avvertiva Hegel 1, ricominciare da capo, delimitando le
proprie competenze.
Tuttavia, ciò che ci si deve aspettare oggi dalla filosofia del diritto è una adeguata presentazione di
quello che è stato chiamato il portento dell’epoca moderna, cioè il riconoscimento dei diritti umani come
principio giuridico universale; diritti che prima di essere un’opzione politica, ideologica, etica o religiosa
rappresentano il modo in cui è giunta a maturazione la mentalità propria della cultura occidentale,
mentalità che è costitutivamente giuridica, cioè dominata dal paradigma del diritto.
Non a caso il costituzionalismo, il cui culmine è stato proprio nell’epoca moderna e la cui base
ideologica – politica era fornire di una disciplina giuridica i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo,
anche al fine di porre dei limiti all’arbitrio del potere sovrano, ha rappresentato un fenomeno tutto
europeo o, comunque, proprio dei paesi tipicamente occidentali (compreso il nordamerica).
Ciò vuol dire che la cultura occidentale ha posto a base della propria coscienza epistemologica
(paradigma), cioè della propria riflessione filosofica sul sapere scientifico, da cui dipende il modo in cui
ciascuna cultura guarda il mondo e con cui costruisce e pratica il sapere scientifico, quella struttura
antropologica (diritto) che consente la costruzione del sociale e, quindi, dell’uomo, sulla base di una
particolare forma di relazionalità, quella che riconosce la parità di principio tra i soggetti in relazione.
Da ciò deriva, innanzitutto, il riconoscimento dell’alterità soggettiva, dei diritti dell’altro, ovvero
il riconoscimento dell’altro quale portatore di spettanze assolute che generano in noi dinamiche di dovere;
ed è dall’intreccio di queste spettanze e di questi doveri che nasce il gioco sociale in generale.
E’ per queste motivazioni che il diritto costituisce il paradigma relazionale fondamentale nella
cultura occidentale e la relazionalità il paradigma fondamentale di comprensione della realtà. Il diritto, in
sostanza, si è costituito non solo come mera struttura regolativa del nostro essere-insieme, ma soprattutto
come riconoscimento del valore assoluto che questo nostro essere-insieme possiede per il costituirsi della
coscienza stessa.
Non a caso alla tematica del diritto si è sempre affiancata una grande attenzione per quella della
giustizia:
• Aristotele: solo la giustizia, il cui spirito si radica nel riconoscimento dell’alterità, è virtù
specificamente relazionale e proprio per il suo tramite l’uomo riesce ad essere pienamente uomo;
• Socrate: tra fare e subire un’ingiustizia non c’è simmetria perché solo chi fa un’ingiustizia nega il
riconoscimento dell’altro e delle sue spettanze;
• Kant: la più grande e grave miseria degli uomini non dipende dall’avversa fortuna, ma
dall’ingiustizia.
Questa consapevolezza in Occidente si è radicata attraverso complesse dinamiche storiche:
l’esperienza giuridica romana, la grande filosofia greca e, soprattutto, l’ispirazione biblica.
Nell’ebraismo, infatti, la relazionalità giuridica è elevata a criterio stesso del rapporto tra Dio e il
suo popolo; la legge, la Torah diviene il solido fondamento dell’intera esistenza.
In questo il Cristianesimo non ha innovato, sostituendo semplicemente alla Torah Cristo stesso,
cioè ad una relazionalità rigida una relazionalità aperta, in grado di rinnovarsi continuamente; ed è
indubbio che il cristianesimo è cresciuto presupponendo il diritto, radicandosi nella giustizia e facondone
proprie le ragioni; tant’è che il primo atto di carità, per il cristianesimo, consiste proprio nel riconoscere
quanto spetta all’altro, indipendentemente da quanto spetta a noi.
Questi sono i motivi per i quali in Occidente l’antigiuridismo non si è mai radicato
profondamente.
A questo punto bisogna interrogarsi sul futuro del paradigma della giuridicità occidentale.
1Hegel = filosofo tedesco vissuto tra il ‘700 e l’’800 considerato uno dei maggiori esponenti
dell’idealismo tedesco.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Partendo dal presupposto che esso è giunto ad affermarsi contro due paradigmi alternativi,
considerati miti regressivi, tendenti ad abolire l’esperienza giuridica, cioè il solipsismo 2 e
l’individualismo collettivo3 , si può affermare che il suo trionfo, simboleggiato dalla diffusione del tema
dei diritti umani, può essere considerato un signum prognosticum dell’inizio di una nuova fase della
storia dell’umanità: la pace universale nel segno del diritto, come ci suggerisce la cosiddetta “storia dei
filosofi o profetica”, la quale si distingue dalla storia empirica per il fatto che, a differenza di questa, non
cerca le cause per individuarne gli effetti ma cerca di scoprire in eventi straordinari (per Kant uno fu la
Rivoluzione francese) un’allusione, un indizio, del cammino tendenziale dell’umanità.
2 Solipsismo = tesi filosofica in base alla quale il soggetto pensante non ammette altra realtà all’infuori di
se stesso.
3 Individualismo collettivo = nega la dinamica della intersoggettività subordinandola all’unità
indifferenziata del corpo politico inteso come totalità.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. II: IL CARATTERE INTERPERSONALE DEL DIRITTO
Il diritto è, per sua struttura, relazionale e la relazionalità, quale carattere intrinseco del diritto,
tende all’interpersonalità, cioè al riconoscimento del valore infinito della persona umana, e solo
sommariamente può essere spiegata con la socialità, cioè con il carattere eminentemente sociale
dell’essere uomo (ubi societas ibi jus).
E’ quindi una categoria più complessa di quanto possa sembrare e lo testimonia la grande
attenzione prestata alla c.d. “ipotesi robinsoniana” che dimostra come la relazionalità, in realtà, non
faccia riferimento ad un fatto ma ad un principio (l’essere uomini tra uomini) che potrebbe non trovare
alcuna corrispondenza nella realtà (Robinson, pur da eremita, decide comunque di darsi e di seguire delle
regole per mantenere la propria dignità di uomo nei confronti dei propri concittadini, nonostante non
sappia se li rivedrà mai più).
La teoria generale del diritto, invece, tende a semplificare oltremodo la complessità di questo
problema, come nel caso della teoria del diritto predominante nel secolo scorso, quella normativistica di
Kelsen, secondo cui non può esistere un comando senza un comandante, che pensa al diritto
esclusivamente come ad un sistema di norme e che definisce i rapporti tra soggetti non solo
necessariamente ma anche gerarchicamente relazionati tra loro.
Tale teoria presenta i seguenti limiti:
1. esaspera la dimensione normativa del diritto;
2. vede la relazionalità esclusivamente come verticale, tra sovrano e suddito;
3. contiene un implicito paradosso, cioè che il sovrano non è sottoposto alla legge in quanto è legge.
Quest’ultimo punto, in particolare, implica l’assenza di un qualunque criterio di giustizia per
giudicare la volontà di chi detiene il potere; in realtà, invece, quando si afferma il carattere relazionale del
diritto si presuppone che tale relazionalità sia giusta (jus come ipsa res iusta), sottintendendo l’innato
senso di giustizia dei consociati: l’honeste vivere, infatti, primo dei tre celebri juris praecepta, implica il
riferimento alla capacità intrinseca degli uomini di giudicare la coesistenza umana a partire dal principio
di giustizia ed è in tal senso che va intesa la classica definizione del diritto come obiectum justitiae.
Come già accennato nel capitolo precedente, Aristotele definisce la giustizia come virtù, nel senso
di agire non casuale ma meditato dell’uomo, e l’uomo come l’essere la cui massima virtù sta
nell’esercizio della giustizia e nel riconoscimento dell’alterità (in tal modo fondando il modo occidentale
di pensare l’uomo): iustitia est ad alterum: l’altro con cui la giustizia impone di rapportarsi è colui che
pretende da me il riconoscimento di un debito, di una spettanza, di ciò che è suo (unicuique suum). In
questo Kant non si discosta di molto quando afferma che è solo l’esercizio della libertà a costituire la
dignità dell’uomo: l’atto di giustizia (a ciascuno il suo) è veramente tale quando è libero e consapevole.
Proprio perché relazionale, cioè non chiuso, non compiuto in quanto essere difettivo, l’uomo trova
in sé solo il principio della sua identità; tutto ciò che va oltre, che lo costituisce nella sua storia personale
gli deve essere riconosciuto e dato dall’altro, come debito di giustizia. E in ciò non c’è simmetria perché
i miei debiti saranno sempre superiori alle mie pretese a causa dell’incapacità di rendere appieno all’altro
quanto realmente gli spetta.
- Aristotele: se l’altro esiste indipendentemente da me e se è nella relazione con l’altro che io costituisco
me stesso, ciò implica che l’altro ha rispetto a me un primato.
Nell’ermeneutica contemporanea, questo principio trova corrispondenza nel primato della
domanda sulla risposta:
- Gadamer4 : l’uomo non è principalmente l’essere che attende le risposte, ma l’essere che pone le
domande; e la certezza di non poter avere adeguata risposta non è motivo sufficiente per cessare di
domandare, per spegnere cioè il rapporto dialogico.
Tuttavia, per arrivare - da Aristotele ed i greci, per i quali l’idea di giustizia è rimasta allo stato
ideale essendo per loro l’individuazione della dignità dell’uomo nella realizzazione della giustizia una
conquista e non un presupposto - ad affrontare seriamente la domanda sulla identità di prossimo
dell’altro, è stata necessaria la mediazione del cristianesimo; nella parabola del Buon Samaritano, Gesù,
alla domanda “chi è il mio prossimo?” risponde invertendo i termini della questione, chiedendo “chi si è
fatto prossimo dell’uomo assalito dai briganti? Chi tra i passanti ha sentito l’appello della giustizia, chi si
4 1900 – 2002: allievo di Heiddeger.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
è sentito obbligato verso di lui? Chi ha ritenuto di avere il dovere di soccorrerlo?”: la questione dell’altro
è risolta attraverso l’esistenza di una possibilità esemplare.
La parabola di Cristo trova le sue radici nella secolare pedagogia esercitata da Dio nei confronti di
Israele, pedagogia che ha sempre assunto le forme dell’esperienza giuridica: il patto tra Dio e Israele
(Berit) è un’alleanza, un contratto che presuppone un riconoscimento forte dell’altro in quanto altro. I
profeti stigmatizzano Israele per la sua infedeltà in quanto atto di autentica ingiustizia, poiché non
riconosce a Dio quel che gli spetta sulla base non di un atto di sovranità, bensì di un patto col suo
popolo; su questi presupposti l’incarnazione assume anche una valenza giuridica rappresentando
l’estrema fedeltà di Dio alle promesse dell’alleanza.
E’ evidente allora come la categoria della “persona” nasca da un lungo confronto tra l’esperienza
giuridica classica e la sensibilità ebraico-cristiana, confronto da cui emerge il postulato ontologico 5 sul
quale si fonda il mondo moderno: il riconoscere nella persona non solo l’altro, colui con cui mi confronto
ed instauro rapporti sociali, ma soprattutto colui che ha una spettanza originaria ed irriducibile, che è, al
contempo, etica e giuridica, non in virtù di ciò che fa ma di ciò che è, per il suo essere.
Questo postulato trova forse la sua migliore espressione nella fraternità, principio attivamente
operante sul piano delle istituzioni e del diritto come fondamento giuridico del valore sociale della
solidarietà e come la conseguenza più adeguata del carattere interpersonale del diritto.
• Dirks: libertà ed uguaglianza devono essere mediate dalla fraternità in quanto la libertà, se radicalizzata,
produce disuguaglianze e l’uguaglianza, se radicalizzata, sopprime la libertà.
A questo si collega anche il tema della carità, nella cui medesima direzione si muove il diritto;
quest’ultimo non ama ma riconosce l’infinito valore della persona per cui prepara sempre la strada alla
carità (mentre l’ingiustizia ne soffoca ogni possibilità).
I cristiani, però, sanno anche che non esiste fraternità senza paternità comune e che anche un
fratello che ignora il Padre, anche per sua colpa, o che addirittura lo rinnega, non per questo cessa di
essere un fratello: la parabola del figliol prodigo serve proprio ad estirpare definitivamente l’idea che, nel
nome della giustizia, sia lecito rinnegare un uomo, una persona, un fratello.
5Ontologico = da ontologia, branca della filosofia che studia le modalità fondamentali dell’essere in
quanto tale al di là delle sue determinazioni particolari.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. III: DALLA NATURA AL DIRITTO NATURALE
Il problema della natura e della sua forza normativa sta riacquistando, in ambito etico e giuridico,
una nuova rilevanza negli ultimi anni, grazie alle questioni ecologiche e bioetiche che richiedono
soluzioni obiettive, cioè calibrate sulla natura.
Quel che interessa individuare non è il concetto di diritto naturale, ma quello di natura e,
soprattutto, indagare quale è il rapporto che l’uomo ha con la natura.
• Eraclito affermava che “la natura ama nascondersi”, sottolineando il suo carattere enigmatico, che la
rende oggetto di un sapere non immediato ma scientifico, che può essere acquisito solo attraverso duro
studio e lavoro.
Questa antica intuizione, peraltro ancora valida, evidenzia come il carattere costitutivo della
natura sia quello del nascondimento che non sembra consentire un assoluto e definitivo disvelamento; chi
invece ritiene che la natura non ci nasconda nulla e che l’incapacità di comprenderla immediatamente ed
integralmente derivi solo dalla nostra miopia, finisce col negarle qualsiasi carattere normativo in quanto,
in tale prospettiva, anche ciò che c’è di più innaturale appartiene alla natura (non esisterebbe alcuna colpa
“contro natura”), e sospende ogni questione anche sull’ordine morale come ordine specifico che,
all’interno della natura, spetta all’uomo.
In generale, invece, il pensiero umano si è sempre rapportato alla natura considerandola non solo
come l’ambiente che ci circonda ma anche, e soprattutto, come l’orizzonte normativo della nostra prassi
morale.
La natura costituisce un problema perché nella riflessione su di essa il soggetto umano scopre la
scissione, la molteplicità di contraddizioni della realtà: interna alla natura stessa (distruzione e morte), tra
oggettività e soggettività (cose e uomo), inerente alla stessa soggettività umana (il “noi” di cui possiamo
disporre, il corpo, e quello di cui non possiamo disporre, l’identità umana).
Questa consapevolezza di scissione, che è insuperabile, investe la stessa totalità della natura,
totalità la cui conoscenza è impresa impraticabile; tanto che l’oggetto del sapere naturalistico-scientifico
non è la natura ma sue singole ed autonome determinazioni particolari.
Le concezioni scientiste, quelle che si basano su teorie scientifiche, ritengono che l’uomo e la
natura siano due cose separate: la natura è il regno del fattuale, della meccanica, del biologico, ecc., ma
l’uomo ha in più la dimensione spirituale; tra uomo e natura, quindi, c’è un rapporto di trascendenza,
uomo e natura stanno da due parti diverse. La natura viene vista come il “diverso”, da noi: un’animale,
una pianta sono diversi da noi in quanto noi siamo esseri razionali, spirituali.
Tuttavia la radice di ogni filosofia della natura sta nel ritenere che essa sia un’unità sussistente
ancor prima che se ne possano analizzare i diversi elementi: filosofia della natura equivale ad affermare
che esiste un rapporto primigenio tra uomo e natura, che essi sono reciprocamente coinvolti e che questo
coinvolgimento è costitutivo dell’essere uomo; non a caso nessuna religione interpreta la natura come
caos ma come cosmo quale presupposto di ogni cultura.
Se si intende la natura come la totalità degli enti, compresi noi stessi, non si potrà ritenere l’uomo
una variabile indipendente: l’uomo è natura e la natura, nell’uomo, è principio vivente.
- Aristotele vede la natura teleologicamente, come capacità di mutamento, capacità per cui una cosa,
essendo ciò che è, può operare, nel senso di realizzare un’opera, in un certo modo.
Si rende allora necessaria una lettura metafisica6 della natura, l’unica che consente di percepirla
come normativa; l’ambito della metafisica è essenziale per l’uomo perché è esistenziale, è l’ambito in cui
egli agisce come individuo e in cui può esercitare la propria libertà (no meccanicismo).
Una tale lettura evidenzia nella natura una duplicità fondamentale tra la sua fatticità, cioè il suo
frantumarsi in enti molteplici e diversi che sono assunti ad oggetto di studio delle varie scienze, e la sua
ragion d’essere, logos, che costituisce l’oggetto specifico dell’indagine filosofica; ogni ente tende a
coincidere con il suo logos.
La ragion d’essere non è estrinseca ai singoli enti ma interna ad essi; ed è normativa perché la sua
universalità è di ordine non quantitativo, cioè diretta ad una molteplicità di destinatari, ma qualitativo in
quanto orienta ogni ente a diventare ciò che è; ed essendo noi parte di questa natura, dobbiamo agire in
modo da assecondarla e realizzare quello che ci porta ad essere.
Al riguardo è particolarmente appropriata l’immagine dell’uomo come autocomprensione:
6 Metafisica: parte della filosofia che si occupa dei principi primi e dei valori assoluti della realtà.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
- Chiavacci: per l’uomo conoscere la propria natura è autocomprendersi e autocomprensione vuol dire
comprensione di ciò cui siamo chiamati, del vuoto d’essere che in ogni nostra scelta dobbiamo cercare
di colmare.
Se il nostro essere viene da noi compreso come vuoto d’essere e se la nostra natura è quella di chi
è chiamato e ha le potenzialità di colmare questo vuoto, la norma fondamentale del nostro esistere è
quella di essere in ogni circostanza della nostra esistenza l’essere tensionalmente volto a realizzare la sua
pienezza d’essere; e la violazione di questa norma fondamentale sarà evidente nel non restare fedele a
questa potenzialità.
Autocomprensione, quindi, vuol dire che il vuoto può essere colmato, che le nostre capacità di
autocomprensione esistono all’interno di un quadro di riferimento “naturale” che ci ricomprende, che il
nostro essere è collocato in una dimensione di temporalità al cui interno si svolge il processo che ci porta
verso noi stessi per colmare il nostro vuoto.
“Diventa ciò che sei”, come affermava Pindaro, è l’unico precetto rivolto dalla natura ad ogni
ente; ma solo l’uomo ha la capacità di rispondere liberamente, scegliendo di riconoscere la propria natura
e di assumerla come normativa.
Il riferimento alla dimensione normativa della natura può costituire quel modo di pensare il
mondo come dotato di senso e il diritto naturale può essere definito come l’ordine dell’esistenza.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. IV: IL DIRITTO NATURALE E LA FALLACIA NATURALISTICA
Hume è stato un grande filosofo scozzese del ‘700 cui si deve l’elaborazione della c.d. “Legge di
Hume” secondo la quale da una serie di proposizioni tutte assertive, cioè attinenti all’“essere”, alla
descrizione della realtà, non può essere inferito alcun precetto, cioè il “dover essere” relativo alla morale,
in quanto si determina un salto logico.
Dall’accettazione della legge di Hume deriva il non cognitivismo etico, prospettiva che nega ad
ogni discorso di filosofia pratica, compresa la morale, valutativo e precettivo, un’autentica portata
conoscitiva, propria delle sole discipline che riguardano l’“essere” come, ad esempio, la scienza; nasce
così la grande divisione che ritiene reciprocamente irriducibili i discorsi fattuali e quelli normativi 7 .
Tutti coloro che hanno sostenuto il contrario, come in particolare i giusnaturalisti, cioè che
sostengono la possibilità del passaggio “dall’essere al dover-essere”, cadono in quella che i filosofi
chiamano “fallacia naturalistica”, cioè nella violazione della legge di Hume.
Questa concezione, però, è molto più fragile di quanto non possa sembrare; innanzitutto risulta
impossibile dare una prova logicamente valida del salto logico tra descrittivo e prescrittivo.
In secondo luogo, se su un piano minimale la grande divisione può essere ritenuta molto
ragionevole (impossibilità di derivare un giudizio di valore su un accadimento dal mero giudizio di
esistenza del medesimo accadimento), altamente criticabile risulta invece l’istanza massimalista del non
cognitivismo (tutte le proposizioni assiologiche e-o normative sono prive di senso o arbitrarie perché non
fondate obiettivamente su nulla, tantomeno sulla natura, e, quindi, valide e relative al solo soggetto che le
proferisce):
• nasconde una contraddizione: se i valori sono arbitrari non sono nemmeno comunicabili in quanto la
comunicazione richiede una qualche oggettivazione e razionalizzazione; sono allora solo partecipabili
emotivamente o imposti, finendo così col trasformarsi in fatti (ciò che in definitiva assumerebbe la
dignità del valore sarebbe proprio il fatto compiuto, cioè la forza, sia emotiva che materiale); e il
carattere arbitrario non viene meno se si passa dall’individuo al gruppo sociale, considerando come
valori le credenze o le ideologie;
• il normativo non si contrappone al fattuale, cioè alla realtà intesa non come giustapposizione di
frammenti ma come totalità, bensì solo al cognitivo, cioè alla lettura scientifica della realtà.
Facciamo un esempio: come dedurre dalla proposizione “A va a casa” il precetto “A deve andare
a casa” senza una premessa normativa? Se si intende ragionare in una prospettiva riduzionistica è
impossibile in quanto la prima è una proposizione che descrive solo un frammento di esperienza, che del
reale fa capire ben poco e da cui effettivamente non posso dedurre alcunché di normativo; ma proprio per
questo non si può dire che essa sia davvero descrittiva di un fatto; per esserlo dovrebbe dirci qualcosa di
non frammentario, di inquadrato nell’insieme dei fatti che costituiscono il reale in modo da poter
ricostruire l’intero che ricomprende il frammento.
Diverso sarebbe il caso in cui per “A” intendessimo uno scolaro e dessimo alla sua azione di
andare una dimensione cronologica (“A” va a casa quando finisce la scuola); a questo punto è plausibile
dedurre la proposizione “A deve andare a casa quando finisce la scuola”.
In sostanza, quindi successive integrazioni di esperienza, fattuali e non normative, possono dare
senso ad un evento che, altrimenti, visto in una dimensione frammentaria, risulta incapace di fondare un
dovere.
Sulla base di queste argomentazioni, allora, il giusnaturalismo può pretendere di derivare un dover
essere dall’essere, dalla natura, quando recepisce quest’ultima non come mera esistenza ma in funzione
del suo logos, della sua essenza, come teleologicamente orientata: dalla constatazione “A è madre di B”,
descrizione appartenente all’“essere”, si può dedurre che “A deve accudire B”, quindi una proposizione
del “dove-essere”, in quanto col concetto di madre non si intende solamente la persona che
biologicamente ha partorito B, bensì l’essenza stessa della madre, cioè di colei che è proiettata, per
natura, alla cura dei figli.
Anche volendo ammettere che la descrizione delle essenze è, di fatto, una valutazione e che,
quindi, fondare un dover essere su una descrizione di essenze equivale a fondarlo su un giudizio di valore,
7 Un’esasperazione del non cognitivismo etico è rappresentato dal non descrittivismo etico secondo cui,
essendo inderivabili da qualsiasi osservazione empirico-fattuale, i discorsi etici devono essere ritenuti del
tutto privi di significato.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
non si tratta però di una valutazione arbitraria o soggettivistica: esiste infatti una dimensione del dovere
indipendente da qualsiasi desiderio o volontà in quanto radicata nell’obiettività di un’essenza.
Come scrive Husserl, un guerriero deve essere valoroso non perché qualcuno lo desideri o lo
voglia, come invece sostengono i normativisti come Kelsen (secondo cui una norma, un dover essere, per
essere valida deve effettivamente essere posta da una qualche autorità e quindi non può esistere una
norma “pensata”, cioè che non si fondi su di un atto di volontà), bensì perché il valore è insito
nell’essenza del guerriero: un guerriero non valoroso non è un guerriero.
In conclusione possiamo affermare che “A deve essere B” se e solo se B è necessario all’esserci di
A, in quanto la non osservanza di B implica l’irriconoscibilità della natura di A, un depauperamento del
reale nei limiti in cui il reale stesso ha bisogno, per giungere alla propria pienezza, di quella
collaborazione attiva e responsabile da parte dell’uomo che noi percepiamo come doverosa; il
comportamento doveroso, quello esigito dal diritto naturale, è quello attraverso cui il reale si manifesta
all’uomo come un universo significante e permane attraverso l’azione umana nella propria identità non
meramente empirico-fattuale ma essenziale.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. V: NATURA, EVOLUZIONE, DIRITTO
Il punto di vista originario della filosofia è l’ontologia, come fondamento dell’etica; il che, per la
filosofia del diritto, ha comportato la costruzione del modello giusnaturalistico: corrente di pensiero che
a fondamento del diritto pone la natura, letta ontologicamente, come l’espressione dell’ordine dell’essere,
e che, pur non esigendo presupposti teologici, può essere inquadrata in un discorso di teologia naturale
che riconosce nella natura l’impronta della divinità o che identifichi con essa stessa.
A differenza dell’ebraismo e dell’islamismo, per i quali, se Dio è il creatore del cielo e della terra,
una mediazione naturalistica sembra addirittura blasfemo, la tradizione cattolica del Cristianesimo ha
saputo conciliarsi con l’idea di una filosofia della natura: la rivelazione, infatti, attesta, da un lato, che il
mondo è stato creato e, dall’altro, che all’uomo è stato affidato il compito di discernere, con le sue facoltà
naturali, il giusto dall’ingiusto; la prospettiva creazionista giustifica, quindi, la possibilità dell’emergenza,
nell’ordine della natura, della libertà, cioè della condizione stessa di possibilità del diritto.
La crisi del giusnaturalismo inizia con l’avvento della scienza moderna e la sua ostilità nei
confronti di ogni forma di pensiero metafisico: da Hobbes 8 in poi, infatti, i giuristi hanno elaborato l’idea
che il diritto sia convenzionale, che abbia un carattere artificiale, irriducibile a qualsivoglia presupposto
naturalistico.
In particolare, l’avvento del paradigma evoluzionistico elaborato da Darwin9 , di cui si è
impossessato il positivismo 10, ha sconvolto ogni precedente paradigma con la sua pretesa di individuare il
punto di vista originario della filosofia nella biologia come fondamento dell’etica.
Attualmente l’evoluzionismo si presenta sottoforma di versioni forti e versioni deboli ma entrambe
partono dal presupposto che l’evoluzione è un fatto storico, il cui percorso è spiegabile senza ricorrere
all’ipotesi di un ordinatore esterno; tuttavia, mentre le versioni deboli restano nell’ambito del sapere
strettamente biologico e si riconoscono incompetenti ad indicare il fondamento delle proprietà emergenti
(tra cui il diritto) che caratterizzano l’evoluzione culturale, le versioni forti si dilatano da teoria biologica
a teoria antropologica, pretendendo di spiegare gli inizi della moralità e del senso di giustizia e
scardinando, così, la pretesa di una radice metafisica di queste dimensioni. Nel dettaglio:
1. Versioni deboli: ritengono che nessuna fase del processo evolutivo, in particolare quella culturale,
possa essere ridotta ai suoi livelli inferiori e non riducono la mente al biologico; per tale motivo questa
versione non entra in conflitto con le religioni, in quanto la semplice ammissione dell’esistenza della
mente è sufficiente come substrato naturalistico per l’affermazione meta-naturalistica dell’esistenza
dell’anima.
2. Versioni forti: riduzioniste, molto avverse alle credenze religiose; i punti nodali sono:
• tutte le specie viventi sono il prodotto dell’evoluzione, per mutazione e selezione, da un unico gruppo
di organismi primordiali;
- la specie umana appartiene integralmente alla natura; la sua onticità non è riconducibile ad alcun
fondamento ontologico e l’ipotesi di un intervento divino a fondamento della sua esistenza e delle sue
scelte morali è errata;
• la natura, unica e sufficiente, esaurisce tutte le dimensioni del reale e non è lecito attribuirle alcun
senso intrinseco;
• è da considerare mistica e da condannare ogni illusione antropocentrica dell’uomo, soprattutto quella
di potersi emancipare dalla natura o di avere un primato su di essa;
• la moralità e il senso di giustizia sono emergenze evolutive casuali e meramente psichiche.
Esiste un duplice ordine di ragioni che rende difficilmente accettabile per il giurista il paradigma
evoluzionistico in senso forte, quando cioè esce dal biologico per entrare nell’ambito dell’antropologico
(la scienza del diritto, invece, non ha nulla da obiettare nei confronti di una teoria evoluzionistica in
senso debole, che sappia restare negli orizzonti del sapere biologico e che si riconosca incompetente a
indicare il fondamento di quelle proprietà emergenti – tra le quali il diritto – che caratterizzano
l’evoluzione culturale):
8 Hobbes = filosofo britannico del ‘600.
9
Darwin = naturalista britannico dell’’800.
10 Positivismo = movimento filosofico e culturale ispirato all’esaltazione del progresso e del metodo
scientifico che nacque in Francia nella prima metà dell’800, che si diffuse a livello europeo e mondiale.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
1. L’idea che l’insorgenza del senso morale dipenda da predisposizioni neuronali rese possibili
dall’evoluzione della specie, che esista qualcosa come un orientamento all’umano attivato dal mero
caso ma nelle forme dinamiche del progresso, non è coerente con gli stessi postulati della dottrina
evoluzionistica che, infatti, pur sottolineando come l’uomo sia solo una delle innumerevoli varianti
aleatorie dell’evoluzione, priva, come tutte le altre, di ogni significato intrinseco, sceglie di
interessarsi al solo cammino dell’evoluzione che porta all’umanità, oltretutto radicando i propri
concetti epistemologici fondamentali in categorie elaborate dalla nostra mente e, quindi, strutturate
antropologicamente (finalismo, caso, necessità), innescando così un circolo vizioso ineliminabile: è
solo a partire dal fatto che l’uomo elabora l’idea del senso che si può sostenere che l’evoluzione sia
priva di senso.
Per argomentare appieno quanto sopra, prendiamo l’esempio dell’altruismo, inteso come il sacrificio
di sé per il bene altrui: secondo gli evoluzionisti esso avrebbe un mero fondamento biologico in
quanto, attraverso la selezione naturale, alcuni individui acquisiscono casualmente una fertilità
differenziale che si manifesta in un vincolo a comportarsi in modo da massimizzare le proprie
possibilità di riproduzione e sopravvivenza; conseguentemente nessun individuo potrebbe elaborare
naturalisticamente il principio dell’altruismo. Già Darwin, però, mostro come questo sia riscontrabile
non solo nell’uomo ma anche in molte specie animali: l’altruismo antropologico, allora, non sarebbe
che una mera variante di quello biologico; in realtà c’è una discriminante essenziale che è
l’intenzionalità. Infatti mentre l’altruismo biologico è prettamente comportamentale, cioè
inconsapevole, l’altruismo antropologico è intenzionale e, quindi, scaturente da un senso morale
tipico del solo uomo.
2. Premettiamo che tutto ciò che indirettamente o direttamente è riconducibile alla responsabilità di
un soggetto, è cioè intenzionale, costituisce l’ambito specifico del diritto e che, tradizionalmente, la
responsabilità si identifica o si fonda sulla libertà, categoria metafisica, irriducibile a categorie
scientifiche; non a caso per gli evoluzionisti la responsabilità, così come il senso sociale, costituisce,
invece, un mero prodotto psichico e casuale dell’evoluzione: l’uomo è evolutivamente indotto a
considerare sé e gli altri come responsabili e costruisce, di conseguenza, un sistema socio-giuridico
coerente. Tale tesi, però, va incontro ad almeno due difficoltà:
- ammettendo che il senso giuridico e morale della responsabilità è un prodotto casuale
dell’evoluzione, se ne sottolinea il carattere molto positivo per l’affermazione della nostra specie e,
quindi, si riconosce che esso meriti il supporto di credenze religiose e filosofiche; viceversa, deve
considerarsi molto dannoso evolutivamente il fatto che l’idea di responsabilità sia considerata un
pregiudizio e pericoloso che la sua demistificazione sia proposta come plausibile: infatti, negando
ogni fondamento etico al senso di responsabilità si giustifica l’abbandono ad atteggiamenti deliranti
di irresponsabilità.
- la riconduzione della responsabilità al merito, che la dottrina giuridica ritiene indispensabile, non ha
alcuna giustificazione nella logica evoluzionistica: avendo il senso di responsabilità, per
quest’ultima, una diffusione statistica e potendo apparire più o meno forte nei singoli individui, può
accadere che esso sia assente o gravemente carente in un soggetto, senza che ciò possa essere
ascritto a sua colpa; come deve rapportarsi un sistema giuridico a tali individui? Ha senso rispettarli,
punirli e prevederne il reinserimento sociale oppure ha più senso distruggerli in nome della difesa
sociale?
In conclusione: l’uomo, come individualità biologica, si identifica col proprio bios ma come
anthropos, è espressione del zoè, cioè del vivente come espressione di significato che per l’uomo assume
la connotazione delle possibilità della libertà; quando l’evoluzionismo pretende di assumere posizioni
forti e ritiene una mistificazione l’idea propriamente umana della libertà, che invece è il presupposto di
ogni esperienza giuridica, diventa minaccioso per un sapere come quello giuridico il cui obiettivo è
garantire che lo strutturarsi della vita relazionale avvenga nel rispetto dell’ordine della libertà, quale
quello riconducibile al diritto.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. VI: DIRITTO E MORALE
La stretta affinità tra diritto e morale11 è da individuare nella circostanza per cui solo
nell’esperienza giuridica ed in quella morale emerge quell’alterità sostenuta dal non uccidere; per
Benedetto Croce, invece, secondo cui l’unico problema autentico è quello dell’unità della vita dello
spirito, la tematizzazione del nesso tra diritto e morale andrebbe semplicemente eliminato come un falso
problema, in quanto sono entrambe mere astrazioni concettuali cui si può al massimo riconoscere una
consistenza ontica e non ontologica; conseguentemente sono solo le scienze umane a poter riflettere su
diritto ed etica.
Diritto e morale sono considerati sistemi normativi dotati di una rispettiva coerenza intrinseca e il
problema dei loro reciproci rapporti ammette solo tre soluzioni: la reciproca irrilevanza o il primato di
uno dei due sull’altro; storicamente si possono individuare tre grandi fasi caratterizzate ciascuna dal
prevalere di uno di questi modelli:
- Età antica e Medioevo: supremazia della morale sul diritto
Il diritto era concepito come funzionale alla morale in quanto, in quell’epoca, dominava una concezione
della vita prettamente religiosa e le leggi, ossia ciò che costituisce il diritto, non avevano valore se non
rispettavano l’ordine di valori dati da Dio: l’unica possibilità di giustificare le norme giuridiche è
riportarle ad un ordinamento meta-positivo che viene accolto non perché imposto dal potere, bensì
perché riconosciuto dal cittadino come sostanziato dalla sua etica. Per questo il paradigma classico è
stato adottato dal pensiero cristiano quale possibilità di tematizzare un ambito, quello del diritto,
marginale per la sensibilità evangelica e non teorizzabile a partire esclusivamente dalle Scritture.
- Epoca moderna: separazione tra morale e diritto
La crisi del paradigma classico ha portato all’affermarsi di una netta separazione tra la logica del diritto
e quella della morale; a partire dal Macchiaveli in poi, circa nel ‘500, la morale riguarda semplicemente
la coscienza degli individui: ciò che è bene e ciò che è male diventa semplicemente un problema di
coscienza. La tarda scolastica anticipò la frattura introdotta alla Riforma, riconoscendo al diritto una
morale propria, pubblica (la ragion di stato): il diritto costruisce il sistema delle azioni sociali, all’etica
è lasciata la cura delle anime. Non a caso è l’epoca in cui l’Europa ha artificializzato l’esperienza
sociale: deperimento del diritto consuetudinario, nascita del diritto processuale, codificazione del diritto
privato, ecc…; del male si risponde, prima che a Dio, alla società. Parimenti, l’invenzione del diritto
internazionale, risalente a Grozio, è stata sollecitata dalla necessità di trovare un sistema di
comunicazione obiettivo e trans confessionale, destinato a sostituire quello medievale costituito dalla
consapevolezza di appartenere all’universalità della comunità cristiana, con le sue leggi comuni.
- Epoca contemporanea: primato del diritto sulla morale
L’integrale privatizzazione del diritto e la secolarizzazione della morale cristiana hanno favorito la
convinzione dell’opinione pubblica di essere in possesso di un reale minimo etico, quello veicolato dal
diritto, grazie a cui è garantita la coesistenza umana civile; il moltiplicarsi delle carte dei diritti e delle
proclamazioni costituzionali dei diritti dell’uomo sono il segno del trionfo della moralità pubblica, del
diritto, quale moralità meta-etica e meta-culturale. La cultura contemporanea riconosce spazio all’etica
nei limiti in cui questa riconosce il primato del diritto e si modella sui principi giuridici universalmente
accettati: quindi i valori morali sono tali soltanto perché sono, in qualche modo, contenuti e riconosciuti
nella Carte dei Diritti. L’epoca contemporanea è quella del desiderio di riconquistare un’unità non solo
morale e giuridica, ma anche culturale, religiosa ed assiologia dell’umanità, è l’epoca della
riconciliazione in cui diritto e morale sono destinati ad incontrarsi nell’eticità dello Stato; e lo
strumento della conciliazione è la politica, vista come teoria della prassi collettiva, e non più del miglior
governo, prassi in cui l’antitesi tra essere e dovere, tra azione reale e bene ideale, quindi tra diritto e
morale, è definitivamente superata 12. E se lo Stato è la totalità etica, l’etica individuale non solo perde
ogni consistenza ma ha bisogno dell’etica pubblica per ritrovare la propria ragion d’essere.
11 Con il termine morale si può genericamente indicare quella disciplina che si occupa del bene, cioè di
stabilire cos’è il bene e cos’è il male.
12 Il primato della politica ha trovato due grandi forme di realizzazione, il nazionalismo ed il
totalitarismo; in entrambe la moralità propria del diritto viene a coincidere con la moralità stessa dello
Stato.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Il primato del diritto rispetto alla morale ha assunto la forma più caratteristica nel dominio del
positivismo giuridico (Kelsen) che ha sempre negato ogni contaminazione con le logiche della politica
e dell’etica in quanto il problema giuridico fondamentale non è quello della giustizia ma quello della
validità (secondo il positivismo giuridico, uccidere è reato semplicemente perché è vietato dalla legge;
conseguentemente è possibile che, in una futura società, uccidere non sia più un reato perchè cambiano
le circostanze, cambiano le condizioni, e perché importante non è il contenuto morale o il contenuto di
giustizia delle norme, delle leggi, ma importante è la loro validità; è fondamentale, cioè, che la legge
”non uccidere” sia stata stabilita da un legislatore che abbia il potere di emanare una legge valida, ma
che non ha nulla a che vedere con il fatto che questa norma sia giusta o ingiusta). Tuttavia Radbruch
evidenzia come l’apoliticità del diritto sia un mito in quanto quest’ultimo, quale tecnica di
organizzazione sociale positivamente determinata dal legislatore, è eminentemente soggetto alla
politica.
Recentemente, però, questa posizione è entrata progressivamente in crisi perché ci sono stati
eventi che hanno mostrato come il diritto non possa essere semplicemente un insieme di norme valide ma
debba essere portatore di concetti di giustizia, di contenuti etici più universali (pensiamo allo sterminio
degli ebrei durante la seconda guerra mondiale); secondo molti siamo entrati in un’epoca post-moderna in
cui gli ordinamenti giuridici hanno rinunciato alla loro pretesa assolutezza nei confronti dell’etica e in cui
il diritto è sempre più aperto all’integrazione reciproca tra i vari ordinamenti statali, alla costruzione di un
nuovo diritto privato universale, ponendo a proprio fondamento la dignità dell’uomo quale etica minima,
quale valore da difendere in sé e non perché è utile alla collettività umana (come invece sostengono gli
utilitaristi).
Forse, quindi, ci stiamo incamminando verso la costruzione di quello Stato di diritto universale in
cui solo è possibile ipotizzare un riconoscimento universale, ontologico e non utilitaristico, degli uomini;
e ne è testimonianza il fatto che oggi le polemiche sui problemi etico\giuridici più laceranti (aborto,
eutanasia, pena di morte) non hanno per oggetto modi diversi di intendere il diritto, bensì modi diversi di
dare concretezza alle categorie della dignità umana.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. VII: L’ETICA DEL DIRITTO
Per quanto siano rilevanti, i valori tutelati dal diritto sono sempre apparsi freddi, incapaci di
suscitare un autentico sentimento di obbligo nei loro confronti; riferendosi infatti all’ordine delle azioni,
più che a quello delle coscienze, il diritto è apparso carente sul piano dell’autenticità che costituisce,
invece, lo specifico dell’esperienza morale; per questo motivo i cultori del diritto hanno sempre cercato
previamente di giustificare il diritto, cioè di mostrare che la carenza di autenticità che nella cristianità fu
considerato peccato, il fariseismo, lo è in quanto peccato di cattivi giuristi, non della cosa “diritto”.
La dialettica diritto\morale, però, ha subito una metamorfosi nel complesso quadro postmoderno,
in cui si è passati da un paradigma che, in nome dell’autenticità, riconosceva un primato dell’etica sul
diritto, ad un paradigma opposto, che riconosce una supremazia del diritto sull’etica, chiedendo a
quest’ultima di giustificare se stessa e le sue pretese; e ciò avviene non negando all’etica il suo carattere
di autenticità, bensì mediante la c.d. privatizzazione dell’etica.
- Max Weber13: percepisce la crisi della concezione tradizionale dell’etica, quale sistema di valori assoluti
e condivisi, e rileva la progressiva tendenza del particolarizzarsi della morale che si conclude con il
nuovo paradigma culturale del politeismo etico, secondo cui l’etica non è universale ma si articola in
una molteplicità di singole opzioni morali, irriducibili ad unità sia perché tra i diversi valori che
presiedono l’ordinamento del mondo il contrasto è inconciliabile, sia perché le opzioni sono tanto più
autentiche quanto più si vivono sul piano della prassi e meno si dialettizzano sul piano della teoria
(mentre i precetti etici tradizionali potevano essere continuamente violati sul piano della prassi ma
comunque erano riconosciuti da tutti come validi in quanto principi generali di condotta) .
- Engelhardt14: gli uomini devono abituarsi a considerarsi reciprocamente “stranieri morali”, cioè abitanti
di un mondo che, pur costringendoli a vivere sempre più vicini e ad interagire, non può pretendere che
parlino il medesimo linguaggio etico, né condividano un comune piano di valori; conseguentemente, il
linguaggio necessario all’interazione non può essere etico, bensì giuridico: l’accordo basato non su
buone ragioni, in quanto la ragione postmoderna si è dimostrata incapace di individuare un contenuto
obiettivo, e quindi buono, alla ragione, ma sulla mera buona volontà di accordarsi. Ciò che resta,
quindi, è una sorta di diritto naturale minimo riferito alla possibilità che le persone si adoperino per
trovare, convenzionalmente, soluzione ai loro conflitti e alla modalità della loro coesistenza.
Solo il diritto, quindi, con la sua fredda esteriorità formale, è in grado di garantire il politeismo
etico proprio perché le molteplici etiche, portatrici di una propria specifica carica di autenticità, si
rivelano insindacabili, incomunicabili e conflittuali; in questo modo la vita etica, seppur privatizzata, è
riconosciuta come insindacabile a livello pubblico e quindi i conflitti etici scompaiono in quanto il diritto
si impegna a proibirli espressamente.
Dal primato procedurale del diritto sull’etica, in quanto fondato su un accordo, è stata elaborata
una versione moderna dell’antica tesi che pone il dialogo a fondamento del vivere sociale; l’accordo,
infatti, non può che essere il frutto di un dialogo ma il dialogo è possibile solo tra persone che si
riconoscano reciprocamente come persone; e il riconoscimento, presupposto del dialogo, deve avere non
solo una valenza empirica (l’altro, considerato come singolo individuo che mi si contrappone, è come
me), ma soprattutto ontologica (l’altro, considerato come altro e non solo come mero individuo empirico,
è come me) ed assiologica (l’altro, considerato come altro e non solo come mero individuo empirico, vale
quanto me).
L’”altro” deve essere inteso come “colui nel quale io ritrovo me stesso” e, soltanto per questo, può
pretendere da me un trattamento secondo giustizia; solo a queste condizioni può instaurarsi quel dialogo
che è condizione per realizzare l’accordo comune: diversamente possono nascere solo dialoghi e accordi
ipocriti, ingannatori e strumentali.
Da ciò si evince anche che non esistono, né possono esistere, “stranieri morali”; l’essere straniero
è categoria empirica, non antropologica o filosofica: nessuno è tanto straniero da rendere impensabile la
possibilità di parlargli; nessun linguaggio è totalmente intraducibile; nessun valore etico, per quanto non
condivisibile, è assolutamente incomprensibile e incomunicabile.
13
Max Weber = economista, sociologo, filosofo e storico tedesco, vissuto a cavallo tra l’’800 e il ‘900,
considerato il padre dello studio moderno della sociologia e della pubblica amministrazione.
14 Engelhardt = medico, biologo e filosofo statunitense vivente.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Il principio “non esistono stranieri morali”, da cui l’etica deve ripartire, è al tempo stesso
teoretico, perché implica l’affermazione ontologica dell’uguaglianza, etico, perché implica l’affermazione
assiologia della fraternità, e giuridico, perché sottrae al dibattito etico allo spazio esclusivo della
coscienza interiore e ne fa oggetto di un pubblico confronto.
Nell’orizzonte postmoderno, la comunità cristiana deve scegliere come inserirsi nel grande
dibattito del politeismo etico, come fronteggiare le sue pretese di neutralizzazione assiologica:
1. assumere uno spirito di intransigenza: difficilmente attuabile in quanto sfocerebbe
nell’intolleranza;
2. cercare un patteggiamento cognitivo: comporterebbe la rinuncia ad alcuni elementi della propria
tradizione morale.
3. assumere un atteggiamento di protesta profetica: potrebbe portare ad una sorta di
autoghettizzazione morale.
4. cedere al relativismo: ritenere che dalla dispersione morale possa generarsi una nuova spontanea
tensione verso l’unità etica.
Per capire quale ipotesi è la più coerente con l’identità cristiana è necessario saper interpretare il
nostro tempo in modo da potervi scorgere un orientamento; e il criterio ermeneutico che il cristiano
tenderà ad assumere non avrà alcun carattere di neutralità (e sarà quindi autenticamente ermeneutico), né
avrà un carattere soggettivistico perché non rispecchierà la soggettività di chi riceve il messaggio ma
l’oggettività di chi ne è la fonte; si tratta di una delle tante dimensioni paradossali che caratterizzano il
cristianesimo e la sua etica: il Dio che si è fatto uomo non ha potuto che farsi uomo nel tempo e nello
spazio, non ha potuto non assumere un’identità personale particolare; ma il messaggio che ha lasciato è
universale, rivolto a tutti gli uomini e a tutte le culture.
Questo paradosso, però, costituisce il fondamento dell’identità cristiana ma non il criterio storico
d’azione, che va ricercato altrove; ciò, però, che va sottolineato è che la pretesa della comunità cristiana
deve avere un carattere pubblico non diverso, nel principio, da quello che legittima il potere pubblico: il
cristianesimo deve farsi testimone vivente della possibilità storica che gli uomini siano accomunati da una
prassi morale non escludente, da cui emerga, quale principio ontologico, la verità della loro pari dignità di
esseri umani; ma perché la stessa parola dignità abbia un senso, è necessario postulare il primato
dell’universale sul particolare, dell’uguaglianza sulla differenza, dell’assoluto sella storia e del bene sul
male.
E l’insistenza sul carattere pubblico fornisce almeno due criteri attraverso cui la comunità
cristiana può avanzare, nell’attuale contesto, le proprie pretese:
.a“primato del cognitivo sul normativo”, cioè l’antecedenza del vero sul bene; prima di parlare dei valori
i cristiani debbono parlare della verità delle cose alle quali i valori devono fare riferimento; solo così il
bene può accomunare tutti gli uomini e ha senso la ricerca di una giusta legislazione (confronto
ontologico prima che assiologico);
.b “communicatio facit civitatem”, la pretesa di comunicazione: poiché la verità, in linea di
principio, è conoscibile, il dovere di comunicarla e di diffonderla possiede non solo una valenza
cognitiva, ma anche sociale e relazionale; in questo modo, da un alto, attraverso il riferimento alla
verità, il discorso etico è sottratto ad ogni tentazione intimistica e\o irrazionale, dall’altro si ridona
dignità alla comunicazione.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. VIII: LA VIOLENZA E IL DIRITTO
Nei confronti della violenza, il giudizio umano ha sempre avuto un atteggiamento ambivalente, da
una parte di opposizione, dall’altra di attrazione; questo perché esiste una paradossale verità della
violenza che affonda le proprie radici nell’intimo dell’uomo, il quale ne è, contemporaneamente,
affascinato e ripugnato.
Le moderne scienze umane hanno cercato di non farsi coinvolgere da questa dialettica, assumendo
nei confronti della violenza un atteggiamento descrittivo, intendendola quale ogni atto fisico di un
individuo o gruppo contro un altro individuo o gruppo; in questo modo la qualificazione assiologia della
violenza, giusta o non giusta, avviene in base a sistemi di valori descrivibili ma non fondabili
razionalmente e, quindi, legittimi in un discorso prescrittivo ma non scientifico.
Se consideriamo l’esperienza giuridica, lo stesso diritto, pur essendo uno strumento di libertà
ritenuto tecnica non violenta di risoluzione dei conflitti, non è rifuggito dall’uso della spada, ricorso che
molte teorie hanno tentato di giustificare qualificandolo come potere di coazione e, quindi, come regola
della forza, senza quindi considerarne la violenza intrinseca.
Ciò che costituisce l’essenza fenomenologica della violenza è la sua incapacità di concentrarsi e
modellarsi sul logos, sulla verità, l’incapacità di riconoscersi subordinata ad una misura; è la rinuncia alla
verità che apre la strada alla violenza.
Il più importante contributo italiano al tema della violenza viene da Cotta 15 il quale afferma che è
appunto la misura a distinguere, nell’ambito della categoria dell’agire-contro, l’atto di forza, dotato di
giustificazione giuridica, dall’atto di violenza; l’atto di forza, infatti, è sempre misurato a tre diversi
livelli:
1. è posto in essere con misura interna, a partire da un obiettivo equilibrio interno dell’agente;
2. è posto in essere secondo misura (esterna all’agente), in base a regole obiettive e prefissate;
3. è posto in essere a fini di misura (misura finale), per introdurre un ordine precedentemente carente
nella realtà.
La mancanza di anche una sola di queste dimensioni rende l’atto di forza ambiguamente aperto
alla violenza (a differenza di quanto sostiene il formalismo istituzionali stico, secondo cui è sufficiente la
misura esterna, cioè la legalità).
L’esperienza storica ha mostrato che non è mai stata la cultura filosofica a sconfiggere la violenza
ma che, molto spesso, è addirittura accaduto il contrario; e rare volte essa si è trasformata in un’efficace
e generalizzata pedagogia perché, anziché combattere i violenti, spesse volte i filosofi hanno preferito
rinunciare ad ogni combattimento (basti pensare al nascondimento epicureo davanti alla follia del mondo
ed alle sue violenze).
Ma in un tale contesto la violenza può diventare il tramite di un nuovo conferimento di senso,
presentarsi come il benefico, seppur brutale, motore della storia; secondo questo paradigma della violenza
costitutiva e rigeneratrice delle forze vitali del mondo, la violenza non è da considerare frutto di una
perversione o smarrimento umani, bensì costituirebbe la trama originante e costitutiva dell’umano.
• Girard 16: la violenza è dimensione fondatrice dell’humanum ma il suo meccanismo esige periodiche
crisi sacrificali in cui si scarica la violenza che è comunque alla base della pace che gli uomini
instaurano; pace provvisoria quindi, che richiede, in tempi più o meno lunghi, la riattivazione di un
analogo meccanismo sacrificale. L’autentico volto del logos sarebbe dunque violento e proprio nel
logos e nella sua capacità di dominio della realtà va ravvisata la radice propria di ogni violenza.
Un tale logos non merita venerazione ma esecrazione e questo è il grande tema di tutta la
tradizione gnostica e che torna periodicamente nella cultura occidentale, ogni volta che l’esistente viene
letto come assiologicamente perverso ed ontologicamente privo di senso; non a caso a tale visione va
ricondotta la logica del fenomeno rivoluzionario come fenomeno tipicamente moderno e radicalmente
contrapposto al fenomeno, premoderno e tradizionale, della rivolta: il rivoluzionario accusa il passato e
soprattutto il presente di essere inguaribilmente intrisi di violenza e ritiene che solo il passaggio
rivoluzionario, necessariamente violento, ad una dimensione dell’essere totalmente nuova potrà aprire
all’umanità la speranza di un nuovo logos.
15 Sergio Cotta = filosofo italiano, studioso del diritto, vissuto fino al 2007.
16 Renè Girard = critico letterario ed antropologo francese vissuto nel ‘900.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
• Heidegger: è proprio in ciò che ha reso specifico l’Occidente, cioè la sostituzione del pensiero
dell’essere con la costruzione del logos della metafisica, che è da vedere l’espressione più piena della
volontà di potenza; l’uomo sarebbe ormai giunto a un punto di non ritorno: la volontà di potenza
generata dal trionfo del logos, una volta posta in essere, può ammettere recriminazioni, vagheggiamenti,
ma non reali possibilità di inversioni di rotta.
In realtà, però, secondo i teorici del pensiero debole, l’epoca che viviamo, il postmoderno, si
distingue dall’epoca moderna in quanto non più radicata nella volontà di potenza; il postmoderno, infatti,
nasce nel momento in cui la guerra, cioè il mezzo più drastico usato dalla volontà di potenza per ottenere
la massimizzazione di se stessa, si è rivelata, nell’era nucleare, non solo impossibile ma anche
impensabile, in quanto non serve a raggiungere alcun fine e, con i mezzi odierni, implicherebbe la
distruzione totale; e con l’impensabilità della guerra si rivela impensabile anche la stessa nozione di
potenza su cui l’Occidente ha costruito l’idea stessa di logos: il pensiero, riconosciuta la propria
costitutiva debolezza, è costretto a riformularsi come pensiero non della potenza ma del limite.
Le buone ragioni del pensiero debole vanno ravvisate nella rivalorizzazione della radice ebraica
della tradizione metafisica medievale; è, infatti, nel Vangelo di San Giovanni che il Signore dice a San
Paolo: “la mia potenza si manifesta nella debolezza”; indubbiamente si può affermare che non esiste altra
parola più netta contro la violenza.
- Levinas: non si può lottare contro la violenza con la violenza stessa; la radice del nostro problema è nel
primato della teoresi sull’etica: quando non riusciamo più a cogliere il volto dell’altro ma ci limitiamo
a pensarlo, l’abbiamo escluso da quella che per noi è la realtà; al rapporto abbiamo sostituito
l’immagine del rapporto conformandola ai nostri modelli mentali e cedendo così alla tentazione
dell’assolutizzazione della nostra soggettività.
Conseguentemente, è solo partendo dal postulato etico del prendersi cura dell’altro che ha senso
porsi il problema dell’identità dell’altro e del nostro rapportarci a lui; la cultura contemporanea ha
svuotato la relazionalità, determinando la scomparsa del diritto e l’affermazione di quella violenza
mascherata da libertà e liberazione.
Il Diritto vivente, quello che non si incarna in norme o codici ma che vive nella relazione e che si
presenta, al tempo stesso, come condizione e conseguenza del dialogo umano, può divenire, a suo modo,
cifra della non violenza e dell’assoluto.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. IX: LA NONVIOLENZA
Il termine non violenza possiede almeno due accezioni:
1. non violenza pragmatica o negativa: indica un modo di agire, una tecnica di azione politica che ritiene
di poter e dover trovare solo in sé la propria giustificazione; soffre della debolezza tipica delle
dinamiche della prassi che rinunciano a qualsiasi riferimento al piano dei principi o delle dottrine; può
pertanto essere utilizzata da qualsiasi ideologia o movimento, anche per favorire l’assetto di regimi
politici in realtà oppressivi;
2. non violenza dottrinale o positiva: fa riferimento ad una dottrina, ad un insieme di principi teoretici,
etici e politici, nei quali può trovare il proprio fondamento una tecnica di azione politica ma che
mantengono la loro vitalità indipendentemente dalla loro applicazione pratica o che possono
giustificare forme di applicazione molto diverse; presuppone una propria specifica antropologia al cui
interno il ripudio della violenza è principio primo e costitutivo, seppur non inteso in modo aprioristico.
In sintesi, la non-violenza pragmatica ritiene giusta l’azione non-violenta perché la ritiene tale da dare
buoni risultati, o da dare sempre risultati migliori dell’azione violenta; la non-violenza dottrinale, invece,
ritiene che il ripudio della violenza sia giusto in se stesso, anche nell’ipotesi in cui esso non dia gli esiti
sperati.
Della non violenza dottrinale esistono due modelli:
1. modello orientale: è identificabile nell’azione di Gandhi, l’unico possibile modello di teoria ed azione
non violenta, il satyagraha, termine con difficoltà tradotto in “insistenza per la verità”, il quale fa
riferimento alla verità quale sinonimo di Dio e che viene conquistata attraverso l’esperienza
personale; esso postula la conquista dell’avversario mediante la sofferenza nella propria persona: ciò
implica che l’avversario, sul piano psicologico, non può restare indifferente all’atteggiamento di chi
non infligge sofferenze ma accetta di patirle, ma soprattutto implica la convinzione ontologica per cui
al nemico non può essere evidente l’universale coappartenenza degli uomini, il loro comune destino
che la violenza deforma. Quindi, la non-violenza gandhiana, il cui fine è la conversione universale
alla verità, cioè a Dio, assume il duplice carattere di lotta a favore degli oppressi (perché siano liberati
dalla violenza degli oppressori) ma anche di lotta a favore degli stessi oppressori (perché siano
liberati anche loro da ciò che li opprime, cioè da ciò che li induce ad operare con violenza contro gli
altri); da qui il carattere pubblico ed anti-individualistico del satyagraha: la sofferenza che io decido
di accollarmi, per essere efficace, dev’essere conosciuta non solo nella sua attualità ma anche
nell’intenzionalità (sofferenza per), perché è negli scopi, e non in se stessa, che trova le proprie
ragioni.
2. modello occidentale: è il modello del diritto come tecnica di soluzione delle controversie, giusta e non
violenta, implicando l’irrilevanza della mera forza come criterio di regolamentazione dei conflitti
intersoggettivi e la subordinazione di questi ad un sistema obiettivo e pacificante di regole; assume
come fondamentale paradigma relazionale non violento quello secondo cui è la giustizia il principio
regolatore delle relazioni, paradigma che prende sul serio l’intersoggettività relazionale. E’ il modello
che ha caratterizzato l’Occidente e che sta penetrando nella cultura planetaria; rispetto al modello
gandhiano, altamente spirituale perché rivolto con forza alle coscienze, risulta caratterizzato da
un’intrinseca e riduttiva dovuta all’istituzionabilità del diritto, esperienza priva di un univoco
referente etico ed esposta al degrado formalistico e farisaico; eppure proprio queste caratteristiche
hanno consentito al diritto di assurgere ad unico strumento realmente operativo ed universale di
riconoscimento, difesa e promozione dei diritti di tutti gli uomini.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. X: GIUSTIZIA, CARITA’, PENA
Secondo Bobbio17 il valore supremo, laico, è la giustizia; se essa esistesse non ci sarebbe bisogno
della carità ma, egli afferma, la giustizia non è di questo mondo.
In realtà, però, la giustizia non è alternativa alla carità rappresentandone, invece, la prima delle
condizioni di possibilità; lo stesso diritto non si contrappone alla carità ma si muove nella stessa
direzione: il diritto non sa amare ma sa riconoscere, come la carità, l’infinito valore della persona, la sua
dignità, e senza questo previo riconoscimento nessun atto di amore può essere autentico o possibile.
Un esempio di come il diritto rappresenti una prima forma di apertura nei confronti della carità è
rappresentato dal diritto penale che mostra la coscienza profonda che gli uomini hanno sempre avuto del
nesso tra diritto e dignità umana: per il diritto penale l’uomo è meritevole di pena perché ha male
utilizzato la propria libertà, orientandola al male.
Quando il diritto penale interviene sul reo e lo punisce, ne sottolinea implicitamente la
responsabilità e, di conseguenza, la libertà; il suo fine, infatti, non è l’intimidazione, la prevenzione, la
difesa sociale o la rieducazione sociale del reo, che fanno invece riferimento ad altri ambiti di esperienza
e pratica sociale; il diritto penale ha come propria finalità specifica l’espiazione della colpa e, di
conseguenza, il recupero sociale del reo a partire dal rispetto della sua dignità umana che nessuna colpa,
per quanto grave, potrà mai cancellare.
La pena, facendo soffrire il reo, gli offre un’occasione efficace per prendere coscienza di come
abbia abusato della sua libertà ed il diritto penale presuppone che, scontata la pena, il reo abbia espiato e,
quindi, pagato il proprio debito con la società e gli rinnova la propria fiducia reinserendolo nel libero
gioco della società civile.
Diviene a questo punto chiaro quale sia l’unico argomento valido contro la pena di morte: una tale
pena, uccidendo il reo, da indebitamente per scontato che il delitto lo ha reso a tal punto indegno da
togliergli il diritto di far parte della comunità umana.
Tuttavia il diritto, tutto il diritto, non solo il penale, ha una struttura fragile e fredda perché non da
né la garanzia dei vincoli politici, né il calore dei rapporti amicali, e la consapevolezza di questi limiti ha
fatto sorgere la tentazione di ricondurre il diritto all’interno di una diversa forma coesistenziale facendone
una variante subordinata della politica o della morale.
Con Rousseau e il suo “contratto sociale” etica e politica sono giunte a confondersi con la volontà
generale e il problema sembrava risolto, con l’individuazione di una comunità di uomini liberi che si
autodeterminano senza bisogno di restrizioni aprioristiche o formali perché le loro volontà si accordano
spontaneamente in virtù della reciproca solidarietà; ma nel progetto ruousseauiano, a parte il non aver
considerato il problema rilevante dell’eventuale divergere del volere di alcuni rispetto alla volontà
generale, si fa un errore di fondo, cioè dislocare l’origine della libertà nel “tutto collettivo” e non, come
corretto, nel singolo.
Pertanto lottare per il diritto, perché la sua struttura propria non subisca violenze, significa, come
affermava Jhering, lottare per il riconoscimento che l’uomo è un essere libero e che la libertà fa capo
all’uomo in quanto singolo che si rapporta coesistenzialmente ad altri singoli e non ad un anonimo Tutto
collettivo; quindi, la lotta per il diritto ha per obiettivo quello di riconoscerne la funzione non come forma
suprema di rapporto tra gli uomini ma semplicemente come forma non surrogabile da altre.
17 Norberto Bobbio = filosofo, storico e politologo italiano del ventesimo secolo.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XI: L’OBIEZIONE DI COSCIENZA
L’obiezione, il dire di no, alle leggi precostituite può avere una duplice natura: psicologica,
quando è finalizzata non a contestarle ma esclusivamente a trasgredirle, cioè a soddisfare un capriccio
egoistico, oppure assiologica, quando l’obiettore si sente destinatario del dovere di dire di no a quanto la
legge gli ingiunge di fare.
Volendo riservare la qualifica di obiettore solo a coloro che obiettano per senso del dovere,
l’obiezione appare come un fenomeno premoderno: l’obiettore dice di no alle leggi perché non le fa
coincidere con il diritto, le ritiene cattiva determinazione del diritto da parte del detentore del potere (la
verità del diritto, quindi non è prodotto dell’attività politica ma suo presupposto); in questo senso
l’obiezione è sempre dalla parte non solo del diritto ma anche del legislatore, perché lo richiama ad essere
fedele alla sua competenza specifica, porta avanti un’indiretta e dura esortazione al buon uso del potere
(che deve mediare tra la verità del diritto e la concreta dinamica della storia).
In quanto testimone del diritto contro la legge, l’obiettore non è un rivoluzionario ma tende ad
avvicinarsi alla figura del martire quale testimone della verità; e la verità dello jus può essere
concretizzata in molti modi diversi dalla lex attraverso l’auctoritas del legislatore, ma in nessun modo la
lex può manipolare la verità dello jus.
Tuttavia l’auctoritas, quando smarrisce le proprie ragioni costitutive, diventa implacabilmente
ostile all’obiezione perché la percepisce come volta a relativizzarla e a richiamarla ai propri compiti
specifici; essa, infatti, è sempre soggetta alla tentazione di divenire mero esercizio di potere, di dettare la
verità invece di servirla (autopotenziamento e autoreferenzialità), tentazione irresistibile nell’epoca
moderna, tanto da indurre Ritter a parlare di “volto demoniaco del potere”.
Nei confronti dell’obiezione il potere può assumere diversi atteggiamenti: sordo e cieco, per
significare che nessuna obiezione può scalfirlo, benevolo, nel senso di clemente e non sanzionatorio,
repressivo, reprimendo la protesta dichiarando di agire in nome di quella stessa verità cui si richiama
l’obiettore; quest’ultimo atteggiamento, premoderno ma che sopravvive anche nel nostro tempo, è
pericoloso in quanto il potere, accettando il confronto, rischia di essere relativizzato qualora le ragioni
dell’obiettore si rivelassero le migliori.
Tuttavia, la via scelta dal potere nell’epoca moderna consiste nella c.d. neutralizzazione, cioè nella
riduzione assiologica delle pretese del politico; il potere neutralizzato presuppone che non si dia un unico
cosmo che racchiude la globalità della realtà, che le da ordine e cui fare riferimento quale fondamento
ultimo della giustizia, privata e pubblica; esso rescinde ogni nesso con qualsiasi valore che pretenda di
assurgere a principio per poter gestire, con rigore empirico, la realtà sociale sempre più complessa.
Diviene quindi un potere incontestabile perché, proprio per la sua neutralità, afferma di essere in
grado, nel proprio ambito, di assorbire qualunque pretesa e di assolvere qualunque compito (potere
propriamente sovrano); e tale proprio ambito diventa, per ciò stesso, globale perché ciò che sta oltre è
ritenuto di principio inconoscibile, indicibile e, quindi, irrilevante (per cui l’obiezione sembra destinata a
perdere ogni spazio).
Nell’epoca moderna il potere giunge alla sua piena neutralizzazione con l’affermarsi dello Stato
democratico che fa riferimento all’unico parametro del numero in quanto, in democrazia, la qualità delle
scelte è posposta ai criteri strettamente quantitativi che governano i sistemi elettorali; in questo contesto il
potere, da un lato, si è dilatato, facendo coincidere il corpo elettorale con l’intero corpo della società
civile, dall’altro si è deteologizzato, relegando al privato il principio di trascendenza: la laicità dello Stato
moderno, quindi, è diventato il segno ella sua pretesa neutralità, sovranità e democraticità.
Le dinamiche descritte sono state riassunte dal Rorty18 nell’unica felicissima formula della
“priorità della democrazia sulla filosofia”: la filosofia divide, genera conflitti, la democrazia unisce,
garantisce la pace; essa giunge a piena maturazione quando si riconosce fondata non su di una filosofia o
teoria politica, bensì sulla giustizia in senso procedurale, cioè su se stessa. Bisogna applicare alla stessa
filosofia il principio politico di tolleranza e regolamentare attraverso la giustizia procedurale i conflitti
delle ideologie filosofiche.
Lo Stato democratico, quindi, assume a sua base il principio di tolleranza: rispetta ogni
affermazione di verità ma non può accettare che siano rivendicate le ragioni che non ammettano di essere
sottoposte alla dialettica neutrale del gioco democratico, perché questo implicherebbe la negazione dello
18 Rorty = filosofo statunitense, vissuto fino al 2007.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
stesso principio di tolleranza; gli ordinamenti moderni, quindi, che, differenza dei regimi premoderni, non
possono assumere tra i presupposti del loro assetto istituzionale la coincidenza tra verità, diritto e morale,
non potranno che manifestare un atteggiamento di incomprensione nei confronti dell’obiezione,
riconoscendo alle sue pretese solo una rilevanza privata.
In sostanza, nella modernità, a ciascuno viene riconosciuto il diritto alla propria coscienza ma a
quest’ultima non è più riconosciuto il carattere di sapere comune in quanto non può essere verificata nel
contenuto, come afferma Luhmann; il potere, quindi, tende a svuotare di senso l’obiezione, più che a
contrastarla, anche approntando alternative legali (come il servizio civile): in tal modo gli obiettori sono
legalmente gratificati ma, contemporaneamente, la loro pretesa di verità è neutralizzata e rispettata solo
perché degradata a ideologia di un sottogruppo sociale.
Ciononostante, nell’epoca moderna l’obiezione non solo non scompare ma continua a manifestarsi
in una molteplicità di micro e macro fenomeni e la sua permanenza e diffusione attestano non solo che il
progetto neutralizzatore è insoddisfacente, ma soprattutto un radicale mutamento nella valutazione della
logica dello stesso potere: se prima se ne contestava il cattivo uso, adesso si contestano le scelte
normative perché rivelative dell’intollerabilità intrinseca del potere in sé e non in quanto effettivamente
deprecabili; il permanere dell’obiezione, quindi, rende manifesta la cattiva coscienza della modernità e
questa non riesce a fronteggiarla se non cercando di moltiplicare le alternative da porre a disposizione dei
singoli obiettori e opponendo, alla fine, alle esigenze delle coscienze quelle della pianificazione sociale 19.
Tuttavia, se l’obiezione smaschera la fallacia delle pretese neutralizzanti dell’epoca moderna, essa
stessa ne rimane inquinata dalla logica: l’obiettore, infatti, non si identifica più con colui che rivendica il
diritto contro la legge ma con colui che parla della coscienza come di un oracolo, affermandone la priorità
contro quella del diritto (c.d. disubbidienza civile); l’obiettore, altrimenti detto, vuole presentarsi come un
delinquente per convinzione che, da custode della verità (atemporale ed obiettiva), pretende di porsi come
il creatore di una verità futura (storica e soggettiva) che è egli stesso, con la sua azione, a plasmare.
Quindi forza contro forza anziché verità contro forza: l’obiezione moderna, o dissenso civile,
tende ad acquistare il carattere di una tecnica per innovare nei tempi brevi, al di fuori delle regole
parlamentari, gli assetti politici ed ordina mentali; l’obiezione, allora, da fenomeno etico-religioso,
diviene fenomeno politico, da appello alla verità diviene manifestazione di opinione.
- Luhmann: l’obiezione diventa “coscienza infelice” perché quanto più essa, nella prassi, ottiene ascolto
e riconoscimento da parte dell’ordinamento, tanto più questo ascolto e questo riconoscimento
equivalgono ad una oggettivizzazione delle sue esigenze, a una loro riconduzione a specifiche ed
impersonali dinamiche di ruolo: le alternative che il sistema giuridico predispone, cioè, sono finalizzate
non al progresso civile e sociale, bensì a dissolvere i conflitti di coscienza, cioè a far tacere le coscienze
(paradosso).
La crisi, o fallimento, dell’esperienza moderna travolge anche i principi della democrazia liberale
perchè, come afferma Rorty, il vocabolario individualistico del discorso politico che abbiamo ereditato
dall’illuminismo si è mostrato inadeguato a promuovere un sentimento comunitario.
L’auspicio per il mondo postmoderno è che si apra un autentico processo di laicizzazione del
politico, il quale torni a pensare il nesso costitutivo tra politica e verità, a riconquistare la consapevolezza
che tra il piano della politica (piano ontico) e quello della verità (piano ontologico) esiste si una
distinzione netta ma non necessariamente un’incomunicabilità; l’obiezione moderna, infatti, non è
propriamente laica proprio perché, essendo meramente prassistica, non riesce a differenziarsi relamente
da quello stesso potere che contesta.
L’obiezione post-moderna, quindi, dovrà spogliarsi da ogni compromissione con i potenti e con il
potere, dovrà ritornare ad essere, da prassi, testimonianza, ribadendo che la verità è un presupposto e non
una conseguenza dell’esercizio del potere; l’obiezione potrà essere davvero tale solo se meta ideologica,
solo, cioè, se risponderà non ad un’opzione politica diversa rispetto a quella privilegiata dal legislatore,
ma ad un richiamo alla verità.
19La pianificazione sociale si profila come la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse per
perseguire un obiettivo di cambiamento nel sistema sociale, al fine di risolvere un qualche problema e la
cui soluzione è considerata di rilevante importanza culturale.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
In questo modo acquisterà la dignità di vero atto politico perché avrà di mira il bene in sé, e quindi
anche quello della comunità, e non interessi contingenti; in sostanza, l’obiezione, più che etica dovrà farsi
dianoetica 20, cioè dovrà porsi come difesa della verità e non come rivendicazione di opzioni ideologiche.
Esemplificando questo punto cruciale, si fa riferimento al caso più bruciante e controverso degli
ultimi decenni, cioè la depenalizzazione dell’aborto volontario e l’obiezione di coscienza dei medici; la
scelta tra criminalizzazione e depenalizzazione dell’aborto mette in causa questioni giuridiche e non
etiche e diverse possono essere le vie giuridiche per impostarne la soluzione, ma una sola via rimane
preclusa al legislatore, cioè quella di gestire il problema sociale dell’aborto dando al fenomeno una
qualificazione ontologica e, conseguentemente, assiologica.
Il legislatore, depenalizzando l’aborto ha riconosciuto un primato ontologico della madre rispetto
al figlio, ma il punto è che non spetta al legislatore proclamare tale primato ed ecco perché un medico
potrebbe rifiutarsi di praticare aborti pur non rivendicando per se stesso il ruolo di obiettore di coscienza,
in quanto gli basterebbe sottolineare che l’uccisione di una vita non rientra nella prassi medica nella quale
ogni medico dovrebbe riconoscere la specificità della sua professione; il medico che fa obiezione contro
l’aborto difende il valore della vita ma, allo stesso tempo, egli difende qualcosa di ancora più importante,
cioè la verità.
20Dianoetica = virtù più elevata; secondo Aristotele sono dianoetiche la scienza, la saggezza, l’arte, la
sapienza e l’intelligenza
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XII: GIURIDISMO E ANTIGIURISDISMO: L’INSEGNAMENTO DI S. AGOSTINO
La rilevanza di Sant’Agostino per la filosofia del diritto sembra, a giudizio di molti, limitarsi alle
sue dottrine sul diritto naturale ma, in realtà, ciò che Agostino ha sentito come essenziale in ordine alla
questione del diritto, e che costituisce il suo reale contributo, non è stato tanto il problema del suo
fondamento, cioè del diritto naturale, quanto il problema della sua osservanza; in quest’ottica il problema
giuridico, quindi, da onto-sociologico diviene antropologico: non si discute sul fatto che un diritto ci sia
e che riscuota un’adesione da parte dei soggetti cui si indirizza, bensì sul fatto se il diritto trovi
rispondenza nell’essere dell’uomo, se questi, cioè, possa accettarlo ed osservarlo sinceramente.
In questa prospettiva il problema del diritto tende a ridursi al problema della legge in generale, della
stessa normatività nel suo dialettizzarsi con la volontà del soggetto; Agostino si chiede attraverso quale
itinerario la volontà del soggetto accetta di conformarsi alla legge ed è stato tra i primi ad evidenziare
l’insufficienza del diritto come regola di vita.
- Furto delle pere raccontato nelle Confessioni (400 d.c.): non fu il desiderio di conseguire un bene in
quanto tale la vera causa del furto, né l’ignoranza di cosa sia un furto o del fatto che esso è proibito;
conseguentemente, la legge in quanto tale non è capace di garantire che la volontà si volga al bene ed
anche la stessa volontà, seppur non soggetta a tentazioni, è incapace di conformarsi al dettato della
legge. E’ il gusto della colpa a spiegare l’azione.
Egli, però, raggiunse la piena consapevolezza della rilevanza del tema della normatività soltanto
attraverso il diretto confronto con Pelagio e le sue dottrine.
- PELAGIO: è generalmente considerato un naturalista; giudizio non erroneo se lo si considera in senso
teologico: egli è naturalista in quanto crede che il battesimo sani integralmente la natura umana,
ripristinando la piena facoltà di libero arbitrio di cui era dotata prima del peccato di Adamo; non può
essere invece considerato naturalista se con questo termine ci si riferisce alla fonte della moralità che,
per lui, non è la natura ma la volontà di Dio espressa nella legge che ha promulgato per gli uomini,
senza preoccuparsi di raccordare i precetti divini agli impulsi o alla ragione naturale dell’uomo.
L’uomo cui rivolge i suoi insegnamenti non è mai l’uomo “naturale” ma l’integrus christianus, colui che
conosce e mette in pratica la legge di Dio: chi si adegua a questa legge può elevarsi ad una perfezione
preclusa ai comuni mortali; il messaggio pelagiano è semplice ma terrificante nella sua semplicità:
poiché la perfezione è possibile all’uomo, essa è obbligatoria.
Pelagio rivive e reintrerpreta il messaggio agapico tipico del cristianesimo in termini propriamente
giuridici; le virtù caratterizzanti del cristiano diventano la scienza (che fa conoscere la legge di Dio), la
fede (che induce ad accettarla) e, soprattutto, l’ubbidienza (con cui si pratica quella stessa legge che
conosciamo ed accettiamo).
Quindi, l’unico oggetto di fede, l’unico criterio di vita, è la legge, mentre il criterio ultimo della
moralità pelagiana coincide con il criterio della giustizia e il criterio della giustizia con quello
dell’osservanza della legge di Dio, l’unica promulgata per tutti e che tutti, quale che sia la loro
condizione, devono osservare; si tratta di una morale senza dubbio teocentrica ma anche, e soprattutto,
nomocentrica, cioè basata sulla legge di Dio; non a caso il peccato è inteso da Pelagio come contemptus
Dei, e non come violazione di un ordine naturale, ed egli disdegna la distinzione tra comandi e consigli
evangelici, perché un Dio legislatore non può manifestare la sua volontà consigliando, ma solo
ordinando.
Conseguentemente, il “comunismo” pelagiano non ha alcuna valenza né politica, né agapica: non per
amore verso i più indigenti bisogna rinunciare alle ricchezze a loro favore, ma perché tale è l’esplicita
volontà di Dio.
Pelagio, dunque, non è un difensore della natura umana come intrensicamente buona, bensì un rigido
moralista secondo cui tutti i precetti assumono il medesimo valore intrinseco in quanto bisogna fare
riferimento non a ciò che viene comandato ma solo all’autorità di chi comanda; dalla natura non è
desumibile alcuna norma di condotta: l’unico criterio di vita è quello dato da Dio attraverso la sua legge
e proprio perché, a differenza di ogni altra natura, è destinatario della legge, l’uomo è libero.
Su questi presupposti si innestano le radici della polemica pelagiana; secondo Agostino il vero
problema non era quello di proclamare la sovranità della legge di Dio e suscitare ubbidienza nei suoi
confronti, quanto quello dell’intonazione giuridista di tutto il discorso di Pelagio, dove la dimensione
della legge non è coordinata con quella della carità: per Pelagio la libertà di ubbidire alla legge è implicita
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
nell’esistenza stessa della legge, per Agostino l’uomo solo se ha l’amore è libero e può, di conseguenza,
ubbidire alla legge; è questo il punto centrale della controversia: pur esistendo una legge divina ed una
legge di natura, ciò non è sufficiente a suscitare nell’animo di chi deve osservarla la capacità di farlo.
E’ l’esperienza a mostrare l’esistenza di questo stato paradossale della volontà; Agostino non
segue teorie astratte, per lui è l’esperienza che ogni uomo ha di sé a svelare che non dal buono o dal
cattivo uso della nostra volontà deriva l’osservanza o l’inosservanza della legge, bensì dalla nostra
volontà stessa, da come, di fatto, è conformata.
Altro punto di dissenso riguarda la natura e le sorgenti di un’azione creativa integralmente buona:
per Pelagio la legge è tale da autogarantire la propria osservanza, per Agostino la legge ha bisogno di un
qualcosa che costitutivamente non le appartiene, di un aiuto: la grazia.
Per Pelagio la grazia altro non è che la legge stessa attraverso cui Dio mostra e rivela cosa
dobbiamo fare; per Agostino, invece, la grazia è la stessa possibilità di fare, possibilità che non troviamo
in noi stessi ma che ci viene concessa da Dio: non è possibile, dopo aver conosciuto la legge, adempierla
in virtù della legge stessa, senza l’aiuto della grazia, cioè dell’amore di Dio in noi, così come non è
possibile accedere alla verità per chi non ama.
La grazia è un qualcosa di estraneo all’ordine naturale perché coincide con il creatore più che con
le creature: il Dio che ci ha creato è colui che ha creato la natura ed è lo stesso che elargisce la grazia.
Agostino ebbe un’altra durissima polemica con Giuliano Vescovo di Eclano, il cui oggetto
riguardava sempre la determinazione di come la volontà umana si rapporta alla legge e tutto il lessico
della polemica si incentra sulla tematica della giustizia che, per Agostino, non esisterebbe in quanto Dio,
tramite la grazia, sarebbe presente nell’uomo; in tal modo, infatti, il libero arbitrio sarebbe vano e
diventerebbe incomprensibile perché Dio ritenga l’uomo responsabile delle proprie azioni.
In realtà, per Agostino, la grazia non da particolari contenuti alla volontà (cioè ciò che vuole Dio);
se la grazia opera sulla volontà è per darle la capacità di volere liberamente, per darle quella libertà che
un essere creato, cioè finito, non può costitutivamente possedere: libertà e amore sono attributi non delle
creature ma del creatore; al tempo stesso, però, l’uomo che partecipa alla libertà ed all’amore non si sente
ricolmo di qualcosa di altro da lui, bensì si sente pienamente in possesso di sé, dato che proprio nella
libertà e nell’amore l’uomo possiede Dio.
Agostino, quindi, tematizza la libertà come un quid medium tra determinismo ed assoluta
indifferenza delle scelte, cerca di spiegare il mistero per cui la volontà, creata da Dio costitutivamente
buona e libera, è ancora, dopo il primo peccato, costitutivamente libera ma non più buona.
In conclusione, l’essenziale dell’atteggiamento agostiniano nei confronti della legge va colta in
una sorta di discentramento del giuridico che si accompagna all’analogo discentramento del politico; con
Agostino, per la prima volta, alla categoria del giuridico, della normatività, viene tolto il primato
nell’ambito della filosofia pratica.
Per Agostino muta, innanzitutto, la dimensione categoriale stessa della legge: il diritto e, più in
generale, la normatività richiedono sempre e comunque un di più di se stessi, un di più che è l’esatto
corrispettivo di quell’esigenza di continua integrazione che caratterizza l’essere uomo.
Egli, inoltre, giunge a modificare il concetto stesso di religione, evitando al cristianesimo di
cadere nelle spire del giuridismo, diversamente da quanto fatto da altre religioni come, ad esempio,
l’Islam.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XIII: LA TOLLERANZA DIFFICILE
Nelle società complesse e caratterizzate da un’irriducibile pluralismo assiologico, a fondamento
etnico, religioso e\o ideologico, solo il principio di tolleranza, unitamente al pluralismo, può garantire la
fluidità del vivere sociale e l’individuazione di adeguate soluzioni agli innumerevoli e complessi
problemi di coesistenza che inevitabilmente emergono; ma è fondamentale individuare il giusto modo di
intendere entrambi.
Del pluralismo dei valori esistono diverse accezioni, tra cui:
- Fattuale: quando il pluralismo viene rilevato come fenomeno dal carattere sociologico-quantitativo,
relativo alle pratiche sociali. La maggiore o minore rilevanza di tale pluralismo sarà riconnessa alla
attualità sociologica dei singoli contesti concreti; conseguentemente, un valore o una pratica sociale
empiricamente non rappresentati in un determinato contesto sociale non meritano alcuna attenzione
perché privi della loro unica consistenza, cioè quella fattuale.
- Di principio: da una parte sottolinea la necessità e l’imprescindibilità, per la pienezza dell’esperienza
umana, della molteplicità delle pratiche sociali e delle sottostanti dimensioni assiologiche; dall’altra
riconosce l’impossibilità di ricondurre tali pratiche ad univocità assiologica, linguistica e normativa, a
causa della strutturale relatività dell’esperienza umana. Esso, quindi, si colloca agli antipodi di ogni
fondamentalismo perché confuta la pretesa di codificare univocamente i valori; tuttavia esso sfugge
anche ad ogni relativismo perché non solo postula l’esistenza obiettiva dei valori, ma addirittura li
afferma come pienamente conoscibili, seppure secondo la logica dell’esperienza, del dialogo e della
testimonianza.
Per quanto riguarda il principio di tolleranza, esso denota innanzitutto una convinzione
pragmatica, secondo cui è opportuno che l’errore, sul piano teoretico, o il male, sul piano pratico, non
vadano mai combattuti ma sempre e solo sopportati per diversi ordini di motivi:
1. argomento latitudinario: l’intolleranza è quasi sempre concettualmente futile in quanto si accanisce su
differenze sostanzialmente inessenziali.
2. argomento di opportunità: l’intolleranza va respinta in quanto controproducente più per chi la pone in
essere che per i perseguitati, ai quali, invece, dona una nobile occasione per mettere alla prova
l’autenticità delle loro convinzioni, rinsaldandone l’attaccamento, mentre negli intolleranti attiva uno
spirito di persecuzione e violenza.
3. argomento libertario: invoca la tolleranza non solo verso visioni del mondo diverse dalla propria, ma
anche verso comportamenti sociali si ignobili ma la cui repressione sarebbe ingiustificata per ragioni
utilitaristiche (si pensi all’usura).
4. argomento di pedagogia sociale: la tolleranza va promossa perché costituisce l’unico strumento
attraverso cui la collettività può imparare ad esercitare la virtù dell’autocontrollo verso il naturale
impulso all’intolleranza.
5. argomento di indifferentismo morale: poiché per l’uomo non c’è alcuna autentica via di accesso alla
verità, la tolleranza è propugnata in quanto si ritiene che non esistono mali o errori così negativi da
essere combattuti.
6. argomento storicistico: la storia mostra quanto vani siano i tentativi di accelerare processi storici che
devono svolgersi con il proprio ritmo intrinseco; il giudizio ultimo sulle singole visioni del mondo,
che nascono e tramontano indipendentemente dalle buone intenzioni degli uomini, va lasciato alla
storia: anticipare simili giudizi attraverso la repressione di quelle visioni del mondo che possono
apparire aberranti è oltretutto in contraddizione con il fatto che la persecuzione, anziché stroncare
l’errore, tende a rafforzarlo, mentre la tolleranza costituisce il miglior modo di combatterlo in quanto
ne favorisce la consumazione interna.
Nonostante l’iperargomentazione, però, sia il pluralismo fattuale che il principio della tolleranza
pragmatica risultano deboli, contraddittori ed incompatibili, a differenza di quanto pretende il
multiculturalismo come ideologia, secondo cui tutte le identità sociali minoritarie devono essere
rappresentate equamente all’interno non solo della società civile, ma anche dello Stato, in termini di
visibilità, potere e cultura.
Il pluralismo fattuale, infatti, diviene materialmente intollerante verso le opinioni che di fatto non
sono socialmente rappresentate; il principio pragmatico di tolleranza, invece, entra in contraddizione con
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
se stesso quando due visioni del mondo, che dovrebbero essere equivalenti e meritare rispetto e tutela, si
rivelano reciprocamente contraddittorie ed incompatibili e vengono a fronteggiarsi.
Tale contraddizione non può essere superata né adottando un atteggiamento di assoluta neutralità,
che finirebbe col favorire la visione più violenta ed aggressiva, né sposando la causa della visione non
aggressiva per proteggerne l’esistenza, in quanto il tollerante non rispetterebbe davvero lo specifico della
visione aggressiva.
Non è quindi possibile pensare alla tolleranza come non limitata, e non solo fattualmente, ma
anche nel suo principio; bisogna allora percorrere risolutamente l’iter che porta dal pluralismo fattuale e
dalla tolleranza pragmatica al pluralismo ed alla tolleranza intesi come principi, con riferimento, cioè,
non alla loro contingenza empirica ma alla verità implicita nel loro concetto; in sostanza, la tesi che si
vuole sostenere è che la verità del pluralismo e della tolleranza coincide con quella delle singole visioni
del mondo elaborate dalle singole persone.
Presupposto di questa tematizzazione è che la verità ha in sé la forza di prevalere sul falso e la
fecondità di questa tematizzazione dipende dal raccordare il principio di tolleranza con la prospettiva
ermeneutica della verità; la filosofia del Novecento ha mostrato come la verità si offra all’uomo non nelle
forme astratte del pensiero logico-formale, ma sempre nelle modalità personali dell’interpretazione.
In tale contesto trova le proprie radici il tema della dignità della persona: le persone hanno una
loro dignità in quanto ognuna è portatrice di una visione del mondo e la verità del mondo non ha altro
modo di manifestarsi che incarnandosi nelle singole visioni delle singole persone; proprio perché
possiede una radice personale, ogni singola visione del mondo è di principio traducibile in ogni altra e
quindi compossibile con tutte le altre.
Questo nesso costitutivo tra il tema della verità e quello della persona resta la condizione
fondamentale di possibilità di ogni discorso sulla coesistenza.
Tra le critiche più decise a questo nesso va posta quella elaborata dal neopragmatista Rorty, il
quale, però, non riesce a coniugare questa critica all’interno di un orizzonte ermeneutico: infatti, il
mostrare i limiti del carattere realistico della conoscenza non implica che il mondo sia una nostra mera
costruzione culturale, così come insistere sul fatto che i fattori soggettivi sono essenziali nelle scienze non
implica alcuna svalutazione della scienza stessa.
Il tema della dignità non va inteso come un principio astratto, di tipo giusnaturalistico, da cui, una
volta elaboratane una formulazione, sarebbe possibile dedurre logisticamente un coerente sistema di
norme di condotta; il problema consiste nel nella pretesa di dare a tale principio una formulazione
esauriente e conclusiva, che possa essere sottratta ad ogni personalizzazione ermeneutica.
Pertanto, il modo specifico in cui il principio della dignità della persona può essere conosciuto,
come qualsiasi altro principio assiologico, è quello indiretto dell’analogia; di conseguenza, l’unico modo
in cui esso può essere adeguatamente formulato è quello della dialogicità ermeneutica, tra i cui
presupposti spiccano il portato di senso di cui ogni dialogante deve farsi carico e quello della pluralità dei
dialoganti stessi, che si aprono al confronto reciproco e che sono reciprocamente tolleranti, attenti cioè al
possibile incremento di esperienza che può emergere attraverso il dialogo.
Come l’ermeneutica non implica l’equipollenza di tutte le interpretazioni, così la tolleranza non
significa che tutte le opinioni vanno accolte e rispettate perché contemporaneamente vere e false; e così
ancora, il pluralismo non vuol dire che tutte le opinioni vanno rispettate nella loro materialità
quantitativa, bensì significa compiacersi della varietà di visioni del mondo, quale segno di ricchezza del
suo manifestarsi.
Tolleranza, allora, significa che tutte le opinioni vanno accolte e rispettate perché solo attraverso
la loro dialettica è possibile far emergere, in via indiretta, il principio della verità.
Premesso tutto questo, il diritto, più di qualunque altra, è una forma di sapere caratteristicamente
dialogica e, quindi, vive strutturalmente di questa sintesi di pluralismo e tolleranza; quindi è al diritto e ai
suoi principi strutturali che deve riferirsi chiunque voglia operare per la tolleranza.
Pensiamo al processo: esso è per sua natura plurale, non essendoci processo senza la pluralità
delle parti; e non c’è processo nemmeno senza la massima tolleranza, senza, cioè, la massima
disponibilità alla dialogicità: in sostanza, non c’è processo che non si radichi nel più pieno rispetto delle
persone protagoniste dello stesso.
Inoltre, se è vero che è l’interesse privato del singolo ad ottenere la tutela del giudice, non è vero
che è questo stesso interesse privato a giustificare l’intervento del giudice, bensì è il principio di giustizia
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
come principio ermeneutico che, nell’esperienza coesistenziale, si manifesta attraverso la particolarità dei
casi concreti; ecco perché la rivendicazione del proprio diritto particolare implica, come presupposto, che
si creda nell’esistenza di una verità del diritto stesso, cioè la giustizia.
Si tratta, quindi, di un criterio induttivo per individuare quali siano i principi e\o le pretese
particolaristici che possono legittimamente rivendicare tutela e\o promozione: tutti quelli che manifestano
un carattere ermeneutico, attraverso cui, cioè, possa emergere, indirettamente, la verità della situazione
umana.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XIV: IL DIRITTO E IL TEMPO
Che tra tempo e diritto esista un nesso costitutivo è intuizione immediata; d’altronde la croce teoretica
del giusnaturalismo è sempre stata quella di coniugare l’atemporalità dei principi con la radicale
contingenza dell’esperienza umana, l’assolutezza del diritto naturale con la variabilità delle sue
applicazioni storiche; meno immediata è, però, la determinazione di tale nesso; sono essenzialmente due,
in Occidente, i paradigmi a partire dai quali è stata pensata la relazione tra diritto e tempo:
1. Paradigma tradizionalistico: tutte le pratiche sociali, soprattutto quelle giuridiche, sono il prodotto non
di specifiche volontà, individuali o collettive, bensì emergono dal tempo stesso, costituiscono il
prodotto di un processo di selezione guidato più che dalla ragione dal successo; la verità del diritto
emerge, quindi, dalla tradizione, quale processo di trasmissione, che fa perno sulla memoria collettiva
dell’umano e ne garantisce l’identità. Per essere tale la tradizione deve possedere un forte e specifico
carattere normativo, deve cioè essere intesa come concreto ed attuale principio di azione, in grado di
rinnovarsi per il fatto stesso di trovare accettazione e ottemperanza negli individui; in questa
prospettiva la tradizione fa appello a quella ragione che vede nella persistenza selettiva del passato il
modo specifico ed ottimale di manifestazione dei valori del diritto (radicamento razionale).
2. Paradigma storicistico: la verità, in particolare quella del diritto, si rileva nella storia ma la
significatività della storia ha rilievo solo per il presente in quanto il passato non possiede alcun
carattere normativo per il presente; ribadisce quindi come essenziale il nesso tra diritto e tempo ma
comprende il tempo in modo strettamente sincronico, intendendolo nella ristrettissima accezione della
contemporaneità.
Nessuno dei due modelli, però, sembra cogliere esattamente lo specifico del rapporto diritto-
tempo in quanto entrambi assumono diritto e tempo come realtà separate, chiamate ad interagire senza
nulla perdere della loro separatezza: in sostanza, le entificano; se però diritto e tempo sono enti dotati di
propria autonoma specificità, ciò significa che per la verità dell’uno è sostanzialmente irrilevante la verità
dell’altro.
Qui si vuole invece sostenere che diritto e tempo si coappartengono, cioè che la determinazione
concettuale dell’uno implica la determinazione concettuale dell’altro e che l’esperienza dell’uno trova
nell’esperienza dell’altro la sua condizione di possibilità.
In questo il punto essenziale di riferimento è “Essere e Tempo” (1927) di Heidegger, secondo cui
l’essere non è dal tempo né nel tempo, non può, cioè, pensarsi né, come secondo il tradizionalismo, come
un prodotto della temporalità, né, come per lo storicismo, come condizionato da un rapporto di
accoglienza da parte del tempo: l’essere è tempo, cioè possiamo coglierlo solo attraverso la categoria
della temporalità; il tema della creaturalità, strettamente religioso, viene riformulato in una prospettiva
teoretica: l’uomo è una creatura, cioè non possiede in sé la ragione del suo essere, in quanto è chiamato
alla vita da Dio ed in quanto a Dio dovrà rendere conto della sua vita nel giorno della sua morte; l’uomo,
quindi, è un ente qualificato dalla contingenza, è un essere per la morte: poiché sa che di dover morire, la
temporalità acquista un rilievo primario, divenendo la forza che modella la sua identità, diversamente da
quanto accade per gli animali che, inconsapevoli di dover morire, non possono acquisire identità.
Questa cifra di caducità possiede valenze strettamente cognitive: noi ci apriamo al mondo in
quanto esseri finiti che del mondo possono percepire solo la finitudine, ovvero la temporalità come
successione di eventi irreversibili caratterizzati da un ordine che non dipende da noi; ogni nostro sforzo
di collocarci stabilmente nell’orizzonte dall’atemporale, cioè dell’essere, si traduce inevitabilmentein
un’entificazione dello stesso essere, cioè in mistificazione.
Il modo proprio di essere dell’uomo è, pertanto, quello dell’esserci, dello stare nel mondo sempre
all’interno di una situazione data e specifica (carattere situazionale dell’esistenza); ma in questo orizzonte
si determina anche la possibilità per l’uomo di trascenderne la mera onticità e di porsi la questione del
senso delle cose, e la temporalità diviene l’unico modo per cogliere, seppur allusivamente, la verità
dell’essere e, quindi, di noi stessi nella successione e nell’ordine degli enti.
Tra i momenti del tempo, allora, si instaura una distensione che solo nell’orizzonte del diritto
acquista un proprio senso: nel diritto, e tramite esso, riusciamo a conseguire la salvezza delle nostre
azioni (ad esso affidiamo la garanzia del persistere della nostra identità, delle promesse, degli impegni,
dei contratti e quindi del sussistere tra gli uomini di reciproca fiducia); tutte le dimensioni fondamentali
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
attraverso cui percepiamo l’essere dell’uomo sono, al contempo, nel tempo e nel diritto che, pertanto, si
implicano costitutivamente.
In questa prospettiva, secondo cui il rapporto tempo\diritto è essenziale per la comprensione
dell’essere dell’uomo, il lavoro ed il tempo libero appaiono omologhi e degni di pari attenzione e tutela;
in entrambi, infatti, entra in gioco la categoria dell’agire tipico umano, come agire serio, cioè non
necessitato e, quindi, disinteressato; il carattere serio del lavoro è più facilmente percepibile di quello del
tempo libero, mentre il carattere disinteressato del tempo libero è più facilmente percepibile di quello del
lavoro; in entrambi, però, l’uomo trova la misura del tempo attraverso l’estrinsecazione, l’oggettivazione
della propria azione.
Il diritto è chiamato a dettare le proprie regole che non sono quelle dell’azione in senso materiale,
considerata cioè nei suoi contenuti, bensì in senso strutturale, come possibilità stessa di acquistare
carattere specificatamente umano, cioè significante; solo attraverso questo tipo di azione l’uomo qualifica
la propria quotidianità: da qui l’obbligatorietà morale non solo del lavoro ma anche quella del buon uso
del tempo libero.
L’uomo ha il dovere di considerare il tempo libero con la stessa serietà con cui considera il tempo
che dedica al lavoro perché entrambi sono dotati di un’analoga significatività; nella prospettiva classica,
addirittura, l’otium possedeva un primato assiologico sul tempo dedicato al lavoro: è lo spazio
dell’incontro dell’uomo con se stesso, con la verità dell’essere, e in questo senso è il necessario
presupposto per godere il senso autentico della festa e per aprirsi ad un altro dovere fondamentale, quello
del culto.
La valorizzazione, tipicamente postclassica e cristiana, del lavoro, quindi, non deve implicare
affatto la svalutazione dell’otium: entrambi sono essenziali perché in entrambi si manifesta la verità
dell’uomo; il primato dell’etica del lavoro, tipica del nostro tempo, fa dimenticare cosa sia l’accidia:
peccato capitale contro il terzo comandamento che impone di santificare le feste; l’accidioso non è solo
colui che non agisce, bensì colui che perde le ragioni dell’agire, colui le cui azioni soffrono di
svuotamento di senso.
In questo contesto, allora, compito e responsabilità del giurista è quello di aiutare gli uomini a
proteggere il proprio tempo, rendendolo pieno di senso e indicando non cosa spetti loro fare, bensì come
sono chiamati a farlo se non vogliono che la loro azione decada nell’insignificanza.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XV: VERIDICITA’
Il tema della veridicità poggia su talune premesse di fondamentale importanza:
1. L’uomo non è creatore di verità ma creatura della verità, verso la quale deve avere un assoluto ed
incondizionato rispetto;
2. Il rispetto dell’uomo nei confronti della verità è inderogabile: in caso contrario ci si riconoscerebbe il
diritto di assumere verso il reale un atteggiamento potestativo che non compete all’uomo;
3. Il rispetto per la verità è premessa ontologica del rispetto che l’uomo deve nutrire per se stesso, cioè è
una condizione antropologica costitutiva; Dostoevskij scriveva che chi mente a se stesso e ascolta le
proprie menzogne arriva al punto di non poter più distinguere la verità né dentro di sé, né intorno a sé:
emerge il carattere dialettico della menzogna che presuppone una dualità empirica, quando si mente
agli altri, o una dualità trascendentale, quando il soggetto, mentendo a se stesso, si sdoppia;
4. L’esperienza umana è ontologicamente relazionale e deontologicamente paritaria, il che
necessariamente si traduce nel vincolo linguistico-comunicativo che rapporta l’uomo alla verità: per
l’uomo, infatti, la parola non è mero strumento per esternare il proprio pensiero interiore ma è veicolo
della comunicazione interpersonale e, quindi, dimensione costitutiva del proprio essere. Nella
comunicazione intersoggettiva, il dire implica sempre l’ascoltare dato che, in primo luogo, il parlare
è sempre un parlare a; il linguaggio, insomma, è un codice che necessita di una disponibilità attenta:
deve essere decodificato e ricodificato dall’ascoltatore nel proprio codice. E’ nella sintesi di questi tre
momenti (codificazione, decodificazione e ricodificazione), nella radicale apertura reciproca di chi
parla e di chi ascolta che consiste la comunicazione e che si formano i vincoli umani intersoggettivi.
Le immediate conseguenze di queste premesse sono:
1. è impossibile tematizzare la veracità come strettamente autoreferenziale; la falsità non può essere
compiutamente definita come caratterizzata dalla semplice volontà di dire ciò che non si pensa,
perché lo stesso dire, e quindi anche il falsiloquio, hanno un referente ben più articolato, che non è
riconducibile né alla mera intenzionalità di chi parla, né alla possibile ricezione di questa da parte di
chi ascolta, né alla situazione in cui sono calati i dialoganti, ma all’insieme obiettivo che coinvolge
chi parla, chi ascolta e ciò di cui si parla. In questa prospettiva non si può concordare con quanto
sostenuto da S. Agostino, secondo cui non c’è mendacio quando, tacendo, si occulta la verità; infatti
anche i diritti del segreto, che vanno tutelati, nascono in una situazione relazionalmente complessa e
non possono essere gestiti unilateralmente da chi, nella situazione, è parte accanto ad altri.
Conseguentemente, per esplicitare fino in fondo il nodo concettuale del mendacio, è necessaria una
terminologia che tuttora ci fa difetto.
2. bisogna liberarsi della cultura logocratica che riduce il logos unicamente al dire in quanto parola e che
presume, oggettivandolo, di avere un criterio rigoroso per qualificarne la veridicità; è necessario
recuperare il carattere mistico del linguaggio, come mezzo di comunicazione spirituale che pone in
relazione gli uomini non nella loro realtà di organismi biologici, ma nella loro realtà di menti e di
coscienze. Sotto questo profilo emerge un paradosso: il linguaggio, da un lato, non è mai
oggettivabile, dall’altro, la sua verità consiste proprio nella sua non totale oggettivabilità; il senso
comune non riesce a sciogliere questo paradosso ma è necessario mantenere la consapevolezza che
l’oggettivazione del logos, come parola, e l’assoluta marginalizzazione delle sue valenze mistiche
implicano un impoverimento della percezione della realtà. Anche la c.d. svolta linguistica in filosofia
insegna che il significato delle proposizioni, e quindi la loro veridicità, non può essere colto in se
stesso ma solo rispetto ad un background di premesse e prassi che non fanno parte del significato
stesso21.
Spostando l’attenzione sull’esperienza giuridica, questa possiede un carattere analogo a quello
relazionale dell’esperienza etica in generale; il dire non ha mai la mera valenza personale di
esplicitazione delle proprie cognizioni o intenzioni interiori: esso ha un valore costitutivo di situazioni
giuridico- relazionali, dotato di rilievo istituzionale all’interno dell’ordinamento giuridico.
Perché un discorso abbia valenza giuridica, non solo bisogna che al loquente sia riconosciuta una
specifica capacità, ma che analoga capacità sia riconosciuta all’interlocutore e che la locuzione stessa
21Assumendo fino in fondo questa prospettiva si possono evitare le questioni casistiche accumulatesi
negli anni, come quella di Jankelevitch (1970) che distingue tra: veracitas purissima, sinceritas diabolica,
pium mendacium, bona malafides, mala bonafides, ecc…(vedi pag 185 del testo).
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
avvenga all’interno di una situazione qualificabile istituzionalmente e a partire da referenti semantici
condivisi; ove una di queste dimensioni fosse alterata o mancasse, il discorso acquisterebbe il connotato
di irrilevanza o una valenza antigiuridica.
Il diritto, in sostanza, va inteso come un agire comunicativo che usa il linguaggio come un
medium, al quale è immanente il fine ultimo dell’intesa; ma in che modo l’insieme che coinvolge chi
parla, chi ascolta e ciò di cui si parla, si costituisce come esperienza giuridicamente rilevante?
Innanzitutto non può darsi diritto all’infuori di un’esperienza che implichi la fondamentale parità
relazionale dei soggetti coinvolti; e la parità si fonda ontologicamente: il diritto è una relazione tra pari,
all’interno di una situazione esistenziale che distingue sì le persone per identità ed interessi, e che
giustifica, quindi, il loro relazionarsi, ma che le omologa nella loro soggettività di esseri umani, dotati di
pari dignità e di pari capacità di comprensione reciproca; ecco come il comune uso del linguaggio, che è
struttura costitutiva della soggettività, sia il veicolo ordinario della relazione giuridica.
Quindi, la situazione concreta all’interno della quale le persone si incontrano ed agiscono acquista
la valenza di criterio obiettivo di giustizia (chiunque venisse a trovarsi in quella stessa situazione concreta
dovrebbe comportarsi in modo analogo) ed altrettanto obiettivo va considerato il modo in cui dovrebbe
essere nominata linguisticamente la situazione giuridico-relazionale (nel rapporto giuridico è
imprescindibile il nesso tra il sorgere dell’obbligo e il prodursi di situazioni tipiche che, attraverso il
linguaggio, acquistano una loro obiettiva qualificabilità).
Pertanto, la veridicità, nel diritto, non fa esclusivo riferimento alle cognizioni interiori e personali
dei loquenti, ma alla loro cognizione della situazione relazionale all’interno della quale si colloca l’azione
rilevante giuridicamente, in quella che è la valenza istituzionale che ad essa viene riconosciuta
dall’ordinamento; conseguentemente, per il diritto la misura della veridicità non può essere la mera
soggettività del loquente ma la veridicità, il dire la verità, è ermeneutica e relazionale e gode di tutta
l’obiettività della relazionalità ermeneutica.
Una relazione interpersonale ingiusta, cioè antigiuridica, implica sempre l’alterazione della verità
del diritto; in altre parole, il parlare è sempre qualificato dall’ascoltare così come l’ascoltare è sempre
qualificato dal parlare ed entrambi sono qualificati dalla realtà esistenziale e personale dei loquenti come
soggetti di diritto.
Pertanto, anche nel diritto, come nella morale, vige la norma “è sempre vietato dire il falso” che,
per il giurista, delegittima la pretesa, da parte di chi mente, di porsi al di fuori o al di sopra del diritto e
della parità relazionale che esso implica.
In termini positivi, la norma “è sempre vietato dire il falso” può essere riformulata in diversi modi,
fino a farla coincidere col principio giuridico fondamentale della buona fede (inteso come il relazionarsi
affinchè l’incontro sia per entrambe le parti giuridicamente significativo); se fosse possibile immaginare
una deroga a questa norma, ciò equivarrebbe alla possibilità di immaginare una legittimazione
dell’ingiustizia, cioè un’impossibilità.
- Kant: nel criticare Costant22, secondo cui dire la verità è un dovere verso chi ha un diritto alla verità, ma
nessuno ha un diritto alla verità che danneggi altri, sostiene che non può esistere un diritto di mentire
perché la menzogna avvelena la fonte stessa del diritto, indipendentemente dal fatto che essa possa
arrecare un utile non a chi la proferisce ma a chi è diretta (egli arriva fino al paradosso secondo cui
anche all’assassino che cerchi la sua vittima si dovrà dire, se interrogati, dove ella si trova). Il punto su
cui insiste Kant è deontologico, non teleologico: la menzogna, erodendo la fede nell’onestà dell’altro,
va condannata non perché dannosa per la coesistenza, bensì perché la rende di principio impensabile;
inoltre, il suo argomento è strettamente giuridico: ciò che viene in questione non è tanto la condanna
etica della menzogna, che Kant da per presupposta, quanto la possibilità di considerare giuridicamente
giustificato il mentire, almeno quando si abbia la certezza che dire la verità all’interlocutore favorisca
un male morale. La soluzione assolutamente negativa che egli da a questa questione è sempre apparsa
insoddisfacente e provocatoria.
Molti sono stati i tentativi tesi ad eliminare questo carattere paradossale dalla teoria kantiana; tra
questi quello di Cotta che riassorbe il dovere di dire la verità nella prospettiva della moralità, il cui
criterio è la socialità (la risposta alla questione sulla liceità o meno del mentire, allora, può arrivare solo
spostando il piano del discorso da quello del linguaggio a quello della coesistenza); i critici di Kant, più
spesso, utilizzano lo stesso argomento della teoria di Constant quando affermano che la verità va detta
22 1767 – 1830.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
soltanto a colui che ha un diritto alla verità, ma è molto difficile costruire una dogmatica del diritto alla
verità come diritto relativo.
In realtà, la soluzione al problema va ricercata in altra direzione: è verissimo che le veridicità
nelle asserzioni è dovere formale dell’uomo verso tutti, ma è altrettanto vero che la categoria giuridica
della veracità è relazionale e lo dimostra il fatto che il soggetto, destinatario di una domanda, per dare una
risposta giusta deve percepire con esattezza il senso della domanda unitamente al contesto e l’identità di
colui che la pone; in sostanza è dalla situazione dialogica stessa che emerge il portato di verità che entra
in questione nel dialogo (il medico che nasconde al malato la verità del suo stato non mente se ciò che
egli può dirgli ha un’obiettiva valenza terapeutica: la verità del rapporto terapeutico consiste nella verità
della terapia e non nella mera esattezza diagnostica o prognostica delle locuzioni).
Conseguentemente, la menzogna, giuridicamente, è definibile solo in termini strettamente
razionali e ha rilievo solo quando la discrasia tra linguaggio esterno e coscienza interna assume la forma
relazionale dell’inganno, che sostituisce al fondamentale atteggiamento giuridico dell’essere-per
l’atteggiamento antigiuridico dell’essere-contro e che si attua attraverso la captazione della buona fede
altrui, dando forma all’ingiustizia.
Quanto sopra aiuta a far comprendere alcune peculiarità del diritto processuale con riferimento
alla mancanza di uno specifico e formale obbligo di veridicità alle parti: il processo civile si fonda sul
principio dispositivo in base al quale le affermazioni concordi delle parti non possono essere sindacate dal
giudice il quale devono essere da lui recepite come verità, cioè sono il presupposto del suo agire (diritto
processuale delle parti di dar vita ad una verità giuridica concordemente costituita dalle loro
dichiarazioni); il processo penale, invece, è retto dal principio inquisitorio, finalizzato ad accertare la
verità dei fatti per come essi si sono effettivamente svolti e non per come le parti vogliono presentarli al
giudice; tuttavia esiste un diritto riconosciuto all’imputato di mentire: ciò non è segno di indifferenza del
diritto verso la verità, ma piuttosto indizio del fatto che l’imputato non è soggetto, bensì oggetto del
processo e che, di conseguenza, non trovandosi in una situazione propriamente dialogica, in quanto il
processo è da lui subito, qualunque cosa egli dica non va misurata col metro della verità.
Da un punto di vista teologico, mentire è tradire una fiducia riposta in noi da colui che ci ha
creato; è negazione della dimensione teologica della verità, e non della mera dimensione antropologica
della sincerità, ed è per questo che la menzogna diviene non solo ingiustizia ma, soprattutto, peccato; e
l’uomo è mentitore; per lui la menzogna non è una possibilità accidentale ma è un tratto costitutivo.
Ciononostante, per quanto il torto e l’ingiustizia appaiono costantemente prevalenti
nell’esperienza storica, anche l’esigenza di riconoscere alla giustizia un assoluto primato, seppur ideale,
resta ineludibile perché è su questo ideale, e non sulla fattualità del torto, che si regge la possibilità stessa
per gli uomini di coesistere; ma il diritto non può auto fondarsi, è una realtà umana che ha bisogno di un
fondamento più che umano, di un fondamento assoluto: è così che l’antropologia viene ad incrociarsi
ineluttabilmente con la teologia.
Questo ci aiuta a comprendere il fenomeno, presente in quasi tutte le culture, della costante
presenza di formule religiose nel linguaggio giuridico dei processi, cioè l’invocazione del nome di Dio
come suprema garanzia di veridicità ed affidamento reciproco dei soggetti in reciproco rapporto.
In realtà, nelle società secolarizzate si assiste ad un inesorabile processo di erosione di tale
riferimento ma ciò ha lasciato un grande vuoto che gli uomini hanno cercato faticosamente di riempire
con il nome di totalità sempre diverse (Re, natura, nazione, stato, popolo, ecc….); e il fallimento di tutti
questi surrogati espone i sistemi giuridici contemporanei al rischio incalcolabile del fondamentalismo
giuridico, disprezzato e temuto nonostante il problema che esso pone, cioè il fondamento assoluto del
sistema giuridico, sia autentico ed irrinunciabile.
L’errore del fondamentalismo non è quello di voler dare un fondamento teologico, ma è duplice:
filosofico perché resta all’interno della logica logocratica; teologico perché sostituisce alla fedeltà a Dio
la fedeltà alle sue parole, dimenticando che la verità di Dio è verità dello spirito e che nessuna lettera
potrà mai contenerla adeguatamente.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XVI: VERITA’ E RESPONSABILITA’
La riflessione sul nesso esistente tra verità e responsabilità può partire da una citazione che
Sant’Agostino fa nel libro decimo delle Confessioni, in cui egli si rivolge alla verità, quindi a Dio; un Dio
che concede di parlargli è un Emanuele, un Dio-con-noi, pertanto il discorso da filosofico diviene
teologico, ma deve intendersi come discorso rivolto alla nostra intelligenza, non alla nostra fede: è infatti
possibile porre correttamente il problema della responsabilità se non si presuppone il carattere personale
della verità che è oggetto della responsabilità stessa o che dalla stessa verità è istituita? Se la
responsabilità crea problema non è forse perché alla sua radice si colloca un’ineludibile questione
teologica?
Claudio Ciancio insiste sull’idea che la verità sia nello stesso tempo potente e fragile a causa della
dialettica che esiste tra l’ontico e l’ontologico; dire la verità è dire il senso degli enti che non è separabile
dall’essere che li costituisce, in quanto nel separare essere e senso vi è una degradazione dell’essere;
conseguentemente, dire soltanto la verità ontica è mentire.
Sembra quindi che, almeno in negativo, una via per la verità esista e consiste nel diffidare di ciò
che è soltanto ontico; eppure l’uomo non appartiene all’ordine dell’essere, bensì a quello degli enti, per
cui ha nella sua disponibilità soltanto la verità ontica.
L’uomo è certamente in grado di pensare e di parlare di una verità anche ontologica ma non è in
grado di viverla; inoltre, percepire l’ontologico nell’ontico è una pretesa che, in una prospettiva ebraico-
cristiana, non può che essere denunciata in quanto rischiosa: l’ontico, infatti, non è altro che il creaturale,
per cui non ha alcun senso intrinseco in quanto il senso è tutto del Creatore e nel Creatore.
Perché il discorso sul senso possa avere un netto profilo ontologico, possa cioè avere un senso,
bisogna ammettere fino in fondo il principio di creazione (non solo parlare metafisicamente di Dio ma
parlare teologicamente a Dio); e ciò è dimostrato dal fatto che nella storia degli uomini, quando questa
possibilità non si è presentata (periodo precristiano) o è stata rifiutata (orizzonte scientistico moderno), il
desiderio e l’esigenza di dare un senso intrinseco all’ontico (e quindi falso) non è venuto meno: gli
uomini, nel tentativo di costruirsi un senso, non hanno fatto altro che costruirsi idoli.
E’ un fenomeno che facciamo fatica a percepire fino in fondo perché viviamo in un orizzonte
cristiano in cui la dimensione ontologica è garantita e protetta da un paradigma creazionistico, un
implicito apriori teologico, ormai cristallizzato e teoreticamente ancora operante; in un orizzonte non
creazionistico, invece, è il divino a costituire la chiave di accesso alla comprensione del reale.
Non è un caso che la rinnovata attenzione odierna verso il simbolo ed il mito rappresenti una
nostalgia verso il paganesimo, verso cioè un orizzonte che rigetta il principio di creazione e che, quando
concepisce l’idea dell’universo, non lo vede orientato personalisticamente, perché creato da Dio, ma
panteisticamente, cioè “naturalisticamente”.
Il creazionismo ci impone di prendere sul serio che l’onticità ha una sua verità semplice,
assolutamente non simbolica; che l’onticità è si povera di senso ma che questa povertà trova un suo
riscatto e la sua garanzia nel fatto che l’ontico corrisponde al progetto creatore di Dio e che
sperimentando l’ontico in quanto ontico l’uomo accetta la volontà di Dio: le cose, insomma, vanno
rispettate e percepite nel loro ordine che, per quanto possa apparire povero di senso, è quello in cui
comunque siamo chiamati a vivere la nostra esperienza temporale.
Conseguentemente non è possibile parlare di responsabilità in un universo increato e, quindi, non
solo non personale ma privo di ogni impronta proveniente da un creatore; non a caso i greci, come non
sono mai giunti a pensare il principio di creazione, così non hanno mai elaborato un’autentica metafisica
della responsabilità riuscendo, al più, a tematizzare l’imputazione, ad attribuire cioè un’azione ad un
agente come alla sua causa; del resto responsabilità è un termine entrato nel lessico occidentale on prima
della fine del Settecento.
Non è l’essere ma Dio che rende responsabile l’uomo provocandolo, chiamandolo, cioè, davanti a
sé: l’uomo si scopre responsabile solo quando viene interpellato, quando gli viene rivolta una domanda
ineludibile da parte di chi ha l’autorità per porla; ma se l’autorità ha questo potere ciò non dipende da una
ragione mitica o simbolica, per un senso cioè ad essa intrinseco, bensì perché in essa si rende operante
l’intenzione creatrice di Dio, per una ragione strettamente ontica.
In un mondo creato e voluto da Dio siamo responsabili solo verso l’ontico, cioè la “legge
naturale”, e la responsabilità è scelta per il bene, cioè per Dio.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Illuminante, al riguardo, è la riflessione sulla legalizzazione dell’aborto; se si imposta il problema
riflettendo sulla sua dimensione ontica, non si può non percepirlo come semplice: il feto è vita umana
individuale, fin dalla sua prima fase di sviluppo.
Dire di no all’aborto non è solo ubbidire alla volontà di Dio ma, prima ancora, prendere sul serio
la nostra onticità di individui che sono già se stessi nel grembo; coloro che ritengono lecito legalizzare
l’aborto, perché sostengono che si debba negare al feto la qualità di persona, fanno un discorso ontologico
e non ontico: sono cioè in errore non solo perché proiettano sul dato ontico una valutazione ontologica,
ma perché rifiutano di prendere sul serio l’ontico.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XVII: IL DIRITTO COME PROBLEMA TEOLOGICO
Quando si affrontano tematiche complesse come quella del rapporto tra diritto e teologia, il diritto
va inteso e descritto come un’esperienza umana relazionale, volta al reciproco riconoscimento
intersoggettivo, un’esperienza umana naturale, perché è uno dei modi di strutturarsi dell’humanum, e di
carattere universale, nel suo dinamismo diffusivo, e societario, nel suo principio e nella sua struttura
costitutiva; la norma, invece, e quindi il diritto positivo, non è altro che la determinazione storico-
contingente del principio categoriale della giuridicità.
Premesso questo, lo studio della rilevanza teologica del diritto costituisce il problema della
teologia del diritto, teologia che, però, parte da una prospettiva non teologica ma filosofica: spetta infatti
alla filosofia definire le cosiddette posizioni pure in tutti gli ambiti del sapere; teologia del diritto può
significare qualcosa soltanto se la teologia si mantiene pura, cioè se prende sul serio se stessa; in
particolare, la teologia deve assumere e mantenere fino in fondo il proprio irrinunciabile carattere
ecclesiale23.
In sostanza, difendere la purezza della teologia del diritto comporta prendere sul serio il riflettere
sull’impronta specificamente cristiana ed ecclesiale che si può rinvenire nel diritto, inteso, appunto, come
esperienza giuridica; e la necessità di operare una distinzione tra i problemi della normatività morale e
quelli concernenti la struttura intersoggettiva societaria dell’esistenza è stata resa urgente dalla negativa
esperienza dello statualismo ottocentesco e dalle provocazioni del normativismo.
Chiamata a riflettere sul diritto, la teologia del nostro secolo si è indirizzata lungo due vie: quella
protestante e quella cattolica; in entrambe il diritto in senso categoriale è riconosciuto come necessario,
ma secondo logiche ben diverse.
Protestantesimo:
• non condanna la natura in quanto tale, né le scienze che assumono la natura e l’uomo a proprio
oggetto: la natura è pur sempre figlia di Dio; quello che in realtà è corrotto, a causa del
peccato, è il nostro rapporto con Dio;
• condanna il diritto quando con esso si intende la legge morale naturale quale strumento di
salvezza; in questo caso il protestantesimo è assolutamente antigiusnaturalista, il che, però,
non si traduce più in antigiuridismo: se infatti al diritto si danno, per contenuto, i precetti di
Dio è possibile costruire un diritto che sia veicolo di grazia;
• il diritto della grazia è l’unico ad avere rilevanza teologica;
• quel che rileva per la teologia è un diritto che può essere compreso e colto solo nella
dimensione liturgica e confessionale e, di conseguenza, nell’ambito della comunità ecclesiale,
la quale si raccoglie e si identifica unicamente nel nome di Gesù e non a partire dalla generale
esigenza societaria che è propria dell’uomo (sublimazione cristocratica dell’esperienza
giuridica).
Cattolicesimo:
• riconosce il diritto mediante la sua legittimazione naturalistica e laicale;
• ha legittimato su di una base teologica la filosofia cristiana del diritto
• il tradizionale giuridismo della Chiesa cattolica viene a perdere di incisività teologica,
affidandosi alla riflessione umana naturale.
Ad oggi sembra pacifico che, anche se la teologia protestante ha ormai rinunciato ad ogni
antigiuridismo, sul piano storico-sociale ad essa appaiono preclusi spazi che la teologia cattolica sembra
invece avere a sua salda disposizione; è il caso, ad esempio, dei diritti umani; per i protestanti, infatti, la
difesa dei diritti umani è irrilevante ai fini della salvezza, mentre per i cattolici la difesa dei diritti umani
è difesa della stessa dignità dell’uomo, creatura di Dio, difesa che possiede un’obiettiva valenza trans-
culturale.
Tuttavia, oggi, la teologia cattolica del diritto corre il rischio, nel dare ascolto al mondo, di
smarrire la specificità del proprio oggetto: temendo il modello di una morale teologica costruita come una
tavola di precetti si ortodossi ma incapaci di suscitare un’adeguata orto prassi, molti teologi moralisti
hanno costruito un’etica della pura ispirazione; in sostanza non esistono più norme morali specificamente
cristiane, ma esiste solo un’ispirazione cristiana dell’agire etico.
23 Concernente la Chiesa nel suo aspetto di comunità preminentemente spirituale.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Analogamente, non esiste un diritto specificamente cristiano: ai cristiani spetta agire
giuridicamente confortati dalla loro fede nella giustizia trascendente di Dio; e questa dottrina si rivela
rischiosa in quanto fa della teologia un discorso non di annuncio esterno ma di rammemorazione interna,
per cui rinuncia, di principio, ad entrare nella sfera della conoscenza storica e filosofica.
Si dice che bisogna tradurre gli argomenti di fede in altrettanti argomenti di ragione: ma quale
ragione?
La ragione su cui si fonda la teologia, o cui fa appello, è situata in un ambito non neutrale, né
neutralizzabile, un ambito che di principio è aperto all’accoglienza di significati che la ragione stessa è
incapace in quanto tale di produrre; in questo è da cogliere lo specifico del principio cattolico che non
reputa l’ambito delle cose profane come irrilevante per la logica della salvezza per un duplice motivo:
perché sa che la stessa autentica comprensione delle cose profane implica un’apertura alla fede e perché
sa, nello stesso tempo, che solo un’apertura alla fede, almeno implicita, rende possibile un’autentica
comprensione delle cose profane.
Non si tratta ovviamente di sacralizzare i valori profani o di assolutizzarli come valori teologici,
bensì di comprendere i valori profani grazie alle sollecitazioni intellettuali della teologia e di agire di
conseguenza su di essi, donando loro una nuova vitalità e una nuova forza di autoaffermazione.
La battaglia che la cultura cattolica combatte da anni su alcuni fronti, come quello del divorzio,
dell’aborto, della difesa della democrazia o della condanna del razzismo, è emblematica: questi sono
infatti tutti ambiti che ben possono essere difesi ed argomentati razionalmente, ma che una ragione
illuministicamente neutrale non riesce con le proprie forze a sindacare; essa ha bisogno di essere attivata
da una forza che essa come mera ragione, non possiede e che solo la teologia è in grado di darle.
Quindi la teologia, quando resta fedele alla propria ispirazione originaria, opera non alterando le
categorie dell’esperienza naturale ma imponendone una lettura diversa: in tal modo essa è in grado di
cambiare efficacemente il mondo, pur rispettandone l’identità; e poiché si tratta di una lettura non
esauribile, data l’inesauribilità di principio del proprio oggetto, essa si ripropone in ogni nuovo contesto
culturale come sempre nuova sollecitazione ermeneutica, come sempre nuova tensione in ogni ambito
conoscitivo ad un rinnovamento interno delle categorie epistemiche.
Consideriamo, a titolo esemplificativo, il tema dei diritti umani che costituisce, da una parte, un
elemento irrinunciabile nella nostra cultura giuridica e, dall’altra, corrisponde ad un’istanza risolutamente
teologica: i diritti umani corrispondono nel concetto alla verità del messaggio biblico-evangelico,
secondo cui ogni uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, ognuno è suo figlio; ebbene, l’affermarsi
di questo tema ha portato a compimento l’inserzione, nell’esperienza giuridica, di un radicale principio di
simmetria, già affermato da Socrate ma radicatosi nelle coscienze grazie all’annuncio cristiano, secondo
cui i diritti umani vanno riconosciuti anche a chi li nega, che la dignità è un carattere che non acquista, né
si perde perché è connaturato all’uomo.
Concludendo, possiamo affermare che il diritto è e rimane realtà strettamente laica; proprio per
questo la teologia diviene teologia del diritto non perché dia al diritto contenuti positivi o perché metta a
disposizione del giurista categorie teologico-dogmatiche, bensì perché introduce nel circolo ermeneutico
una parola nuova che né la ragione, né la coscienza, in quanto tali, cioè non neutrali né univoche, sono in
grado di formulare.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XVIII: UN FONDAMENTO TEOLOGICO PER IL DIRITTO?
C’è un modo non autentico di elaborare un discorso teologico sul diritto che sottrae alla teologia la
sua specificità, cioè di essere il tentativo di proferire una parola umana che sappia far tesoro e assumere
come presupposto un ascolto della parola divina, riducendola invece a mera filosofia della religione,
incapace di percepire che l’analogia ontica tra parola di Dio e linguaggio umano presuppone
un’irriducibile differenza ontologica; tale modo è quello che assume come oggetto della teologia l’idea di
Dio, anziché la sua parola, e come oggetto della teologia del diritto la legge, intesa come univoca volontà
di Dio, anziché la sua promessa.
Una teologia così concepita, anche quando non incappa nella trappola del fondamentalismo, che
assume come normativamente vincolante non la parola di Dio ma la parola umana che della parola divina
tenta di essere riproduzione e oggettivazione, resta invischiata in un compito che non è suo e che non le
compete, cioè l’assumere il ruolo di superiore ed ultima istanza di controllo di ogni dimensione del
pensiero e della prassi; e ciò spiega anche l’emarginazione, tutta moderna, della teologia rispetto alle altre
forme di sapere, processo che costituisce un impoverimento epistemologico, e non anche assiologico od
esistenziale, gravissimo per ogni altra forma del sapere in quanto solo l’interconnessione dei saperi
garantisce a ciascuno di essi la possibilità di verificare le proprie pretese di legittimità.
In questo orizzonte la teologia conserva una precisa funzione epistemologica: offrire alle altre
forme di sapere una specifica modalità di ampliamento del loro intrinseco comprendere; il che implica
riconoscere che la curvatura che la teologia può offrire agli altri saperi, oltre ad aumentarne la
significatività, ne fornisce un’integrazione di senso che essi non potrebbero autonomamente elaborare.
Per ottenere questo risultato, ovviamente, non basta giustapporre il discorso teologico a qualsiasi
altra forma di discorso, ma bisogna elaborare delle strategie di ricombinazione, evitando il rischio di
perdere il giusto sentiero; spesso, infatti, il discorso teologico sul diritto positivo viene trasformato in un
discorso sul diritto naturale, cui segue la tentazione di demandare alla teoria del diritto naturale oneri
epistemologici che essa non può assumersi e che spettano alla teologia in quanto tale, il cui compito non
è quello di rendere pensabile il diritto naturale, di fornire un puntello alle sue buone ragioni, ma di offrire
al diritto naturale, e così anche al diritto positivo, un orizzonte di senso.
Un orizzonte di senso emerge in virtù di una serie di indicazioni che riguardano il diritto non in
quanto tale ma quello che ci investe e ci coinvolge, quello che ci provoca e che porta sulla nostra bocca le
parole giustizia/ingiustizia.
La ragione illuministica non è mai riuscita a togliere significanza al discorso profetico,
all’annuncio della costante ulteriorità della giustizia e quello che viene in discussione in questo contesto
è l’assunzione della consapevolezza che solo un discorso profetico crea un debito di senso, il quale
costituisce la dimensione archetipa della categoria dell’obbligatorietà (non può esistere obbligo ove io
non mi senta obbligato).
La funzione profetica introduce la temporalità nel diritto, ne attiva le dinamiche intrinseche, gli
fornisce un orientamento, gli dona un linguaggio e, nelle sue forme storiche, può assumere configurazioni
progressive o regressive, ma ha sempre rappresentato la forza costitutiva della coscienza giuridica ed ha
potuto farlo perché nel profetismo fede e giustizia si legano indissolubilmente: se è la fede a rendere
credibile la possibilità dell’avvento della giustizia, è l’annuncio della giustizia a rendere la fede
meritevole di essere creduta.
Il diritto possiede, quindi, in quello che abbiamo chiamato discorso profetico, un apriori che è
necessario tematizzare per giustificare l’obbligatorietà delle norme, obbligatorietà che non significa solo
coazione ad ottemperare, requisito necessario ma non sufficiente del diritto positivo, ma, soprattutto,
coscienza del carattere ineludibile del dovere giuridico, perché fondato sul diritto altrui.
- Kant: è nostro dovere tenere in considerazione i diritti altrui e rispettarli come sacri; chi ci governa è
santo e ciò che ci ha dato di santo è il diritto.
E’ solo attraverso la teologia che questo tema, vero e proprio apriori del diritto, può sollevarsi
dallo statuto di mera intuizione ed incarnarsi nel discorso della scienza del diritto, acquistando così un
pieno rilievo epistemologico; il prezzo dell’elusione della riflessione teologica, per la scienza del diritto,
consiste nella formalizzazione e, quindi, nella deformazione sistematica dei concetti giuridici
fondamentali: da esperienza il diritto si riduce a sistema, la responsabilità ad imputazione, l’autorità a
potere, l’amministrazione della giustizia ad esecuzione di una procedura, il matrimonio a contratto, la
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
persona a mero soggetto di diritto e, esito ancor più grave, la giustizia viene espunta dall’orizzonte di
interesse del giurista e confinata nel novero dei concetti di esclusiva rilevanza etica o politica.
Come sostiene Arkoun24, dipende dal concetto teologico di Libro, nel senso forte del termine come
libro sacro, il determinarsi e l’imporsi nella cultura occidentale del concetto storico, culturale,
antropologico ed operativo, e quindi debole, di libro, concetto che costituisce la necessaria condizione di
possibilità della elaborazione di tutti i codici che regolamentano e danno dinamicità alla struttura sociale;
ed è stato quindi grazie alle religioni del libro che la ragione orale è stata soppiantata da quel diverso tipo
di ragione che è quella della parola scritta ed è qui che diviene indispensabile la mediazione della
teologia: solo essa può infatti mostrare che la funzione del Libro (Bibbia, Vangeli, Corano) non è quella
di fornire una legittimazione sacrale al potere, in quanto il Libro è il luogo che dà testimonianza e da cui
emerge quel che è considerato scandalo e follia, anche per i giuristi, cioè il libero ed irreversibile
vincolarsi di Dio nei confronti dell’uomo.
Il Libro non è un codice ma un trattato che descrive i termini di quell’alleanza, liberamente
sottoscritta, tra l’uomo e Dio che il primo potrà anche disattendere ma che Dio non revocherà mai; il
fondamentalismo è inaccettabile non perché teologico ma in quanto a-teologico, perché non percepisce
l’identità del Signore con il Padre, perché accede al Libro senza la minima mediazione di un logos che ne
faccia percepire il senso.
Alcuni sostengono che il vero fondamentalismo sia oggi riscontrabile in molti teorici e studiosi del
diritto, ovvero in tutti coloro per i quali la legge costituisce l’ultimo orizzonte di intelligibilità della
ragione giuridica; il problema è antico perchè la venerazione per la lettera caratterizza, forse da sempre, i
giuristi ma non è detto che sia sempre doveroso liberarsene; tuttavia, nei limiti in cui i giuristi hanno
lasciato il loro intelletto aperto alla ragione teologica, hanno potuto relativizzare la loro esperienza
epistemologica e lasciarle quel minimo di duttilità, linfa vitale del sapere.
Lutero ci spiega che l’ultima parola che resta ai giuristi quando più non riescono a sopportare i
tormenti della loro coscienza è una parola teologica, cioè la preghiera, ma la preghiera cui qui si fa
riferimento è una preghiera filosofica, mediante cui l’uomo acquista la consapevolezza di non essere
l’origine né di se stesso, né del suo sapere, né della sua storia, e da cui potrà scaturire quell’altra forma di
preghiera che, aprendo l’uomo alla pietà nei confronti di questa umanità senza pietà può avviarlo al
compimento della vita etica.
E al giurista è richiesto solo il riconoscimento che, per la realizzazione della giustizia, le sue forze
sono infinitamente deboli e limitate e che pure, nonostante ciò, egli è chiamato a consumarle
letteralmente tutte; in questo consiste l’initium sapientiae per la scienza del diritto.
24 1991
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XIX: I DIRITTI DELL’UOMO
Dopo Auschwitz, quindi dopo la vergogna di cui si è macchiata l’umanità nel secolo scorso, il
tema dei diritti è tornato ad essere di grande attualità; anzi, proprio a quelle terribili sofferenze si deve la
proclamazione, nel 1948, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo da parte dell’ONU.
Quindi il nostro tempo è il tempo dei diritti dell’uomo e ciò è il portato non dell’affermazione di
una particolare speculazione filosofica o dottrina, bensì di un senso etico concreto che solo nel nostro
tempo è riuscito a catalizzarsi ed installarsi definitivamente nelle coscienze, quasi a costituire un
universale etico; non a caso alla tematica dei diritti umani e della loro difesa è riconducibile il movimento
antisegregazionista di Luther King, il nuovo diritto internazionale, l’autorevolezza di organizzazioni
come Amnesty International.
Tuttavia, se da una parte sentiamo ormai la tematica dei diritti umani come culturalmente
irrinunciabile, dall’altra non possiamo non ammettere come essa sia in larga parte irrealizzata
storicamente; ed è proprio in questa dialettica tra irrinunciabilità ed irrealizzazione che si colloca il
tormento del nostro tempo.
Esistono certamente precise motivazioni storiche della violazione dei diritti umani che variano da
paese a paese e da regime a regime; ma le ragioni più profonde sono in realtà metastoriche, attenendo al
modo stesso di pensare tali diritti:
1. i diritti umani conoscono un limite essenzialmente politico: essi, infatti, valgono, oggi, solo per i
cittadini di uno Stato che si sia impegnato formalmente a riconoscerli; quindi, alla garanzia dentro lo
Stato, non si affianca un’analoga garanzia contro lo Stato: finchè non esisterà una cittadinanza
planetaria, l’attuazione dei diritti sarà sempre strutturalmente limitata.
2. un secondo problema è di carattere strutturale ed attiene alla logica propriamente giuridica cui è
subordinata l’effettiva difesa istituzionale dei diritti: il diritto è un sistema volto a mediare pretese
individuali conflittuali e questa mediazione avviene istituzionalmente, nel segno della
massimizzazione della libertà di tutti; pertanto, sembra che nessun singolo diritto può essere
rivendicato da un soggetto senza essere in qualche modo limitato dal concorrente diritto di un altro
soggetto: di conseguenza, la realizzazione dei diritti umani sarebbe costitutivamente parziale. La
difficoltà nasce dal confondere lo statuto specifico del conflitto dei diritti con quello del conflitto dei
valori, dalla cui notoria non gerarchizzabilità deriva l’impossibilità di risoluzione, in termini di
giustizia, di ogni controversia che li riguardi se non mediante un atto decisionistico (che pone fine alla
controversia troncandola bruscamente e non riconoscendo quali siano obiettivamente le spettanze di
ciascuna parte); se invece non si moralizza il diritto, se cioè si comprende che il conflitto è tra opposte
pretese giuridiche soggettive, e non tra valori, l’antinomia può essere risolta ricorrendo al principio, di
matrice kantiana, dell’universalità, cioè riconoscendo come obiettivamente meritevole di tutela quel
diritto che non ha, o che ha comunque meno, il carattere del privilegio: la stessa rivendicazione di un
diritto, infatti, è possibile solo in quanto riconosciuta come obiettiva, cioè valida per chiunque venisse
a trovarsi nella medesima situazione (altrimenti si parlerebbe, appunto, della rivendicazione di un
privilegio).
3. il terzo, e fondamentale, problema riguarda la proliferazione delle carte dei diritti (già nel 1978
l’ONU ha pubblicato una raccolta ufficiale di ben 88 testi di dichiarazioni dei diritti umani) che
potrebbe costituire il prodromo della crisi definitiva di questo strumento di difesa dei diritti. E’
innegabile che a monte di questo moltiplicarsi vi sia l’esigenza di massimizzare la tutela degli
individui enumerando con la maggior precisione possibile le loro spettanze; esigenza rispettabile,
soprattutto in un momento come il nostro che, nell’incapacità di trovare un fondamento teoretico ai
diritti, cerca di garantire loro almeno uno stabile fondamento positivo; ma è anche un’esigenza
ingenua perché la totalità del sapere, soprattutto giuridico, non è mai quantitativa ma qualitativa, cioè
legata al suo saper cogliere in profondità le esigenze e le linee portanti della realtà che deve
regolamentare.
In realtà, la via maestra per difendere le spettanze assolute degli uomini passa attraverso la
consapevolezza che l’uomo è garantito veramente solo quando tutti i diritti che gli vengono riconosciuti
sono ricondotti ad un unico, stabile fondamento: il diritto di avere diritti, cioè il riconoscimento di ogni
uomo per quello che veramente è: persona; quindi la lotta per la promozione e la difesa dei diritti umani
viene a coincidere con la lotta per il riconoscimento della dignità umana, in quella che è la sua
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
dimensione istituzionale minima e fondamentale: la capacità di ogni uomo di essere soggetto, e non
oggetto, di un rapporto, di essere, in quanto persona, costituzione di senso.
Quindi, prima ancora che valori politici, morali e sociali, i diritti dell’uomo vanno compresi per
viventi manifestazioni, nel soggetto, del principio del diritto che, nel suo intrinseco potenziale di
universalità relazionale, fornisce l’unica chiave per rivendicare e difendere i diritti dell’uomo.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Anelito : brama, aspirazione ardente.
CAP. XX: PLURALITA’ DELLE CULTURE E UNIVERSALITA’ DEI DIRITTI
Il mondo è caratterizzato dal pluralismo dei valori, nel senso che ogni cultura umana, essendo
diversa dalle altre, sostiene determinati valori che le sono propri; tuttavia, se la molteplicità e la
contraddittorietà delle culture e delle loro norme etiche e giuridiche è un fatto, parimenti un fatto è
l’anelito degli uomini nei confronti di un’unità che superi ogni dispersione.
Per i metafisici questo è il problema dell’uno e del molteplice e di come ciò che è singolare si
rispecchi, si diffonda o si manifesti in ciò che è plurale; per gli studiosi della morale è piuttosto il
problema dell’individuazione e della fondazione di norme assolute.
Il principio del pluralismo culturale è stato spesso utilizzato come ulteriore argomento critico nei
confronti del diritto naturale e delle sue pretese di assolutizzare come eterne ed immutabili le proprie
norme: secondo i critici del giusnaturalismo, infatti, se le culture sono, nel loro principio, plurime, non
può aver senso affermare che esistono diritti umani assoluti, innati, di carattere meta-culturale; ne
consegue che la stessa Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo andrebbe interpretata come si un
nobile documento ma in cui sono registrati non i diritti validi per ogni epoca e popolo, bensì solo i diritti
sentiti come irrinunciabili dalla cultura occidentale.
Ciò che va evidenziato, è che la critica al giusnaturalismo sfocia nella critica alla filosofia in
generale, come possibilità di discorso sulla verità.
• Chiavacci25: distingue i valori storici da quelli metafisici, qualificando i primi come quelli reali, umani,
e i secondi come il prodotto di una cultura.
E’ evidente che si potrebbe affermare esattamente il contrario; ma l’importante è insistere, come
insegna Pareyson, sul fatto che se una filosofia è tributaria della cultura del suo tempo, è cioè meramente
espressiva, non va considerata vera filosofia ma ideologia: la filosofia, infatti, è veramente tale quando è
rivelativa, quando cioè cerca di porre l’uomo in rapporto con la verità; conseguentemente, mentre il
pensiero espressivo consiste in una mera descrizione del mondo, in una registrazione delle diverse
dinamiche assiologiche presenti in esso, il pensiero rivelativo si presenta come infinitamente più gravoso
perché obbligato in via preliminare a liberarsi di ogni possibile forma di inquinamento ideologico (come
il condizionamento culturale).
Ma come è possibile un pensiero rivelativo? Lo stesso Chiavacci sostiene che esiste un appello a
un valore, al valore dell’uomo come valore radicale, che diviene giudizio morale sulla cultura; che esista
un’esperienza morale profonda, presente in ogni uomo, anteriore ad ogni condizionamento culturale,
radice di ogni re-azione ad esso, che permette di parlare ancora di ideali umanitari, di diritti umani, di
giustizia e pace, è qualcosa che dev’essere assunto se non si vuole perdere ogni originalità dell’individuo.
Ebbene, se si ammette l’esistenza di questa esperienza morale profonda, che non è riducibile ad un
dato culturale, non si può non ammettere la possibilità di un pensiero rivelativo, cioè di una
tematizzazione speculativa di questa esperienza (cioè una filosofia), capace di sottrarsi al
condizionamento culturale.
La filosofia così intesa, quindi, si presenta e si propone come possibilità di giudizio delle culture,
delle loro verità e della loro molteplicità e contraddittorietà, ma questo non implica che la filosofia si
presenti nei confronti delle culture come giudizio di condanna: essa non chiede alle culture di rinunciare
ad essere loro stesse, chiede soltanto di rinunciare ad assolutizzarsi, abbandonando la pretesa di far
assurgere i valori che esse sostengono ad unità di misura di ogni altra cultura (etnocentrismo); lo
specifico contributo che il pensiero rivelativo porta all’ermeneutica delle culture consiste, da un lato, nel
disvelarne il senso unitario, dall’altro nel mostrare che questo senso unitario non può essere colto
dall’etnologia ma dalla filosofia, perché non opera su di un piano strettamente culturale ma su un piano
specificamente antropologico, che trascende la pluralità delle culture: è solo attraverso l’ermeneutica
filosofica delle culture che è possibile far emergere le loro profonde valenze unitarie.
Consideriamo l’aneddoto di Erodoto sul trattamento riservato ai cadaveri dei genitori da parte dei
Greci e dei Calati, considerato come il primo esempio nella letteratura occidentale di presa di coscienza
del pluralismo culturale; la conclusione è relativistica ma è chiara la percezione di come sia i Greci che i
Calati abbiano in comune un valore fondamentale, quello del rispetto dei genitori, valore si condizionato
ma solo culturalmente, cioè solo nelle sue dimensioni estrinseche e non nella sua struttura fondamentale:
25 Parroco di Firenze, è docente di teologia morale presso la facoltà teologica dell'Italia centrale.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
rilevare la relatività delle culture, come dato di fatto, non implica rilevare la relatività della verità
dell’uomo.
E’ questo probabilmente il punto su cui vuole richiamare l’attenzione S. Agostino quando fa
riferimento alla regola aurea: “Il precetto non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te non è cambiato
mai ed è rimasto costante nel tempo e nello spazio”; il suo senso non è però quello di fungere da criterio
per riportare ad unità le molteplici culture, quanto piuttosto di costituire un’opportunità per attingere alla
dimensione meta-culturale dell’essere dell’uomo, di costituire un indizio della verità dell’uomo: un essere
che realizza veramente la propria soggettività è veramente se stesso solo quando riconosce la soggettività
dell’altro, quando individua nell’altro le stesse esigenze, gli stessi bisogni, le stesse spettanze che
riconosce in se stesso.
La regola aurea, evidentemente, non ha un carattere culturale perché non esiste un modo univoco
per ottemperare ad essa; e la sua universalità dipende proprio da questo, dal porsi di principio al di sopra
di tutte le culture.
Andando avanti nel ragionamento sull’universalità dei diritti, nonostante ogni cultura sia
primariamente strutturata al fine di elaborare i canoni minimi necessari alla sopravvivenza, a potenziare
le forze dell’individuo integrandolo nella comunità, in ogni cultura sono anche presenti precetti di più
ampio respiro, la cui funzione obiettiva è quella di definire ciò che è giusto, appropriato ed umano; ogni
cultura, cioè, è caratterizzata da un anelito per l’universalità, pretende di avere per proprio oggetto l’uomo
in sé (sovrapproduzione culturale).
Ne consegue che il carattere pluralistico delle culture potrebbe essere invocato non come dato
giustificante un relativismo assiologico, ma come argomento per ipotizzare una sorta di eccedenza
dell’essere dell’uomo rispetto a tutte le forme espressive del suo essere; tale eccedenza, da un lato,
giustificherebbe la molteplicità delle forme culturali, dall’altro, ne costituirebbe il confine: se le forme
espressive dell’humanum sono, nel loro principio, inesauribili, non qualsiasi forma espressiva può, di per
sé, veicolare l’humanum in quanto tale.
Secondo Levi-Strauss la norma che proibisce l’incesto sarebbe un precetto caratterizzato da
normatività universale, sia perché è empiricamente rilevabile come universale, sia perché è l’unica di cui
si possa postulare l’universalità; infatti, segnando il passaggio dalla natura alla cultura, sottraendo cioè
l’uomo alla irriflessività dello stato animale per consegnarlo al regno dell’autocoscienza, essa non può
essere identificata né con una legge naturalistica in senso stretto, né con una norma etico-culturale: la sua
effettiva universalità e la sua unicità dipendono proprio dal suo essere cerniera tra questi due mondi.
In realtà esistono anche altre norme trans-culturali, obiettivamente universali, seppure, a volte,
camuffate da prassi sociali di non facile lettura; un esempio è quello del tabù del cannibalismo: Arens 26 ha
dimostrato come esso sia una norma effettualmente universale ma mai creduta tale perché la sua pretesa
violazione è sempre stata utilizzata come giustificazione dell’aggressività trans-culturale o per iniziative
colonialistiche.
Passando poi dalle norme materiali a quelle strutturali, è ancora più facile individuare l’esistenza
dell’universalità di alcune di loro: norma di reciprocità, dell’ospitalità, del dono, ecc…, che altro non
sono che ulteriori determinazioni del tabù dell’incesto.
Tuttavia, rilevare l’esistenza di principi normativi universali non comporta automaticamente che
essi possano essere adottati come norme fondamentali di codificazioni positive: spetta ad ogni cultura
dare forma materiale a quei principi universali di carattere strutturale ed assumersene la responsabilità
storica; in realtà, rilevare l’universalità di alcuni sommi principi è essenziale per mostrare la
fondamentale capacità di comunicazione di tutte le culture e, di conseguenza, di tutti gli individui.
A questo punto è necessario chiedersi se le diverse culture in cui si incarnano in forme diverse i
principi strutturali dell’humanum siano sempre tali da difenderli fedelmente e, quindi, da rispettare
sempre e comunque in quanto legittimi per il solo fatto di esistere, o se possano e debbano essere
giudicate ed, eventualmente, combattute.
Di certo il giudizio sulle culture non può essere sospeso; tuttavia una cultura non va giudicata
usando come unità di misura un’altra cultura, perché tutte le culture sono passibili in egual misura di
giudizio: giudicare una cultura significa verificarne la coerenza interna in quanto l’universale che da
forma alle culture non è obiettivato né obiettiva bile, ma è un principio costitutivo.
26 1980.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Conseguentemente, l’errore del relativismo non sta nel sottolineare la diversità e spesso la
reciproca difficilissima comunicabilità di culture diverse e nemmeno di non aver preso atto dell’esistenza
di valori trans-culturali, bensì nel ritenere che le culture siano autosignificanti, universi chiusi di
esperienza che non rinviano ad altro che a se stessi, mentre non sono altro che dei media attraverso cui gli
uomini hanno cercato di attingere ad una realtà metafisica.
Quanto detto fino ad ora consente di negare che anche la Dichiarazione universale dei Diritti
dell’Uomo sia un assoluto, ma ciò non vuol dire metterne in dubbio o svalutarne i contenuti, dato che essa
appare comunque quanto di più adeguato alla difesa della dignità dell’uomo sia ipotizzabile; tuttavia non
possiamo ignorare sotto quali condizionamenti essa è stata pensata e scritta e che la stessa teoria dei diritti
umani non può essere considerata neutrale.
Ai giuristi contemporanei, quindi, spetta in primo luogo riconoscere il limite culturale inerente
alla Dichiarazione, di matrice strettamente occidentale, e in secondo luogo il compito di inventare un
nuovo linguaggio attraverso cui le culture possano reciprocamente fecondarsi permanendo ciascuna nella
propria identità.
Le lingue occidentali devono recuperare il duale: gli uomini hanno diritti perché sono gli uni con
gli altri, perché l’esistenza dell’uno richiede l’esistenza dell’altro, perché nella loro identità il singolare si
unisce al plurale, l’affermazione dell’io al riconoscimento del tu.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
CAP. XXI: I DOVERI DELL’UOMO
Se esistono i diritti, correlativamente, esistono i doveri; tuttavia, che nell’età dei diritti esistano
doveri da qualificare come doveri fondamentali è questione antica ed irrisolta.
Ciò che si dà di essenziale nella formula doveri fondamentali è proprio la qualificazione di
fondamentale: il fondamentale è tale non perché dotato di importanza, ma perché non ha altro
fondamento che se stesso, perché non posa né rinvia ad altro che lo costituisca come tale; quando
riflettiamo su ciò che è fondamentale ci sentiamo rinviati alla dimensione dell’assoluto inteso come ciò
che è sottratto alla nostra disponibilità.
Quindi, va ritenuto fondamentale un dovere che gravi su tutti gli uomini indiscriminatamente e
che, nel contempo, sia tale che nessuno possa sottrarsi al suo adempimento: è un debito che non può non
essere pagato; ma esistono debiti del genere?
I poeti hanno individuato questo dovere fondamentale nel debito di morte, nel dover morire; è un
topos letterario, che troviamo nell’Alcesti di Euripide e nell’Enrico IV di Shakespeare, ma che non va
trascurato: la morte, come mero fatto naturalistico, ci accomuna a qualsiasi altro vivente, ma la morte
come debito ci caratterizza inequivocabilmente.
- Heidegger: il decesso è un fatto, la morte un significato; ma se lo è, lo è proprio perché, pur essendo un
fatto, essa non può mai essere completamente appiattita sul mero piano dei fatti in quanto le è inerente
la dimensione del dovere. Nella morte, insomma, essere e dover essere coincidono; la morte è un
dovere fondamentale perché in essa è indiscutibile la coincidenza tra ciò che sopravviene come fatto e
ciò che sopravviene come rendimento di un debito.
E questo lo hanno capito anche i teologi quando, prendendo sul serio la promessa di eternità fatta
dal creatore alla creatura, hanno negato che per l’uomo la morte vada intesa come evento naturale e
l’hanno, di conseguenza, tematizzata come espiazione di una colpa.
Cerchiamo di esprimere la dimensione della fonda mentalità vedendo se analogo discorso può
essere fatto per la simmetrica categoria dei diritti fondamentali; se il dovere fondamentale è quello in cui
sein e sollen coincidono, anche il diritto fondamentale dovrà essere chiarificato in modo analogo: è
fondamentale quel diritto che inerisce a tal punto l’uomo che non gli può mai essere completamente
sottratto, quel diritto che costituisce il fondamento di una pretesa soggettiva tale da non poter non essere
in qualche modo soddisfatta.
Qui sta il paradosso stoico sulla libertà, che da un lato è vista come un diritto che l’uomo
giustamente pretende che gli altri gli riconoscano, ma che dall’altra parte è considerata una dimensione
così propria dell’essere dell’uomo che nessuno glielo può propriamente sottrarre; insomma, nella libertà
sein e sollen coincidono: la libertà è il diritto fondamentale proprio perché assoluta e in espropriabile e,
nel contempo, assolutamente rivendicabile; essa è il presupposto ed insieme l’obiettivo di ogni prassi
umana: il punto di partenza (ciò che mi fa identificare l’uomo in quanto uomo, nella sua dignità) e il
punto di arrivo (ciò che l’uomo deve diventare per raggiungere la sua pienezza).
Premesso tutto ciò, possiamo ora approfondire il discorso sul dovere fondamentale come dovere
giuridico; un dovere giuridico fondamentale dev’essere tale che in esso sein e sollen coincidano, dando
quindi sostanza ad un dovere di essere.
La coesistenza può essere veramente detta il dovere fondamentale, ovvero il fondamento del
diritto, perché, essendo l’uomo costitutivamente relazionale, fuoriuscire dalla coesistenza non è possibile,
significherebbe uscire dallo stato di essere umano, e perché, dall’altra parte, la coesistenza è uno stato in
cui non si deve entrare perché ci si è già; il fatto di coesistere diviene per l’uomo il dovere di riconoscere
sé e gli altri come coesistenti e il dovere di coesistere presuppone l’ineliminabilità del fatto che sempre e
comunque noi uomini siamo già coesistenti.
PAGE 38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: alice-manolio (alicemanolio96@libero.it)
Potrebbero piacerti anche
- Appunti Filosofia Del Diritto-Norme, Concetti, ArgomentiDocumento91 pagineAppunti Filosofia Del Diritto-Norme, Concetti, Argomentimadririca97100% (3)
- Riassunto Pagliaro GeneraleDocumento232 pagineRiassunto Pagliaro GeneraleSilvia DchNessuna valutazione finora
- Manuale Teoria Generale Del Diritto (Completo)Documento33 pagineManuale Teoria Generale Del Diritto (Completo)Aurelia BadeaNessuna valutazione finora
- GazzoniDocumento39 pagineGazzonistonea23100% (1)
- A Catania Manuale Di Teoria Generale Del Diritto 1Documento12 pagineA Catania Manuale Di Teoria Generale Del Diritto 1GaetanoMontalbano100% (1)
- Schemi Di Diritto Commerciale (2006)Documento40 pagineSchemi Di Diritto Commerciale (2006)Palla di Lardo100% (3)
- Diritto Privato 1 F Ruscello - SintesiDocumento127 pagineDiritto Privato 1 F Ruscello - SintesiRiccardo RosaNessuna valutazione finora
- Schermi Riassuntivi Diritto Romano Manuale Di Diritto Privato RomanoDocumento79 pagineSchermi Riassuntivi Diritto Romano Manuale Di Diritto Privato RomanopaolovglNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleDocumento41 pagineRiassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleGianmarco BrunoNessuna valutazione finora
- Diritto CostituzionaleDocumento18 pagineDiritto Costituzionalealteriuris100% (2)
- Riassunto Diritto Del LavoroDocumento113 pagineRiassunto Diritto Del LavoroAlessandra PignataroNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Giustizia Amministrativa, Travi - SCHEMIDocumento46 pagineLezioni Di Giustizia Amministrativa, Travi - SCHEMIMaricaNessuna valutazione finora
- Filosofia Del Diritto, Barberis HartDocumento88 pagineFilosofia Del Diritto, Barberis HartArdita BitiNessuna valutazione finora
- Filosofia Del Diritto - VernaglioneDocumento50 pagineFilosofia Del Diritto - Vernaglioneberilo1975Nessuna valutazione finora
- Filosofia Diritto-DiktatDocumento33 pagineFilosofia Diritto-Diktatlorisan24Nessuna valutazione finora
- Riassunto Di Filosofia Del Diritto RossDocumento19 pagineRiassunto Di Filosofia Del Diritto RossMassimo BelibaniNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale Civile 1°libroDocumento84 pagineDiritto Processuale Civile 1°libroMartina De bellisNessuna valutazione finora
- 7.nozioni Di Diritto CivileDocumento12 pagine7.nozioni Di Diritto CivileJosephmetalNessuna valutazione finora
- Schemi Filosofia Del Diritto 2009 10Documento126 pagineSchemi Filosofia Del Diritto 2009 10AntoninaBelmonteNessuna valutazione finora
- Riassunti Diritto Processuale CivileDocumento126 pagineRiassunti Diritto Processuale CivileDjamilaNessuna valutazione finora
- Filosofia Del DirittoDocumento43 pagineFilosofia Del DirittoMariyaNessuna valutazione finora
- Procedura Civile IDocumento66 pagineProcedura Civile IFederico Movia100% (1)
- Filosofia Del DirittoDocumento65 pagineFilosofia Del Dirittouncle_sam94Nessuna valutazione finora
- Romano - Marrone 2Documento56 pagineRomano - Marrone 2acidfrehmour100% (1)
- Storia Del Diritto Medievale&Moderno Prima MetàDocumento38 pagineStoria Del Diritto Medievale&Moderno Prima MetàLuca GambirasioNessuna valutazione finora
- Diritto Soggettivo Ed Interesse LegittimoDocumento8 pagineDiritto Soggettivo Ed Interesse Legittimouniroma13Nessuna valutazione finora
- Diritto PrivatoDocumento14 pagineDiritto PrivatoAlessia Cogliati100% (1)
- Sistemi Giuridici ComparatiDocumento46 pagineSistemi Giuridici ComparatiBarbara Ishtar100% (1)
- Istituzioni Di Diritto RomanoDocumento44 pagineIstituzioni Di Diritto RomanolessgotNessuna valutazione finora
- Diritto CivileDocumento17 pagineDiritto Civileappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Trabucchi Capo 1 (44 Pag.)Documento44 pagineTrabucchi Capo 1 (44 Pag.)Angela Valentino100% (1)
- Marrone - LineamentiDocumento107 pagineMarrone - LineamentiNuccia Malta100% (1)
- Istituzioni Di Diritto Pubblico Riassunto Diritto Costituzionale ARCIDIACONO CARULLO RIZZADocumento63 pagineIstituzioni Di Diritto Pubblico Riassunto Diritto Costituzionale ARCIDIACONO CARULLO RIZZAGenovese Carla0% (1)
- Testo Unico Pubblico Impiego MAGGIO 2017 PDFDocumento40 pagineTesto Unico Pubblico Impiego MAGGIO 2017 PDFkasparjNessuna valutazione finora
- Docsity Appunti Lezioni Di Storia Del Diritto Italiano I Prof Ssa Sigismondi Universita La Sapienza Di Roma Canale M ZDocumento70 pagineDocsity Appunti Lezioni Di Storia Del Diritto Italiano I Prof Ssa Sigismondi Universita La Sapienza Di Roma Canale M ZmikhaelspertiNessuna valutazione finora
- Il Positivismo GiuridicoDocumento31 pagineIl Positivismo GiuridicoPaolo Sarandi100% (1)
- Il Negozio GiuridicoDocumento7 pagineIl Negozio GiuridicoMariaCristinaZuppelliNessuna valutazione finora
- Codificazione Diritto RomanoDocumento9 pagineCodificazione Diritto RomanocindyNessuna valutazione finora
- Diritto Costituzionale, MartinesDocumento28 pagineDiritto Costituzionale, MartinesPiersilvio VisioliNessuna valutazione finora
- Appunti - Istituzioni Di Diritto Privato (Galgano)Documento63 pagineAppunti - Istituzioni Di Diritto Privato (Galgano)Beniamino AmitranoNessuna valutazione finora
- Diritto Pubblico Appunti LezioniDocumento92 pagineDiritto Pubblico Appunti LezioniMiko ArzoNessuna valutazione finora
- Schemi RomanoDocumento24 pagineSchemi Romanomalik_uxNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto PrivatoDocumento62 pagineIstituzioni Di Diritto PrivatomemanuelemNessuna valutazione finora
- Domande Diritto PubblicoDocumento24 pagineDomande Diritto PubblicoCarlotta Charlie MarinoNessuna valutazione finora
- Filosofia Del DirittoDocumento11 pagineFilosofia Del DirittoValeria Brits TortoraNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale Civile CompletoDocumento84 pagineDiritto Processuale Civile Completomiriam1skibaNessuna valutazione finora
- Diritto Privato: La FamigliaDocumento27 pagineDiritto Privato: La FamigliaGiurisprudenzaPisaNessuna valutazione finora
- Diritto Romano e CristianesimoDocumento5 pagineDiritto Romano e CristianesimodonpedrodetoledoNessuna valutazione finora
- Diritto RomanoDocumento24 pagineDiritto RomanoAlexandra ValtellinaNessuna valutazione finora
- Diritto CanonicoDocumento47 pagineDiritto Canonicotresda100% (1)
- Sintesi FinocchiaroDocumento127 pagineSintesi Finocchiaroceccone23Nessuna valutazione finora
- Le Fonti Del DirittoDocumento8 pagineLe Fonti Del DirittoRenèe Antonia GilibertiNessuna valutazione finora
- Tutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaDa EverandTutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaNessuna valutazione finora
- ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionaleDa EverandENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionaleNessuna valutazione finora
- Separazione e divorzio. Principali aspetti sostanziali e processuali.Da EverandSeparazione e divorzio. Principali aspetti sostanziali e processuali.Nessuna valutazione finora
- Test RIPAM di inglese: Quesiti a risposta multipla di lingua inglese tratti dalla banca dati del RIPAM FormezDa EverandTest RIPAM di inglese: Quesiti a risposta multipla di lingua inglese tratti dalla banca dati del RIPAM FormezNessuna valutazione finora
- I Soggetti Di Diritto. La Persona Fisica.Documento6 pagineI Soggetti Di Diritto. La Persona Fisica.AliceNessuna valutazione finora
- Cap 1Documento1 paginaCap 1AliceNessuna valutazione finora
- I Fondamenti Del DirittoDocumento4 pagineI Fondamenti Del DirittoAliceNessuna valutazione finora
- CAP XI CottaDocumento8 pagineCAP XI CottaAliceNessuna valutazione finora
- Wilhelm Heinrich Wackenroder, La Visione Di RaffaelloDocumento5 pagineWilhelm Heinrich Wackenroder, La Visione Di RaffaelloSeth WrightNessuna valutazione finora
- L'arte Nel RinascimentoDocumento30 pagineL'arte Nel RinascimentoSuzana E PepaNessuna valutazione finora
- Alcuni Aspetti Della Meditazione Cristiana (Sintesi)Documento5 pagineAlcuni Aspetti Della Meditazione Cristiana (Sintesi)Catello ImperatoNessuna valutazione finora
- Frammenti Di EraclitoDocumento2 pagineFrammenti Di EraclitoGianluca FascianaNessuna valutazione finora
- Sulla "Religione Cosmica" Di Albert EinsteinDocumento7 pagineSulla "Religione Cosmica" Di Albert EinsteinTomasoNessuna valutazione finora
- Diritto Privato ComparatoDocumento29 pagineDiritto Privato Comparatoappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- KalypsoDocumento472 pagineKalypsoDanielNessuna valutazione finora
- Lukács e SpenglerDocumento3 pagineLukács e SpenglerVincenzo FatigatiNessuna valutazione finora
- Storia Politica Dell'AntichitàDocumento65 pagineStoria Politica Dell'AntichitàMaria RosetoNessuna valutazione finora
- La Didattica MetacognitivaDocumento13 pagineLa Didattica MetacognitivaAngelaSalarisNessuna valutazione finora
- La Civiltà CattolicaDocumento626 pagineLa Civiltà CattolicaalexknoedelNessuna valutazione finora