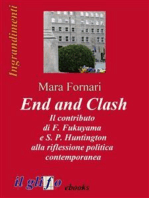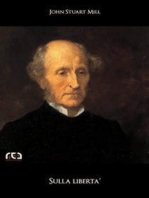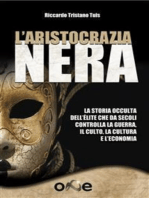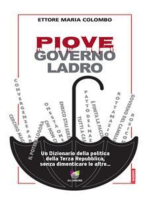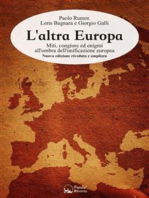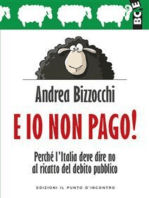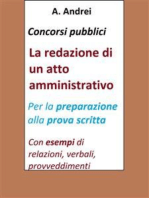Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Relazioni Internazionali
Caricato da
GTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Relazioni Internazionali
Caricato da
GCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|3304637
Relazioni Internazionali
Relazioni Internazionali (Università degli Studi di Pavia)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
STATO E RELAZIONI INTERNAZIONALI cap.1
1. I CONFINI DELLA DISCIPLINA
Le relazioni internazionali sono una disciplina accademica nata come ramo della scienza politica, e designano
contemporaneamente:
REALTA’ DISCIPLINA
Storicamente le relazioni internazionali esistono da La teoria delle relazioni internazionali è una disciplina
quando esistono delle unità politiche indipendenti (siano recente, nata nel 1919 con l’istituzione in Galles della
esse clan, popoli, imperi o stati) sufficientemente coese da prima cattedra di International Politics, e trasmigrata
riuscire a distinguere tra le relazioni che si svolgono al poco dopo soprattutto negli Stati Uniti, nell’ambito della
proprio interno e quelle che ciascuna intrattiene con le transizione egemonica che ha segnato il ‘900 anche sul
altre, ovvero relazioni internazionali. Pertanto, terreno politico, economico, militare e ideologico. Questa
quest’ultime non sussistono in tutti quei contesti storici trasmigrazione ha inciso fortemente sull’orizzonte della
nei quali manca la distinzione tra interno ed esterno, a disciplina, sia per quanto riguarda la scelta degli eventi da
causa dei confini imprecisi o perché gli uomini sono tenere in considerazione, sia per quanto riguarda il
legati a fedeltà multiple come accadeva durante il periodo storico. Infatti, la teoria delle relazioni
Medioevo europeo. internazionali si è programmaticamente rivolta alla
Tuttavia, relazioni internazionali sussistono in varie vicenda della guerra fredda appartenente alla K2° metà
epoche storiche: tra le polis greche in età classica, tra del ‘900, trascurando il rapporto tra il ‘900 con i secoli
Roma e Cartagine, tra gli stati territoriali prima su scala che l’hanno preceduto. In questo modo, si è smarrita la
europea poi mondiale. Ovviamente, a seconda della consapevolezza che la politica internazionale considerata
natura degli attori principali e delle diverse entità che non è altro che un modello, storicamente e
compongono il sistema, le relazioni internazionali geograficamente determinato, e pertanto non valido in
cambiano radicalmente. termini assoluti.
2. IL SISTEMA POLITICO INTERNAZIONALE MODERNO
Quando oggi si parla di relazioni internazionali si danno quasi sempre per scontate due cose:
GLOBALIZZAZIONE POLITICA INTERSTATALE
Al di sopra dell’articolazione in aree regionali e sub Sebbene i protagonisti delle relazioni globali siano anche
regionali, il mondo attuale costituisce un sistema politico, attori di altra natura (ONG, individui, multinazionali,
economico e giuridico unitario, tenuto insieme dalla fitta organizzazioni intergovernative), il posto principale spetta
rete di interdipendenze. agli Stati, in quanto unici titolari del diritto di impiegare
legittimamente la violenza.
Tuttavia, entrambi i presupposti sono il risultato di un processo storico molto recente e, pertanto, non possono essere
considerati universalmente validi.
Questo vale per l’equiparazione tra relazioni internazionali e relazioni globali. Infatti, solo tra il 1500 e il 1600 il mondo
cominciò a essere percepito nella sua unità, sebbene questa fosse ancora limitata a un intreccio poco profondo tra
commercio, guerra e religione. Fu necessario attendere la metà dell’800 perché l’unificazione della società
internazionale subisse una accelerazione decisiva, con il consolidamento del sistema capitalistico mondiale da una
parte, e con l’integrazione delle diverse aree regionali in un unico teatro politico dall’altra (corsa coloniale).
Ma ancora più controversa è l’origine dell’equiparazione tra politica internazionale e politica interstatale. Il passaggio
dalla convivenza medievale a quella moderna avvenne in modo lento e discontinuo. La periodizzazione convenzionale
individua nella pace di Vestfalia del 1648 l’atto di nascita definitivo del sistema internazionale moderno.
2.1 Anarchia, insicurezza e guerra
Con la differenziazione tra politica interna ed esterna, nasce anche il primo e fondamentale contrassegno del sistema
politico internazionale moderno: la mancanza di un governo mondiale. Questa condizione per la quale ogni soggetto
sarebbe costretto ad avere cura di se stesso viene definita Anarchia Internazionale. Riferita alla politica internazionale,
tuttavia, la parola anarchia non ha lo stesso significato che possiede nel linguaggio comune. Il sistema politico
internazionale è sì privo di governo, ma non per questo disordinato: il principale problema delle Relazioni
Internazionali, è appunto capire come in un sistema anarchico si possa ottenere l’ordine.
Sebbene infatti la cultura contemporanea si sia abituata a vedere nell’anarchia un problema, è bene ricordare che essa è
stata per lungo tempo il contrassegno del pluralismo e delle libertà dell’Europa, in opposizione al dispotismo asiatico e
allo spettro della monarchia universale.
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
Ma cosa comporta trovarsi in un ambiente privo di governo? La raffigurazione dello STATO DI NATURA di Hobbes
della metà del ‘600, afferma che condannando tutti i soggetti all’autodifesa, la mancanza di un’autorità a cui rivolgersi
per tutelare i propri diritti condanna ciascuno a preoccuparsi delle intenzioni degli altri. La mancanza di un organo in
grado di garantire il soddisfacimento delle promesse fa in modo che le azioni degli altri possano apparire sempre
sospette o addirittura possano essere fraintese.
Sebbene, nella politica internazionale esistano dei freni quali la somiglianza culturale, le istituzioni o l’esistenza di
relazioni continue tra gli attori, ogni volta che questi freni cessano di operare, l’anarchia piega verso quella condizione
chiamata DILEMMA DELLA SICUREZZA. Anche quando nessuno tra gli altri stati ha intenzione di attaccare gli altri,
essi possono continuare a temere che le rispettive intenzioni non siano destinate a rimanere pacifiche e possono dunque
sentirsi costretti ad accumulare in anticipo potenza (armi e alleati) per difendersi. Questo porta anche gli altri attori ad
incrementare la potenza, secondo un movimento a spirale esemplificato nel ‘900 dalla corsa agli armamenti e agli alleati
della guerra fredda.
La relazione tra Iran – Israele – Paesi arabi (i primi due con la Turchia non sono paesi arabi): l’Iran è il
soggetto svantaggiato che teme un’aggressione, pertanto si procura armi e risorse per difendersi. Ma nel
momento in cui si procura tali risorse, Israele teme una minaccia alla propria sicurezza e risponde procurandosi
altre risorse. Conseguenza è che anche i paesi arabi temendo la competizione vicina si rinforzano.
A differenza che negli ordinamenti politici interni, nei quali il monopolio dell’uso della forza da parte dello stato
obbliga tutti gli altri soggetti a competere in modo pacifico, declassando tutte le altre forme di violenza nella categoria
dell’illecito, la mancanza di un’agenzia analoga a livello internazionale legittima l’uso della forza da parte dei singoli
stati. Il contesto anarchico offre contemporaneamente alla violenza, una condizione permissiva, un insieme di limiti e
una possibile via d’uscita, che hanno dato spunto a 3 grandi tradizioni di pensiero: hobbesiana, groziana e kantiana.
HOBBESIANA - La prima è fondata sull’analogia tra anarchia internazionale e qualunque altro tipo di anarchia. Ogni
qualvolta che manca un’agenzia per promuovere i propri diritti, ciascuno potrà fare assegnamento sulle proprie forza e
sulla propria capacità di premunirsi contro gli altri. In questo senso, la condizione che vige normalmente è un
atteggiamento di guerra. Tuttavia, neppure in questo caso l’anarchia internazionale sarebbe condannata alla violenza,
per due ordini di motivi:
1. Per lo stesso Hobbes, la guerra non consiste solo nella battaglia e nell’atto del combattere, ma in uno spazio di
tempo in cui la volontà di affrontarsi è sufficientemente dichiarata, in cui per tutto il tempo non vi è
assicurazione del contrario.
2. Nei contesti interni ogni volta che qualcuno minaccia o aggredisce qualcun altro rischia di incorrere nella
sanzione della forza politica organizzata per contrapporsi all’uso privato della forza, ma nel contesto
internazionale la mancanza di una tale organizzazione costringe a provvedere da sé alla sicurezza, e questo non
vuol dire necessariamente condannare a una guerra senza fine.
GROZIANA - La seconda tradizione si basa su quelli che Bull ha definito come obiettivi fondamentali di qualunque
convivenza: la limitazione della violenza, il mantenimento delle promesse e stabilizzazione del possesso. Sin dalla sua
nascita anche il sistema internazionale moderno ha sviluppato un proprio tessuto di istituzioni necessarie per la
convivenza. A questo tessuto appartengono la prassi delle conferenze internazionali, il sistema diplomatico e il diritto
internazionale. Tali istituzioni sono riassunte nel concetto di società internazionale dalla Scuola Inglese delle relazioni
internazionali, mentre Schmitt le inserisce nel concetto di jus publicum europaeum. Questo basterebbe a confutare la
tesi hobbesiana di equivalenza tra anarchia internazionale e anarchia. Tuttavia, è la visione della guerra che incide
maggiormente. A differenza che nella prima teoria, qui la guerra può figurare persino come il CONTRARIO DEL
DISORDINE, o guerre en forme secondo l’espressione del giurista Vattel, sia in quanto è chiamata a svolgere un ruolo
essenziale nel mantenimento dell’ordine internazionale (imponendo il diritto, preservando l’equilibrio di potenza o
consentendo il mutamento), sia in quanto, nello svolgimento di queste funzioni, essa è vincolata da precisi limiti:
1. nella legittimità, poiché è possibile ricorrervi solo con giusta causa;
2
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
2. nella conduzione, poiché richiede che siano tracciati limiti spaziali e temporali allo scontro per preservare
almeno i neutrali e i non combattenti;
3. nella titolarità, perché solo pochi soggetti, gli stati, hanno diritto di combatterla legittimamente.
KANTIANA - La visione kantiana si basa sul progetto per la pace perpetua, e suggerisce la possibilità di liberarsi del
tutta dall’ammissibilità della guerra superando la forma anarchica della convivenza internazionale. Il sottinteso di tale
soluzione è riconosciuto da Bobbio: allo stesso modo in cui gli uomini nello stato di natura hanno ceduto la forza ad un
potere unico, così gli stati dovranno compiere il medesimo passaggio.
2.2. Anarchia o anarchie? La politica internazionale come politica
interstatale
In realtà l’analogia tra l’anarchia internazionale e lo stato di natura hobbesiano è solo apparente.
1. La prima differenza riguarda la dimensione del POTERE. Nel contesto anarchico dello stato di natura, i
soggetti sono tutti egualmente in grado di nuocersi,, quindi di uccidersi. Al contrario, nel contesto
internazionale l’anarchia non si avvicina mai a questa condizione. Nel contesto attuale, per esempio, nessuno
può aspirare ad invadere o distruggere gli Usa. In questo senso, la disuguaglianza di potere ha potuto essere
vista come il surrogato del governo in un ambiente anarchico.
Ma al di sotto delle diseguaglianza tra stati forti e deboli, esiste una differenza ancora più marcata: se gli stati
hanno potuto essere considerati come protagonisti della politica internazionale è perché hanno concentrato su
di sé la maggior parte delle risorse di potenza. Da qui l’equiparazione tra politica internazionale e politica
interstatale.
2. La seconda differenza è costituita dall’esistenza di RELAZIONI più o meno continue. Nello stato di natura
hobbesiano, gli attori possono non avere mai occasione di incontrarsi; gli uomini hanno rapporti occasionali tra
loro ma senza cessare di restare essenzialmente isolati. Nel sistema internazionale, al contrario, gli stati
possono essere condannati a non potersi isolare gli uni dagli altri neppure quando lo vorrebbero. Proprio qui
sta il significato concreto dell’espressione “sistema internazionale”, diffusa già dal ‘600-‘700, man mano che si
impose la consapevolezza che non fosse più possibile isolare la sovranità di ogni singolo sovrano da ogni altro.
3. Un’ultima differenza con la riflessione hobbesiana, è costituita dal principio di SOVRANITA’, che
istituzionalizza il potere degli stati come unici titolari della piena legittimità internazionale anche sul terreno
del diritto e che ha affermato l’idea della società di stati come forma di organizzazione politica dell’umanità, al
posto di altre idee alternative, quali ad esempio una comunità cosmopolitica di singoli esseri umani, o un
impero universale.
3. IL SISTEMA INTERSTATALE COME ECCEZIONE STORICA
Per capire se l’equiparazione tra politica internazionale e politica interstatale esprima ancora le relazioni attuali, bisogna
tener presente che, oltre ad essere recente, essa costituisce un eccezione storica. Wight ne mette in evidenza alcuni
elementi di fragilità:
1. L’attuale sistema interstatale è esistito grosso modo a partire dal 1500, e noi abbiamo l’illusione che sia
normale. Ma se guardiamo indietro, non si fatica a constatare come, nella maggior parte dell’esperienza
storica, al posto del complesso concetto di sovranità convivessero molteplici forme di dipendenza e
semidipendenza (come nel sistema feudale europeo). Al posto dell’idea moderna di confine, il potere di
ciascuna unità degradava a poco a poco fino a intrecciarsi con quella di altre unità. Inoltre, al posto
dell’omogeneità e dell’uguaglianza tra gli stati, la convivenza internazionale comprendeva
contemporaneamente soggetti diversissimi tra loro quali imperi, città-stato…
2. Il sistema interstatale sorto nel ‘600 è europeo e, per questo, eurocentrico, sorto sulle rovine dell’universalismo
medievale. Europeo era anche il diritto internazionale cresciuto dalle categorie del diritto romani; ed europeo
3
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
era soprattutto il protagonista di tale diritto, lo stato. Pertanto, sebbene l’attuale sistema internazionale abbia da
almeno un secolo un orizzonte globale, bisogna tener presente che tale globalizzazione è il risultato
dell’espansione mondiale di un’esperienza che, in origine, era specificamente europea.
3.1. Il carattere circoscritto e parziale della politica interstatale
L’aspetto interstatale delle relazioni internazionali costituisce uno spazio chiuso e circoscritto, dominato dal monopolio
statuale sulla diplomazia e la forza, e di conseguenza sui loro rispettivi esiti, la pace e la guerra.
Tuttavia, una società transnazionale è fatta di scambi commerciali, migrazioni di individui e gruppi, credenze comuni,
istituzioni indifferenti ai confini e composta oltre che dagli stati, da un’infinità di soggetti. Emerge così all’interno di un
sistema internazionale moderno, un equilibrio tra relazioni interstatali e relazioni internazionali non-statali. Addirittura
le relazioni commerciali ed economiche sono cresciute tanto da creare tra gli stati un’interdipendenza complessa sempre
più fitta e fra attori sempre più vari: stati, organizzazioni internazionali intergovernative, organizzazioni internazionali
non-governative, imprese multinazionali e singoli.
Tuttavia, ci sono questioni (a cominciare da quella ambientale) che non possono essere trattenute dalla geometria
politica e giuridica degli stati, così come non possono essere gestite da nessuno di essi senza il concorso di tutti gli altri.
3.2. Verso la crisi del sistema interstatale?
Nella possibile crisi della presa dello stato sulle relazioni internazionali convergono due processi diversi e storicamente
opposti.
1. Il primo riguarda i problemi del consolidamento dei sistemi interstatali regionali che compongono l’attuale
contesto internazionale. A differenza del sistema regionale dell’Europa centro-occidentale e di quello
americano, tutti gli altri sistemi sono sorti soltanto nel corso dell’ultimo secolo, sulle rovine di precedenti
sintesi imperiali. Sebbene in alcuni di essi il grado di consolidamento sia già sufficientemente elevato (Europa
centro-orientale e Asia orientale), in altri casi gli stati sono privi di istituzioni politiche efficienti (Rwanda,
Sierra Leone, Liberia, Congo, Somalia, o l’Afghanistan degli ultimi 20 anni, o lo stesso Iraq negli ultimi anni).
Capita spesso, inoltre, che stati dotati di tutti gli attributi necessari siano privi di riconoscimento internazionale,
come nel caso del Sud Africa fino alla fine dell’apartheid o in quello di Israele.
2. Il secondo riguarda l’orizzonte del sistema internazionale più consolidato, che ha dato segni crescenti di
cedimento, a causa di un problema di logoramento. La disponibilità degli stati a cedere parte delle proprie
prerogative sia verso il basso che verso l’alto, conferisce all’attuale convivenza internazionale un carattere
politicamente e giuridicamente ibrido, chiamato dalla letteratura governance multilivello.
4. LA DISCIPLINA CONTEMPORANEA DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
4.1. Una scienza americana?
Le restrizione dell’orizzonte storico nello studio delle relazioni internazionali produce una distorsione prospettica, che
induce a scambiare per normale ciò che, storicamente, è e resta un’eccezione. Ma ad aggravare questo rischio
contribuisce un’altra particolarità: da 60 anni a questa parte il centro di irradiazione di tutti i maggiori dibattiti teorici e
metodologici della disciplina sono gli Stati Uniti e l’insieme delle sue università, centri di ricerca e riviste scientifiche.
Non che siano mancate riflessioni sulla politica internazionale più o meno autonome rispetto a questo nucleo, ma
affinchè tali riflessioni potessero essere considerate parte del corpo disciplinare delle relazioni internazionali (cioè
essere incluse nei curricula, nelle bibliografie e nei programmi d’esame), esse hanno dovuto passare attraverso un
processo di selezione che ne ha recepite alcune ma a prezzo di rimuoverne completamente altre. Pertanto, come
disciplina accademica, le relazioni internazionali sono rimaste nel proprio nucleo fondamentale una scienza americana.
Come pesa tale distorsione prospettica sul modo in cui i problemi sono stati trattati e sul modo in cui sono stati scelti?
1. Una prima conseguenza è la costante centralità dei problemi posti dall’opinione pubblica, dai decision makers
e dalla comunità scientifica degli Stati Uniti.
2. La seconda conseguenza è la preferenza delle c.d. teorie istituzionalistiche delle relazioni internazionali per le
istituzioni sorte nell’ultimo secolo su iniziativa degli Stati Uniti (ONU, BM, FMI, OMC), invece che
concentrarsi su istituzioni di più lungo periodo quali la diplomazia, la prassi delle conferenze internazionali o
lo stesso principio di sovranità, cioè le istituzioni costitutive della convivenza internazionale degli ultimi 5
secoli.
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
3. La terza conseguenza è più seria. Per la stessa ragione per la quale ha privilegiato le vicende storiche più vicine
alla società americana, la riflessione contemporanea sulle relazioni internazionali ha ignorato altre questioni
fondamentali, a partire dalla fine della centralità dell’Europa e la dissoluzione dell’architettura politica,
economica, istituzionale e culturale da essa dettata ai rapporti tra Occidente e mondo.
4.2. Le relazioni internazionali e i traumi storici del Novecento
Si possono individuare differenti approcci allo studio delle relazioni internazionali, profondamente influenzati dagli
avvenimenti storici in cui nascono:
IDEALISMO – si afferma con l’istituzione della prima cattedra di International Politics nel 1919 in Galles, affidata a
Zimmern. L’intitolazione della cattedra da parte di Zimmern al presidente Wilson segnalano già quale fosse il problema
che la nuova disciplina scelse di individuare come fondamentale: la guerra come patologia da curare. Alla base c’è
l’esperienza delle prima guerra mondiale; questo trauma storico cambia la politica giuridica dell’Europa e nasce l’idea
che quello che è accaduto non deve più accadere. Le soluzioni proposte dall’idealismo riguardano tre possibili fattori
sul quale la guerra si fonda:
• Se la causa della guerra fosse la frammentazione delle relazioni politiche internazionali, e dunque la
divisione del mondo in stati, allora un aumento dell’interdipendenza economica potrebbe evitare la
guerra; con la crescita del commercio la guerra può essere evitata secondo la logica “perchè
sacrificare uomini e fare guerra ad un paese dove ho investimenti?
• Se la causa della guerra fosse la struttura anarchica della politica internazionale, e dunque la continua
ricerca della sicurezza nazionale che ne deriva, allora dovrebbero essere opposti dei meccanismi di
sicurezza collettiva, tramite l’istituzione di una organizzazione universale di sicurezza (la Società
delle Nazioni) e, in ultimo, la creazione di un vero e proprio governo mondiale.
• Se la causa della guerra fosse la natura bellogena di alcuni stati, allora sarà necessaria la
trasformazione di tutti gli stati in senso democratico e liberale.
Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale sancisce il fallimento di questo programma.
REALISMO - compare nel secondo grande trauma del ‘900 ovvero la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda,
che mettono a nudo le utopie dell’idealismo fallite. L’approccio realista rifiuta come prima cosa la fiducia propria
dell’idealismo nella possibilità di cambiare alla radice la natura della politica internazionale. A partire da qui, anche il
problema del rapporto tra guerra e pace fu riformulato. Proprio alla guerra e alla sua minaccia fu affidato il compito di
garantire la pace, o almeno di prevenire guerre peggiori, conformemente al presupposto che non sia necessario
perseguire la pace ad ogni costo, bensì opporre alla minaccia una minaccia ancora peggiore e all’aggressione certa una
più vantaggiosa guerra preventiva.
Avvantaggiato dalla perfetta rispondenza con il clima politico e strategico della guerra fredda, il realismo non fece
fatica ad affermarsi come il paradigma dominante delle relazioni internazionali postbelliche, quale sarebbe rimasto fino
alla fine degli anni ’80 e quale, per molti versi, rimane ancora oggi.
NEOMARXISMO - il realismo inizia ad essere sfidato con l’affermarsi di nuovi approcci che si diffondono tra gli anni
’60 e gli anni ’70, con l’inizio della decolonizzazione e la nascita di nuovi stati indipendenti. Questi approcci non
nascono tanto per il successo della decolonizzazione, ma per il disincanto che arrivò dopo, perché nulla era cambiato e
la dipendenza con i paesi dominanti era ancora più salda. C’erano infatti, alla base solidi rapporti economici e sociali
che non potevano essere sradicati.
Il problema delle scienze marxiste è trovare un modo per spezzare questa dipendenza. Il conflitto si spostava così
sull’asse Nord/ Sud e non più Est/Ovest. Riprendendo l’idea idealista, le scienze marxiste individuano nelle relazioni
economiche la chiave di volta dell’ordine internazionale. Eppure, come il realismo, in tali relazioni il neomarxismo non
cerca uno scampo alla guerra, bensì il luogo per eccellenza del conflitto e della gerarchia internazionale.
Dal momento che l’interdipendenza economica riproduce le disuguaglianze tra partner, è necessario sganciarsi dal
sistema capitalistico mondiale. Le soluzioni proposte sono dunque la rivoluzione internazionale e lo sganciamento dagli
automatismi dell’economia capitalistica mondiale.
A prescindere dal sottinteso politico-ideologico della teoria, l’approccio neomarxista offrì almeno 3 contributi alla
comprensione delle relazioni internazionali contemporanee:
1. il riorientamento delle dinamiche globali dall’asse Est/Ovest all’asse Nord/Sud, articolato a propria volta nella
bipartizione centro/periferia;
2. la riscoperta del lungo periodo, necessario a cogliere la formazione e la continua evoluzione dell’economia-
mondo capitalistica, e al cui interno la vicenda della guerra fredda perde la centralità accordatale dal realismo;
3. il riallacciamento del rapporto tra conflitti interni e conflitti internazionali, attraverso il ruolo connettore di
quei settori sociali il cui potere interno dipende simbolicamente dalla divisione del lavoro internazionale (ad
esempio la teoria della dependencia studia le ragioni di dipendenza tra Usa e America Latina, non solo la
struttura istituzionale ma quella interna;
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
Tuttavia, il successo delle tigri asiatiche che avevano adottato teorie economiche opposte alla teoria neomarxista a
partire dagli anni ’80, e l’indipendenza della Cina sono un chiaro esempio della scarsa credibilità di queste teorie.
ISTITUZIONALISMO LIBERALE (o neoliberalismo) – al contrario delle altre teorie, non nasce da uno shock ma da
una convinzione che si diffonde a partire dagli anni ’70 -’80. Le prime ragioni di comparsa di tale approccio sono di
carattere economico. Man mano che si allontanava la memoria della guerra, si diffonde l’idea che tra i paesi più forti
(Europa, Usa e Giappone) le relazioni riguardassero tematiche come quelle economiche, commerciali, ambientali, che
non avevano più a che fare con la preoccupazione realista per la sicurezza militare e la guerra; comincia pertanto ad
apparire improbabile un conflitto tra questi paesi. Lo shock petrolifero è la dimostrazione di quanto siano importanti le
interdipendenze economiche.
L’altra ragione legata alla nascita di questo approccio è il declino americano; con il crollo di Bretton Woods, la sconfitta
in Vietnam, lo scandalo Watergate e l’invasione russa in Afghanistan appare sempre più evidente la possibilità di un
declino dell’egemonia americana. Ma se davvero c’è un declino cosa succederebbe alle interdipendenze economiche?
La soluzione istituzionalista pone al centro il ruolo delle ISTITUZIONI. L’invenzione delle istituzioni come la BM e il
FMI sono un prodotto dell’egemonia americana ma, una volta consolidate, tali istituzioni possono vivere anche senza la
sua egemonia, e riusciranno a mantenere stabile l’economia. Esse inoltre incidono sul contesto internazionale per una
serie di motivi:
1. se in un sistema anarchico si introducono delle istituzioni consolidate queste abbassano i costi di transizione
quindi è più facile maturare accordi;
2. le istituzioni diminuiscono l’incertezza e la paura reciproca perché c’è un continuo scambio di informazioni
istituzionalizzate;
3. le istituzioni consolidate diminuiscono la propensione all’inganno perché se inganno qualcuno è possibile che
ritrovi la stessa persona in un altro negoziato e quindi se io baro posso avere delle ripercussioni in altre
trattative.
Il dibattito tra neorealismo e neoistituzionalismo è centrale nello studio delle relazioni internazionali: se esiste oppure
no una gerarchia dominata, secondo il realismo, dalla sicurezza militare; se dunque abbia ancora senso definire un’unica
gerarchia del potere internazionale (al cui vertice resterebbero i paesi più forti secondo il realismo) oppure sia meglio
riconoscere l’esistenza di diverse strutture di potere (economica, militare, ecc.); se le istituzioni internazionali siano puri
riflessi dei sottostanti rapporti di potere o invece delle variabili intervenienti.
Tuttavia, neorealismo e neoliberalismo hanno in comune alcune premesse:
• gli stati sono gli attori fondamentali del sistema internazionale,
• gli stati sono per entrambi egoisti e razionali,
• l’identità degli stati è data, e pertanto sono incapaci di apprendere perché il loro problema è cosa ottenere e
quanto ottenere.
COSTRUTTIVISMO – si rivolge contro questi 3 assunti e si afferma dagli anni ’70 a partire da uno shock, ovvero la
fine della guerra fredda, che porta a una decostruzione di identità, di stati, di regioni e di spazi. Gli stati non sono più
dunque gli attori fondamentali.
Il problema che si pongono i costruttivisti è come ricostruire l’ordine (come inventare un nuovo ordine e su che cosa?).
La soluzione proposta è molto simile a quella neoliberalista: le istituzioni già emergenti e consolidate. Comprendere le
istituzioni significa superare la dimensione statocentrica in quanto nelle istituzioni mature si trovano soggetti diversi
dallo stato (società civile, ONG). Rispetto ai neoliberalisti tuttavia, i costruttivisti si aspettano molto di più dalle
istituzioni che devono secondo loro rappresentare più soggetti. Le istituzioni devono cambiare il concetto di sicurezza e
riplasmare le identità degli attori per cambiare l’anarchia.
EQUILIBRIO DI POTENZA cap.2
1. LA TEORIA DELL’EQUILIBRIO DI POTENZA
1.1. Definizione di equilibrio di potenza
L’equilibriodi potenza (balance of power) è uno dei concetti più vulnerabili delle relazioni internazionali, e le sue
origini si innestano nella pratica della politica internazionale fin dalle sue origini. La migliore definizione di equilibrio
di potenza si riferisce a una situazione nella quale nessun attore, da solo o tramite alleanze può dominare tutti gli altri.
Una simile situazione richiede tre condizioni:
non è necessario che i vari attori siano dotati di uguali risorse, ma è necessario che la distribuzione di potenza
sia diffusa, in modo che l’attore più forte non sia in grado di sconfiggere tutti gli altri attori insieme;
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
una distribuzione diffusa della potenza non è sufficiente a garantire l’equilibrio.
l’ultima condizione riguarda il comportamento degli attori, che devono far prevalere una tendenza alla politica
di bilanciamento. Pertanto gli attori devono allearsi con il più debole contro il più forte ( balancing) e non viceversa
(bandwagoning).
Secondo il ragionamento di Bobbio, si può affermare che la teoria dell’equilibrio di potenza non sia una teoria della
fine della guerra, cioè del passaggio dallo stato di guerra potenziale allo stato di pace definitivo, bensì una teoria della
continuazione dello stato di tregua.
1.2. Equilibrio di potenza e realismo
l’equilibrio di potenza è fortemente influenzato dalla tradizione realista per tre principali motivi:
1. come tutte le teorie realiste, anche l’equilibrio di potenza è caratterizzato da una visione ciclica della storia,
secondo cui ci può essere progresso in altri settori (economico, tecnologico, sociale) ma nel campo della
politica internazionale ci sono leggi eterne e immutabili, appunto come quella dell’equilibrio, che ricorrono
nelle varie aree geografiche ed epoche storiche;
2. l’equilibrio di potenza si basa sui tre cardini della tradizione realista, ovvero lo stato come attore principale
della scena internazionale, la condizione anarchica del sistema internazionale, l’enfasi sulle questioni di
sicurezza.
3. l’equilibrio, in linea con la tradizione realista, si basa su fattori oggettivi e sull’interesse individuale degli stati,
definito in termini di potenza, piuttosto che su considerazioni soggettive.
Ci sono però due punti di vista sul funzionamento dell’equilibrio. C’è chi ritiene che l’equilibrio emerga
volontariamente come frutto di esplicite scelte da parte delle principali potenze, mentre altri sostengono che l’equilibrio
venga a verificarsi spontaneamente. Secondo Claude esiste anche una versione semiautomatica dell’equilibrio nella
quale è sufficiente che una sola potenza interpreti il ruolo di bilanciamento, schierandosi sistematicamente con il più
debole (come ad esempio la Gran Bretagna in epoca moderna, formando di volta in volta alleanze di contenimento).
VOLONTARIO – la prima visione caratterizza soprattutto il realismo classico nei primi 20 anni del dopoguerra. Un
esempio emblematico della teoria volontaristico è quella di Kaplan che afferma come siano necessarie delle regole per il
funzionamento di un meccanismo di equilibrio: gli stati dovrebbero opporsi a qualsiasi stato o coalizione che cerchi di
assumere una posizione di dominio sul sistema. Inoltre prevede che gli stati in guerra dovrebbero fermarsi prima della
distruzione del paese vinto, e dargli la possibilità di reintegrarsi nel sistema, in modo tale da poter sfruttare poi
coalizioni future con gli stati vinti.
Un discorso a parte merita la posizione della Scuola Inglese, ispirata al pensiero di Wight e Bull, che enfatizza la
possibilità da parte degli stati di condividere regole di governo. Tali regole internazionali consentirebbero il
mantenimento dell’ordine internazionale e il perseguimento di alcuni obiettivi primari: mantenimento dell’indipendenza
degli stati e della società internazionale. L’equilibrio di potenza non sarebbe dunque solo espressione della politica
estera di uno o più stati, ma una norma generalizzata di condotta propria della società degli stati, i quali conformandosi
ai suoi precetti garantirebbero la stabilità internazionale.
2. FUNZIONAMENTO DELL’EQUILIBRIO
2.1. L’equilibrio di potenza come teoria sistemica
SPONTANEO - La versione attualmente più influente sulla teoria dell’equilibrio di potenza è tuttavia quella
sistematica, secondo il quale l’equilibrio emerge spontaneamente. Il fondatore del REALISMO STRUTTURALE,
Waltz ha sostenuto che il sistema internazionale sia composto da unità (gli stati) e dalla struttura nella quale queste
operano. A sua volta, ogni struttura è composta da tre elementi:
1. il principio ordinatore (anarchico o gerarchico),
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
2. la differenziazione funzionale tra le unità,
3. la distribuzione delle capacità tra le unità.
Nel contesto internazionale, il principio ordinatore è quello anarchico perché non vi è un governo mondiale, non vi è
differenziazione funzionale perché tutti gli stati devono pensare da soli alla propria sicurezza (self-help) e l’unica
variabile rilevante rimane quella della distribuzione di potenza.
Il principio del self-help induce gli stati a schierarsi con il più debole contro il più forte. Se si astenessero dall’allinearsi
contro il più forte, si troverebbero prima o poi alla mercé dello stato che ha maggiori capacità di minacciare la sicurezza
o addirittura la sopravvivenza. In secondo luogo, se gli stati si alleassero con il più forte, forse otterrebbero dei vantaggi
maggiori nel breve periodo ma poi sarebbero costretti ad affrontare uno stato espansionista e rafforzato dalle ultime
conquiste. Pertanto, se il sistema è anarchico, l’equilibrio si verifica sempre e comunque, qualsiasi sia il livello di
sviluppo, il regime politico o preferenze ideologiche. In tal senso, la politica internazionale avrebbe caratteristiche
omeostatiche, nel senso che una potenziale fonte di instabilità genera spontaneamente forze contrarie, e tanto più forte è
lo shock esogeno che minaccia l’equilibrio, tanto più forti saranno gli incentivi a contrastarlo.
La TEORIA DEL DOMINIO (Bandwagoninig) prevede che anche un piccolo spostamento nella distribuzione di
potenza scateni ulteriori cambiamenti dello stesso segno. La teoria del domino fu una teoria geopolitica statunitense,
avanzata sia dai democratici che dai repubblicani, durante la Guerra Fredda. La teoria asseriva che se una nazione
chiave in una determinata area fosse stata presa dai comunisti, le nazioni vicine sarebbero cadute come pezzi di un
domino, diventando anch'esse comuniste una dopo l'altra.
Mentre nella teoria dell’equilibrio prevale una tendenza alla stabilità e alla naturale compensazione di cambiamenti,
nella teoria del dominio l’instabilità è frequente.
2.2. Flessibilità degli allineamenti
In entrambe le versioni, volontarista o spontanea, la teoria sull’equilibrio sottintende che gli stati si alleino in base a
condizioni esterne come la distribuzione di potenza e non in base alle preferenze ideologiche. Le alleanze di equilibrio
infatti non sono mai per qualcuno ma sono sempre contro qualcuno, e questo è definito non per la sua specifica identità
ma in termini della potenza in quel momento ad esso disponibile. Il più stretto degli alleati potrebbe quindi diventare, se
il suo potere crescesse eccessivamente, la più mortale delle minacce mentre il peggiore dei nemici potrebbe diventare,
se il potere diminuisse, il migliore degli alleati. Sembra dunque che le considerazioni ideologiche passino in secondo
piano quando le esigenze di equilibrio lo richiedano in modo impellente (vedi Unione sovietica e Usa nella II guerra
mondiale).
3. TIPI E FORME DI EQUILIBRIO
3.1. Bipolarismo e multipolarismo
Un vivace dibattito ha percorso la disciplina sulla relativa propensione all’equilibrio di vari sistemi internazionali in
base al numero di grandi potenze.
Il realismo classico ha sostenuto la preferenza per le configurazioni MULTIPOLARI (con più di due grandi potenze)
che comporta maggiori possibilità di trovare alleati potenziali e di mobilitare una quantità di risorse maggiori rispetto a
quelle dell’aggressore. Inoltre se uno stato ha molteplici controparti, disperderà tra esse la sua attenzione e pertanto sarà
più difficile che entri in una competizione mortale con un altro stato in particolare. Invece di rincorrersi l’un l’altro, gli
stati possono quindi ricorrere ad alleanze che garantiscano la sicurezza e che compensino le accresciute capacità di un
potenziale avversario.
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
Il realismo strutturale sostiene invece il BIPOLARISMO. Questa teoria presuppone due singole potenze; pertanto le
amicizie e le inimicizie sono dettate esclusivamente dal sistema internazionale stesso. In tale contesto
l’indeterminatezza è al minimo poiché ogni superpotenza è consapevole che la minaccia non potrà che provenire
dall’altra. Ciò porta a una minore dispersione di risorse da parte degli stati, ma anche la conseguenza che debbano
rispondere agli attacchi in prima persona. Questo ha un’importante conseguenza in quanto evita il fenomeno del
buckpassing, ovvero il rischio che gli stati preferiscano che sia un altro stato a contenere la minaccia, scaricando in
questo modo il barile. In un mondo bipolare, un’azione di una superpotenza provocherà immediatamente una risposta.
Ad esempio, durante la guerra fredda, gli Usa sapevano che il loro nemico era l’URSS, quindi la politica di sicurezza
americana sapeva qual era l’obiettivo e qual era il problema.
Se nei sistemi multipolari parte della sicurezza di uno stato dipende dai propri alleati, ci potrebbe essere una pericolosa
tendenza a sostenerli a qualsiasi costo nel timore di perderli, e questo potrebbe allargare un conflitto agli stati minori
coinvolgendo tutti gli alleati (sindrome del chainganging). Al contrario, in un sistema bipolare le superpotenze possono
o debbono contare esclusivamente sulle proprie forze. Mentre il multipolarismo dunque garantisce flessibilità degli
allineamenti, ma rigidità nelle strategie (sottostare alla necessità degli alleati), nei sistemi bipolari la rigidità degli
allineamenti offre agli stati una spiccata flessibilità nelle strategie. Se da un lato gli stati temono di essere abbandonati
dai propri alleati nel momento del bisogno, temono altresì di venire intrappolati dai propri partner a perseguire obiettivi
altrui solo per poter mantenere l’alleanza in vita (dilemma della sicurezza delle alleanze).
Vi è comunque un lato negativo del bipolarismo, ovvero l’impossibilità di trovare un compromesso tra le due
superpotenze, poiché questo sarebbe visto come una debolezza.
3.2. Equilibrio di minaccia
Un altro interessante dibattito riguarda la natura delle variabili che influenzano il comportamento di bilanciamento e
quindi l’equilibrio di potenza.
La teoria ortodossa presuppone che la variabile critica sia la potenza, ovvero lo stock di capacità, in particolare belliche,
a disposizione di uno stato. Tuttavia, questa teoria non ha alcun riscontro nella realtà. Ad esempio, all’indomani della
Seconda guerra mondiale, la maggior parte degli stati si è alleata con gli USA contro l’URSS, sebbene quest’ultima
fosse chiaramente meno potente.
Una teoria più complessa sull’equilibrio, introdotta da Walt, è basata sulla minaccia invece che sulla potenza. In breve,
gli stati non creerebbero delle alleanze contro lo stato più potente ma contro quello più minaccioso.
La minaccia è una variabile complessa, cha a sua volta dipende da 4 variabili:
potenza aggregata (capacità a disposizione di uno stato)
tecnologia militare (grado in cui le capacità sono in grado di essere trasformate in potere offensivo)
geografia (il potere è tanto più minaccioso quanto più vicino)
intenzioni (uno stato più aggressivo sarà ritenuto più minaccioso di quello che non ha nessuna ambizione
espansionistica)
3.3. Equilibrio di potenza e preferenze degli stati
L’ultima questione, collegata a quella delle intenzioni offensive degli stati, è costituita dal rapporto tra balance of
power e preferenze originate dalla natura interna degli stati, nel senso delle spinte ideologiche e dei meccanismi
istituzionali che determinano la politica estera. Le relazioni internazionali, a questo proposito, fanno una distinzione tra
potenze conservatrici e potenze revisioniste, ovvero interessate al cambio anche violento dell’ordine.
Secondo questa visione, i meccanismi di bilanciamento si innescano contro quelle potenze che sono revisioniste,
mentre non scattano contro potenze conservatrici che sono interessate al mantenimento dell’ordine. Da questo
approccio discende una classificazione dei vari sistemi internazionali a seconda che siano omogenei o eterogenei. I
sistemi di primo tipo sono caratterizzate da visioni ideologiche di tipo conservatore (possono esserci conflitti ma solo
relativi ad assetti istituzionali), mentre gli eterogenei sono quelli che hanno una visione della politica radicalmente
differente da quella comune. Questi sistemi sono intrinsecamente più instabili in quanto, oltre ai normali obiettivi di
politica estera, le potenze hanno anche un’agenda rivoluzionaria che mira a modificare gli assetti di politica interna
degli stati. I conflitti saranno dunque più sanguinosi.
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
Secondo il realismo difensivo o neoclassico, il meccanismo dell’equilibrio di potenza tende ad essere un sufficiente
deterrente per la maggior parte degli stati perché questi cercano sicurezza e si accontentano quando ne raggiungono un
ragionevole livello. Solo pochi stati non si accontentano della sicurezza acquisita, e vogliono massimizzare il proprio
potere fino al raggiungimento di una posizione egemonica. In tal caso però la prospettiva di una coalizione contro di
loro non funge da deterrente e l’equilibrio fallisce.
Schweller considera importanti le intenzioni degli stati per il funzionamento dell’equilibrio di potenza, dal momento
che stati revisionisti difficilmente si alleerebbero contro stati conservatori. Esistono 4 tipi di stati differenti, che
Schweller illustra con esempi tratti dalle origini della Seconda guerra mondiale :
1. quelli estremamente orientati alla difesa dello status quo (leoni, Gran Bretagna);
2. quelli interessati allo status quo (agnelli, Europa Orientale);
3. quelli interessati al revisionismo (lupi, Germania nazista);
4. quelli che si adoperano a guadagnare vantaggi opportunistici da un cambiamento degli assetti internazionali
(sciacalli, Italia fascista).
La stabilità non dipenderà dunque solo dalla logica dell’equilibrio, ma anche dal bilanciamento di queste forze (leoni e
agnelli contro lupi e sciacalli). Schweller introduce anche un’altra variabile necessaria per un bilanciamento efficace: la
capacità estrattiva. Uno stato, per poter contrastare una minaccia, deve poter essere in grado di mobilitare le risorse a
sua disposizione. Quindi, la strategia migliore per uno stato dipenderà anche dal consenso fra le sue elité politiche.
A queste critiche che sottolineano l’importanza delle variabili interne, lo strutturalismo risponde con una visione
offensiva, sostenendo che è sufficiente che stati in una condizione anarchica vogliano sopravvivere perché si
manifestino politiche sistematiche di bilanciamento.
Il realismo eterodosso introduce anche, oltre all’abilità diplomatica, una dimensione ideologica per la quale alcuni tipi
di stati producono maggiore instabilità con le loro finalità rivoluzionarie.
4. RISCONTRI STORICI DELL’EQUILIBRIO DI POTENZA
4.1. Equilibrio di potenza, guerra e stabilità
Il ragionamento di fondo dell’equilibrio di potenza sottolinea che una distribuzione equilibrata della potenza è la
migliore condizione per l’efficace funzionamento dei meccanismi della reciproca deterrenza e quindi, per trattenere gli
attori dal conflitto aperto. Nei rapporti diadici se la potenza di un attore eguaglia quella di un altro attore, allora
entrambi sanno che la guerra fra di loro avrà un esito molto incerto e produrrà costi elevati: di conseguenza essi si
asterranno dal conflitto. Una situazione di potenza diffusa implica invece l’esistenza di più grandi potenze di peso
simile che si possono coalizzare fra di loro per sventare un attacco di qualsiasi attore, che sarà dunque dissuaso dal
tentarlo.
L’idea è dunque che una particolare distribuzione della potenza produce incertezza circa la vittoria e, di conseguenza,
riduce il ricorso alla guerra stessa. La ricerca empirica ha dunque analizzato sia la nozione di potenza, intesa come
variabile indipendente, sia quella di guerra, che è la variabile dipendente dell’analisi.
La letteratura ha cercato di individuare le risorse che rendono potenti gli stati e ha costruito degli indicatori.
Il COW PROJECT ha prodotto un indice di potenza che aggrega diverse dimensioni delle capacità degli stati:
peso demografico
peso economico
peso militare
Il computo delle risorse detenute dagli stati non risolve però il problema della ricerca empirica sull’equilibrio di
potenza, così è stato costituito un ulteriore indice che studia i livelli di concentrazione. E’ dunque un indicatore che
calcola la capacità dei singoli stati e come sono diversamente dotati di risorse. In questo modo si possono individuare
gli stati che hanno una potenza concentrata o diffusa.
10
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
Per quanto riguarda la nozione di guerra, la gran parte dei contributi si è concentrata sulla guerra interstatale , e cioè sui
conflitti fra eserciti regolari di stati-nazione che producono almeno 1000 morti in battaglia, ignorando invece guerre di
tipo diverso, come le guerre civili o coloniali.
Nelle formulazioni più o meno classiche dell’equilibrio di potenza è rinvenibile un’IPOTESI MASSIMALISTA
secondo cui una distribuzione equilibrata di potenza porta ad una riduzione della guerra in generale (guerra di per sé)
nel sistema internazionale. Questa idea tuttavia non è prevalente nella letteratura più recente, dove prevale un’IPOTESI
MINIMALISTA secondo cui una distribuzione equilibrata di potenza porta a un aumento della stabilità del sistema
internazionale.
Per comprendere la differenza delle due ipotesi bisogna tener presente che la guerra produce sempre una qualche forma
di instabilità nel sistema internazionale. Tuttavia, un conto è la guerra che produce una diversa allocazione delle
risorse, un’altra è la guerra che elimina dal sistema internazionale uno o più dei suoi membri. Pertanto, mentre la teoria
massimalista guarda alla guerra di per sé, e quindi a ogni tipo di instabilità, quella minimalista sottolinea che la guerra
è spesso uno degli strumenti con cui gli stati hanno tradizionalmente conservato l’equilibrio nel sistema. Di
conseguenza, nel selezionare la variabile dipendente, si concentra sulla guerra che vede combattere le grandi potenze
del sistema e ha come posta in gioco la difesa dello stesso attore o coalizione di attori che vuole conquistare il
controllo. Questa teoria prevede che l’equilibrio di potenza impedisca che la politica espansionistica di un qualunque
attore possa esplicarsi fino al raggiungimento di una situazione egemonica e mettere a rischio l’indipendenza di tutti gli
attori. Dire infatti che un sistema politico internazionale sia stabile significa due cose: che esso resta anarchico, e che
nessuna variazione ha luogo nel numero delle parti principali costituenti il sistema.
4.2. Le aspettative empiriche alternative circa la stabilità
Diversi elementi testimoniano a favore delle aspettative empiriche dell’equilibrio di potenza nella loro versione minima.
Tuttavia queste evidenze sembrano riguardare solo periodi circoscritti della storia internazionale. Ci sono autori infatti
che sostengono che la parità di potenza fra gli stati sarebbe proprio la condizione che rende più probabile la guerra,
poiché quando la potenza è distribuita in modo equilibrato fra due attori uno di loro può sperare di vincere la guerra; e
che la guerra sarà meno frequente quando la potenza è distribuita in modo squilibrato, ovvero quando è concentrata.
MANSFIELD suggerisce il rapporto tra distribuzione delle capacità degli attori nel sistema internazionale e
l’occorrenza della guerra, nella forma di una U invertita. Quando la potenza è diffusa, la probabilità di guerra sarebbe
bassa, al crescere della concentrazione la guerra scoppierebbe più frequentemente ma, superata una certa soglia, la
probabilità del conflitto tornerebbe bassa.
4.3. Equilibrio di potenza e politiche di bilanciamento
Il bilanciamento è l’aspettativa empirica che riguarda il comportamento degli attori del sistema internazionale. In base a
questa aspettativa la tradizione dell’equilibrio di potenza prevede che, quando un particolare attore cerca di
massimizzare la propria potenza e di conquistare una posizione egemonica nel sistema internazionale, la risposta degli
altri attori sarà di opporre all’aspirante egemone una quantità di potenza sufficiente a equilibrare i rapporti di forza, così
da sventrare l’attacco.
Gli stati della variabile dipendente che confermano l’equilibrio di potenza possono assumere forme diverse:
1. autorestrizione dell’aspirante egemone che anticipa le politiche di bilanciamento diplomatico di fronte alla
concentrazione di potere nel sistema;
2. politiche di bilanciamento diplomatico di fronte alla concentrazione della potenza in capo a un attore del
sistema;
3. la formazione di uno schieramento di bilanciamento in una guerra che contrappone le grandi potenze del
sistema all’aspirante egemone.
La ricerca empirica si è concentrata sulle ultime due forme. La letteratura sottolinea, infatti, come i tentativi di
conquista del sistema internazionale che si sono storicamente verificati sono stati costantemente accompagnati dalla
formazione di coalizioni antiegemone e dei suoi alleati, portando alla periodica riorganizzazione politica dell’intero
sistema.
11
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
Anche l’aspettativa empirica circa il comportamento degli attori ha trovato critiche significative. Infatti le grandi
potenze tengono comportamenti diversi dal bilanciamento: quest’ultimo non può dunque essere considerato un
comportamento che ci si deve aspettare ma solo una delle possibili risposte. Schroeder infatti sostiene che nel periodo
tra 1684 e 1945, il periodo rispetto in cui vi è stato un alto consenso circa la validità del paradigma realista, gli attori
internazionali hanno seguito strategie differenti di bilanciamento. Per esempio fu adottato l’hiding (nascondersi dalla
minaccia, sottrarsi dal conflitto o rimanere neutrali) il transcending (risolvere il conflitto attraverso accorgimenti
istituzionali basati sul consenso internazionale o su atti formali), oppure il bandwagoning. A queste strategie sono
ricorsi sia stati grandi che piccoli, rendendo il bilanciamento una strategia rara e spesso di ultima istanza.
4.4. L’equilibrio di potenza e il sistema internazionale
contemporaneo
Le osservazioni di Cobden sostengono che l’equilibrio sia una pura illusione, un concetto privo di un significato
concreto. Inoltre, la teoria dell’equilibrio non offre strumenti precisi per definire la potenza degli stati né tantomeno
strumenti per limitare o annullare l’effetto di aumento di potenza derivante da mezzi pacifici quali il commercio o la
produzione.
La critica più radicale sostiene che l’equilibrio di potenza poteva essere frequente fino alla fine del 1800, ma che alcune
trasformazioni della politica interna lo hanno reso obsoleto nel sistema contemporaneo. In particolare:
Massificazione della politica: avvenuta negli ultimi cent’anni ha indotto gli stati a dover giustificare le proprie
scelte al pubblico. Queste ultime hanno prodotto politiche estere più ideologiche che legittimano la scelta in base ai
principi ideali. Inoltre le democrazie tendono ad allearsi tra loro a prescindere dalle variabili di potenza.
Accelerato ritmo di innovazione tecnologica che rende sempre più difficile calcolare l’impatto delle risorse
sugli stati.
Rapporto con la guerra: sebbene l’equilibrio, secondo i suoi sostenitori, ridurre l’incidenza o l’intensità dei
conflitti armati, sicuramente non li elimina completamente. Anzi, la guerra a volte è necessaria per ristabilire
l’equilibrio. Questa caratteristica poteva essere sopportata finchè le guerre erano relativamente poco distruttive e non
toccavano direttamente la vita dei civili. Ora però, la stabilità garantita dall’equilibrio è stata considerata insufficiente.
Ikenberry segnala che vi sono tre possibili tipi di ordine nella politica internazionale:
1. dell’equilibrio (spontaneo),
2. costituzionale (negoziato)
3. egemonico (imposto).
L’insoddisfazione verso il primo tipo, ha indotto a spostare l’attenzione sugli altri due. Da un lato, in seguito alla Prima
guerra mondiale che era stata attribuita almeno in parte il fallimento del sistema di alleanze basato sull’equilibrio di
potenza, è stato introdotto il concetto di sicurezza collettiva. Si tratta di una soluzione istituzionale, alternativa
all’equilibrio, che ha ispirato la costituzione della Società delle Nazioni e, dopo il 1945 delle Nazioni Unite.
Dal momento che i meccanismi di balancing erano inaffidabili, la sicurezza collettiva mira ad introdurre un
meccanismo più certo, istituendo un obbligo legale a sostenere le vittime di un attacco e promettendo protezione
all’intero sistema internazionale. Tuttavia, le organizzazioni di sicurezza non hanno avuto risultati decisivi, ma solo
parziali. Altri hanno ipotizzato un mantenimento della stabilità internazionale che poggia non tanto su un equilibrio
quanto su una chiara gerarchia di potenza, con un attore dotato di una forza preponderante sugli altri (teorie
dell’egemonia).
12
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
EGEMONIA cap.3
1. TEORIA DELL’EGEMONIA
1.1.Definizione di egemonia
Il termine egemonia indica la guida che veniva riconosciuta ai capi supremi degli eserciti. Per estensione, la parola
designava la relazione tra Atene e le altre città-stato elleniche, quando, per difendersi dall’impero persiano, formarono
una lega della quale Atene era a capo, pur essendo preservata l’indipendenza di ogni singolo alleato. Applicato al
sistema internazionale, il termine definisce la supremazia di uno stato che, sulla base di risorse di varia natura, ha una
preminenza sulle altre unità statuali.
L’egemonia designa pertanto l’influenza che una grande potenza stabilisce sopra gli altri Stati del sistema, e che può
variare dalla leadership al dominio. L’estensione dell’egemonia può riguardare l’intero sistema politico internazionale
(USA dopo il 1989) oppure essere limitata a un sottoinsieme regionale (egemonia austriaca sugli stati dell’Italia
preunitaria fino al 1860).
In termini generali è possibile descrivere la politica internazionale come una successione di ordini che vengono imposti
al mondo dalla potenza egemone di turno, per cui l’evoluzione di qualsiasi sistema è stata caratterizzata dal successivo
emergere di stati potenti che hanno governato il sistema stabilendo i modelli delle interazioni internazionali e le regole
del sistema affermando il proprio ruolo attraverso guerre di ampia portata.
1.2. Il tema dell’ordine internazionale
È possibile suddividere le teorie dell’egemonia tra:
• TEORIE OLISTICHE (o globaliste), che hanno come unità d’analisi il sistema internazionale – quali la teoria
dei cicli lunghi e quella dell’economia-mondo;
• TEORIE RIDUZIONISTE, che hanno come unità di analisi lo stato e le relazioni tra Stati – quali la teoria
della stabilità egemonica e la teoria della transizione di potere.
Con l’eccezione della teoria del ciclo di potenza di Doran, tutte le teorie sull’egemonia sono accumunate da un’idea di
fondo: che la stabilità del sistema internazionale dipenda da una concentrazione di potenza, cioè da una distribuzione
diseguale ma ottimale della potenza all’interno del sistema stesso. E’ l’ipotesi opposta a quella su cui si basano le teorie
dell’equilibrio di potere. Tanto più è evidente la disparità nella distribuzione di potenza tra egemone e sfidanti, tanto
meno probabile sarà il ricorso alla guerra. Quest’ultima viene considerata non soltanto come la più grave minaccia
arrecata a qualunque ordine internazionale, ma è anche la modalità principale attraverso cui avvengono le successioni
tra potenze egemoni.
Gli studi sull’egemonia muovono prevalentemente dalla tradizione realista delle Relazioni internazionali. I teorici
dell’egemonia, in particolare, accettano la premessa realista della natura anarchica dell’area internazionale, ma
ritengono che l’ordine derivi dalla concentrazione di potere e che, quando l’ordine è assente, il disordine
contraddistingue la politica. La fonte massima di instabilità è legata al declino della potenza dominante che concede
spazio alle aspirazioni degli sfidanti di rimpiazzare l’egemone attraverso una guerra costituente.
L’ipotesi di fondo è che l’ordine internazionale sia, nel corso del tempo, stabilito dall’esito di una grande guerra
costituente che è all’origine di una nuova epoca. Di solito, nel momento in cui l’egemonia si delinea, l’ordine tende
verso la stabilità. Quando invece l’ordine precedente è messo in crisi da una nuova distribuzione e articolazione del
potere, cioè quando la supremazia dell’egemone vacilla e incomincia a declinare, allora è possibile che il sistema sia
soggetto ad instabilità. In questo susseguirsi di ordini non è però riscontrabile una logica evolutiva, in quanto la solidità
di ciascun sistema dipenderà dal tipo di guerra che lo ha generato. Infatti, nel caso dell’egemonia americana successiva
all’89 ci si chiede se una delle cause della sua fragilità non sia da ricercare proprio nel fatto che il conflitto che l’ha
generata sia stato la guerra fredda, e non una guerra vera e propria.
La stabilità/ instabilità dell’egemone dipende anche da:
Risorse possedute dall’egemone (militari, economiche ecc)
13
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
Impegni a cui deve e vuole rispondere
Configurazione del territorio in cui opera
Tipo di egemonia (coercitiva, benevola o costituzionale)
Attitudine comportamentale degli altri attori
1.3. Egemonia tra impero e leadership
Secondo la teoria egemonica, ipotizzare che il sistema intero sia anarchico è una semplificazione errata. Esistono,
infatti, relazioni di carattere autoritario. In una relazione di autorità A vuole che B segua, e B volontariamente
acconsente. Altrettanto semplicistico è immaginare un sistema internazionale dominato esclusivamente da rapporti di
forza. In realtà le fonti dell’autorità sono molteplici e vanno dalla religione all’ideologia, fino al commercio. Possiamo
dunque distinguere due varianti di egemonia:
LEADERSHIP BENEVOLENTE e LEADERSHIP COERCITIVA. Nel primo caso è esclusivamente il leader che
fornisce il bene collettivo della sicurezza e dell’implementazione dei regimi internazionali, lasciando gli altri stati liberi
dall’onere di contribuire. Nel secondo caso l’egemone impone la partecipazione all’ordine economico e ai regimi
internazionali e costringe gli altri attori a condividere i costi del bene collettivo attraverso tassazioni. Per un egemone
coercitivo la possibilità di sfruttare gli altri sono normalmente circoscritte; in caso contrario aumenteranno le
probabilità di sfide e il costo complessivo dell’egemonia. 1 In realtà è difficile immaginare l’egemonia come puro e
semplice esercizio di potere, senza ammettere che la stabilità dell’egemone possa dipendere tanto dalla coercizione
quanto dal consenso e dalla capacità di generare collaborazione presso le élite degli altri stati. In questo senso si
definisce impero un sistema istituzionale, in cui la classe politica ha ottenuto ed esercita stabilmente potere sulla classe
politica di una o più sintesi politiche precedentemente sovrane, senza però dissolvere o assorbire queste ultime.
Aron individua nella pace egemonica il punto intermedio tra la pace d’equilibrio e la pace dell’impero. Nella pace
egemonica, l’assenza di guerre dipendente dalla superiorità incontestabile di una delle unità; ma tuttavia lo stato
egemonico non cerca di assorbire le unità ridotte all’impotenza. Per gli stati più potenti, l’aspirazione all’egemonia ha
un’attrattiva, ma questa non la rende priva di costi.
Ikenberry esplora le ragioni per cui gli stati secondari optano per l’ubbidienza alle potenze egemoni. Egli parte dalla
considerazione che le strategie postbelliche di moderazione, attualmente, ricercano l’equilibrio tramite la costruzione di
un sistema internazionale dotato di pesi e contrappesi, legato a logiche istituzionali. Proprio la logica istituzionale
contribuisce a spiegare la notevole stabilità dell’ordine post 1945 tra le democrazie industrializzate. Su queste
premesse, Ikenberry individua tre tipi ideali di ordine internazionale:
1. equilibrio di potenza
2. egemonia
3. costituzionalismo
In questa prospettiva l’egemonia non è altro che una modalità di realizzazione dell’ordine. Se gli stati-guida e quelli
secondari sono disposti a realizzare un ordine basato su istituzioni vincolanti, l’ordine assumerà caratteristiche
costituzionali. Le istituzioni, che l’egemone stesso crea, giocano un ruolo determinante per la stabilità. Esse mentre
tutelano i più deboli, consentono allo stato-guida di esercitare la propria egemonia risparmiando il potere politico-
militare. Le istituzioni si assumono così il compito di tutelare l’ordine e la collaborazione, sin dall’inizio dell’egemonia,
subito dopo la “vittoria”. Questo dimostra che le relazioni di potenza asimmetriche, soprattutto se sviluppate tra stati
democratici, sono compatibili con un ordine politico stabile.
1
Definisco egemonia vera la direzione temporanea da parte di uno stato su di uno o più altri stati che diventano seguaci
per effetto di una sottomissione più o meno volontaria.
14
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
2. IL TEMA DEL CAMBIAMENTO E IL RUOLO DEL CONFLITTO
Gilpin analizza, nella TEORIA DELLA STABILITA’ EGEMONICA (riduzionista), come cambiano i sistemi politici
internazionali e il ruolo della guerra nel determinare le successioni tra potenze egemoni. Il concetto di cambiamento nel
campo delle relazioni tra Stati è articolato su tre livelli:
il mutamento dei sistemi: riguarda la natura degli attori o dei diversi enti che compongono un sistema
internazionale (es. da impero a stati)
mutamento sistemico: un cambiamento nella forma di controllo o governo di un sistema internazionale. Si ha
mutamento sistemico quando si produce una frattura tra il sistema sociale esistente e la redistribuzione del potere.
mutamento di interazione: un cambiamento che risulta da regolari interazioni o processi tra entità del sistema
internazionale.
Solo la presenza di un egemone può garantire una duratura stabilità al sistema, ma quest’ultima è resa difficile da una
serie di fattori come, ad esempio, una diseguale distribuzione del progresso tecnologico ed economico. Inoltre, mentre
la potenza egemone vede declinare il suo potere effettivo, le potenze in ascesa soffrono di una c.d. inconsistenza di
status, cioè hanno un rango che percepiscono inferiore alle proprie legittime aspirazioni e capacità.
Gilpin riassume gli effetti di un cambiamento sistemico:
1. un sistema internazionale è stabile se nessuno stato ritiene vantaggioso un mutamento del sistema
2. uno stato tenterà di mutare il sistema internazionale se i benefici attesi superano i costi
3. uno stato cercherà di cambiare l’assetto internazionale attraverso l’espansione territoriale, politica ed
economica fino a quando i costi marginali non eguagliano i benefici
4. una volta raggiunto l’equilibrio tra costi e benefici relativi a ulteriori cambiamenti, i costi economici del
mantenimento dello status quo tendono a crescere più rapidamente della capacità economica di sostenere lo
status quo
5. se non si risolve lo squilibrio del sistema internazionale, il sistema verrà modificato e si stabilirà un nuovo
equilibrio che rifletterà le redistribuzione del potere.
La TEORIA DELLA TRANSIZIONE DI POTERE (riduzionista) analizza il gap tra rango e capacità (tra status e
potere) inteso come fattore di instabilità che innesca il cambiamento, e associa direttamente l’esplodere di un conflitto
di grandi dimensioni al mutamento nella struttura di potere all’interno del sistema politico internazionale. Quanto più la
distribuzione delle capacità politiche ed economiche e militari tra gli stati membri del sistema internazionale si
distribuisce equamente, tanto più cresce la possibilità di guerra. Mentre la pace è di fatto meglio tutelata da uno
squilibrio tra nazioni avvantaggiate e svantaggiate. La pace è pertanto il risultato di una distribuzione diseguale del
potere, che quanto più è marcata, tanto più scoraggia la tentazione di eventuali sfidanti di ottenere un cambiamento
della propria posizione, all’interno del sistema.
Secondo la TEORIA DEL CICLO DI POTERE di Doran, nel sistema politico internazionale ogni Stato ha un ruolo, che
riflette il suo potere relativo, le sue aspirazioni e la loro accettazione da parte del sistema. Quando potere e ruolo vanno
fuori sincronia, crescono i rischi del verificarsi di momenti critici del sistema. Ogni scostamento dalla posizione di
equilibrio per il singolo Stato si riflette dunque sul sistema.
In base alla TEORIA DEI CICLI LUNGHI (olistica), la guerra egemonica è il motore permanente del mutamento
politico e anche un modo di selezionare la leadership. Questo da luogo a periodi di dominio globale da parte di alcune
potenze mondiali, che nell’esperienza storica hanno assicurato l’ordine nel sistema internazionale. Il fattore che
scandisce il passaggio da un ciclo all’altro è quindi costituito dalla guerra, più precisamente da una guerra generale o
“globale”, cioè un conflitto in cui almeno una parte ha buone probabilità di ottenere la vittoria decisiva, che può far
emergere un nuovo leader e provocare una trasformazione del sistema.
15
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
3. LE RISORSE DELL’EGEMONIA: MILITARI, ECONOMICHE,
INTELLETTUALI
Molto ampio è lo spettro di quelle che vengono considerate le risorse dell’egemonia. Le principali sono la supremazia
militare (soprattutto navale), la leadership economica (in particolare in termini tecnologici e di commercio su lungo
raggio) e l’influenza intellettuale (in termini di produzione di idee e di istituzioni). In realtà solo la combinazione di più
risorse riesce a determinare il successo di un attore nel conseguire l’egemonia.
3.1. La supremazia militare
Nessuna teoria considera la forza militare pura e semplice una fonte sufficiente di egemonia, ma quasi tutte insistono
nella necessaria presenza di una supremazia militare. Egemonia è la capacità di proiettare la forza militare su scala
globale che consente ad una potenza di acquistare una posizione dominante nell’economia mondiale. Un’importanza
cruciale è rivestita dal potere marittimo. È il dominio dei mari che permette all’egemone di creare un sistema di
transazioni commerciali a vasto raggio e di trarne profitto. Un aspetto fondamentale è sottolineare la relazione tra
egemone e sfidante maggiore. Non è detto che il ruolo della potenza mondiale incida su tutte le transazioni che
avvengono a livello regionale. Questo fa si che le guerre globali portino a nuovi sfidanti, attraverso la frattura che si
sperimenta nella coalizione vincitrice.
3.2. La leadership economica
Wallerstein sostiene nelle TEORIA DELL’ECONOMIA-MONDO (olistica) che: l’economia-mondo capitalista ha
proceduto attraverso fasi di espansione e di concentrazione, così come sostiene che il grado di concentrazione del potere
passa attraverso cicli con periodi di concentrazione che cedono il passo a periodi di multipolarità. La relazione tra cicli
economici e cicli di potere sta nel diseguale e ingiusto sviluppo dell’economia-mondo capitalista, che consente
l’emergere periodico di una potenza egemone, con una posizione economica superiore rispetto agli altri. Secondo W. è
possibile parlare di egemonia solo nelle situazioni in cui una grande potenza ha un’efficienza economica in termini
produttivi, commerciali e finanziari. L’egemone acquisisce la propria posizione grazie ai vantaggi che riesce a
realizzare in termini di produttività agricola ed industriale. Questo consente di praticare prezzi più competitivi.
L’apertura dei mercati può essere imposta con la guerra. È importante sottolineare che nonostante lo sviluppo diseguale
abbia prodotto un ciclo ricorrente dell’egemonia, non c’è certezza che un nuovo egemone emergerà, infatti ci sono
lunghi periodi nei quali nessun egemone è evidente. Secondo Wallerstein le differenza nella distribuzione del potere
sono dovute alle differenze in termini di dimensioni e tassi di crescita dei singoli stati che compongono il sistema
internazionale. Un ulteriore elemento importante è sicuramente l’aspetto del progresso tecnologico. Con la modernità,
potere economico e ricchezza tendono a coincidere, diventando elementi decisivi nella distribuzione internazionale di
ricchezza e potere nella lotta per l’egemonia. Le dimensioni del paese e il punto di partenza contano nel determinare la
capacità di disturbare l’equilibrio del sistema, almeno tanto quanto la velocità con cui avviene la modernizzazione.
3.3. L’influenza intellettuale
Perché un attore possa esercitare una vera e propria egemonia, non bastano le risorse materiali, cha danno vita
all’HARD POWER (potere militare ed economico) ma è necessario possedere anche il SOFT POWER, ovvero la
capacità di attrarre e sedurre: esso consiste nell’indurre gli altri a fare ciò che si desidera, e si affida alla capacità di
definire le priorità plasmando le preferenze altrui. Affinchè l’egemone sia in grado di raggiungere i suoi scopi in
politica internazionale, è necessario che gli altri paesi che ammirano i suoi valori, emulano il suo esempio e aspirano al
suo stesso livello di prosperità, desiderino seguirlo. Bisogna comunque tenere presente che il potere egemonico deve
essere distinto dal puro potere di persuasione, perché l’egemonia non nasce solo dalla forza di attrazione, ma dalla
combinazione di tutti i tipi di potere: di coercizione, condizionamento e persuasione fondati sostanzialmente su
leadership militare, supremazia economica e sull’influenza intellettuale.
4. LIMITI E ALTERNATIVE ALL’EGEMONIA
4.1. Perchè le egemonie finiscono
Tutte le teorie sull’egemonia concordano su un punto: ogni egemonia è per definizione temporanea. Tutte le egemonie
sono transitorie perché i costi crescono più rapidamente delle risorse necessarie al loro mantenimento. Per l’egemone è
16
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
dunque impossibile conservare nel lungo periodo il monopolio delle capacità tecnologiche ed economiche all’origine
del proprio successo. A ciò occorre sommare le crescenti aspettative dei cittadini, i quali rifiutano di continuare a
sopportare i sacrifici necessari per preservare il ruolo egemonico, e spingono affinchè i consumi interni vengano
privilegiati. Una combinazione di fattori interni ed esterni determina una seria crisi fiscale per l’egemone che non ha
molte alternative per venirne fuori. Può cercare di capovolgere il trend interno o attaccare l’eventuale sfidante per
ridurre il gap di potere. Oppure può ridurre il livello del proprio impegno internazionale e promuovere alleanze
strategiche con altri stati.
Una delle ragioni per cui, nel lungo periodo, i costi di mantenimento dell’ordine nel sistema arrivano a superare i
vantaggi consiste nell’iperestensione o overstretching. Per evitare il rischio di un possibile overstretching, l’egemone
può iniziare a ritirarsi, cioè a ridurre la propria azione in aree e settori che siano vitali per il proprio interesse nazionale.
Ma questo genera instabilità nell’equilibrio del sistema e può indurre eventuali sfidanti a tentare la via del conflitto. La
crisi dell’egemone segue quindi il percorso contrario rispetto a quello che aveva permesso la sua ascesa: dispersione dei
vantaggi tecnologici, crescita del costo del lavoro, declino commerciale e infine una minore efficienza finanziaria con
una conseguente fuga di capitali.
4.2. Egemonia e cooperazione
Kindelberg affermava la necessità di uno stabilizzatore, affinché il sistema si mantenesse stabile.
L’esistenza di un egemone non è sufficiente ad assicurare la stabilità, intesa come bene pubblico fornito dall’egemone
ma di cui possono godere anche gli altri Stati. La stabilità può essere assicurata dunque solo quando l’egemone decide
di sopportare i costi necessari per fornire il bene collettivo e riesce a ottenere il sostegno da parte degli altri stati.
Kindelberg individua inoltre 5 responsabilità che l’egemone si deve assumere affinché il sistema rimanga stabile:
1. mantenere un mercato relativamente aperto per le scorte in caso di difficoltà
2. provvedere alla fornitura di prestiti a lungo termine
3. sostenere il credito durante la crisi
4. gestire la struttura dei tassi di cambio
5. assicurare un certo grado di coordinamento delle politiche monetarie nazionali.
Tali funzioni possono essere sintetizzate nel concetto di infrastruttura economica internazionale. La presenza di un
attore egemone dovrebbe essere la condizione necessaria affinché le norme e le istituzioni che garantiscono la stabilità
del sistema possano essere create, mantenute e applicate. L’egemone dovrebbe assicurare la stabilità e imporre i costi ai
beneficiari oltre che svolgere funzioni di polizia. L’incentivo alla cooperazione da parte degli altri attori coinvolti deriva
proprio dall’interesse egoistico di questi.
Secondo Keohane, l’egemonia facilita la cooperazione mentre il declino rende più difficile la cooperazione, mettendo a
rischio i regimi egemonici e dunque l’ordine e la stabilità internazionale. Bisogna comunque tener presente che,
sebbene l’egemonia possa facilitare la cooperazione, essa non è condizione necessaria e sufficiente per ottenerla.
Keohane nota infatti che i modelli di cooperazione sorti sotto l’egida dell’egemonia americana sono sopravvissuti al suo
declino.
17
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI cap.4
1. LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI TRA SPERANZE E
SCETTICISMO
Le istituzioni internazionali offrono un quadro di principi e regole che pongono freni all’arbitrio degli stati nei loro
comportamenti reciproci e pertanto vengono frequentemente invocate come correttivo essenziale al carattere anarchico
delle relazioni internazionali. Inoltre esse consentirebbero ai governi di affrontare una serie di problemi sentiti da tutti,
(di natura economica, ambientale e sociale). Allo stesso tempo, le istituzioni internazionali sono anche oggetto di
considerevole scetticismo, a causa dell’impossibilità di queste di usare legittimamente la forza per vincolare l’azione
degli stati.
Occorre prima di tutto fare una distinzione
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONE
gruppo di individui dotato di una struttura formale e insieme di regole che sfruttano l’interazione tra individui
orientato verso un obiettivo comune. e gruppi definendo i comportamenti permissibili e non
permissibili.
Le organizzazioni internazionali sono entità materiali Le istituzioni internazionali sono sistemi di regole
composte da persone di vario tipo che usano risorse per accettati dai vari stati che stabiliscono come essi devono o
perseguire obiettivi stabiliti collettivamente dagli stati che non devono comportarsi gli uni nei confronti degli altri.
li hanno creati.
Nel linguaggio comune si fa spesso confusione. Questo perché la maggior parte delle istituzioni internazionali sono
gestite da un’organizzazione internazionale, e generalmente gli stati creano simultaneamente entrambe. Ma è comunque
possibile che esista una istituzione internazionale senza che vi sia una organizzazione incaricata di gestirla e viceversa.
Lo studio delle istituzioni internazionali precede di molto l’affermazione delle Relazioni Internazionali come disciplina
accademica della prima metà del 20° secolo. I teorici dello jus gentium del 1600 e del 1700 miravano a definire le
regole di condotta di stati sovrani, ma ritenevano che ogni limitazione del loro potere dovesse provenire dai sovrani
stessi piuttosto che da accordi internazionali. Gli autori di fine ‘700 inizi ‘800 invece elaboravano piani per la creazione
di assemblee di sovrani, assemblee popolari e corti internazionali che avrebbero dovuto formare la struttura
organizzativa per un diritto internazionale vincolante. La nascita della moderna disciplina di Relazioni internazionali
all’indomani della prima guerra mondiale era motivata, in questo senso, dalla volontà di approfondire la conoscenza
18
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
delle condizioni che favoriscono la cooperazione pacifica tra gli stati e il ruolo che le istituzioni internazionali possono
avere nel promuovere la cooperazione.
La tradizione istituzionalista apparve con variegate basi teoriche: teoria funzionalista, teoria neofunzionalista, teoria dei
regimi, costruttivismo, approccio della global governance.
2. ISTITUZIONALISMO REALISTA
2.1. Genealogia dell’istituzionalismo razionalista
L’istituzionalismo realista emerse a partire dagli anni ’80 in risposta a precedenti approcci istituzionalisti e alle critiche
realiste che furono mosse contro di essi. Tra i precursori istituzionalisti sono particolarmente importanti:
FUNZIONALISMO (sviluppato da Mitrany) NEOFUNZIONALISMO (sviluppato da Haas)
Lo stato come forma di organizzazione sociale aveva L’integrazione sovranazionale in un settore di policy (per
dimostrato di essere incapace di soddisfare i bisogni esempio il carbone e l’acciaio) genera incentivi nei settori
fondamentali degli individui e pertanto doveva essere più vicini. Tale effetto, c.d. spill-over, può essere
affiancato da nuove forme di autorità basate sulle funzionale (dovuto all’interdipendenza tra i settori
conoscenze tecniche ed economiche, che avrebbero del’economia moderna) oppure politico (promosso dalle
ridotto la salienza dei conflitti internazionali e promosso èlite amministrative ed economiche).
la pace durevole. Mitrany riteneva che, a un certo punto,
la lealtà della popolazione nei confronti di queste nuove
benefiche agenzie funzionali avrebbe superato quella nei
confronti delle vecchie autorità statali, dando vita a una
nuova forma di organizzazione politica globale.
2.2. Assunti e ipotesi
L’istituzionalismo realista nasce come tentativo di mostrare che l’egemonia non è una condizione necessaria per
assicurare la cooperazione in condizioni di anarchia. Keohane dimostra come la cooperazione sia possibile anche in
assenza di un egemone e che le istituzioni internazionali hanno un ruolo essenziale nel promuovere tale cooperazione.
Per dimostrare ciò, accetta gran parte degli assunti generalmente associati con la tradizione realista delle relazioni
internazionali:
1. la centralità degli stati nelle relazioni internazionali;
2. gli stati agiscono secondo i dettami della razionalità strumentale, ossia scelgono la possibilità di azione che
produce maggior utilità;
3. gli stati badano solo ai propri interessi;
4. gli stati operano in un mondo anarchico, privo cioè di governo mondiale capace di far rispettare gli accordi,
prevenire o punire comportamenti aggressivi.
Il punto di partenza della teoria istituzionalista sono le preferenze degli stati, considerate esogene rispetto alla teoria
stessa, cioè sono prese come date senza chiedersi come siano nate. L’uso della teoria dei giochi è, in tale contesto, un
elemento importantissimo nella ricerca istituzionalista: esso offre una serie di preposizioni sul legame tra preferenze
individuali, vincoli strategici e le probabilità di esiti cooperativi. La teoria si presenta tuttavia parziale, in quanto sarà
necessaria una teoria aggiuntiva che spieghi quello che gli stati vogliono quando agiscono sulla scena internazionale.
Un seconda caratteristica della teoria è la logica funzionalista: l’esistenza delle istituzioni, e la loro stessa forma, viene
spiegata in termini di funzioni che esse devono svolgere per portare benefici agli stati.
La teoria dell’istituzionalismo razionalista ha tuttavia un altro limite: non si applica a tutte le situazioni in cui gli stati si
possono trovare. In particolare non si applica a situazioni in cui gli interessi degli stati coincidono perfettamente e
19
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
pertanto sono superflue sia la cooperazione che le istituzioni. Né si applica a situazioni in cui gli interessi degli stati
sono del tutto incompatibili, nel senso che qualunque cosa che avvantaggia uno stato rappresenta un danno equivalente
per l’altro. L’istituzionalismo si applica a quella vasta gamma di situazioni in cui gli interessi sono parzialmente
compatibili e parzialmente conflittuali.
2.3. Collaborazione e coordinamento
Tra i vari tipi di situazione caratterizzati da preferenze miste, l’attenzione degli istituzionalisti si è concentrata su due
gruppi particolarmente importanti:
Nei GIOCHI DI COLLABORAZIONE gli stati traggono vantaggi maggiori da un esito in cui tutti operano
rispetto ad un esito in cui nessuno coopera, ovvero defezionano. In realtà, un interesse comune alla cooperazione non è
sufficiente a garantire un esito cooperativo. In molte situazioni, infatti, uno stato può trarre vantaggio dalla
cooperazione reciproca, ma un vantaggio ancora più grande se tutti cooperassero ed esso defezionasse. L’interesse
individuale a defezionare di regola prevale sull’interesse comune a cooperare. Tali situazioni sono esemplificate dal
c.d. dilemma del prigioniero: ad esempio in ambito di negoziati bilaterali agli armamenti, entrambi gli stati possono
preferire una limitazione dell’arsenale nucleare dell’avversario, ma una riduzione delle testate nucleari dell’avversario
senza una propria corrispondente limitazione, può essere un esito ancora più desiderabile.
Nei GIOCHI DI COORDINAMENTO gli stati hanno solitamente un interesse comune nel raggiungere un
accordo, ma un conflitto di interessi rispetto ai termini dell’accordo stesso. La cooperazione è preferita alla mancanza
di cooperazione, ma sono possibili diverse forme di cooperazione e i partecipanti non preferiscono tutti la stessa
soluzione. I giochi di coordinamento richiedono generalmente un processo negoziale attraverso il quale gli stati
identificano una soluzione di compromesso. Ma anche in questo caso l’interesse individuale a raggiungere l’accordo
preferito, prevale sull’interesse comune a raggiungere un accordo qualsiasi. Questo accade perché allo scopo di
ottenere una distribuzione dei benefici che sia più vantaggiosa possibile, i negoziatori usano tattiche che aumentano il
rischio che il negoziato fallisca, come il bluff.
Sia i giochi di collaborazione che quelli di coordinamento, combinano incentivi a cooperare con incentivi a scegliere
comportamenti non cooperativi. Una differenza sostanziale tra i due tipi di giochi è che, una volta stabiliti i termini
dell’accordo, nei giochi di coordinamento i partecipanti non hanno un interesse nel violare i termini dell’accordo,
mentre nei giochi di collaborazione i partecipanti trarrebbero vantaggio dalla defezione unilaterale. Secondo gli
istituzionalisti, alla base di questi problemi si trova spesso un deficit di informazione. Se infatti gli stati in situazioni di
coordinamento possedessero un’informazione perfetta sul rischio di defezione, potrebbero sviluppare meccanismi di
deterrenza e sanzioni sufficienti a consentire un alto livello di cooperazione.
Le istituzioni internazionali possono facilitare la cooperazione tra stati precisamente perché aumentano la quantità e la
qualità dell’informazione disponibile. L’informazione è dunque per gli istituzionalisti, una variabile che può essere
modificata grazie alla creazione di istituzioni internazionali. La forma delle istituzioni deve riflettere le funzioni che
deve svolgere:
dovrebbe offrire un contesto in cui è possibile tenere negoziati efficienti e trasparenti;
dovrebbe dare una struttura al processo di contrattazione attraverso delle regole istituzionali;
dovrebbe garantire la presenza di un mediatore imparziale che suggerisce una soluzione equa per entrambe le
parti;
dovrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo, escludendo accordi incompatibili ecc..
Le istituzioni dedicate ai giochi di coordinamento non devono curarsi troppo dell’attuazione degli accordi raggiunti, in
quanto gli attori non hanno nessun incentivo nel violare i termini dell’accordo. Differentemente accade per i giochi di
collaborazione. In questo caso le istituzioni internazionali impongono alle parti regole che:
1. diminuiscono l’ambiguità degli obblighi dei partecipanti;
20
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
2. impongono obblighi di trasparenza e giustificazione;
3. delegano agli agenti imparziali di verificare il rispetto degli accordi;
4. strutturano sanzioni in caso di violazione.
Generalmente le istituzioni non vengono chiamate a punire eventuali violazioni direttamente, perché ciò rimane
prerogativa degli stati. Le istituzioni piuttosto aumentano la trasparenza dei rapporti interstatali e in questo modo
prevengono le violazioni.
3. LA CRITICA DEL REALISMO
Gli autori di tendenza realista delle relazioni internazionali sono da sempre scettici nei confronti delle capacità delle
istituzioni di mettere dei freni all’azione degli stati.
1. Secondo i realisti, le situazioni in cui gli interessi tra i vari attori sono incompatibili, sono più comuni di
quanto pensino gli istituzionalisti. Mentre infatti per gli istituzionalisti la maggior parte dei casi di mancata
cooperazione sono dovuti alla mancanza dell’informazione che permetterebbe agli stati di realizzare gli
interessi che hanno in comune, per i realisti sono spiegati dalla mancanza di interessi comuni. In altre parole,
per i realisti il conflitto deriva da interessi incompatibili.
2. I realisti riconoscono che in molte occasioni due stati potrebbero entrambi trarre vantaggio da una decisione di
cooperare. Ma il punto decisivo è che gli stati non sono interessati unicamente ai propri guadagni, ma anche ai
guadagni degli altri stati. In un sistema internazionale anarchico gli stati sono estremamente attenti all’entità
della loro potenza economica e militare rispetto a quella degli altri stati, perché gli altri stati potrebbero
rappresentare una minaccia alla propria autonomia e sopravvivenza. Se la cooperazione produce maggiore
guadagno per la controparte, questo può indurre uno stato a non cooperare perché il guadagno relativo può
essere altrettanto importante del guadagno che ne otterrebbe in termini assoluti. Quanto più uno stato ha il
timore che le risorse della controparte potrebbero un giorno essere usate contro di esso, tanto meno sarà
disposto ad accettare la cooperazione, a dispetto dei vantaggi che questa potrebbe portare. I realisti in questo
senso criticano gli istituzionalisti, perché essi considerano solo i guadagni assoluti e non relativi.
3. Un ulteriore critica all’istituzionalismo è che le istituzioni internazionali sono epifenomeniche, cioè
rispecchiano meramente gli interessi e i rapporti di forza tra gli stati e non hanno alcun potere causale
indipendente. L’effetto delle istituzioni sarebbe solo apparente: in realtà la struttura sottostante spiegherebbe
tanto le istituzioni quanto gli esiti.
4. ISTITUZIONALISMO COSTRUTTIVISTA
Secondo la logica dell’istituzionalismo costruttivista le istituzioni strutturano non solo gli incentivi esterni ma anche gli
obiettivi fondamentali e talvolta le stesse identità degli attori. Definendo modelli culturali di comportamento
appropriato e promuovendo visioni del mondo condivise, le istituzioni non influiscono solo su ciò che gli attori
possono fare, ma anche su ciò che vogliono fare e su chi sono. In altre parole, la sovranità degli stati non può essere
indipendente dalle istituzioni, che forniscono un quadro normativo per la loro azione.
Una fonte importante per le teorie costruttiviste sono gli scritti di Wendt, che identifica tre livelli di
internazionalizzazione delle norme internazionali: nel primo livello, gli attori sanno quale è la norma ma obbediscono
solo quando sono costretti a farlo (realismo); nel secondo livello gli attori scelgono di obbedire alla norma perché
ritengono che farlo sia nel loro interesse (istituzionalismo realista); nel terzo livello, secondo una logica costruttivista,
gli attori obbediscono alla norma perché la considerano legittima. Su questo processo si concentra l’attenzione
dell’istituzionalismo costruttivista.
La teoria costruttivista mostra inoltre come molte caratteristiche dello stato contemporaneo derivino da modelli
culturali generati e diffusi da processi di portata globale, tra cui spicca l’attività delle organizzazioni internazionali.
Questi modelli culturali globali definiscono, ad esempio, cosa sia uno stato e quali funzioni deve assolvere.
Paradossalmente, la sovranità non è concepita come un attributo intrinseco agli stati, ma come una forma di
21
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
riconoscimento da parte degli altri stati che nel mondo contemporaneo si manifesta soprattutto attraverso
l’appartenenza ad organizzazioni intergovernative come l’ONU. Nella World Polity Theory, sviluppata da Meyer e i
suoi collaboratori, viene sottolineato l’elevato grado di consenso transnazionale circa il valore di questioni come i
diritti umani e dei cittadini, lo sviluppo socio economico e l’istruzione. Le organizzazioni internazionali sono pertanto
un vettore centrale per la diffusione di modelli culturali.
4.2.Socializzazione e argomentazione
Per l’istituzionalismo costruttivista l’impatto delle istituzioni sugli stati avviene in larga misura attraverso processi di
socializzazione. La socializzazione è un processo attraverso il quale l’interazione sociale porta i nuovi stati ad
interiorizzare le norme e i modi di vedere di una società. In tale senso, Johnston ha identificato due meccanismi di
socializzazione:
1. Nel caso dell’influenza sociale, la conformità con norme risulta da benefici e sanzioni di tipo sciale e non
materiale. Tra i benefici spiccano un senso di benessere psicologico, un senso di appartenenza a un gruppo
sociale e il godimento del rispetto degli altri membri del gruppo. Le sanzioni possono essere la
disapprovazione o di esclusione dal gruppo. L’ipotesi costruttivista è che questi fattori esercitino un’influenza
importante sugli stati in quanto membri di istituzioni ed organizzazioni internazionali, in particolar modo
agendo sui rappresentanti degli stati.
2. La persuasione è un insieme di atti comunicativi che generano una convergenza di preferenze e opinioni in
assenza di sanzioni materiali o psicologiche. Gli istituzionalisti di scuola costruttivista si aspettano che
l’influenza sociale e la persuasione avvengano con più facilità all’interno di organizzazioni internazionali che
in interazioni non istituzionalizzate. Le organizzazioni internazionali forniscono un ambiente particolarmente
favorevole alla diffusione e penetrazione di nuove norme e nuovi metodi di interpretare la realtà. La teoria
dell’azione comunicativa di Habermas si è dimostrata particolarmente influente in tale contesto. In particolare,
mettendo a paragone due forme di comunicazione che si riscontrano nei negoziati internazionali, la
contrattazione e l’argomentazione si ritiene plausibile che la persuasione nel primo e la forza dell’argomento
migliore nel secondo abbiano un ruolo determinante per definire l’esito del negoziato.
INTERDIPENDENZA ECONOMICA E POLITICA
INTERNAZIONALE cap.5
1. ORIGINI DELLA TEORIA DELL’INTERDIPENDENZA
1.1. Il liberalismo nelle relazioni internazionali
Le teorie relative all’equilibrio di potenza ed egemonia, sono teorie compatibili con la tradizione realista. La principale
teoria che si occupa degli effetti dell’interdipendenza economica sulla politica internazionale è invece ascrivibile
all’altra grande tradizione di pensiero internazionalista: quella liberale.
Essa emerge da una critica dei principali assunti del realismo:
1. Lo stato non è visto come l’unico attore rilevante sulla scena internazionale. Esistono pertanto altri soggetti di
cui tenere conto quando si analizzano le relazioni internazionali, e lo stato è visto come un agente che opera
per conto di altri principali. Alcuni di questi si trovano ad un livello più alto dello stato, come le organizzazioni
internazionali. Alcuni sono di livello transnazionale, come ad esempio le compagnie multinazionali o grandi
chiese religiose. Altri infine si trovano a un livello subnazionale, e rendono necessario prendere in
considerazione anche le variabili di politica interna per spiegare la politica estera.
Trovano quindi spazio vari tipi di configurazione dei RAPPORTI TRA SOCIETA’ E STATO. Al contrario,
per i realisti qualsiasi tipo di stato tende a comportarsi nello stesso modo, a prescindere dalle sue caratteristiche
particolari, con una più netta separazione tra politica interna e politica estera. L’immagine liberale della
politica internazionale è quindi più complessa in quanto non vi sono solo gli stati che interagiscono tra di loro,
22
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
ma nella quale entità internazionali, transnazionali e subnazionali stabiliscono una fitta rete di relazioni che
influiscono sugli esiti politici.
2. In secondo luogo, l’ambiente in cui operano questi diversificati tipi di attori non è sempre lo stesso tipo di
anarchia. Dal momento che le caratteristiche interne degli stati sono viste come rilevanti, anche i rapporti tra
uno stato ed un altro saranno influenzate da queste caratteristiche.
L’anarchia internazionale, intesa come assenza di governo mondiale, non sarà omogenea nel tempo e nello
spazio come nell’analisi realista, e potrà essere più o meno vincolante con effetti conflittuali a seconda delle
circostanze. Le relazioni tra democrazie, o tra stati che commerciano intensamente, saranno quindi diverse
dalle relazioni tra stati che hanno regimi politici differenti, o che non commerciano tra loro.
3. In terzo luogo, almeno nei casi in cui l’anarchia sia meno severa e i rapporti meno conflittuali, le relazioni tra
stati non sono necessariamente dominate solo da considerazioni che riguardano la sicurezza. Al contrario di un
mondo realista, la cooperazione è possibile, e ciò permette agli attori di concentrarsi sui loro obiettivi. Le
questioni economiche assumono preminenza nell’analisi liberale, mentre i realisti considerano questi
argomenti comunque subordinati alla necessità della sopravvivenza di fronte all’incertezza dell’anarchia.
Le prime versioni del liberismo internazionalista contemporaneo emersero dopo le devastazioni della Prima Guerra
Mondiale. Esse adottavano una visione idealista e utopica, che immaginava possibile basare l’intero sistema
internazionale su un’armonia degli interessi e una pacifica interdipendenza tra stati. Le delusioni culminate nello
scoppio della Seconda guerra mondiale, hanno portato alla nascita di una nuova scuola, quella neoliberale. Questa
adottava una visione più articolata di interdipendenza complessa, secondo la quale nello stesso sistema internazionale
potevano convivere sia relazioni conflittuali tra avversari che relazioni più cooperative tra stati che non percepivano un
conflitto così imminente, e sarebbe quindi possibile concentrarsi sui rapporti di tipo economico.
Le diverse premesse delle due tradizioni delle relazioni internazionali, si intersecano anche con una differente visione
dell’evoluzione storica. Mentre i realisti sono scettici sulla possibilità di un sostanziale cambiamento che consenta di
ridurre i sospetti reciproci tra stati e dunque la guerra, i liberali credono nella possibilità del progresso e di un percorso
storico di miglioramento capace di trasformare le relazioni internazionali e di allontanare lo spettro della guerra.
Oltretutto i liberali credono in una direzione progressiva nell’evoluzione storica da una condizione passata di instabilità
a una futura pace, non più intesa semplicemente come tregua tra un conflitto e l’altro, ma come una condizione di
autentica stabilità e fiducia che renda obsoleto l’uso della violenza.
Secondo il liberismo sono 3 i principali possibili percorsi verso la riduzione della guerra come fenomeno della politica
internazionale: le istituzioni internazionali, il commercio internazionale e la democratizzazione.
1.2. Il liberalismo commerciale
Il liberismo commerciale identifica il progresso nelle relazioni internazionali con la diffusione delle moderne economie
industriali di mercato a partire dalla fine del ‘700. L’incremento della produzione economica mondiale, dovuto
all’efficienza allocativa del mercato internazionale e al progresso, ha comportato un aumento costante della ricchezza.
Ciò avrebbe avuto delle ripercussioni inedite sulle relazioni internazionali, inducendo un crescente numero di paesi a
concentrarsi sul benessere economico piuttosto che sul proprio successo militare.
L’ottimismo del liberalismo commerciale è basato sulla visione di Smith e di Ricardo sui benefici del libero commercio
che, se liberato dalle interferenze statali, porta ad un aumento del benessere per tutti, individui e stati. Secondo la teoria
del vantaggio comparato, se ciascuno stato si specializza nell’attività che gli è più congeniale, questo porta sia alla
massimizzazione delle potenzialità di ciascuno, sia ad una maggiore efficienza complessiva. Ciò che è più rilevante da
un punto di vista internazionale, è che la teoria liberale suggeriva che le politiche di impoverimento della propria
controparte non fossero razionali da un punto di vista economico. La ricchezza dei vicini favoriva infatti il proprio
sviluppo economico in quanto facilitava l’accesso a tecnologie più avanzate e mercati più facoltosi, in grado di
assorbire maggiormente le proprie esportazioni. Questa idea innovativa si scontrava con l’opinione prevalente in
precedenza, secondo la quale il protezionismo era preferibile al libero commercio in quanto si riteneva che la ricchezza
dell’uno potesse crescere solamente a scapito degli altri (dottrina mercantilista).
23
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
La solidità dell’apparato teorico del liberalismo e il successo empirico delle economie liberali hanno fatto sì che un
sempre crescente numero di paesi abbia adottato una postura commerciale aperta, e che la rete di relazioni economiche
internazionali si sia progressivamente estesa e infittita, fino all’attuale fase di globalizzazione.
2. INTERDIPENDENZA ECONOMICA E POLITICA INTERNA
2.1. Interessi particolari e decisioni collettive
La scelta di uno stato di aprire la propria economia è però anche influenzata dalla dinamica di interessi economici dei
vari settori produttivi, e da come essi interagiscono nella politica interna. Mentre gli aspetti diplomatici e militari
dipendono dal controllo del governo, i processi economici dipendono in larga misura da attori privati e sociali che
possono essere influenzati dallo stato solo in maniera indiretta. Questo gruppo di attori è chiamato gruppo di interesse.
Anche se il libero commercio porta a una maggiore efficienza complessiva e a un miglioramento, nel lungo periodo,
del benessere individuale, questo benessere, soprattutto nel breve periodo, non è distribuito uniformemente. Il capitale
e il lavoro investiti nei settori competitivi godono di un beneficio immediato all’apertura dell’economia, mentre il
capitale e il lavoro nei settori che soffrono la competizione internazionale devono essere reinvestiti, passando da una
fase temporanea di riconversione che può precedere la riduzione o la cessazione delle attività. Come ha dimostrato
Olson nella sua teoria dell’azione collettiva, questi gruppi hanno sia l’incentivo che l’opportunità di distorcere la
politica commerciale. Anche se, come membri della società in generale i membri di un gruppo d’interesse avessero un
interesse verso un’economia efficiente, i loro interessi come membri del gruppo tenderebbero a prevalere, anche perché
quest’ultimi, nel caso di industrie non competitive, possono riguardare la stessa sopravvivenza della categoria.
Un’ulteriore distorsione può emergere dal fatto che i vari gruppi d’interesse possono allearsi, al fine di controllare
meglio le decisioni pubbliche. Secondo la logica del log rolling, ciascun gruppo imporrà le proprie preferenze alla
coalizione, che potrebbe così avere una maggiore probabilità di successo, al prezzo di una minore coerenza negli
obiettivi comuni. Tuttavia, questi problemi sono ancora più evidenti nei regimi non democratici. Gli stati autocratici
riescono infatti ad evitare il confronto con l’opinione pubblica e gli elettori.
Una diversa conseguenza riguarda le società multinazionali, dotate di notevoli risorse economiche, in alcuni casi
superiori addirittura al PIL di alcuni stati. Esse svolgono attività in molteplici paesi, rendendo impossibile a ciascun
singolo governo di esercitare controllo su di loro. In alcuni casi, le multinazionali sarebbero in grado di modificare le
politiche dei governi, persuadendoli o costringendoli ad aprire l’economia nazionale alle loro attività.
2.2. Le critiche neomarxiste
L’ottimismo liberale sul ruolo del libero commercio viene aspramente criticato dalla scuola marxista, per la quale i
fattori economici sono importanti almeno quanto per la scuola liberale, ma che si trova in netto disaccordo riguardo
agli effetti dell’interdipendenza. Per i neomarxisti il mercato non porta ad una maggiore ricchezza complessiva, ma
all’inevitabile sfruttamento delle classi meno privilegiate, che basano il loro sostentamento sul proprio lavoro, da parte
delle classi che detengono i capitali. Lungi dal migliorare le condizioni sociali complessive, la modernizzazione crea
solo nuove occasioni di oppressione dei pochi sui molti, e prima o poi questa situazione diventa insostenibile. Ne
consegue un conflitto, la lotta di classe, che può essere risolto solo con una rivoluzione che collettivizzi i mezzi di
produzione e alteri il corso della storia. Anche a livello internazionale l’apertura del commercio comporta l’estrazione
di risorse dall’economia meno ricca da parte di quella più avanzata aumentando la disuguaglianza globale. Si creerebbe
così un particolare tipo di sottosviluppo, descritto dalla teoria della dipendenza, per il quale gli stati più arretrati nel
contesto dell’economia capitalista globale rimangono poveri perché interagiscono con quelli più ricchi, che li inducono
a specializzarsi in settori poco redditizi. Non bisogna quindi aspettarsi che i Paesi del Terzo Mondo seguano il percorso
dall’arretratezza alla povertà che ha caratterizzato i paesi del Primo Mondo, perché colonialismo e neocolonialismo
impediscono che si inneschi questo tipo di sviluppo autonomo.
Altri teorici neomarxisti disegnano un sistema globale naturalmente piramidale nel quale chi detiene le leve
economiche domina gli altri, sia politicamente che economicamente. Wallerstein descrive un modello di sistema-
mondo strettamente integrato alla divisione internazionale e suddiviso in tre aree poste in un ordine gerarchico: il
centro avanzato ed industrializzato, la semiperiferia in via di sviluppo e la periferia arretrata e sfruttata dalle altre due
24
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
zone. I paesi che di volta in volta appartengono a queste categorie possono cambiare, ma non il fatto che esistano questi
tre livelli. Viene quindi spiegata la perdurante e crescente diseguaglianza a livello globale.
3. LE CONSEGUENZE DELL’INTERDIPENDENZA SULLA
POLITICA INTERNAZIONALE
3.1. Gli effetti pacifici dell’interdipendenza
La più rilevante aspettativa del liberalismo commerciale riguardo alla politica internazionale concerne gli effetti
dell’interdipendenza economica sui rapporti tra stati.
Tra i primi è più importanti pensatori a sostenere la tesi dei benefici effetti del commercio ci sono Montesquieu, Hume
e Mill, per il quale è il commercio che rende obsoleta la guerra, rafforzando e moltiplicando gli interessi personali che
le sono naturalmente opposti.
L’apogeo della pace commerciale è stato poi raggiunto dalla scuola di Manchester, guidata da Cobden, la cui influenza
si è fatta sentire fino allo scoppio della Prima guerra mondiale. Secondo tale corrente di pensiero, tre sono gli effetti
principali del commercio a favore della pace e della stabilità.
1. In primo luogo, il commercio modifica gli incentivi degli stati nell’arena internazionale. Da un lato, il libero
commercio permette agli stati di ottenere i prodotti di cui hanno bisogno senza dover correre dei rischi, e i
costi di una guerra di conquista.
La guerra poteva ancora essere profittevole nell’era pre-industriale, quando la produzione economica, legata al
territorio, era meno fragile e le armi meno distruttive, ma non aveva più lo stesso valore in un’economia
industriale basata sulle specializzazione e sull’incremento della produttività.
2. In secondo luogo, i benefici economici di una maggiore interdipendenza diventano un incentivo a mantenere la
pace in quanto la competizione politica e la guerra interromperebbero i flussi economici e la maggiore
efficienza ad essi connessi. Volendo assecondare il desiderio dei propri cittadini a conseguire un alto tasso di
sviluppo economico, i governi si asterranno da politiche aggressive che possono mettere a repentaglio i frutti,
passati e futuri, di un’economia aperta. Da un lato, l’interdipendenza può essere intesa come sensibilità, nel
senso che gli stati diventano sensibili a eventi che avvengono presso i loro partner economici. Dall’altro lato,
l’interdipendenza può anche essere intesa come vulnerabilità, dal momento che un’eventuale interruzione dei
flussi economici comporterebbe un costo che inciderebbe sul benessere del paese.
3. In terzo luogo, vi sono effetti sociologici di un’economia internazionale capitalista. Le frequenti relazioni che
intercorrono tra gli stati interdipendenti riducono i pregiudizi reciproci e, secondo il liberismo sociologico,
enfatizzano le comunanze, piuttosto che le differenze, tra popoli e nazioni.
3.2. Le critiche realiste alla prospettiva liberale
Il realismo non condivide l’enfasi posta dai liberali sui fattori economici e, in particolare, ritiene che i vantaggi
provenienti da una politica economica aperta siano insufficienti per prevalere sulle considerazioni riguardo alla
sicurezza.
Per Rousseau, ad esempio, gli stati sono in competizione per vantaggi relativi piuttosto che per vantaggi assoluti,
poiché i vantaggi si fanno sentire solo per contrasto.
Allo stesso modo altri pensatori, come Hamilton e List, suggerivano di rinunciare ai benefici dell’apertura del
commercio per mantenere una capacità economica indipendente che potesse garantire la sicurezza dello stato. Uno
stato reso insicuro dell’anarchia internazionale semplicemente non poteva permettersi di porsi alla mercé di altri stati.
Lo sviluppo di un intenso scambio commerciale, non creerebbe una reciproca interdipendenza volta all’aumento del
benessere complessivo, ma un rapporto di competizione e di controllo. Gli stati sarebbero più vulnerabili. Temendo che
i prodotti necessari per la propria economia possano venire negati nel momento del bisogno, gli stati potrebbero cercare
25
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
di ottenerli con la forza. In queste circostanze, una stretta interdipendenza potrebbe essere lei stessa fonte di sospetto o
persino di guerra.
Secondo una visione strutturalista, solo chi è forte e sicuro, oppure chi si trova in un ambiente già pacifico, può
permettersi di intraprendere un commercio libero da condizionamenti politici o strategici. L’apertura commerciale, che
si è progressivamente affermata negli ultimi due secoli non sarebbe quindi frutto di un mutuo interesse da parte degli
stati, ma delle capacità di una potenza dominante di determinare questa situazione, secondo la teoria egemonica (Gran
Bretagna prima e Stati Uniti poi).
Seguendo questi precursori, la maggior parte dei realisti contemporanei relega quindi gli argomenti economici in
secondo piano, sebbene un certo gruppo vada oltre: i mercantilisti. Non solo la competizione politica potrebbe inibire la
cooperazione economica, ma le interferenze provenienti dall’arena economica potrebbero essere addirittura rischiose e
controproducenti per la stabilità. Le origini di questa posizione si riscontrarono proprio in Rousseau, che sosteneva
come l’interdipendenza portasse non tanto all’armonia, quanto al reciproco sospetto e proponeva agli stati un benigno
isolazionismo.Il fatto che gli stati europei si tocchino in tanti punti significa infatti che nessuno di loro può muoversi
senza infastidire tutti gli altri. I loro movimenti, poi, sono tanto più letali, tanto più i loro legami sono stretti.
4. INTERDIPENDENZA E PACE NELLA STORIA
L’ipotesi liberale sulle relazioni tra pace e scambi commerciali sostiene che livelli più alti di commercio sono associati
a una minore incidenza della guerra. L’effetto pacificatore dell’interdipendenza economica sarebbe poi particolarmente
sviluppato nelle relazioni tra stati di regime politico liberale, facendo intendere che i due fattori, commercio e
democrazia, si rafforzino a vicenda. I realisti invece sostengono una relazione positiva tra interdipendenza e conflitto.
Sebbene sembra esserci un supporto empirico per la tesi liberale, il rapporto tra interdipendenza economica e politica
internazionale è quanto meno complesso e non lineare. Un’ulteriore complicazione deriva dal fatto che è difficile
stabilire se sia la cooperazione economica a ridurre il conflitto politico, oppure se la riduzione del conflitto politico
permette l’emergere di una fruttuosa cooperazione economica. L’interdipendenza potrebbe quindi essere considerata
come un effetto, piuttosto che come causa della pace.
Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, nel 1913, per la Germania il commercio estero nel suo complesso
rappresentava il 38% del PIL, mentre per Gran Bretagna era addirittura il 52% e per la Francia il 54$%. Ciò fu
insufficiente a mantenere la pace tra le grandi potenze e 4 lunghi anni di guerra portarono a devastazioni mai viste.
Dopo la crisi del ’29, gli stati avevano intrapreso politiche commerciali protezionistiche se non autarchiche. Così come
la Prima guerra m. indebolisce le argomentazioni liberali, allo stesso modo la teoria realista viene indebolita dalla
situazione appena citata. Se infatti l’interdipendenza portasse gli stati a competere, una relativa autonomia e da
autosufficienza avrebbe dovuto portare gli stati ad una competizione meno intensa invece che a una guerra. È quindi
evidente come gli effetti politici dell’interdipendenza siano complessi e non semplici e lineari, e che il commercio
internazionale interagisce con la diplomazia in modo complesso. Dopo la seconda guerra m. gli stati del blocco
occidentale hanno intrapreso la strada dell’apertura economica. La pacificazione in occidente e l’intenso sviluppo di
legami commerciali, che in Europa ha portato il decollo del processo di integrazione, ha portato un’inedita stabilità
almeno in una parte del mondo. Questo forte aumento dell’interdipendenza ha messo in luce interessanti fenomeni: il
periodo della guerra fredda ha messo in evidenza la preferenza degli stati a commerciare soprattutto con i propri
alleati, al fine di rafforzare i rapporti di collaborazione. In secondo luogo, la guerra fredda ha anche messo in luce
l’utilità, in termini di competizione militare, di detenere maggiori risorse economiche, frutto di una stretta
interdipendenza.
26
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
POLITICA INTERNA E PACE DEMOCRATICA cap.6
1. POLITICA INTERNA E POLITICA ESTERA
La disciplina delle relazioni internazionali si è sviluppata equiparando la politica internazionale alla politica interstatale
e assegnando un posto cruciale agli stati. Da questo punto di vista, il modello stato centrico delle relazioni
internazionali, assumendo che la politica estera sia dettata da ciò che succede nell’ambiente internazionale,
concettualizza la politica estera come un’attività che non subisce mutamenti rilevanti al mutare delle caratteristiche
degli stati stessi. E, per procedere in questo senso, esso fissa alcuni assunti circa il funzionamento degli stati: la
razionalità, l’autonomia e l’unitarietà.
Altre prospettive, tuttavia, sostengono la necessità di studiare l’attività politica estera tenendo in conto la politica
interna e, in particolare, di considerare almeno tre processi fondamentali dalla cui intersezione emerge la politica estera
di uno stato: le dinamiche intrastatali, in cui i diversi apparati dello stato contribuiscono alla definizione della politica
estera; le dinamiche intrasocietarie, in cui gli attori economici e sociali di uno stato cercano di influenzare la
definizione della politica estera; le dinamiche tra stato e società e la loro interazione all’interno delle logiche
istituzionali.
1.1. La politica estera fra burocrazia e politica
Gli stati non possono essere considerati come attori compatti, ma sono dei costrutti mentali che rimandano, nella realtà,
ad aggregati complessi di persone e di elementi materiali o simbolici. Ad esempio, quando si afferma che l’Iraq ha
invaso il Kuwait, nella realtà non è stato concretamente l’Iran a invadere il Kuwait, ma un certo insieme di persone
fisiche grazie a un certo insieme di mezzi militari. Ma allora, se gli stati sono degli insiemi di apparati, per
comprendere il modo in cui essi decidono e attuano la propria politica estera è necessario tenere in conto il modo in cui
quegli apparati funzionano e interagiscono.
Questa è la strada percorsa dai teorici della politica burocratica o della politica governativa. Secondo questa
prospettiva, i governo smettono di apparire come organismi compatti e divengono attori le cui decisioni e azioni sono
delle risultanti politiche intranazionali: risultanti nel senso che ciò che accade non è scelto come soluzione a un
problema ma piuttosto risulta dal compromesso; politiche nel senso che l’attività da cui emergono le decisioni e azioni
è meglio raffigurabile come un negoziato fra i singoli membri del governo che segue canali strutturati.In altre parole, la
27
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
politica estera di uno stato deriva dall’interazione fra diversi apparati politici e burocratici che contano sulle proprie
singole risorse, agiscono secondo proprie peculiari regole organizzative e lottano per raggiungere i propri obiettivi.
1.2. La politica estera fra gruppi di pressione e comunità
epistemiche
Innanzitutto bisogna considerare che gli apparati e i decisori pubblici non si limitano a negoziare le scelte di politica
estera che maggiormente realizzano i propri interessi, ma devono considerare anche le richieste che provengono
dall’interno. Il modo in cui uno stato persegue i propri interessi esterni, infatti, produce numerose conseguenze interne.
Ma se le scelte di politica estera toccano questioni che coinvolgono gli attori economici e sociali domestici, i decisori
subiranno l’influenza di tali attori: questi ultimi, infatti, detengono risorse consistenti e hanno un peso considerevole
nel processo decisionale pubblico. Ciò fa cadere l’assunto dell’autonomia del governo, dal momento che le decisioni di
politica estera non rispondono principalmente alle sfide del sistema internazionale ma anche alle esigenze domestiche
Mentre nel modello stato centrico si assume che il governo persegua razionalmente l’interesse nazionale, per questa via
si può arrivare a considerare il governo come un attore che interagisce con alcuni gruppi interni per perseguire le
politiche estere che realizzano gli interessi di quella coalizione specifica. Putnam ha sviluppato più di altri questo
ragionamento, costrunendo un modello interpretativo in cui i governi sono concepiti come attori che gestiscono
strategicamente un gioco a due livelli: a livello nazionale, i gruppi domestici perseguono i propri interessi premendo
sul governo affinchè esso adotti politiche loro favorevoli, e i politici cercano di conquistare potere costruendo
coalizioni tra questi gruppi; a livello internazionale, i governi nazionali cercano di massimizzare la propria capacità di
soddisfare le pressioni domestiche e, intanto, di minimizzare le conseguenze negative degli sviluppi internazionali.
La politica estera di uno stato, tuttavia, è potenzialmente sottoposta anche all’influenza di altri gruppi domestici come
le comunità epistemiche. Queste comunità sono intese come reticoli formali e informali di esperti che diffondono in
modo autorevole informazioni e conoscenze circa le questioni internazionali. Ciò avviene in particolare quando la
scelta dei comportamenti internazionali degli stati avviene in condizioni di grande incertezza, quando i problemi in
gioco hanno un elevato contenuto tecnico e/o sono poco politicizzati, richiedendo così delle competenze specifiche per
essere affrontati.
1.3. La politica estera fra opinione pubblica e mezzi di
comunicazione
La politica estera è stata tradizionalmente considerata un settore decisionale isolato dal dibattito pubblico e sottratto al
controllo della popolazione. A sostegno di questa posizione si sono invocati diversi fattori di natura funzionale, ovvero
connessi ai requisiti del buon svolgimento della politica estera: l’esigenza di condurre con riservatezza le trattative
internazionali; la necessità di perseguire interessi di lungo periodo, e quindi di evitare cambi di linea indotti
dall’emotività. A questi fattori inoltre si è associata l’idea che la popolazione sia disattenta, disinformata e
incompetente sulle questioni di politica internazionale e, quindi, finisca per diventare un fattore di disturbo in decisioni
che dovrebbero essere razionali.
Questo ragionamento, tuttavia, non sembra confermato dalla ricerca empirica più recente che, pur mostrando che il
pubblico è tendenzialmente poco informato sui problemi internazionali, evidenzia come esso articoli in un quadro
coerente e stabile le informazioni di cui dispone, e aggiorni questo quadro cognitivo alla luce dei principali mutamenti
del sistema internazionale. Non in tutti i casi e per necessità, dunque, si può assumere che il processo decisionale
avvenga indipendentemente dagli orientamenti della popolazione. Anzi, la ricerca segnala che nelle democrazie liberali
vi è una significativa relazione fra le scelte di politica estera e le preferenze dell’opinione pubblica.
A quest’effetto si associa il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa. I mass media entrano nel processo decisionale
pubblico in almeno due modi: prima di tutto, essi sono parte vitale del processo di formazione delle preferenze
politiche, poiché producono e diffondono informazioni e conoscenze circa le questioni internazionali; in secondo
luogo, ponendo al centro dell’attenzione pubblica certi temi piuttosto che ad altri, influenzano l’agenda politica e le sue
priorità (Cnn effect).
28
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
2. POLITICA INTERNA E POLITICA INTERNAZIONALE:
L’ESPANSIONE DELL’ARENA DECISIONALE
Se si adotta una prospettiva storica ampia, si può rilevare che l’attività della politica estera contemporanea è molto
diversa dalla politica del gabinetto che ha caratterizzato i secoli del sistema degli stati europeo: una politica decisa da
poche figure e condotta bilateralmente grazie ai negoziati confidenziali tenuti da ambasciatori residenti all’estero. A
questa pratica politica ben si adattava la concezione realista della politica estera quale attività di un cento politico coeso
e sostanzialmente isolato dalle influenze provenienti dall’interno. A modificare questo quadro hanno contribuito vari
fattori che hanno acquisito un ruolo decisivo soprattutto nel corso del ‘900: da un lato l’ingresso sulla scena mondiale
della politica di massa e della guerra generale, con i connessi processi di liberalizzazione e democratizzazione;
dall’altro lato, la crescita dell’interdipendenza economica e della velocità dei mezzi di comunicazione fisica e
simbolica.
Di conseguenza, le questioni tenute in conto nell’elaborazione della politica estera si sono ampliate, includendo, al
fianco dei tipici problemi da high politics, una gamma sempre più ampia di temi da low politics. Inoltre, gli attori
coinvolti nella politica estera sono aumentati per numero e per tipo, come sono aumentati gli spazi di intervento dei
gruppi domestici e della popolazione. In ultimo, la riservatezza della diplomazia bilaterale, ha lasciato il posto, in certa
misura, a una politica estera più trasparente, condotta tramite summit o conferenze multilaterali in cui le posizioni di
uno stato sono spesso negoziate da ministri tecnici, invece che dai ministri degli Esteri. A seguito di queste
trasformazioni, l’arena decisionale della politica estera si è allargata ed è divenuta più complessa, e maggiormente
interconnessa con quella interna.
3. LA POLITICA ESTERA TRA GUERRA E ISTITUZIONI
POLITICHE: LA TEORIA DELLA PACE DEMOCRATICA
Gli stati si presentano come una grande varietà di strutture politiche e questa diversità può contare nell’influenzare la
politica estera. Questa notazione è alla base della TEORIA DELLA PACE DEMOCRATICA o della pace separata:
una teoria liberale che instaura un nesso causale tra la natura del regime politico degli stati e i loro comportamenti
internazionali; in particolare tra natura democratica del regime e la guerra.
Nella riflessione sul rapporto tra democrazia e guerra ricorre l’idea che le democrazie si comportino diversamente dagli
altri regimi politici nel sistema internazionale per via della loro natura pacifica. L’origine di questa idea risale al
pensiero di Kant nel “Per la pace perpetua”. In realtà non è possibile sostenere che le democrazie siano più pacifiche
degli altri regimi politici poiché esse combattono meno frequentemente la guerra. Al contrario, le democrazie fanno la
guerra tanto quanto la fanno le non-democrazie. Vi è tuttavia un aspetto importante: le democrazie sono più pacifiche
nei rapporti reciproci, cioè non si fanno guerra tra di loro.
3.1. I dati della pace democratica
Il tema della pace democratica si è imposto come centrale nelle Relazioni Internazionali a partire dalla prima metà
degli anni ’80, a seguito di un contributo di Doyle. Egli incrocia i dati disponibili sulle guerre combattute dal 1800 con
la classificazione dei paesi coinvolti in quei conflitti a seconda del loro regime politico. Dapprima identifica le
democrazie come quei regimi politici che durano da almeno 3 anni, che si distinguono per un’ economia fondata sul
libero scambio e la proprietà privata, la sovranità esterna, la tutela giuridica dei diritti dei cittadini, la subordinazione
dei militari al potere esecutivo, il potere legislativo eletto tramite elezioni, il suffragio femminile. Quindi Doyle
dimostra come nelle 118 guerre considerate in 200 anni, i paesi in cui le libertà sono assicurate costituzionalmente non
si sono ancora fatti guerra.
Altri contributi mostrando anche come le democrazie tendono a non combattere guerre preventive, ovvero a non
attaccare per primi i nemici che si fanno minacciosi. Mentre i regimi non democratici ricorrono con regolarità a questo
strumento per impedire gli avversari di avere la meglio, le democrazie sperimentano strade alternative in base al regime
che fronteggiano: se si tratta di un paese democratico tendono a cercare una soluzione pacifica, se si tratta di un paese
non democratico, tendono a costituire alleanze difensive per sventare il probabile attacco.
Naturalmente la correlazione empirica che fonda la teoria della pace democratica, non è priva di eccezioni.
29
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
3.2. Le cause della pace democratica
In “Per la pace perpetua”, Kant specificava tre elementi che, se realizzati in modo simultaneo, avrebbero portato alla
pace tra le nazioni: la diffusione universale del governo costituzionale repubblicano (ovvero la democrazia), la
stipulazione di un’unione pacifica tra repubbliche e, infine, il rispetto del diritto cosmopolitico.
I fattori indicati da Kant alla fine del ‘700, hanno ispirato le teorie moderne, che hanno individuato tre tipi di cause della
pace democratica:
1. Le cause istituzionali della pace democratica riguardano gli assetti istituzionali e meccanismi decisionali delle
democrazie. Da questo punto di vista, di grande importanza sono due elementi fondamentali: in primo luogo,
le democrazie sono dei sistemi politici in cui il governo dipende dalla capacità di conquistare e mantenere il
consenso dei cittadini tramite le elezioni libere e periodiche; in secondo luogo, le democrazie hanno un
governo limitato in quanto prevedono contrappesi e meccanismi di controllo che sottopongono il potere
esecutivo al controllo degli altri poteri e il governo in carica al controllo dell’opposizione. Questi due elementi
istituzionali basilari sono molto rilevanti perché producono due costrizioni alla scelta di guerreggiare in
democrazia: 1) dal momento che i costi finanziari e umani di una guerra ricadono sui cittadini e che il loro
consenso è necessario per acquistare e mantenere il governo, quest’ultimo tenderà a decidere la guerra meno
di frequente di quanto fanno i governi dei regimi non democratici 2) la divisione dei poteri, la trasparenza e la
pubblicità degli atti delle istituzioni democratiche prevengono decisioni affrettate e ostacolano una politica
estera aggressiva, che richiederebbe segretezza e flessibilità.
2. Le cause normative hanno invece a che fare con la cultura politica. Dal momento che la violenza è esclusa dal
novero delle risorse impiegabili per conquistare o mantenere il potere, e dal momento che le democrazie sono
stati di diritto in cui le dispute vengono risolte con strumenti giuridici e non con la forza, questi regimi
coltivano dunque al proprio interno i valori della risoluzione pacifica dei conflitti e delle controversie. Questi
valori, di conseguenza, influenzano la politica internazionale.
3. Le cause economiche: le democrazie producono un sistema economico di libero mercato che facilita lo
sviluppo delle relazioni commerciali con l’esterno e l’integrazione in un sistema internazionale di libero
scambio. L’alta dipendenza economica può aumentare i costi della guerra e ridurne i benefici, rendendola così
una scelta poco conveniente rispetto alla soluzione pacifica delle controversie.
Nella visione kantiana, l’operare congiunto di queste cause avrebbe portato le democrazie liberali a formare una
comunità pluralistica di sicurezza e, cioè, un insieme di stati indipendenti che escludono l’uso della forza nei loro
rapporti reciproci. Una pace perpetua, ma pur sempre reversibile, poiché connessa all’evolversi delle condizioni che
l’hanno prodotta: un regime democratico può tornare autoritario o totalitario, oppure l’apertura commerciale che fonda
la crescita dell’interdipendenza economica può lasciare il posto a politiche protezionistiche.
Panebianco esprime il dubbio che questo insieme di cause sia davvero in grado di spiegare la pace democratica, poiché
se esse operassero come si attendono i neokantiani, dovrebbero anche rendere le democrazie più pacifiche in generale,
oltre che più pacifiche nei loro rapporti reciproci.
Per completare la spiegazione della pace democratica, la letteratura ha invocato anche altri fattori che concorrono a
formare quella che possiamo chiamare la causa informativa della pace democratica e rimandano all’idea che le
democrazie siano più credibili degli altri regimi politici nella negoziazione e implementazione degli accordi. A
differenza di quello che accade negli altri regimi, i governanti delle democrazie che affrontano le dispute internazionali
sono sottoposti a giudizio degli elettori, che ne possono valutare l’operato, data la pubblicità e la trasparenza dei loro
atti. Di conseguenza, i segnali negoziali che le democrazie mandano nelle controversie internazionali sono molto più
credibile di quelli inviati dai regimi non democratici. Le democrazie sono più affidabili di altri regimi politici per via
del loro pluralismo istituzionale, che coinvolge nel processo decisionale più attori con poteri di veto e di conseguenza,
quando una democrazia ratifica, è molto più difficile che lo rinneghi. Esse inoltre non fondano la loro legittimità sui
leader che lo governano e quindi gli impegni che essi prendono non mutano meccanicamente con il mutare dei
governanti. Infine, essi decidono i propri impegni in modo aperto nel sistema internazionale, e ciò aumenta le
opportunità dei loro alleati di intervenire se queste li vogliono mutare.
30
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
3.3. Il dibattito sulla pace democratica
La teoria della pace democratica non è esente da critiche, anche radicali, che colpiscono diversi aspetti. Limitandosi alle
critiche di carattere generale, la più importante riguarda le definizioni operative della democrazia utilizzate nello studio
comparato dei regimi politici. Infatti Doyle utilizza una definizione poco esigente, appena 3 anni per assumere che la
democrazia sia consolidata. Il punto è allora se si studia davvero la pace democratica se l’analisi empirica seleziona
regimi che sono così blandamente democratici.
Inoltre i realisti sostengono che esistono delle eccezioni, in cui le democrazie si sono scontrate in conflitti armati. Per
spiegare queste eccezioni, la letteratura ha invocato il non completo possesso dei requisiti di tali democrazie. In questa
direzione si è avviato chi sostiene che i problemi della pace democratica derivino dall’avere trascurato un fattore
esplicativo rilevante: il rapporto tra democrazia e la guerra non sarebbe influenzato solo dalla natura democratica dei
regimi politici, ma anche, dal loro grado di liberalismo e cioè dalla misura in cui l’ideologia liberale, con suoi valori
individualistici e universalistici, informa le pratiche di governo e la cultura politica di un paese. Per questa via si
distingue le democrazie fra di loro almeno per un elemento: che siano liberali o illiberali, come capita di frequente nelle
democrazie non consolidate e in quelle dei paesi extraeuropei. Tale distinzione è importante perché alla base delle scelte
di politica estera dei governi sta il modo in cui essi si percepiscono reciprocamente: se una democrazia è governata da
una classe politica illiberale, allora può essere ragione sufficiente per ritenerla minacciosa ed essere disposti a
combatterla.
L’introduzione del criterio dell’ideologia liberale al fianco di quelli relativi alle regole democratiche riduce il campo dei
regimi coinvolti nella pace democratica, restringendolo ai soli paesi occidentali e alla comunità di sicurezza che è nata
dai loro rapporti reciproci: è in questi paesi che troviamo la coincidenza di democrazia e alto grado di liberalismo.
Anche in questo caso vengono sollevate delle obiezioni soprattutto di stampo realista: la pace, per loro, sarebbe causata
da fattori alternativi a quelli precedenti, mentre l’assenza di guerra fra democrazie fino all’inizio del XX secolo
potrebbe spiegarsi notando il basso numero di regimi democratici con confini comuni; dopo il 1945, la pace
democratica si spiegherebbe come esito dell’esistenza di un sistema bipolare in cui paesi democratici erano strettamente
alleati in un blocco egemonizzato dagli USA. La pace quindi sarebbe stata possibile perché riguardava un insieme di
stati che si difendevano insieme contro un nemico comune. Alla sua base dunque non ci sarebbero fattori di natura
democratica, ma sistematico-strutturali.
Si rivela l’importanza e la credibilità negoziale della democrazia, più che della variabile realista dei comuni interessi di
sicurezza, concludendo di conseguenza per la maggiore capacità esplicativa della teoria della pace democratica rispetto
alle teorie sistemico-strutturali.
4. LA PACE DEMOCRATICA E IL SISTEMA INTERNAZIONALE
CONTEMPORANEO
Il crollo del muro di Berlino ha modificato molti attributi fondamentali del sistema internazionale. Uno dei più
importanti è stata la rottura della forte identità di interessi che compattava tra loro i paesi che si difendevano assieme
dall’URSS. Di conseguenza, dopo il 1989 è mancato il fattore che ha prodotto la pace democratica secondo la
prospettiva realista. Va dunque sottolineato che la recente transizione sistematica non ha coinciso con il venir meno
della comunità di sicurezza del bipolarismo, anzi, oltre a sperimentare dei processi di democratizzazione, anche le
grandi potenze non occidentali sono state attratte nell’orbita delle istituzioni che hanno dato veste formale alla comunità
di sicurezza occidentale, come l’avvicinamento della Russia alla Nato, al G7/G8 e all’organizzazione mondiale del
commercio; e con l’ingresso formale della Cina in quest’ ultima. In secondo luogo, negli ultimi decenni il volume degli
scambi commerciali è ulteriormente cresciuto per quantità e per paesi coinvolti, aumentando i legami tra le potenze
democratiche e quelle non democratiche.
Tuttavia va anche segnalata la frequenza con cui delle democrazie hanno iniziato o sono intervenute in conflitti già in
corso contro regimi che non le avevano attaccate: Iraq 1991, ex Jugoslavia 1995, Kosovo 1999, Afghanistan 2001 e Iraq
2003. Risulta così difficile sostenere la natura pacifica delle democrazie, visti i conflitti aperti che esse hanno iniziato.
Ci si può allora interrogare su quali politiche siano più adatte a farla progredire, visto che l’espansione della
31
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
lOMoARcPSD|3304637
democrazia, anche con il ricorso della forza, è divenuto un obiettivo prioritario di alcuni paesi occidentali. Occorre
segnalare che:
le democrazie in via di consolidamento tendano ad iniziare la guerra prima degli altri regimi ( dal 1815 in poi)
le democrazie consolidate tendono a fare guerra più degli altri regimi quando i loro nemici sono piccoli regimi
non democratici
La stessa espansione della democrazia potrebbe dunque aumentare le tensioni internazionali: ciò accadrebbe se le
proliferazioni di democrazie immature portasse ad aumentare la conflittualità del sistema e se le democrazie mature
intervenissero con facilità nelle aree a crescente conflittualità così da eliminare i paesi non democratici fintanto che
sono deboli. In realtà, le guerre combattute per rendere democratici i regimi considerati ostili sono di dubbio esito, e
richiedono ingenti risorse. Ancora più difficile è inoltre esportare le procedure della democrazia ovvero quelle regole
che stanno alla base di essa.
32
Scaricato da Simone Prattella (simonepra1999@hotmail.it)
Potrebbero piacerti anche
- Manuale Relazioni InternazionaliDocumento60 pagineManuale Relazioni InternazionaliVeronicaNessuna valutazione finora
- Relazioni InternazionaliDocumento32 pagineRelazioni InternazionaliveraNessuna valutazione finora
- Cartoline dall'inferno: Fenomenologia del male nello stato islamicoDa EverandCartoline dall'inferno: Fenomenologia del male nello stato islamicoNessuna valutazione finora
- Relazioni InternazionaliDocumento20 pagineRelazioni InternazionaliMaya PapottiNessuna valutazione finora
- Linee guida per l'attuazione dei diritti umaniDa EverandLinee guida per l'attuazione dei diritti umaniNessuna valutazione finora
- Introduzione Alle Relazioni Internazionali RiassuntiDocumento97 pagineIntroduzione Alle Relazioni Internazionali RiassuntiDaria OrlandiniNessuna valutazione finora
- End and Clash - Il contributo di F. Fukuyama e S. P. Huntington alla riflessione politica contemporaneaDa EverandEnd and Clash - Il contributo di F. Fukuyama e S. P. Huntington alla riflessione politica contemporaneaNessuna valutazione finora
- Relazioni Internazionali Appunti Università Di GenovaDocumento53 pagineRelazioni Internazionali Appunti Università Di GenovaGretaNessuna valutazione finora
- Manuale Di Relazioni InternazionaliDocumento35 pagineManuale Di Relazioni InternazionaliMargheritaNessuna valutazione finora
- Hedley Bull - La Società AnarchicaDocumento45 pagineHedley Bull - La Società AnarchicaVeronicaNessuna valutazione finora
- Sociologia Della PoliticaDocumento37 pagineSociologia Della PoliticaAlessia CarreraNessuna valutazione finora
- Cigni senza collo: Lo sguardo breve delle democrazie tra Putin e HamasDa EverandCigni senza collo: Lo sguardo breve delle democrazie tra Putin e HamasNessuna valutazione finora
- Relazioni InternazionaliDocumento54 pagineRelazioni InternazionaliBaioccoNessuna valutazione finora
- La Politica e Gli Stati-RiassuntoDocumento39 pagineLa Politica e Gli Stati-RiassuntoSilvia IvaldiNessuna valutazione finora
- Riassunti Diritto Inter Nazi On Ale TanziDocumento121 pagineRiassunti Diritto Inter Nazi On Ale TanziGianna NaniNessuna valutazione finora
- Diritto Internazionale TanziDocumento108 pagineDiritto Internazionale Tanziscrewyoureg100% (1)
- Un Mondo Sicuro Per La Democrazia - Rel Int ParsiDocumento26 pagineUn Mondo Sicuro Per La Democrazia - Rel Int Parsigiorgio colomboNessuna valutazione finora
- Hausarbeit DeeplDocumento6 pagineHausarbeit DeeplariannaNessuna valutazione finora
- Lezione 1Documento8 pagineLezione 1Anna OlivetoNessuna valutazione finora
- Le Ancore Della DemocraziaDocumento12 pagineLe Ancore Della DemocraziaMariachiara RanieriNessuna valutazione finora
- Multigovernance e MulticulturalismoDocumento41 pagineMultigovernance e MulticulturalismoEleonora DuseNessuna valutazione finora
- 2.5 Dal Terrorismo Politico Alle Nuove Forme Di Terrorismo Globale PDFDocumento43 pagine2.5 Dal Terrorismo Politico Alle Nuove Forme Di Terrorismo Globale PDFpaolo arenaNessuna valutazione finora
- Globalismo e AntiglobalismoDocumento34 pagineGlobalismo e AntiglobalismoFrancesco FerraroNessuna valutazione finora
- Riassunto Formigoni Storia InternazionaleDocumento52 pagineRiassunto Formigoni Storia InternazionalefedemmerolaNessuna valutazione finora
- Sociologia Delle Relazioni Internazionali Appunti PDFDocumento45 pagineSociologia Delle Relazioni Internazionali Appunti PDFArianna RoettaNessuna valutazione finora
- Riassunto - Introduzione Alla Scienza Politica - Della PortaDocumento31 pagineRiassunto - Introduzione Alla Scienza Politica - Della Portaclaudiaronzoni85Nessuna valutazione finora
- Alfredo Rocco - Dottrina Fascismo 1925Documento5 pagineAlfredo Rocco - Dottrina Fascismo 1925Gianmarco AltieriNessuna valutazione finora
- 2 - Stato Come Organizzazione SocialeDocumento48 pagine2 - Stato Come Organizzazione Socialealessandro.pelligraNessuna valutazione finora
- Diritto InternazionaleDocumento62 pagineDiritto Internazionalecaracall99Nessuna valutazione finora
- Autoimmunità, Tardo-Capitalismo, Tecno-Fascismo, Di Raoul KirchmayrDocumento15 pagineAutoimmunità, Tardo-Capitalismo, Tecno-Fascismo, Di Raoul Kirchmayraut autNessuna valutazione finora
- Scienza Politica Sbobbina Del Libro CaramaniDocumento21 pagineScienza Politica Sbobbina Del Libro Caramanisara manciniNessuna valutazione finora
- FOUCAULTDocumento2 pagineFOUCAULTMiriana MarcianòNessuna valutazione finora
- Diritto Internazionale - SIDDocumento25 pagineDiritto Internazionale - SIDgiorgio.g53Nessuna valutazione finora
- Storia Delle Relazioni Internazionali (Con Cartine)Documento42 pagineStoria Delle Relazioni Internazionali (Con Cartine)Federico Faleschini100% (1)
- Storia Del Diritto II Sbobinature 1Documento142 pagineStoria Del Diritto II Sbobinature 1Nadia BattafaranoNessuna valutazione finora
- Politica ContemporaneaDocumento27 paginePolitica Contemporaneamatydirectioner01Nessuna valutazione finora
- Diritto InternazionaleDocumento14 pagineDiritto Internazionaleclaudia.scanoNessuna valutazione finora
- Antropologia Politica: Antropogy of Politics: Una Raccolta Dei Saggi Principali e Importanti Nella Storia DellaDocumento16 pagineAntropologia Politica: Antropogy of Politics: Una Raccolta Dei Saggi Principali e Importanti Nella Storia DellaJennyNessuna valutazione finora
- Anonimo - Antropologia Economica e Politica Delle Reti Criminali ModerneDocumento39 pagineAnonimo - Antropologia Economica e Politica Delle Reti Criminali ModerneGijgan NicolaeNessuna valutazione finora
- Antologia Del Nazionalismo in Italia XIX XX SecoloDocumento20 pagineAntologia Del Nazionalismo in Italia XIX XX SecoloGianfranco MariniNessuna valutazione finora
- Crisi Dell'IoDocumento9 pagineCrisi Dell'IoGaia SimoneNessuna valutazione finora
- Riassunto - Storia Delle Dottrine Politiche PDFDocumento157 pagineRiassunto - Storia Delle Dottrine Politiche PDFAlberto AmorusoNessuna valutazione finora
- In Fase Di GolpeDocumento24 pagineIn Fase Di GolpeRyan JensenNessuna valutazione finora
- Opinionidiunnessuno - Blogspot.it-Nazismo e Comunismo Le Due Facce Della Stessa MedagliaDocumento5 pagineOpinionidiunnessuno - Blogspot.it-Nazismo e Comunismo Le Due Facce Della Stessa Medagliauomomedicina.itNessuna valutazione finora
- Diritto CostituzionaleDocumento8 pagineDiritto CostituzionaleCecilia MalettiNessuna valutazione finora
- AgnewDocumento18 pagineAgnewValentina CerinoNessuna valutazione finora
- Spazi e Poteri Geografia Politica Geografia Economica Geopolitica Claudio Cerreti Matteo Marconi e Paolo SellariDocumento97 pagineSpazi e Poteri Geografia Politica Geografia Economica Geopolitica Claudio Cerreti Matteo Marconi e Paolo SellariPablo GalliganiNessuna valutazione finora
- Riassunto Populismo PenaleDocumento15 pagineRiassunto Populismo PenaleMiko ArzoNessuna valutazione finora
- Storia Delle Dottrine Politiche-Riassunto-GherardiDocumento30 pagineStoria Delle Dottrine Politiche-Riassunto-GherardiEmma MasieroNessuna valutazione finora
- Sciolla 2Documento13 pagineSciolla 2Giulia CarucciNessuna valutazione finora
- BaumanDocumento4 pagineBaumanMarco CaporicciNessuna valutazione finora
- IDEOLOGIEDocumento21 pagineIDEOLOGIExvvdwtbzc9Nessuna valutazione finora
- La Democrazia Totalitaria Nella Riflessione Di J.J.Rousseau, Robesbierre e Saint - JustDocumento53 pagineLa Democrazia Totalitaria Nella Riflessione Di J.J.Rousseau, Robesbierre e Saint - JustGandolfo DominiciNessuna valutazione finora
- Mercati e GuerrieriDocumento25 pagineMercati e GuerrieriHIBA EL ZIANINessuna valutazione finora
- Appunti Relazioni Internazionali - ColomboDocumento114 pagineAppunti Relazioni Internazionali - ColomboViola Banaj100% (1)
- Ludus Septem SapientumDocumento264 pagineLudus Septem SapientumandreacirlaNessuna valutazione finora
- DizionarioDocumento607 pagineDizionarioMariano Olivera100% (1)
- Griglie Classe 2Documento22 pagineGriglie Classe 2Viviana MoriccaNessuna valutazione finora
- John Cage - Blow UpDocumento10 pagineJohn Cage - Blow UpStefano TedescoNessuna valutazione finora
- M. Gennari - Trattato Di Pedagogia GeneraleDocumento100 pagineM. Gennari - Trattato Di Pedagogia Generalericki.podeNessuna valutazione finora
- Tesina Resisende Auf Einem BeinDocumento21 pagineTesina Resisende Auf Einem BeinValentina100% (1)
- EliadeDocumento13 pagineEliadeAdriano TorricelliNessuna valutazione finora
- Filosofia Del DirittoDocumento11 pagineFilosofia Del DirittoValeria Brits TortoraNessuna valutazione finora
- Fake news dell'antica Roma: 2000 anni di propaganda, inganni e bugieDa EverandFake news dell'antica Roma: 2000 anni di propaganda, inganni e bugieNessuna valutazione finora
- Il caso Giorgia Meloni: Social network, cultura pop e comunicazione politicaDa EverandIl caso Giorgia Meloni: Social network, cultura pop e comunicazione politicaNessuna valutazione finora
- L’Aristocrazia Nera: La storia occulta dell’élite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l’economiaDa EverandL’Aristocrazia Nera: La storia occulta dell’élite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l’economiaNessuna valutazione finora
- Da Maometto Al Burj Khalifa – Corso Rapido Su 2000 Anni Di Storia Del Medio OrienteDa EverandDa Maometto Al Burj Khalifa – Corso Rapido Su 2000 Anni Di Storia Del Medio OrienteNessuna valutazione finora
- Quando eravamo i padroni del mondo: Roma: l'impero infinitoDa EverandQuando eravamo i padroni del mondo: Roma: l'impero infinitoNessuna valutazione finora
- L'altra Europa: Miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europeaDa EverandL'altra Europa: Miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europeaValutazione: 2 su 5 stelle2/5 (1)
- Concorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciDa EverandConcorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciNessuna valutazione finora
- Triadi: La minaccia occulta della criminalità cinese nel MondoDa EverandTriadi: La minaccia occulta della criminalità cinese nel MondoNessuna valutazione finora
- E io non pago!: Perché l'Italia deve dire no al ricatto del debito pubblicoDa EverandE io non pago!: Perché l'Italia deve dire no al ricatto del debito pubblicoNessuna valutazione finora
- Carl Schmitt: Eccezione. Decisione. Politico. Ordine concreto. Nomos.Da EverandCarl Schmitt: Eccezione. Decisione. Politico. Ordine concreto. Nomos.Nessuna valutazione finora
- Ordinamento degli Enti Locali: Concorsi per impiegato comunale nelle Aree: Amministrativa, Tecnica, Finanziaria e Contabile, SocialeDa EverandOrdinamento degli Enti Locali: Concorsi per impiegato comunale nelle Aree: Amministrativa, Tecnica, Finanziaria e Contabile, SocialeNessuna valutazione finora
- Gregge e Potere: Il Libretto Rosso delle Pecore NereDa EverandGregge e Potere: Il Libretto Rosso delle Pecore NereNessuna valutazione finora
- Un Anno nell'antica Roma: La vita quotidiana dei romani attraverso il loro calendarioDa EverandUn Anno nell'antica Roma: La vita quotidiana dei romani attraverso il loro calendarioNessuna valutazione finora
- Storia del terrorismo in Italia. L'oblio delle vittime, il potere dei carneficiDa EverandStoria del terrorismo in Italia. L'oblio delle vittime, il potere dei carneficiNessuna valutazione finora
- Concorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaDa EverandConcorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaNessuna valutazione finora
- Sicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuoleDa EverandSicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuoleNessuna valutazione finora
- Il Sistema. Licio Gelli, Giulio Andreotti e i rapporti tra Mafia Politica e MassoneriaDa EverandIl Sistema. Licio Gelli, Giulio Andreotti e i rapporti tra Mafia Politica e MassoneriaNessuna valutazione finora
- Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitariDa EverandDiritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitariNessuna valutazione finora
- Antifa: Storia contemporanea dell'antifascismo militante europeoDa EverandAntifa: Storia contemporanea dell'antifascismo militante europeoNessuna valutazione finora