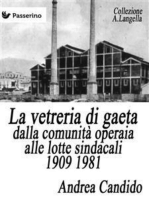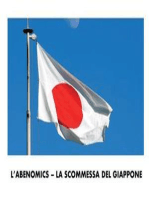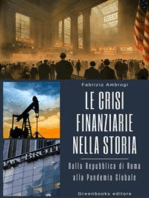Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Sistema Finanziario Globale Dal 1750 Ad Oggi
Caricato da
NiccolòCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Sistema Finanziario Globale Dal 1750 Ad Oggi
Caricato da
NiccolòCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|10542031
Il sistema finanziario globale. Dal 1750 ad oggi
Storia economica della moneta e della banca (Università degli Studi di Firenze)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
CAPITOLO 1: LA GRANDE DIVERGENZA La storia economica ha come oggetto la natura
e le cause della ricchezza delle nazioni (gli economisti cercano quelle “cause”, mentre gli
storici dell’economia le ravvisano in un processo dinamico di cambiamento); essa, è
divenuta particolarmente importante in anni precedenti, quando la domanda “perché certi
paesi sono ricchi e altri poveri?” ha acquisito una portata globale. Sembra che nel 1500 le
differenze di prosperità fra i vari paesi fossero limitate. La divisione ebbe sostanzialmente
origine all’epoca in cui Vasco da Gama salpò per l’India e Colombo scoprì le Americhe.
Possiamo, quindi, dividere gli ultimi cinque secoli in tre periodi:
1. 1500-1800 (Era mercantilista): iniziò con i viaggi di Colombo e da Gama e si concluse
con la rivoluzione industriale. Le Americhe furono colonizzate e iniziarono ad esportare
argento, zucchero e tabacco; molti africani furono portati nelle Americhe e ridotti in
schiavitù per produrre queste merci. I principali paesi Europei cercarono di espandere i
propri mercati colonizzando territori ed escludendo, attraverso dazi e guerre, gli altri paesi
dal commercio. Dall’Asia arrivarono in Europa spezie, tessuti e porcellane.
2. 1800 (Fase del catch-up): quando Napoleone fu sconfitto a Waterloo, nel 1815,
l’Inghilterra aveva raggiunto la supremazia nell’industria e stava estromettendo gli altri
paesi dai mercati. L’Europa occidentale e gli Stati Uniti cercarono di raggiungere lo
sviluppo economico attraverso la combinazione di 4 politiche standard: 1. Creare un
mercato nazionale unificato, con l’eliminazione dei dazi interni e la costruzione di una rete
di trasporti; 2. Erigere una barriera doganale per proteggere le proprie industrie dalla
concorrenza inglese; 3. Stabilizzare la moneta e finanziare gli investimenti industriali,
promovendo le banche; 4. Incrementare la qualità della forza lavoro istituendo il sistema
dell’istruzione di massa.
Queste politiche ebbero successo in questi paesi, che insieme all’Inghilterra, andarono a
costituire l’attuale club delle Nazioni ricche.
3. 1900 (Tecnologia + produttività): nel 1900, queste politiche che avevano avuto
successo in quei paesi, ebbero meno successo nei paesi non ancora sviluppati.
La tecnologia viene inventata, per lo più, nei paesi ricchi i quali sviluppano processi che
impiegano una quantità sempre maggiore di capitale per aumentare la produttività della
manodopera, sempre più costosa. La maggior parte dei paesi ha adottato tecnologie
moderne, ma non abbastanza da colmare il divario con i paesi ricchi. Mentre, altri paesi
sono riusciti, invece, a colmare il divario rispetto all’Occidente del XX secolo, grazie a un
Big Push (che ha puntato sulla pianificazione e sul coordinamento degli investimenti per
compiere un grande balzo in avanti). Nel 1820 l’Europa era il continente più ricco (il paese
più prospero era l’Olanda, con un pil pro capite di 1838$) quindi, il principale problema che
si poneva alla politica economica in altri paesi, era di colmare il divario con gli Olandesi (gli
inglesi ci stavano riuscendo). Dal 1820 a oggi le differenze di reddito si sono accentuate,
con poche eccezioni: i paesi più ricchi, nel 1820, sono cresciuti più rapidamente, mentre i
paesi con redditi inizialmente più bassi sono cresciuti molto più lentamente (per esempio:
Asia meridionale e Medio Oriente). Le eccezioni alla divergenza dei redditi sono state,
principalmente, l’Asia orientale, il Giappone, la Corea del sud, il Taiwan e l’Unione
Sovietica (che si sono mosse controtendenza). Nel 1750 la maggior parte della
produzione manifatturiera era realizzata in Cina (33% tot. Mond.) e India (25%), ma nel
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
1913 il mondo era cambiato e la causa fu l’industrializzazione Europea: il Regno Unito, gli
Stati Uniti e l’Europa producevano tre quarti del totale, mentre la quota cinese e indiana
erano crollate, poiché le loro industrie tessili e metallurgiche erano state estromesse dal
mercato “meccanizzato” dell’Occidente. L’economia Asiatica, si trasformò cosi, in quella
classica del Sottosviluppo (specializzata nella produzione e nell’esportazione di beni
agricoli). La quota inglese, invece, salì dal 2% al 23% durante la rivoluzione industriale. Il
periodo 1880 – seconda guerra mondiale, fu segnato dall’industrializzazione degli Stati
Uniti e, in particolare dell’Europa continentale.
A partire dalla seconda guerra mondiale fino al 1980, la quota del prodotto manifatturiero
mondiale dell’Unione Sovietica aumentò fortemente, per poi cadere verticalmente,
trascinata dal declino delle ex Repubbliche Sovietiche. A partire dal 1980 l’Asia orientale
vide la quota produttiva manifatturiera mondiale di Giappone, Taiwan e Corea del sud
salire al 17%; anche la Cina si stava industrializzando a partire dal 1980.
SALARI REALI Il Pil non misura adeguatamente il benessere (non tiene conto di tanti
fattori, quali la salute, la speranza di vita e il livello di istruzione), poiché è la media dei
redditi dei ricchi e dei poveri. Questo problema può essere risolto calcolando i “salari reali”,
cioè il tenore di vita che può essere raggiunto con i guadagni individuali. Per calcolare il
tenore di vita di un lavoratore dobbiamo confrontare il salario con i prezzi dei beni di
consumo e di questi prezzi occorre calcolare la media per costruire un indice. L’indice che
prendiamo in considerazione consiste nel costo del mantenimento di un uomo della mera
sussistenza fisiologica, cioè del modo meno costoso per mantenersi in vita. Oggi, così
come allora, il tenore di vita in tutta Europa era alto (i lavoratori guadagnavano circa
quattro volte il costo della mera sussistenza); gli operai dell’Inghilterra meridionale
avevano anche il reddito necessario per acquisire i beni di lusso (come libri o
zucchero). Nei paesi poveri, invece, i salari reali sono rimasti al livello di mera
sussistenza Queste società vivono al limite della sopravvivenza e per questo non hanno
incentivi a svilupparsi: la manodopera è abbondante ed economica e le imprese non
hanno convenienza ad utilizzare macchine per l’aumento della produttività. Il vivere al
livello della sussistenza ha altre conseguenze per il benessere sociale ed economico:
1. Coloro che mangiano quanto basta per sopravvivere sono di bassa statura e la bassa
statura è accompagnata dalla riduzione della speranza di vita e dal generale
deterioramento della salute.
2. Queste persone sono meno istruite. Quindi, gli alti salari contribuiscono alla crescita
economica in quanto sostengono la salute e l’istruzione: il livello di sussistenza è la
trappola della povertà.
CAPITOLO 2: L’ASCESA DELL’OCCIDENTE Il processo per cui il mondo è divenuto
sempre più disuguale è la risultante di diversi fattori, tra cui:
1. La geografia: la disponibilità di risorse (grazie ai giacimenti carboniferi in Inghilterra,
abbiamo avuto la rivoluzione industriale), il clima e la distanza dai mercati sono tutti fattori
che contribuiscono a spiegare il fenomeno. La sua rilevanza dipende dalla tecnologia e
dalle opportunità economiche (uno degli scopi della tecnologia è proprio quello di ridurre il
peso dei fattori geografici sfavorevoli, quindi le condizioni diverse si possono riequilibrare
con la tecnologia).
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
2. La cultura: indicata, spesso, come fattore determinante del successo economico. Max
Weber, ad esempio, ha sostenuto che il protestantesimo ha reso i popoli dell’Europa
settentrionale più razionali e più inclini a lavorare duramente (questo sembrava plausibile
nel 1900, quando l’Inghilterra protestante, era più ricca dell’Italia cattolica; oggi è, però,
vero il contrario e questa teoria non è più sostenibile). Ci sono, comunque, aspetti della
cultura che incidono sulle performance economiche; in particolare, l’alfabetizzazione e la
capacità di far di conto (diffuse attraverso l’istruzione di massa) sono state condizioni che
hanno inciso sullo sviluppo economico.
3. Le istituzioni politiche e giuridiche: molti economisti sostengono che il successo
economico è il risultato dell’esistenza di ben definiti diritti di proprietà, di una bassa
tassazione e di interventi dello Stato ridotti al minimo (opinioni che riecheggiano quelle di
Smith e altri autori liberali). Gli storici, invece, hanno analizzato l’effettivo funzionamento
delle monarchie assolute e delle forme di dispotismo orientale, constatando che esse
promuovevano la pace, l’ordine e il buon governo, di conseguenza il commercio fioriva e le
città si espandevano.
4. Le cause immediate dello sviluppo disuguale sono riconducibili al: cambiamento
tecnologico, alla globalizzazione e alle politiche economiche.
LA PRIMA GLOBALIZZAZIONE La grande divergenza ha inizio con la prima
globalizzazione che iniziò nel tardo XV secolo con i viaggi di Colombo, Magellano e altri
esploratori. Questi viaggi necessitavano di navi in grado di compiere le grandi traversate
oceaniche. Queste navi, gli Europei, non le ebbero fino al XV secolo, quando furono
inventati i trealberi.
• Inizialmente, l’impatto dei trealberi sul commercio si avvertì in Europa dove si cominciò a
spedire grano polacco e presto anche i tessuti: gli Italiani avevano dominato l’industria
tessile nel Medioevo, ma, successivamente, fabbricanti inglesi e olandesi riuscirono a
produrre tessuti che imitavano quelli italiani, estromettendoli dal mercato. Questo, fu un
cambiamento di grande portata che avviò la rilocalizzazione dell’industria manifatturiera
Europea verso l’Europa nordoccidentale.
• La comparsa dei trealberi si manifestò nei viaggi che portarono alle grandi scoperte
geografiche. Nel 1498: Vasco de Gama raggiunge Cochin, in India, e riempie la nave di
pepe (a Cochin il pepe costava il 4% del prezzo europeo, l’altro 96% della differenza di
prezzo, era dovuto ai costi di traporto). Nel 1760 il divario tra il prezzo inglese e indiano del
pepe era sceso dell’85%, grazie all’utilizzazione di rotte marittime. Ma, soltanto il
Portogallo beneficiò dei costi di traporto, infatti, mantenne alto il livello del prezzo e intascò
il risparmio di costo. Fu l’entrata in scena delle compagnie delle Indie Orientali, inglese e
francese che distrusse il monopolio portoghese delle rotte marittime e tagliò il prezzo
europeo di 2/3. Il navigatore genovese Cristoforo Colombo propose l’ovvia alternativa di
raggiungere l’Asia navigando dall’Europa verso Occidente. Il 12 ottobre 1492 Colombo
sbarcò alle Bahamas, convinto di aver raggiunto le Indie Orientali: aveva, invece, scoperto
l’America.
Colombo e da Gama innescarono, così, grazie a questi viaggi, la lotta per la conquista dei
territori tra le potenze imperiali: Portoghesi e Spagnoli furono i primi vincitori. I portoghesi
affermarono la propria egemonia nell’Oceano Indiano, si spinsero verso l’Indonesia,
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
creando lungo il cammino una rete di colonie, raggiunsero poi le isole delle spezie, dove
cresceva la noce moscata, i chiodi di garofano e i macis. Scoprirono casualmente il
Brasile, che divenne la loro colonia più vasta. Gli spagnoli, invece, ancora più ricchi
conquistarono l’impero azteco e quello inca: il saccheggio di questi due popoli fruttò un
enorme ricchezza alla Spagna, scoprirono poi ampi giacimenti di argento in Bolivia e
Messico. L’argento fornì agli Europei il denaro occorrente per comprare merci asiatiche,
ma provocò decenni di inflazione. Nel XVI secolo, i paesi dell’Europa settentrionale non
fecero grandi progressi nella costruzione di imperi: si dovette aspettare fino al XVII secolo
perché divenissero importanti potenze imperiali. La compagnia olandese delle Indie
Orientali creò un impero olandese in Asia, a spese dei portoghesi, conquistarono alcuni
possedimenti indonesiani, negli anni 30/40 del seicento anche il brasile e nel 1624
fondarono New York. Nel XVII secolo, anche gli inglesi crearono un impero, specialmente
a spese degli olandesi: i primi passi furono compiuti da Cromwell nel periodo del
Commonwealth e proseguirono dopo la restaurazione. Il primo navigation act fu
approvato nel 1651 (misura mercantilista che mirava ad escludere gli olandesi dal
commercio con i possedimenti inglesi). La prima guerra anglo-olandese fu combatta per
ottenere vantaggi commerciali, ma dette scarsi risultati. Il commercio degli inglesi e
olandesi, con le rispettive colonie dette un forte impulso allo sviluppo delle loro economie,
che videro una forte crescita di città e industrie. Si modificò, di conseguenza, la struttura
occupazionale. Nel 1500, le economie più avanzate erano quella italiana e spagnola (la
popolazione olandese era poco numerosa e l’Inghilterra era prevalentemente dedita alla
pastorizia). Alla vigilia della rivoluzione industriale si verificarono grossi cambiamenti: in
Inghilterra, l’urbanizzazione era progredita più rapidamente che in qualsiasi altro paese
europeo (il 32% della popolazione rurale, non agricola, era occupata in industrie
manifatturiere; i Paesi Bassi erano ancora più urbanizzati e avevano anche loro industrie
esportatrici di grosse dimensioni; la trasformazione fu molto meno accentuata nel resto
d’Europa, in particolare, in Spagna dove nel XVI secolo sembrava la nazione più fortunata,
data
l’enorme quantità di argento che affluiva, ma questo determinò una forte inflazione che
causò una riduzione di competitività, per la Spagna, nell’agricoltura e nell’industria. La
globalizzazione fece, quindi, avanzare l’Europa occidentale, facendo perdere terreno
all’Europa meridionale. Il successo nell’economia globale ebbe importanti conseguenze
per lo sviluppo economico:
1. La crescita dell’urbanizzazione e delle industrie manifatturiere accrebbe la domanda di
manodopera e portò ad alti salari, che contribuirono a determinare gli elevati tenori di vita
a Londra e Amsterdam);
2. L’espansione urbana e gli alti salari determinarono per il settore agricolo una forte
domanda di generi alimentari: il risultato furono le rivoluzioni agricole in Inghilterra e Paesi
Bassi;
3. La crescente domanda originata dai centri urbani portò a drastici cambiamenti
nell’utilizzo delle fonti energetiche;
4. Un’economia ad alti salari generò un alto livello di alfabetizzazione e di capacità
professionali in generale.
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
CAPITOLO 3: LA ROVOLUZIONE INDUSTRIALE La rivoluzione industriale (1760-1850)
inaugurò l’era della crescita economica, inoltre, consentì al reddito di aumentare fino a
raggiungere la prosperità di massa dei nostri giorni. Il motore della rivoluzione industriale
furono il cambiamento tecnologico e le innovazioni. Comparvero numerose invenzioni, tra
le quali, la macchina a vapore, le macchine per filare e tessere il cotone e nuovi processi
per fondere e raffinare il ferro e produrre l’acciaio. Furono, poi, inventate macchine più
piccole, che accrebbero la produttività del lavoro in industrie minori. Ma perché la
tecnologia rivoluzionaria fu inventata in Inghilterra? La rivoluzione ebbe luogo in un
particolare contesto politico e culturale che era favorevole all’invenzione.
1. La costituzione inglese aveva molte caratteristiche che promossero la crescita
economica: la costituzione inglese era tutt’altro che democratica, solo il 3-5% della
popolazione poteva votare; la corona conservava molto potere e, in particolare, quello di
decidere se dichiarare una guerra o concludere la pace. Lo stato inglese, incassando
quasi il doppio di imposte pro capite, di quello francese, spendeva una frazione maggiore
del reddito nazionale e questo contribuì alla crescita economica.
2. La crescita economica fu promossa anche dal potere del parlamento di espropriare
individui contro la loro volontà, il che non era possibile in Francia.
3. La rivoluzione industriale fu sostenuta anche da una cultura scientifica emergente: la
rivoluzione scientifica del XVII secolo, portò ad alcune scoperte relative alla realtà
naturale, che furono applicate da inventori nel XVIII secolo.
4. I cambiamenti più potenti furono l’urbanizzazione e la crescita del commercio, poiché
incoraggiarono la diffusione dell’alfabetizzazione e della capacità di far di conto.
Ma la conoscenza delle scoperte scientifiche era diffusa in tutta Europa, non solo in
Inghilterra, quindi ciò non può spiegare perché la rivoluzione industriale si verificò lì. La
spiegazione va invece ravvisata nella struttura dei salari e dei prezzi. L’economia inglese,
con i suoi alti salari e l’energia a buon mercato, rese conveniente per le imprese locali,
inventare e utilizzare tecnologie all’avanguardia, poiché i salari inglesi erano alti rispetto al
costo del capitale e l’Inghilterra grazie ai suoi giacimenti carboniferi, aveva l’energia più a
buon mercato del mondo. Quindi, le imprese trovavano conveniente utilizzare le tecnologie
per risparmiare il lavoro (relativamente costoso), intensificando l’impiego dei due fattori a
buon mercato: l’energia e il capitale. In Asia e in Africa, il basso prezzo del lavoro
determinò un esito opposto.
L’INDUSTRIA DEL COTONE Dalla metà del XVIII secolo, l’industria del cotone crebbe
sino a divenire, nel 1830, la più grande industria inglese, con l’8% del Pil e il 16% degli
addetti manifatturieri. Famosa l’espressione di Eric Hobsbawm “chi dice rivoluzione
industriale dice cotone”. Lo sviluppo della produzione cotoniera portò all’esplosiva crescita
di molte città (come Manchester). Nel XVII secolo, la Cina e l’India avevano le industrie
cotoniere più grandi al mondo: in questo mercato i tessuti inglesi concorrevano con quelli
Indiani. In Inghilterra i salari erano talmente elevati che i produttori
inglesi potevano sostenere la concorrenza con quelli indiani solamente nel mercato dei
tessuti più grezzi; quindi, avrebbe dovuto inventare macchine in grado di ridurre l’impiego
di manodopera. Dunque, la concorrenza internazionale, fornì lo stimolo che portò alla
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
meccanizzazione della filatura di cotone. Vi furono numerosi tentativi di meccanizzazione
della produzione. Queste macchine intensificarono l’uso del capitale per risparmiare
manodopera, quindi era conveniente utilizzarle là dove il lavoro era costoso e il capitale a
buon mercato, cioè in Inghilterra (per questo fu la culla della rivoluzione industriale). La
spinning Jenny e la Waterframe resero il cotone più competitivo rispetto a quello indiano
nel mercato del tessuto grezzo, mentre il Mule (spinning Jenny più un telaio ad acqua)
consentì agli industriali inglesi di produrre anche i tessuti fini a un costo particolarmente
basso. Non avrebbe avuto alcun senso inventare la filatura meccanica in Francia e in India
perché non era redditizio utilizzarla in quei due paesi. La situazione non rimase però
immutata, negli anni 20 dell’800 divenne economicamente conveniente installare
macchine per la lavorazione del cotone in tutta l’Europa continentale, negli anni 50 anche
nei paesi caratterizzati dai bassi salari come India e Messico. Negli anni 70 i cotonifici
iniziarono a spostarsi nei paesi del terzo mondo.
LA MACCHINA A VAPORE La macchina a vapore fu una tecnologia prodotta dalla
rivoluzione industriale, che indusse le maggiori trasformazioni, poiché consentì di utilizzare
l’energia meccanica in un’ampia serie di industrie. Il tema della pressione atmosferica
attrasse l’interesse di numerosi scienziati, i quali dimostrarono che una volta creato il
vuoto in un cilindro, la pressione dell’atmosfera vi avrebbe spinto un pistone. Nel 1675,
Denis Papin si avvalse di quest’idea per creare un prototipo di macchina a vapore, ma poi
elaborato e messo a punto da Thomas Newcomen, nel 1712, dopo 12 anni di
sperimentazioni. Lo scopo della macchina di Newcomen era quello di drenare le miniere,
che in Inghilterra erano molto numerose. La teoria della forza a vapore era nota in tutta
Europa, ma le attività di ricerca e di sviluppo furono svolte in Inghilterra perché era lì che
conveniva usare la macchina a vapore; inoltre, le grandi macchine a vapore,
consumavano grosse quantità di carbone e quindi erano efficienti in termini di costi, là
dove l’energia era a buon mercato. Alcuni ingegneri (come James Watt o Arthur Woolf)
modificarono la macchina, riducendone il fabbisogno energetico e rendendo regolare
l’erogazione di potenza, così il consumo del carbone per cavallo vapore/ora fu ridotto e
questo demolì il vantaggio competitivo dell’Inghilterra fino al punto di poterla utilizzare in
tutto il mondo. Questo consentì alla rivoluzione industriale di propagarsi nel resto del
mondo.
L’INVENZIONE ININTERROTTA Edmund Cartwright passò decenni a perfezionare il suo
telaio meccanico. Brevettò il suo primo telaio nel 1785 e una versione migliorata nel 1792:
non era però sostenibile commercialmente, così, molti inventori lo migliorarono a poco a
poco. Negli anni ’20 dell’800, in Inghilterra, il telaio meccanico, stava rimpiazzando quelli a
mano. Fu adottato, però, più rapidamente negli USA che in Inghilterra, poiché negli anni
’20 dell’800, i salari erano più alti oltreoceano che in Inghilterra. Ma oltre ad essere
utilizzato nei cotonifici, il vapore, rivoluzionò anche il trasporto: da molto tempo, il carbone
e i minerali di ferro venivano caricati su carrelli che scorrevano su rudimentali rotaie di
legno installate nelle miniere. Nel XVIII secolo, le rotaie di ferro, rimpiazzarono quelle di
legno e le linee furono estese. Nel 1804, Richard Trevithick costruì la prima locomotiva a
vapore su rotaia, nel Galles; fu, inoltre, costruita la prima ferrovia in grado di trasportare
passeggeri e merci, di 35 miglia tra Manchester e Liverpool, aperta nel 1830. La macchina
a vapore fu applicata anche alla navigazione: il primo battello ad avere successo fu il
Clermont di Robert Fulton, che iniziò a navigare regolarmente nell’Hudson dal 1807. Il
vapore, andava sostituendo anche la vela, nel traporto oceanico, ma ci volle un secolo
prima che il vapore prendesse il sopravvento sulla vela, poiché le navi dovevano
trasportare grosse quantità di carbone e questo andava ad occupare molto spazio utile. Il
passaggio al vapore ebbe, quindi, inizio su rotte brevi. Solo, successivamente, quando si
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
ridusse il fabbisogno di carbone, le navi potevano percorrere distanze più lunghe
consumandone la stessa quantità.
La forza vapore è un esempio di General-Purpose Technology (GPT), tecnologia
multiscopo, che può cioè servire a una molteplicità di applicazioni: il loro contributo alla
crescita economica si manifesta molto tempo dopo l’invenzione, la quale inizialmente non
diede un contributo esiguo all’economia, ma poi si riuscì a sfruttarne pienamente le
potenzialità, applicandola diffusamente ai trasporti e all’industria.
CAPITOLO 4: L’ASCESA DEI RICCHI Tra il 1815 e il 1870, la rivoluzione industriale di
propagò con successo dall’Inghilterra al continente. Anche l’America settentrionale si
industrializzò nel XIX secolo, anzi gli USA divennero il leader mondiale della tecnologia.
Mentre l’Inghilterra non aveva una politica di “industrializzazione”, quasi tutti i paesi che ne
seguirono le orme ebbero una strategia per emularne il successo. Nel XIX secolo,
emersero un insieme di politiche dello sviluppo (adottate da molti paesi), originariamente
elaborate in USA e poi promosse in Europa da Friedrich List, il quale aveva vissuto negli
Stati Uniti, ritornando in Germania per scrivere nel 1841 “il sistema nazionale di economia
politica”. I quattro fattori dello sviluppo erano:
1. Creare un mercato nazionale abolendo i dazi interni e migliorando i trasporti; 2.
Innalzare una barriera doganale nazionale per proteggere le industrie dalla concorrenza
inglese; 3. Creare banche per stabilizzare la moneta e fornire capitale alle imprese: 4.
Istituire un sistema di istruzione di massa per accelerare l’adozione e l’invenzione di
tecnologie.
Questa strategia di sviluppo aiutò l’Europa continentale a raggiungere l’Inghilterra: la
Germania ne fu un esempio calzante.
- Istituì un sistema di istruzione elementare universale - La Prussia creò un mercato
nazionale nel 1818, lo Zollverein, per unificare il proprio territorio e per
limitare l’accesso ai produttori inglesi. L’unione economica formò la base dell’impero
tedesco. - L’integrazione dei mercati fu rafforzata dalla costruzione di ferrovie. La prima fu
costruita tra
Norimberga e Fürth. - Nel 1813 fece la sua comparsa la banca Darmstadt, che rese
popolari in Germania le banche
d’investimento a capitale azionario. 20 anni dopo, erano già state fondate diverse banche.
Furono queste banche a sostenere la grande espansione dell’industria tra il 1880 e la
prima guerra mondiale.
Tra il 1815 e il 1870, nel continente, furono create tutte le principali industrie della
rivoluzione industriale: prima della rivoluzione industriale non erano convenienti, ma verso
la metà degli anni ’30 dell’800, il progresso tecnico aveva ridotto i costi del 42%. Nel 1870,
nell’Europa continentale era già stata creata una moderna industria siderurgica: il carbone
di legna fu sostituito dal coke (un tipo di carbone raffinato). Questa tecnica fu messa in
pratica da Abraham Darby nel 1709. Ma l’impiego del coke, nella produzione di ferro non
fu conveniente fino al 1750, così lo si utilizzò, inizialmente, solo per un particolare
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
processo di fusione brevettato da Darby. Tra il 1750 e il 1790, il coke sostituì il carbone di
legna nella produzione di ferro; tuttavia, il coke era ancora troppo costoso. La transazione
si verificò negli anni ’60 dell’800, quando imprese francesi e tedesche fecero un salto di
qualità, passando alla tecnologia siderurgica d’avanguardia, poiché era quella la sola
forma di tecnologia competitiva nei paesi occidentali. Inoltre, l’Europa non rimase indietro
rispetto all’Inghilterra neppure nelle nuove industrie: i paesi occidentali costruirono ferrovie
e locomotive e l’acciaio, che prima del 1850 era un prodotto costoso, grazie a quattro
inventori, costruirono un forno per fondere l’acciaio. Dunque, nel 1870, i paesi dell’Europa
continentale avevano ormai superato le carenze tecnologiche, ma i livelli quantitativi della
loro produzione erano ancora molto inferiori rispetto all’Inghilterra. Questa situazione
cambiò con la prima guerra mondiale, poiché sia l’Europa, sia gli USA superarono le
quantità prodotte dall’industria manifatturiera inglese. Quindi, superarono l’Inghilterra non
solo a volume di produzione, ma la raggiunsero anche sul piano della competenza
tecnologica. In una prospettiva globale, i paesi ricchi continuavano a sviluppare
innovazioni, mentre i paesi non sviluppati non produssero alcuna innovazione.
La natura Macroeconomica pag. 57
CAPITOLO 5: I GRANDI IMPERI Fuori dall’Europa, la Cina era il più grande impero ed
esisteva da migliaia di anni. Da millenni, gli europei erano a conoscenza delle ricchezze
dell’Asia e fu questa una delle ragioni per cui cercarono di raggiungerla navigando. Ma,
non tutti accettavano l’idea che l’Oriente fosse più prospero: erano, innanzitutto,
economisti come Smith, Malthus e Marx, i quali sostenevano che l’Europa fosse più ricca
e avesse migliori prospettive di crescita. Recentemente, sono stati messi in discussione da
una scuola di storia economica detta “californiana”, la quale sostiene che il sistema
giuridico della Cina era paragonabile a quello dell’Europa, i diritti di proprietà erano certi, il
sistema familiare cinese teneva bassa la percentuale di fecondità, i mercati delle merci e
della terra, del lavoro e del capitale erano evoluti quanto quelli europei. Quindi, la grande
differenza per cui la rivoluzione industriale è avvenuta in Europa e non in Asia è
riconducibile alla disponibilità di risorse, mentre riguardo alle istituzioni non vi erano
differenze istituzionali o culturali con l’Europa.
GLOBALIZZAZIONE E DEINDUSTRIALIZZAZIONE L’800 non fu un secolo felice per i
grandi imperi: l’India divenne formalmente una colonia inglese, imperatori cinesi, ottomani
e russi furono rovesciati negli anni ’20 dell’900. Le uniche e parziali eccezioni furono la
Russia e il Giappone. Tre fattori determinarono il successo e fallimento dell’economia fra
Waterloo e la seconda guerra mondiale: la tecnologia, la globalizzazione e le politiche
pubbliche. La rivoluzione industriale dell’Occidente estromise dal mercato i produttori
industriali asiatici per due motivi:
1. L’industria manifatturiera divenne più produttiva in Europa e tagliò di conseguenza i
costi, mentre i produttori asiatici dovevano sperare che gli inglesi migliorassero le
macchine filatrici in misura sufficiente a renderle efficienti in termini di costi anche in Asia,
oppure rimodellare le macchine per adattarle alle loro condizioni locali (come fece il
Giappone).
2. L’avvento della nave a vapore e della ferrovia ebbe l’effetto di intensificare la
concorrenza internazionale e con la caduta dei costi di traporto, l’economia mondiale
divenne sempre più integrata, e i produttori che usavano i metodi artigianali non riuscivano
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
a sostenere la concorrenza delle imprese occidentali. Quindi, dall’Asia al Medio Oriente, i
paesi diventarono i moderni paesi sottosviluppati.
Questi eventi furono il risultato di un principio fondamentale dell’economia: il vantaggio
comparato, secondo il quale, i paesi che commerciano fra loro si specializzano nella
produzione delle merci che possono produrre in modo relativamente efficiente, le
esportano e importano quelle che producono in modo inefficiente. Prima che Vaco da
Gama raggiunse Calicut, ogni paese era effettivamente tagliato fuori dal resto del mondo,
ma questo isolamento svanì con lo sviluppo dei trealberi, la navigazione globale, le navi a
vapore, la ferrovia ecc. Tutto ciò ha ridotto i costi delle transazioni internazionali, integrato i
mercati e provocato l’intensificazione della concorrenza nei mercati mondiali: la ricchezza
delle nazioni dipende sempre più dalle differenze di efficienza nella produzione. Il risultato
è stato il “sottosviluppo” del Terzo mondo. La politica pubblica è il terzo fattore che ha
influenzato l’andamento delle economie dopo Waterloo.
I TESSUTI DI COTONE In Inghilterra, durante la rivoluzione industriale, i perfezionamenti
delle macchine fecero aumentare la produttività dell’industria del cotone. Un aumento delle
attività manifatturiere, che non fosse stata bilanciata da un uguale incremento di quella
indiana, avrebbe necessariamente accresciuto la competitività dei produttori di cotone
inglesi, riducendo al contempo quella dei produttori indiani, secondo il principio
del vantaggio comparato. Viceversa, il vantaggio comparato dell’India, nella produzione
di merci agricole avrebbe dovuto crescere, scendendo al contempo in Inghilterra. Quindi,
secondo la logica del vantaggio comparato, la crescita sbilanciata della produttività,
durante la rivoluzione industriale, avrebbe dovuto favorire lo sviluppo industriale in
Inghilterra e la deindustrializzazione in India, ed è ciò che accadde.
Lo spostamento del vantaggio comparato si verificò in una fase di caduta dei costi di
trasporto. Essi scesero per una duplice causa: l’aumento dell’efficienza delle navi e
l’intensificazione della concorrenza sulle rotte marittime dall’Europa all’India. L’effetto della
crescita sbilanciata della produttività e del calo dei costi del trasporto marittimo si
manifesta nella storia dei prezzi del cotone in Inghilterra: nel 1812, il filato di cotone
costava 43 penny per libbra in India e, soltanto, 30 penny per libbra in Inghilterra. La
tecnologia disponibile nel 1802 non era abbastanza efficiente per consentire ai produttori
inglesi di mandare in rovina quelli indiani; si dovettero aspettare le macchine del 1812 per
riuscirvi. Poi si continuò a migliorare le macchine e nel 1826 il prezzo del filato inglese era
sceso a 16 penny. La produzione indiana di filato di cotone crollò e si riprese soltanto negli
anni ’70 dell’800, quando furono create fabbriche meccanizzate. Questa storia si ripeté
con la tessitura, ma i risultati non furono altrettanto catastrofici per l’India. I rispettivi prezzi
della tela di cotone inglese e di quella indiana non poterono divergere oltre un certo punto,
poiché gli acquirenti consideravano la tela inglese e quella indiana buono sostituti l’una
dell’altra. Fra il 1805 e il 1818 si verificarono due cambiamenti di grande portata: in primo
luogo, la differenza fra i prezzi in India e in Inghilterra divenne molto piccola. I mercati
erano integrati, cosicché i rispettivi sviluppi si influenzavano a vicenda. In secondo luogo, i
prezzi inglesi sceso al di sotto di quelli indiani e le esportazioni di tessuto dall’India
all’Inghilterra cessarono, poiché ora era l’Inghilterra a esportare in India. L’India divenne,
così, un grande paese importatore. Ma, siccome ogni paese ha un vantaggio comparato in
qualcosa, se l’India perse il suo nella produzione manifatturiera, ne ottenne un altro
nell’agricoltura. Mentre, l’integrazione dei mercati del filato e del tessuto si risolse in un
calo dei prezzi che costrinse i produttori indiani a uscire dal mercato, il contrario accadde
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
nel campo della coltivazione della pianta di cotone: il prezzo del cotone grezzo salì
gradualmente, portando a un’espansione della coltivazione e delle esportazioni di cotone
grezzo indiano destinato all’industria tessile inglese. Il cambiamento tecnologico tagliato
su misura delle esigenze dell’Occidente, sommato alla globalizzazione, promosse
l’industrializzazione dei paesi occidentali provocando al contempo la deindustrializzazione
delle antiche economie asiatiche.
L’INDUSTRIA MODERNA IN INDIA L’India era destinata a restare un paese meno
sviluppato che esportava prodotti primari e importava manufatti? Lo sviluppo industriale
richiedeva che l’economia abbandonasse il percorso dettato dal vantaggio comparato. Il
punto di vista nazionalista è che l’India necessitava delle politiche di sviluppo che avevano
aiutato l’Europa continentale e gli Usa a raggiungere il livello dell’Inghilterra. Ma, nel XIX
secolo soltanto l’1% della popolazione indiana era scolarizzato e il tasso di
alfabetizzazione della popolazione adulta era il 6%. I dazi erano bassi e applicati
esclusivamente per ottenere entrate, anziché per finalità di politica industriale. Non vi era
alcuna politica bancaria volta a finanziare l’industria. Il governo coloniale inoltre, fece sì
che la costruzione delle ferrovie indiane divenne un’occasione sprecata (quella di creare
un mercato interno protetto da dazi), favorendo le imprese inglesi e per la nascita delle
industrie siderurgiche e meccaniche si dovette aspettare il Novecento.
CAPITOLO 6: LE AMERICHE Le differenti traiettorie di sviluppo dell’America settentrionale
e di quella meridionale risalgono al periodo coloniale e sono determinate dalle diverse
condizioni geografiche e demografiche del continente: L’America meridionale aveva la
maggior parte della popolazione indigena e possedeva le maggiori ricchezze, ma era
anche più lontano dall’Europa e questo influiva sulla sua capacità di commerciare con
essa. L’America settentrionale, sull’aspetto geografico era più favorita, poiché essa era più
vicina all’Europa (principale mercato delle esportazioni coloniali). Siccome, i costi di
trasporto erano elevati, essa era avvantaggiata rispetto al Sud America. Anche l’interno del
continente poteva essere raggiunto dai tre grandi fiumi: l’Hudson, il San Lorenzo e il
Mississippi. Anche la demografia aveva la sua importanza: il clima temperato prevalente
negli Usa, nel Canada e in gran parte del Sudamerica non era malsano per gli europei,
che poterono moltiplicarsi in queste regioni. Al contrario, nelle regioni caraibica e
amazzonica le malattie tropicali causarono un’elevata mortalità fra la popolazioni europea
e ne frenarono la crescita.
La popolazione indigena era distribuita irregolarmente: la maggior parte viveva in Messico
o nelle Ande, altri vivevano negli odierni Stati Uniti. Questa differenza di popolamento
rifletteva i fattori geografici. L’arrivo degli Europei fu una catastrofe per gli indigeni poiché
essi portarono con sé malattie quali il vaiolo, il morbillo, l’influenza e il tifo, contro le quali
gli indigeni non avevano alcuna forma di difesa immunitaria. La popolazione indigena
passò così da 57 milioni nel 1500 a 5 milioni nel 1750 – il resto fu fatto dalle guerre di
sterminio, dallo schiavismo e dal trattamento disumano inflitto ai nativi dai coloni. Questo
crollo demografico ebbe conseguenze differenti nell’America settentrionale e in quella
meridionale, a causa delle diverse dimensioni raggiunte prima di venire a contatto con gli
europei: nel Messico la popolazione indigena scese, infatti, di oltre il 90%, crescendo
nuovamente dopo la metà del XVII secolo. Mentre nel Nordamerica, la situazione era
diversa: i pochi indigeni che vi abitavano, furono “spazzati via” dalle malattie prima
dell’arrivo dei padri pellegrini, “per far sì che loro trovassero posto in questa terra”. Quindi,
per l’effetto congiunto dell’elevata mortalità degli indigeni e della bassa mortalità dei
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
colonizzatori, le colonie americane divennero rapidamente una sorta di trapianto della
popolazione britannica. Facevano, ovviamente, eccezione a questo, le colonie che
sarebbero divenute il Sud degli Stati Uniti, dove gli europei importarono schiavi africani da
adibire ai lavori pesanti.
L’ECONOMIA COLONIALE DEL NORDAMERICA Nelle colonie britanniche del
Nordamerica il popolamento e le esportazioni erano strettamente connessi: l’economista
Harold Innis ha sottolineato questa connessione con la sua staple thesis, secondo la
quale la crescita di una regione come il Canada fu determinata dalla crescita delle sue
esportazioni verso l’Europa, le quali fornirono il denaro occorrente per acquistare
manufatti, importati dall’Inghilterra. Le staple colonies avevano tre caratteristiche:
1. I prezzi dei prodotti primari nella colonia erano minori di quelli europei, avendo quindi
convenienza ad esportarli;
2. I proventi delle esportazioni costituivano una proporzione elevata del reddito coloniale;
3. I ricavi percepiti dai coloni superavano quelli prevalenti in Europa in ragione di un
margine
sufficiente a coprire i costi e i rischi cui si esponeva chi si trasferiva nella colonia.
L’Inghilterra e le sue colonie nordamericane erano, quindi, luoghi prosperi, con salari
quattro o cinque volte maggiori del livello di sussistenza; dell’andamento dell’economia del
New England non si poteva dire la stessa cosa: la sua economia fu sempre in condizioni
precarie, perché mancava di prodotti agricoli di base. Gli abitanti del New England
crearono anche una grande industria cantieristica, ma l’espansione di queste attività fu
comunque lenta, cosicché la domanda di lavoro nel New England crebbe meno
rapidamente della popolazione. Sebbene la tesi della crescita delle economie coloniali sia
stata elaborata per spiegare il caso canadese, sono le sugar colonies caraibiche a
offrirne i migliori esempi: nel XVII e XVIII secolo, Barbados, Giamaica, Cuba e Santo
Domingo furono tra le più grandi fonti di ricchezza del mondo. Solitamente una colonia
caraibica coltivava zucchero e altri prodotti, come il caffè, e li esportava in Europa. Il
capitale e il lavoro erano forniti da investitori europei e schiavi africani. Le dimensioni
dell’economia coloniale erano determinate dal volume delle esportazioni. In Giamaica, per
esempio, nel 1832 i proventi delle esportazioni di zucchero e altri prodotti tropicali
ammontavano al 41% del reddito dell’isola. Nel sud dei futuri Stati Uniti si ritrovavano
molte caratteristiche del colonialismo caraibico. Il Sud era più ricco delle colonie
settentrionali, attraeva più coloni e vi veniva deportata la maggior parte degli schiavi. I
proventi delle esportazioni rappresentavano oltre il 30% del reddito totale: l’economia
ruotava intorno al riso, come quella della Giamaica intorno allo zucchero. Fra le colonie
britanniche esistevano grandi differenze in termini di disuguaglianze economiche e sociali.
Le colonie del New England e dell’area costiera centrale erano le più egualitarie,
l’abbondanza della terra ne conteneva il prezzo e faceva sì che la maggior parte dei
guadagni fosse percepita sotto forma di salari il che favoriva un’ampia distribuzione del
reddito: vi era una certa presenza di schiavi, ma la schiavitù era sostanzialmente
irrilevante in agricoltura, inoltre le colonie del nord avevano in comune un vantaggio che
prometteva bene per il futuro, ossia l’alto tasso di alfabetizzazione. All’altro estremo si
trovavano le colonie caraibiche, dove la popolazione era costituita per lo più da schiavi e la
disuguaglianza era estrema.
L’ECONOMIA COLONIALE DELL’AMERICA LATINA
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
10
Le diverse regioni dell’America Latina seguirono un percorso di sviluppo diverso da quello
dei futuri Stati Uniti e nessuna di esse ottenne risultati paragonabili. Si distinguono: 1) i
Caraibi e il Brasile, 2) il sud (Argentina, Cile e Uruguay) e 3) il Messico e le Ande.
1. In Brasile si verificarono sviluppi analoghi alle economie caraibiche: esso era
abbastanza vicino all’Europa per esportarvi zucchero. Fra il 1630 e il 1654 gli olandesi
occuparono Pernambuco, la provincia brasiliana grande produttrice di zucchero e quando
la abbandonarono, portarono con sé la produzione di zucchero, introducendola nei
Caraibi. I produttori caraibici erano più vicini all’Europa e riuscirono a battere la
concorrenza dello zucchero brasiliano, tagliando fuori le piantagioni brasiliane. La grande
espansione dello zucchero brasiliano ebbe termine. Nei tre secoli successivi la storia
economica del paese vide una successione di fasi di espansione, legate ciascuna a uno
specifico prodotto primario: l’oro (inizio del 1700), il caffè (1840-1930) e la gomma (1879-
1912).
2. La situazione dell’America Latina meridionale era analoga a quella del Nordamerica, in
quanto vi risiedeva una popolazione indigena poco numerosa che fu eliminata dalle
malattie, dalle guerre e dal trattamento disumano inflitto dagli europei. La differenza, però,
era che l’Argentina era troppo lontana dall’Europa per esportare i propri prodotti e ancora
di più lo era il Cile. L’economia di questi paesi segnò una svolta verso la metà del XIX
secolo, quando le navi furono talmente migliorate da consentire alle loro esportazioni di
competere con successo nei mercati europei.
3. Le più importanti colonie spagnole erano il Messico e le Ande: gli spagnoli qui trovarono
territori densamente popolati, grandi città, un’agricoltura produttiva ed enormi tesori di oro
e argento. I conquistadores abbatterono i sovrani aztechi e inca e ne presero il posto e i
tesori furono saccheggiati.
Rispetto al Nordamerica, un’altra importante differenza era costituita dalla geografia, che
impediva al Perù e al Messico di esportare prodotti primari agricoli; in pratica, i mercati
della costa occidentale dell’America erano più integrati con l’Asia che con l’Europa.
L’argento, in quanto principale merce di esportazione, presentava notevoli inconvenienti,
che impedirono al Messico e alle Ande di emulare lo sviluppo nordamericano: in primo
luogo aveva effetti inflazionistici, in secondo luogo l’argento non generava molti posti di
lavoro e in terzo luogo il reddito generato dalle miniere di argento finiva in gran parte nelle
tasche di una cerchia ristretta di ricchi proprietari, invece di venire distribuito alla
popolazione. Di conseguenza, l’argento contribuì, in America Latina, alla formazione di
una disuguaglianza eccezionalmente elevata. Il Messico non era, quindi, un’economia
basata sull’esportazione di prodotti primari, come quella nordamericana. L’espansione
dell’economia latino-americana si verificò sotto la dominazione spagnola e, quindi,
dimostra che le politiche spagnole per quanto illiberali, non erano talmente deleterie da
prevenirla. I salari erano determinati da fattori interni, dall’equilibrio fra offerta di terra e di
lavoro e dall’efficienza dell’economia. Quando la popolazione indigena crollò, il salario
reale aumentò e verso la metà del 1600 eguagliò il costo della sussistenza. Dopo la metà
del seicento la popolazione aumentò di 5 milioni di abitanti, ci fu un aumento della
domanda di posti di lavoro. L’agricoltura fu trasformata integrando coltivazione europee,
così come l’allevamento. Il trasporto fu rivoluzionato dall’introduzione di cavalli e muli e
l’industria manifatturiera fu stimolata dalla fabbricazione di nuovi prodotti (lana) e dalla
concentrazione della produzione in regioni specializzate, il che favorì la divisone del
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
lavoro. Sebbene nel periodo coloniale l’economia messicana sia cresciuta, la società
presentava un’accentuata disuguaglianza: una ricostruzione, mostra che la classe sociale
più abbiente (circa il 10% della popolazione) disponeva del 61% del reddito totale, mentre i
contadini (circa il 60% della popolazione) non ne percepivano che il 17%. La
disuguaglianza messicana era probabilmente simile a quella delle regioni caraibiche e del
Sud dei futuri Stati Uniti.
L’INDIPENDENZA: GLI STATI UNITI Gli Stati Uniti dichiararono l’indipendenza
dall’Inghilterra nel 1776 e stabilirono il loro sistema di governo con la costituzione adottata
nel 1787: l’economia decollò, la popolazione crebbe e il reddito pro-capite raddoppiò. La
produzione di tabacco, riso e indaco fu rimpiazzata dal cotone. Inizialmente, veniva
coltivato
11
in Georgia, ma non era un’attività molto redditizia, finché Eli Whitney non inventò la
macchina sgranatrice, dopodiché la coltivazione del cotone si diffuse in tutti gli Stati Uniti
del Sud. Negli anni ’50 dell’800 il settore cotoniero era altamente redditizio e la schiavitù
non avrebbe avuto fine senza la guerra civile. L’industrializzazione degli Usa dipese anche
da quattro politiche di sostegno che costituirono il modello standard dello sviluppo
economico nel XIX secolo: la prima fu la politica volta a diffondere l’istruzione di massa,
mentre le altre tre politiche erano quelle proposte originariamente da Alexander Hamilton.
Henry Clay, un senatore americano, etichettò le proposte di Hamilton come il “sistema
americano”, ma esse furono applicate da molti altri paesi, una volta rese popolari da
Friedrich List. La costituzione fu un primo passo verso la loro attuazione, poiché abolì i
dazi dei singoli stati e creò il quadro normativo di un mercato nazionale. I passi restanti
furono compiuti con la costruzione della strada di Cumberland, con il riconoscimento della
prima e poi della seconda banca degli Stati Uniti e l’introduzione di una serie di dazi. Il
protezionismo divenne la politica americana tipica. Fu soltanto a partire dalla seconda
guerra mondiale che gli Usa cercarono di disfare il sistema protezionista, rendendosi conto
che penetrare nei mercati di altri paesi era più conveniente ai loro interessi. Negli anni ’50
dell’800 l’industria cotoniera inglese era la più grande del mondo, ma gli Stati Uniti
venivano immediatamente dopo. Ma, nonostante il cotone procurasse uno dei maggiori
guadagni nei mercati esteri, le entrate derivanti dalle esportazioni complessive di cotone
ammontavano appena al 5-7% del Pil. Inoltre, il mercato del lavoro ottenne risultati migliori
di quelli previsti dalla teoria della crescita basata sull’esportazione di prodotti primari. Il
successo dei tessuti di cotone non dipese soltanto dai dazi protettivi, ma anche dai radicali
avanzamenti tecnologici che consentirono di risparmiare manodopera. Nel 1793 Samuel
Slater, realizzò e gestì il primo stabilimento che ebbe successo sul piano commerciale. Il
successivo passo avanti fu uno stabilimento che integrava le operazioni meccaniche di
filatura e tessitura, realizzato dalla Boston Manufacturing Company. Francis Cabot Lowell
aveva creato quell’azienda dopo aver visitato l’Inghilterra e aver visto in azione i telai
meccanici, di cui disegnò un modello a memoria. Negli anni ’20 dell’800, il salario reale
americano era maggiore di quello inglese e gli Americani adottarono il telaio meccanico
più rapidamente degli inglesi. L’America stava diventando il leader mondiale della
tecnologia industriale.
L’INDIPENDENZA: L’AMERICA LATINA L’indipendenza fu ottenuta nel 1821 con un colpo
di stato di creoli desiderosi di preservare i loro privilegi, che vedevano minacciati dal
liberalismo che andava rafforzandosi in Spagna. L’indipendenza fu seguita da decenni di
stagnazione economica e l’esito fu la deindustrializzazione. I salari reali caddero dal
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
doppio del livello di sussistenza nel 1780 al minimo necessario per sopravvivere negli anni
’30 dell’800. L’industria messicana del cotone crollò e la reazione fu l’adozione di una
versione del sistema americano di Henry Clay, insieme alle proposte di List, ma non vi fu
un generale avanzamento, come avvenne negli Usa. La successiva crescita economica si
verificò durante la dittatura di Diaz, fra il 1877 e il 1911. Diaz applicò le politiche standard
più vigorosamente di Alamàn. Fu creato un mercato nazionale mediante un vasto
programma di costruzioni ferroviarie e l’abolizione dei pedaggi sulle merci in transito negli
stati federali. Si ricorse a dazi per la protezione delle industrie messicane e novità di
questa politica economica fu il puntare su investimenti esteri, anziché sulle banche
d’investimento nazionali, per l’apporto di capitale. Il Pil salì da 670 dollari nel 1870 a 1700
nel 1910, dall’altro il contributo tecnologico locale fu scarso, poiché vennero installate
fabbriche progettate all’estero. Inoltre, i guadagni ottenuti erano circoscritti alle industrie
promosse dallo stato, i salari reali ebbero quindi un andamento tendenzialmente calante.
Differenza America Nord vs Sud pag. 94
CAPITOLO 7: L’AFRICA Nel 1500 l’Africa subsahariana era la regione più povera del
mondo ed è rimasta tale, nonostante l’aumento del reddito pro capite. Per capire perché
l’Africa oggi è povera dobbiamo capire perché lo era nel 1500. La risposta ruota intorno
alla geografia, alla demografia e all’origine dell’agricoltura. Fu la struttura
12
sociale ed economica esistente nel 1500 a determinare come allora il continente rispose
alla globalizzazione e all’imperialismo.
L’AFRICA E IL DIBATTITO SULLA GRANDE DIVERGENZA Nel 1550 l’Africa
subsahariana era povera perché non era una delle poche civiltà agricole avanzate. Le
civiltà agricole presentavano molti vantaggi da cui l’Africa era esclusa –un’agricoltura
produttiva, un’industria manifatturiera diversificata e le risorse istituzionali e culturali
necessarie per la crescita economica moderna. Questi tratti erano necessari per il
progresso del commercio, per lo sviluppo dell’apprendimento e per l’invenzione e la
diffusione della tecnologia moderna. L’Etiopia fu l’unica parte dell’Africa subsahariana a
sviluppare una cultura agraria avanzata. Il repertorio dell’Africa occidentale fu ampliato
introducendovi nuove coltivazioni di origine asiatica tra cui banane, plantano, igname
asiatico, taro e fagioli. Esso fu nuovamente ampliato in misura significativa nel XVI secolo
con l’introduzione del mais, della manioca, della noce e del tabacco originari delle
Americhe. Questi raccolti divennero rapidamente “tradizionali”, il che dimostra
l’inconsistenza della tesi della “immutabilità della tradizione” in quanto spiegazione della
povertà africana. Negli altopiani etiopici, dove le malattie tropicali erano assenti, la
popolazione crebbe rapidamente, mentre la crescita della popolazione nell’Africa
occidentale fu frenata dalle malattie tropicali che mantenevano elevato il tasso di mortalità.
La dieta era prevalente vegetariana, un poco di carne serviva più che altro a insaporire
l’igname; in aggiunta, una famiglia consumava olio di palma e circa 2 litri di vino di palma
al giorno. Questa dieta equivaleva all’assunzione di 1940 calorie al giorno, quindi, questa
gente era al livello della mera sussistenza. Gli abitanti producevano soltanto quanto
bastava per sfamarsi, ma nulla di più. A questo sistema produttivo si confacevano due tipi
di modelli politici: il primo era imperniato sulla banda o sulla tribù. I leader si comportavano
come i capi della banda o della tribù e mantenevano le proprie posizioni per mezzo della
persuasione. Questo sistema politico era relativamente egualitario. La coltivazione
itinerante presentava una caratteristica – la grande quantità di tempo libero di cui
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
godevano gli agricoltori- che dette origine alla gerarchizzazione dell’organizzazione
sociale.
LA TRATTA DEGLI SCHIAVI L’Africa occidentale esportava oro nel mondo mediterraneo e
arabo, ma nel XVI secolo comparve una merce di esportazione di gran lunga più
importante: gli schiavi. Le piantagioni di zucchero delle Americhe generarono una forte
domanda di lavoro che poteva essere soddisfatta nel modo più economico comprando
schiavi. I prigionieri venivano avviati verso la costa dove venivano venduti e imbarcati sulle
navi negriere europee. I re africani usavano il ricavato per comprare armi da fuoco, tessuti
e alcolici. Fra il 1500 e il 1850 da 10 a 12 milioni di schiavi furono deportati nel nuovo
mondo. Altri milioni furono trasportati attraverso il Sahara, o il Mar Rosso e l’oceano
Indiano per essere venduti in Asia.
IL COMMERCIO LECITO Nel XVIII secolo l’opinione pubblica illuminata e religiosa si
rivoltò contro la schiavitù cosicché nel 1807, nell’impero britannico, la tratta fu abolita. Gli
schiavi furono sostituiti da nuove merci di esportazione, cioè dagli oggetti del cosiddetto
“commercio lecito”. Il primo nuovo prodotto fu l’olio di palma (richiesto come lubrificante
per le macchine o per fare sapone e candele). Gli africani si impegnarono ad aumentare la
produzione delle nuove merci di esportazione, in quanto le potevano barattare con merci
di consumo. Importavano, inoltre, tessuti di cotone inglesi e metalli, permettendoseli grazie
alla produzione di olio di palma e esportando di tutto. La Nigeria era il principale
esportatore di olio di palma, ma la produzione si diffuse in tutta l’Africa occidentale: le
prospettive commerciali si ampliarono ulteriormente quando si scoprì che dal nocciolo
della palma si poteva estrarre un olio adatto alla produzione di margarina. La tipica
famiglia ora lavorava 155 giorni in più all’anno per produrre olio di palma, noccioli di palma
e vino di palma, venduti localmente. I prodotti derivati dai frutti della palma non erano
l’unica esportazione dell’Africa occidentale: vi era anche il cacao, originario delle Americhe
e introdotto in Africa nel XIX secolo. In Inghilterra il prezzo del cacao
13
raddoppiò rispetto al prezzo del tessuto di cotone tra gli anni ’40 e ’80 dell’800, e
quell’aumento stimolò gli africani a sperimentare metodi di produzione: una soluzione
consisteva nel separare la proprietà degli alberi da quella della terra, cosicché il piantatore
dell’albero poteva contare su un compenso per il suo investimento.
IL COLONIALISMO Un’altra spiegazione della povertà africana si rifà al colonialismo: in
molti luoghi la dominazione coloniale ebbe lo scopo di trasferire ricchezza dagli africani
agli europei. Benché sotto la dominazione coloniale si sia verificato un certo sviluppo, le
amministrazioni europee non fecero nulla per stimolare forme di moderna crescita
economica. Furono i portoghesi a dare origine al colonialismo europeo. Le altre maggiori
potenze europee crearono degli avamposti fortificati sulla costa dell’Africa occidentale per
facilitare la tratta degli schiavi; gli olandesi fondarono il loro insediamento nel Capo di
Buona Speranza. Nell’Ottocento il colonialismo europeo divenne più aggressivo, ma fu
soltanto alla fine del secolo che le potenze imperiali si spartirono il continente. Il
colonialismo in Africa si è dimostrato anche più rovinoso per lo sviluppo economico
rispetto ad altre parti del mondo: esso ha creato istituzioni pessime. Le prime colonie
africane furono organizzate per mezzo del “governo diretto”, in cui lo stato coloniale
applicava la legge metropolitana ai coloni e agli indigeni. Verso la fine del XIX secolo il
governo diretto fu rimpiazzato dal “governo indiretto”, con cui si mirava a rendere
l’occupazione straniera accetta alla popolazione indigena, riconoscendone tutte le
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
distinzioni etniche e offrendo potere e ricchezza ai capi. Diverse società erano
caratterizzate da una forte mobilità e il diritto di abbandonare le regioni governate da
regimi oppressivi; ma quel diritto fu eliminato quando gli individui furono assegnati
d’imperio a tribù che non potevano più lasciare. Usanze “barbare” come la schiavitù,
furono teoricamente bandite, mentre usanze utili al dominio coloniale, come il diritto dei
capi di comandare lavoro non retribuito, furono conservate, cosicché il lavoro forzato
divenne una caratteristica comune della realtà coloniale. Le politiche coloniali perseguite in
Africa furono tanto deleterie per la crescita quando quelle perseguite in India e altrove. I
governi coloniali adottarono soltanto un elemento del modello di sviluppo del XIX secolo: il
miglioramento dei sistemi di trasporto (furono costruiti 35000 km di ferrovie, intesi a
facilitare le esportazioni di prodotti primari); invece di venire utilizzati per proteggere
l’industria manifatturiera, i dazi furono tenuti a livelli bassi per favorire gli scambi; i governi
coloniali non cercarono di provvedere all’istruzione della popolazione africana: il tasso di
alfabetizzazione rimase molto basso fino a dopo l’indipendenza. I governi coloniali non
cercarono neppure di creare banche locali volte a finanziare gli investimenti. Vi erano
differenze fra le varie colonie:
- A un estremo vi erano le colonie britanniche dell’Africa occidentale, che furono la culla
del governo indiretto. La maggior parte del territorio era sottoposto al controllo dei capi
locali e l’acquisizione di terra da parte degli europei veniva scoraggiata.
- Le colonie tedesche, belghe e francesi dell’Africa occidentale adottarono politiche agrarie
e del lavoro che erano meno favorevoli agli interessi della popolazione indigena. I governi
coloniali espropriarono terre e le concessero a europei che vi investivano per creare
piantagioni e sfruttare miniere.
- Agli antipodi delle colonie inglesi troviamo le colonie di popolamento: il Sudafrica ne è
l’esempio più estremo, come anche lo Zimbabwe. Togliere il possesso della terra agli
indigeni era una politica volta ad assicurarsene il lavoro, oltre che acquisirne la terra.
LA POVERTA’ CONTEMPORANEA IN PROSPETTIVA STORICA All’inizio del XIX secolo,
l’Africa occidentale imboccò una strada che aveva molto in comune con quella delle
colonie nordamericane. Eppure, tutto questo progresso non riuscì a innescare una crescita
economica moderna. Perché? Una spiegazione del primo tipo mostra che dall’inizio del XX
secolo i prezzi reali dell’olio di palma e del cacao tendono a scendere. Entrambi i prezzi
raggiunsero valori estremamente bassi negli anni ’30 del 900. Il
14
prezzo dell’olio di palma non è più tornato al livello anteriore alla prima guerra mondiale,
mentre migliore è stato l’andamento dei paesi produttori di cacao, come il Ghana. Tuttavia,
gli incrementi di reddito andarono allo stato anziché ai coltivatori, poiché questi ultimi
erano costretti a vendere il cacao a un ente statale di commercializzazione che lo
rivendeva nei mercati nazionali. I produttori di cacao hanno subito, comunque, un analogo
crollo perdendo l’occasione di beneficiare degli aumenti dei redditi negli anni ’60- ’70,
poiché l’ente di commercializzazione del cacao non trasferiva loro i proventi derivanti dagli
alti prezzi del mercato mondiale. Se gli africani sono poveri è perché l’agricoltura del
continente genera un tenore di vita paragonabile a quello esistente nella prima guerra
mondiale. Sono due i motivi per cui l’agricoltura non riesce a fare di meglio:
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
1. La caduta dei prezzi delle esportazioni agricole, che dipende da tre ragioni: a.
L’invenzione di surrogati sempre a più buon mercato (come la produzione di lubrificanti
migliori
e meno costosi dell’olio di palma); b. La concorrenza dei produttori asiatici: a partire dal
XX secolo, le palme da olio sono state
coltivate nella piantagioni di Sumatra e della Malesia, dove sono cresciute meglio che
nell’Africa occidentale, estromettendola dai mercati;
c. L’espansione della produzione nello stesso continente africano (fattore particolarmente
importante per il cacao). La produzione si è estesa e i rezzi sono caduti; in questa
prospettiva la povertà africana è un circolo vizioso in cui i bassi salari mantengono bassi i
prezzi dell’esportazione che, a loro volta, mantengono bassi i salari.
2. Il secondo motivo è il livello della produttività basso e stagnante: la meccanizzazione
non è conveniente nell’Africa occidentale a causa del basso livello salariale. Questo è un
altro esempio della “trappola della tecnologia”: a causa dei bassi salari non è conveniente,
in termini di costi, adottare le tecnologie meccanizzate che occorrerebbero per elevare i
salari.
Questo squilibrio del mercato del lavoro riflette gli sviluppo degli ultimi 50 anni. Uno è la
crescita della popolazione, che è aumentata di 5 volte dal 1950 (l’esperienza delle altre
regioni tropicali induce a pensare che la causa immediata sia dovuta a un calo dei tassi di
mortalità, dovuto ai miglioramenti della sanità. Un altro sviluppo è stata la mancata
industrializzazione dell’Africa nel periodo esaminato. Questa mancata industrializzazione
può essere spiegata da tre fattori: 1. Il vantaggio comparato dell’Africa risiede nelle merci
che usano la terra e le risorse in modo intensivo. 2. L’assenza di reti di imprese
complementari: nei paesi ricchi la produzione ha luogo nell’ambito di reti urbane, dove le
imprese si sostengono a vicenda con la fornitura di prodotti e servizi specializzati. Queste
“economie esterne di scala” elevano la produttività. In Africa non vi nascerà mai una rete di
imprese proprio perché in assenza di una simile rete nel continente, nessuna impresa
troverà conveniente insidiarsi. 3. I salari in Africa erano troppo bassi per rendere redditizio
l’utilizzo della moderna tecnologia industriale ad alta intensità di capitale. Così l’Africa è
invischiata in un’altra trappola: la meccanizzazione dell’industria risolverebbe il problema
dei bassi salari, ma a causa dei bassi salari la meccanizzazione non è economicamente
conveniente.
CAPITOLO 8: IL MODELLO STANDARD E L’ULTIMA FASE
DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE Nel 1850 l’Europa e il Nordamerica avevano sopravanzato
il resto del mondo, mentre ai paesi poveri si poneva il problema di raggiungerli. Gli stati
indipendenti potevano applicare il modello standard che aveva funzionato in Usa e
nell’Europa occidentale, ma col tempo questa strategia si rivelò sempre meno efficace.
LA RUSSIA IMPERIALE La Russia fu a lungo la regione più arretrata d’Europa. Pietro il
Grande cercò di farne una moderna potenza occidentale, ma questo non riuscì a colmare
il divario con l’Occidente. Nel periodo successivo l’emancipazione dei sudditi dalla
condizione servile, il governo adottò il modello di sviluppo standard, ma con qualche
modifica. In primo luogo, fu creato un mercato nazionale per mezzo di un vasto
programma di costruzioni ferroviarie; in secondo luogo, si utilizzarono i dazi per favorire lo
sviluppo dell’industria; In terzo luogo, la maggiore innovazione della politica economica
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
russa riguardò la finanza. La Russia puntò sul capitale estero: le ferrovie furono finanziate
vendendone i titoli all’estero e l’investimento diretto estero divenne il principale canale
utilizzato per introdurre tecnologia avanzata. In
15
quarto luogo, l’istruzione fu estesa a partire dagli anni ’60 del’800: al tempo della prima
guerra mondiale quasi metà della popolazione adulta era alfabeta. L’applicazione del
modello standard “modificato” fece salire la quota dell’industria pesante dal 2% del Pil nel
1885 all’8% nel 1913, ma l’agricoltura rimase comunque il settore più importante. In
questo arco di tempo, il valore del prodotto agricolo raddoppiò, grazie all’aumento del
prezzo mondiale del grano. La crescita si arrestò di colpo quando il prezzo mondiale del
grano crollò, dopo la prima guerra mondiale. Nonostante la crescita del Pil, la domanda di
lavori non crebbe in misura sufficiente ad assicurare la piena occupazioni, così i salari
rimasero al livello della sussistenza e il reddito creato dalla crescita andò a ingrossare i
profitti dei padroni dell’industria e le rendite dei proprietari terrieri.
IL GIAPPONE (approfondimento pag. 129-137) Il Giappone costituisce un caso
particolare, in quanto fu il primo paese asiatico ad eguagliare il livello di
sviluppo dell’Occidente. La storia giapponese si divide in 4 epoche: l’epoca Tokugawa
(1603-1868); l’epoca
Meiji (1868-1905), che vide la restaurazione dell’imperatore Meiji e l’inizio della
modernizzazione
economica; l’epoca imperiale (1905-1940), con la diffusione dell’industria pesante e, infine,
l’epoca della
crescita accelerata (1950-90), durante la quale il Giappone raggiunse i paesi ricchi
dell’Occidente.
Nell’epoca Tokugawa la tecnologia progredì, ma nella direzione opposta a quella che
seguì in Inghilterra, poiché nell’Asia orientale i salari erano bassi e i giapponesi
inventarono tecnologie che intensificavano l’impiego di mano d’opera al fine di aumentare
la produttività della terra, del capitale e dei materiali. Lo sviluppo dell’epoca Tokugawa
produsse una prosperità caratterizzata da una forte disuguaglianza: i salari dei lavoratori
rimasero al livello della mera sussistenza, mentre molti godevano di una vita più agiata (il
15% della popolazione viveva nelle città). Il tasso di scolarizzazione era molto elevato per
una società agricola: oltre la metà dei maschi adulti erano alfabeti. Probabilmente, l’alto
livello d’istruzione era dovuto alla commercializzazione dell’economia giapponese, e fu
uno dei presupposti della crescita che sarebbe seguita. Il Giappone dell’epoca Tokugawa
raggiunse un livello di competenza tecnica e amministrativa. L’impulso venne dal settore
militare: nel 1808 HMS Phaeton entrò nel porto della città per attaccare il naviglio
olandese. Il Phaeton minacciò di bombardare il porto se gli olandesi non avessero fornito
gli approvvigionamenti richiesti. I giapponesi non avevano cannoni per difendersi.
Nabeshima Naomasa istituì un gruppo incaricato di creare una fonderia di cannoni.
LA RESTAURAZIONE MEIJI Nel 1867 l’imperatore Meiji ascese al trono: il nuovo regime
attuò forme radicali. Le quattro caste furono abolite, cosicché chiunque poteva svolgere
qualsiasi lavoro; i gravami feudali furono sostituiti da un’imposta fondiaria che forniva la
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
maggior parte delle entrate pubbliche al governo; nel 1873 fu introdotta la coscrizione
universale e fu creato un esercito di tipo occidentale; nel 1890 fu adottata una costituzione
che creò una monarchia costituzionale modellata su quella prussiana.
LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’EPOCA MEIJI Il governo Meiji avrebbe voluto
sviluppare il paese applicando il modello standard, ma riuscì a introdurre soltanto due dei
quattro elementi: il primo fu la creazione di un mercato nazionale, abolendo i dazi fra i
domini feudali e costruendo una rete ferroviaria; il secondo fu l’istruzione universale. Nel
1872 l’istruzione elementare fu resa obbligatoria e nel 1900 era estesa al 90% della
popolazione. Gli atri due elementi dello sviluppo – le banche d’investimento e i dazi
protettivi – furono più difficili da mettere in pratica. Per il Giappone era impossibile
applicare dazi poiché l’aliquota era vincolata al massimo del 5% da un trattato imposto al
paese dalle potenze occidentali. Lo stato intervenne nell’economia per mezzo di “politiche
industriali mirate”, i cui attori principali erano i ministeri degli interni e dell’industria, che
avevano il compito di importare tecnologia moderna. Negli anni ’70-’80 dell’800 entrambi i
ministeri erano convinti che le imprese giapponesi non avrebbero introdotto tecnologie
moderne al ritmo richiesto, così lo stato dovette intervenire con proprie iniziative
imprenditoriali: furono aperte miniere e create fabbriche che utilizzavano macchinari
avanzati d’importazione, ma la maggior parte di esse risultarono fallimentari dal punto di
vista commerciale.
16
I giapponesi risolsero il problema della tecnologia d’importazione rimodellando le
macchine al fine di renderle efficienti nella loro economia di bassi salari.
IL PERIODO IMPERIALE Il Giappone recuperò controllo dei suoi dazi nel 1894 e nel 1911,
e li alzò immediatamente per proteggere l’industria. Negli anni ’20 del Novecento il sistema
bancario era talmente maturato da riuscire a finanziare lo sviluppo industriale. Per di più il
Giappone conservò il suo sistema di politiche industriali mirate. La combinazione di diversi
tipi di politiche si dimostrò particolarmente efficace per la promozione dell’industria
pesante e, così, nel 1905 fu creata per fini strategici la Yawata Steel Works.
L’AMERICA LATINA I paesi latinoamericani sono stati gli ultimi a sperimentare il modello di
sviluppo standard. Il Messico, la regione andina, il Brasile e i Caraibi avevano fatto parte
dell’economia mondiale sin dal XVI secolo, ma l’America Latina meridionale era troppo
lontana dall’Europa per poter intrattenere dei rapporti commerciali con i paesi del
continente. Dopo il 1860, però, le navi a vapore resero conveniente esportare
dall’Argentina e dall’Uruguay. Le economie latinoamericane più grandi sperimentarono il
modello di sviluppo del XIX secolo: una notevole lacuna fu però la mancata istituzione
dell’istruzione universale. Faceva eccezione l’Argentina, che rese obbligatoria l’istruzione
e ebbe, così, la popolazione più istruita del continente. In seguito all’affermarsi della teoria
della dipendenza, il modello standard è stato applicato integralmente e l’istruzione è stata
finalmente resa universale. La produzione manifatturiera e l’urbanizzazione ebbero una
forte accelerazione. Nel 1980 il reddito pro capite era più del doppio di quello nel 1950. Ma
anche il debito estero aumentò e quando i tassi d’interesse salirono non fu più possibile
sostenerlo. L’America Latina entrò così in recessione e il modello standard giunse al suo
limite.
CAPITOLO 9: IL “BIG PUSH” VERSO L’INDUSTRIALIZZAZIONE Nel XX secolo
l’Occidente continuò a guadagnare terreno rispetto al resto del mondo, ma alcuni paesi,
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
segnatamente il Giappone, il Taiwan, la Corea del Sud e l’Unione Sovietica, si mossero in
controtendenza e colmarono il divario che li divideva dai paesi occidentali. I grandi paesi
avevano un solo modo di crescere così rapidamente: costruire simultaneamente tutti gli
elementi di un’economia avanzata – acciaierie, centrali elettriche, fabbriche di autoveicoli,
città ecc. Questo è il big push verso l’industrializzazione. Il big push costringe ad affrontare
difficili problemi, poiché tutto viene costruito prima che si materializzino la domanda e
l’offerta (esempio: si costruiscono le acciaierie prima delle fabbriche di automobili che
useranno i loro laminati; in pratica, prima che si possa contare su una domanda effettiva di
automobili).
LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOVIETICA L’Unione Sovietica è un classico esempio
di big push. Infatti, l’Urss si trovava di fronte allo stesso problema degli altri paesi poveri,
cioè costruire una moderna economia urbana, il che richiedeva massicci investimenti in
tecnologie moderne. La soluzione consistette nella pianificazione centralizzata e il Piano
quinquennale ne divenne il simbolo. Il big push sovietico ebbe inizio nel 1928, con il Piano
quinquennale che poggiava su quattro pilastri: Il primo consisteva nell’incanalare
l’investimento verso l’industria pesante e la produzione di macchinario, che acceleravano
la capacità di costruire stock di beni capitali e pertanto facevano crescere il tasso di
investimento. Il secondo pilastro era la fissazione di impegnativi obiettivi di produzione per
dirigere le attività economiche; il terzo pilastro era la collettivizzazione dell’agricoltura, che
si risolse nel tracollo del prodotto agricolo e nella carestia del 1933. Il quarto pilastro fu
l’istruzione di massa. Queste misure fecero crescere rapidamente l’economia e sembrava
che il modello sovietico potesse essere davvero la formula migliore per lo sviluppo di un
paese povero. Ma poi tutto andò storto: negli anni ’70-’80 del 900 il tasso di crescita scese
gradualmente. La pianificazione centralizzata cedette, così, il passo al mercato, ma ormai
era troppo tardi per salvare l’Urss. Nel caso dell’Unione Sovietica ci si deve chiedere
“Perché il Pil pro capite crebbe così rapidamente fra il 1728 e gli anni ’70?” Il Pil crebbe
rapidamente perché le istituzioni sovietiche avevano una grande capacità
17
di costruire fabbriche moderne di grandi dimensioni e poi perché vi fu una lentezza della
crescita demografica in parte a causa dell’eccesso di mortalità e in parte al declino del
tasso di fecondità.
IL GIAPPONE L’obbiettivo della politica giapponese era “un paese ricco, un esercito forte”.
Il paese aveva bisogno di un big push per eliminare il divario che lo separava
dall’occidente. Fra il 1950 e il 1990 il reddito pro-capite crebbe del 6% annuo, con picchi
dell’8%. Nel 1990 il tenore di vita giapponese era ormai allineato a quello dell’Europa
occidentale. Il Giappone adottò su vasta scala la tecnologia più moderna e capital
intensive. Lo stock di capitale crebbe tanto rapidamente da creare un’economia ad alti
salari nell’arco di una generazione. Nel periodo post-bellico l’industrializzazione doveva
essere pianificata e il compito fu affidato al Miti. Negli anni ’50 del 900 esso si prefisse di
ristrutturare l’industria giapponese per far sì che tutto l’acciaio venisse prodotto in
stabilimenti di dimensioni efficienti. Il potere del Miti derivava dal controllo del sistema
bancario e dalla facoltà di assegnare valuta estera. Dopo il ’60 il dirigismo del Miti si
attenuò, l’espansione proseguì grazie alla costruzione di nuovi stabilimenti in siti edificati
ad hoc (green field). Nonostante il forte aumento salariale del settore, il Giappone era il
produttore mondiale di acciaio a basso costo, grazie al suo impegno a adottare la
tecnologia moderna ad alta intensità di capitale. Durante gli anni 60 e 70 la forte
espansione industriale pose fine all’eccedenza di manodopera dato che nel settore delle
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
lOMoARcPSD|10542031
piccole imprese i salari aumentarono rapidamente. La crescita dei redditi indotta
dall’espansione dell’occupazione determinò una rivoluzione nello stile di vita dei
giapponesi. L’era della crescita vertiginosa non poteva però durare in eterno. La fine
dell’espansione viene fatta coincidere con l’esplosione della bolla immobiliare del 1991.
Dopodiché il Giappone si trovò nella stessa situazione di qualsiasi altro paese avanzato.
LA CINA l’ascesa della Corea del sud e di Taiwan è stata impressionante, ma diverrà
insignificante rispetto a quella della Cina, se quest’ultima continuerà a industrializzarsi con
la stessa rapidità degli ultimi decenni. Quando i comunisti presero il potere il Pil aveva
toccato il fondo, 448 dollari. Nel 2006 il reddito era salito a 6000, collocando la Cina fra i
paesi a reddito medio. La storia economica della Cina si divide in due periodi a partire dal
49, il periodo della pianificazione che raggiunse la fine degli anni 70 e quello della riforma
che dura tutt’ora. Nel primo periodo la Cina adottò un sistema comunista, aziende agricole
collettive, industria statale e pianificazione centralizzata conforme ai dettami sovietici.
Questa strategia favorì lo sviluppo dell’industria pesante. Nonostante le piroette della
politica, fra cui il grande balzo in avanti, la carestia e la rivoluzione culturale, il reddito pro-
capite risultò più che raddoppiato. In seguito alla morte di Mao, nel 76, Xiaoping avviò le
riforme nel 78. La pianificazione fu smantellata e al suo posto fu creata un’economia di
mercato. La Cina attuò le riforme modificando e integrando gradualmente le proprie
istituzioni. A partire dal 78 anche la crescita ebbe una forte accelerazione. Le prime riforme
riguardavano l’agricoltura, in primo luogo, le agenzie di approvigionamento alzarono i
propri prezzi d’acquisto e in secondo luogo la coltivazione collettiva fu sostituita dal
sistema della responsabilità familiare. L’introduzione di queste politiche fu accompagnata
da una forte espansione del prodotto agricolo, nell’arco di 6 anni la produzione balzò
all’8% annuo e anche la produzione di cereali crebbe a un tasso senza precedenti e
ancora oggi ineguagliato. (aumento rese cerealicole) Come in Giappone, in Cina la
manodopera era abbondante e la terra scarsa, perciò il progresso tecnologico si è
concentrato sull’aumento della produttività della terra. Dopo il 78, i funzionari locali di
partito promossero la formazione di township and village enterprises. La produzione di
beni di consumo era rimasta indietro e le Tves colmarono il divario vendendo le proprie
merci nel libero mercato. Le riforme successive crearono un sistema finanziario che
sostituì lo stato nel ruolo dell’allocazione degli investimenti e convertì le imprese pubbliche
da dipartimenti dell’amministrazione statale a società di capitali. Lo stato continua a
guidare attivamente, anche se formalmente meno coinvolto, il settore energetico e
l’industria pesante. Per questa ragione probabilmente l’industria siderurgica ha continuato
a crescere a un ritmo straordinario.
Scaricato da Damiano Franceschi (n.franceschi@luilor.it)
Potrebbero piacerti anche
- Rivoluzioni industriali: La nascita del mondo modernoDa EverandRivoluzioni industriali: La nascita del mondo modernoNessuna valutazione finora
- 1 RivDocumento19 pagine1 RivSara CrisafulliNessuna valutazione finora
- Dom e Risp Storia EconomicaDocumento33 pagineDom e Risp Storia EconomicaMadison OfficialNessuna valutazione finora
- Cap XIII - Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento4 pagineCap XIII - Seconda Rivoluzione IndustrialeAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Storia EconomicaDocumento60 pagineStoria EconomicabhoNessuna valutazione finora
- Storia Economica 2 CapitoloDocumento5 pagineStoria Economica 2 Capitolomariagiovanna brancatiNessuna valutazione finora
- 1870-1914 AppuntiDocumento10 pagine1870-1914 AppuntifinocchiettoNessuna valutazione finora
- Storia EconomicaDocumento85 pagineStoria EconomicaArianna ScaringellaNessuna valutazione finora
- Riassunti Di Storia EconomicaDocumento39 pagineRiassunti Di Storia EconomicaSudip ErcolaniNessuna valutazione finora
- Risposte Storia Economica 2Documento10 pagineRisposte Storia Economica 2Barbara FernandezNessuna valutazione finora
- La vetreria di Gaeta dalla comunità operaia alle lotte sindacali 1909 1981Da EverandLa vetreria di Gaeta dalla comunità operaia alle lotte sindacali 1909 1981Nessuna valutazione finora
- Summary Trade and The Industrial RevolutionDocumento59 pagineSummary Trade and The Industrial Revolutionfrancesco fazioNessuna valutazione finora
- Capitolo 1Documento2 pagineCapitolo 1mariagiovanna brancatiNessuna valutazione finora
- L'età Degli Imperi 1875-1913 - HobsbawmDocumento21 pagineL'età Degli Imperi 1875-1913 - HobsbawmLeonardo MasettiNessuna valutazione finora
- Contesto Storico FrobelDocumento8 pagineContesto Storico FrobelMaria De MarcoNessuna valutazione finora
- Storia DellDocumento8 pagineStoria DellGessica D'AgostinoNessuna valutazione finora
- Sintesi Del Libro Del Corso DI VITTORIODocumento59 pagineSintesi Del Libro Del Corso DI VITTORIOSudip ErcolaniNessuna valutazione finora
- Geografia Culturale - Disuguaglianze e Globalizzazione - Lez.8 AprileDocumento8 pagineGeografia Culturale - Disuguaglianze e Globalizzazione - Lez.8 AprileClaudia CostaNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia ContemporaneaDocumento43 pagineRiassunto Storia ContemporaneaGioia MaffucciNessuna valutazione finora
- Domande e Risposte Storia EconomicaDocumento9 pagineDomande e Risposte Storia EconomicasusannaNessuna valutazione finora
- 02 Storia Delle Relazioni Economiche Internazionali DellacasaDocumento69 pagine02 Storia Delle Relazioni Economiche Internazionali DellacasaLuca MasioNessuna valutazione finora
- Storia Economica Appunti Del CorsoDocumento39 pagineStoria Economica Appunti Del CorsoAbramo Di FucciaNessuna valutazione finora
- La politica estera degli Stati Uniti dal 1898 al 1905Da EverandLa politica estera degli Stati Uniti dal 1898 al 1905Nessuna valutazione finora
- Stato essenziale, società vitale: Appunti sussidiari per l’Italia che verràDa EverandStato essenziale, società vitale: Appunti sussidiari per l’Italia che verràNessuna valutazione finora
- Fattori Determinanti Lo Sviluppo Dell Rivoluzione Industriale in InghilterraDocumento1 paginaFattori Determinanti Lo Sviluppo Dell Rivoluzione Industriale in InghilterraDiego DeplanoNessuna valutazione finora
- 3 RivDocumento28 pagine3 RivSara CrisafulliNessuna valutazione finora
- 01 Anteprima Di Storia Delle Relazioni Economiche Internazionali Miriana V 2020 21Documento11 pagine01 Anteprima Di Storia Delle Relazioni Economiche Internazionali Miriana V 2020 21Luca MasioNessuna valutazione finora
- 01 Storia Delle Relazioni Economiche Internazionali Di Miriana V.Documento64 pagine01 Storia Delle Relazioni Economiche Internazionali Di Miriana V.Luca MasioNessuna valutazione finora
- Seconda Rivoluzione Industriale e Società Di MassaDocumento4 pagineSeconda Rivoluzione Industriale e Società Di MassaGiuseppe CipollaNessuna valutazione finora
- Domande Sulla Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento4 pagineDomande Sulla Seconda Rivoluzione IndustrialeGabriele GiannoneNessuna valutazione finora
- Riassunto Testo Neal-Cameron - Da Cap. VI Fino A Pag 309Documento12 pagineRiassunto Testo Neal-Cameron - Da Cap. VI Fino A Pag 309Pia Leilah LiaNessuna valutazione finora
- La Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento8 pagineLa Seconda Rivoluzione IndustrialeArianna CoronaNessuna valutazione finora
- Storia Economica (Parte 1)Documento27 pagineStoria Economica (Parte 1)Patrick CovatoNessuna valutazione finora
- Storia ContemporaneaDocumento33 pagineStoria ContemporaneaDiego LombardozziNessuna valutazione finora
- Rivoluzione Industriale Pensiero e Questione Sociale: Schema SinteticoDocumento10 pagineRivoluzione Industriale Pensiero e Questione Sociale: Schema SinteticoGianfranco MariniNessuna valutazione finora
- Ed Civica Storia PDFDocumento3 pagineEd Civica Storia PDFgretaNessuna valutazione finora
- Appunti Magici 1-30Documento82 pagineAppunti Magici 1-30Patrick CovatoNessuna valutazione finora
- "Storia Moderna " Di Ago Renata e Vittorio VidottoDocumento60 pagine"Storia Moderna " Di Ago Renata e Vittorio VidottoDiego Pecori50% (4)
- Storia ContemporaneaDocumento57 pagineStoria Contemporanearebecca spezzanoNessuna valutazione finora
- Immanuel Kant PDFDocumento83 pagineImmanuel Kant PDFmais51Nessuna valutazione finora
- Industria, Il Boom Economico e Una Nuova Letteratura ItalianaDocumento12 pagineIndustria, Il Boom Economico e Una Nuova Letteratura ItalianaBojana Borojevic100% (1)
- I Limiti Del MercatoDocumento16 pagineI Limiti Del MercatoLaura VissaniNessuna valutazione finora
- Le Crisi Finanziarie nella Storia: Dalla Repubblica di Roma alla Pandemia GlobaleDa EverandLe Crisi Finanziarie nella Storia: Dalla Repubblica di Roma alla Pandemia GlobaleNessuna valutazione finora
- Xix SecoloDocumento2 pagineXix SecoloFrancesco BernardiNessuna valutazione finora
- L'età Dell'imperialismo e La Società Di MassaDocumento5 pagineL'età Dell'imperialismo e La Società Di MassaDiego DeplanoNessuna valutazione finora
- 1873 - 1895: Seconda Rivoluzione Industriale e Grande DepressioneDocumento5 pagine1873 - 1895: Seconda Rivoluzione Industriale e Grande DepressioneGianfranco Marini100% (3)
- Riassunti Storia EconomicaDocumento43 pagineRiassunti Storia EconomicaOrnella Valentina MarioliNessuna valutazione finora
- Storia Contemporanea 800.Documento20 pagineStoria Contemporanea 800.Enrico SbaragliaNessuna valutazione finora
- Dispensa FinanzeDocumento23 pagineDispensa FinanzeGessica D'AgostinoNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia Economica Ennio de SimoneDocumento88 pagineRiassunto Storia Economica Ennio de SimonePinko PallinaNessuna valutazione finora
- Boom EconomicoDocumento3 pagineBoom EconomicoMargarita Méndez TamayoNessuna valutazione finora
- Economia in ItaliaDocumento18 pagineEconomia in Italiaantonelladicasola42Nessuna valutazione finora
- Dellorefice Giura SintetizzatoDocumento79 pagineDellorefice Giura SintetizzatoGaia Benedetta De ProsperiNessuna valutazione finora
- Imperialism oDocumento12 pagineImperialism oSimone AlbiniNessuna valutazione finora
- Marketing Internazionale Valdani Bertoli Egea 2015 2 PDFDocumento122 pagineMarketing Internazionale Valdani Bertoli Egea 2015 2 PDFLorenzo SquassoniNessuna valutazione finora