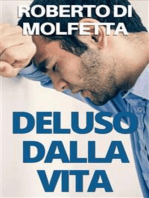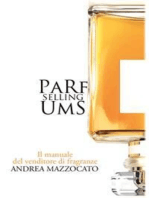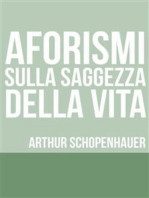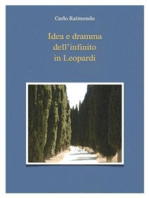Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
La Teoria Del Piacere
Caricato da
Monica De FeoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
La Teoria Del Piacere
Caricato da
Monica De FeoCopyright:
Formati disponibili
LA TEORIA DEL PIACERE
La teoria del piacere di Giacomo Leopardi viene enunciata all'interno dello Zibaldone, ed è così
chiamata dal suo stesso autore. Alla spiegazione di questa teoria Leopardi dedica una ventina di
pagine, che costituiscono un breve e coeso saggio filosofico, steso, come indicano le date che lo
chiudono, tra il 12 e il 23 luglio del 1820.
La riflessione di Leopardi parte da un’idea ben precisa: ogni uomo, nel suo agire, mira «al
piacere, ossia alla felicità»; questa tendenza al piacere non conosce limiti perché connaturata
all’esistenza; al contrario, i mezzi attraverso i quali l’uomo cerca di soddisfarla, i «piaceri»,
sono limitati, temporanei ed effimeri. Ne consegue la distanza incolmabile tra desiderio del
piacere ed effettiva possibilità di soddisfarlo.
La teoria del piacere punto per punto
Procedendo nel ragionamento, Leopardi dimostra le seguenti tesi:
Il desiderio del piacere è infinito per durata (non si esaurisce finché non finisce la vita) e
per estensione (il desiderio del piacere è inesauribile perché riguarda il piacere in sé, e
quindi non possono esistere singoli oggetti che lo soddisfino);
Il conseguimento di un oggetto di desiderio non spegne il desiderio del piacere, in quanto
risponde con qualcosa di finito a una richiesta infinita;
soltanto l’immaginazione può soddisfare il desiderio del piacere – desiderio che è infinito –
perché soltanto l’immaginazione può creare oggetti infiniti per numero, per durata e per
estensione; l’uomo sperimenta una condizione di felicità quando può soddisfare la propria
infinita sete di piacere con questi oggetti infiniti illusori, creati dalla sua facoltà
immaginativa;
la natura aveva disposto gli uomini al piacere facendoli ignoranti, cioè capaci di illusioni e
di immaginazione;
in poesia il vago e l’indefinito sono fonti di piacere in quanto attivano l’immaginazione
(ciò che è indeterminato non può essere percepito dalla ragione perché la ragione non ha
la capacità di concepire oggetti).
TEORIA DELLA VISIONE
Nel brano proposto non si può ancora parlare di flusso di coscienza, ma di una scrittura che nasce
da una riflessione intimi, libera dal controllo linguistico che il poeta esercitava invece sui Canti.
Con questo pensiero Leopardi esprime cosa secondo lui provochi piacere: il piacere è dato dalla
varietà, dalla mescolanza, dalla moltitudine, dal poetico: ad esempio la luce della luna è poetica
quando non è totalmente visibile oppure se il suo bagliore si riverbera su altri oggetti, quindi, gli
impedimenti fisici, della vista, fanno spaziare l’immaginazione.
Infatti, una campagna aperta soleggiata è piacevole a causa dell’idea di indefinitezza che crea in
noi.
È invece impoetica la visione precisa, costretta entro dei confini, nitida, delineata delle cose.
Andando a ribadire è poetico ciò che permette all’animo di spaziare e di dilatarsi. A non essere
piacevole è anche il monotono, il tedio che indica una noia intellettuale, mentale.
TERMINI E PAROLE
Secondo Leopardi la vera poesia deve provocare molte “emozioni vivissime” nel lettore, riempire
il suo animo di” idee vaghe indefinite e vastissime sublimissime”. Questi brani dello zibaldone,
scritti tra il 1820 e il 1821, si riferiscono alle scelte linguistiche capaci di produrre tali effetti.
Potrebbero piacerti anche
- Rudolf Steiner - La Legge Del Piano Astrale e Del DevachanDocumento5 pagineRudolf Steiner - La Legge Del Piano Astrale e Del DevachanFabio AntonelliNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento7 pagineLeopardisusanna100% (2)
- Freud IL POETA E LA FANTASIADocumento10 pagineFreud IL POETA E LA FANTASIAPasquale AsquinoNessuna valutazione finora
- Arthur SchopenhauerDocumento3 pagineArthur SchopenhauerDiego Deplano80% (10)
- DidascaliconDocumento66 pagineDidascaliconDIegob0% (1)
- Schopenhauer, Riassunto, 1 Parte: Caratteri Generali e PessimismoDocumento2 pagineSchopenhauer, Riassunto, 1 Parte: Caratteri Generali e PessimismoGianfranco Marini100% (3)
- KANT Bello e SublimeDocumento46 pagineKANT Bello e SublimeJulieta RicoNessuna valutazione finora
- Teoria Del PiacereDocumento1 paginaTeoria Del PiacereFrancesco Amalia Ruotolo BasilicataNessuna valutazione finora
- Il Piacere Ossia La FelicitàDocumento2 pagineIl Piacere Ossia La FelicitàLorenza OvallescoNessuna valutazione finora
- La Felicità Non EsisteDocumento2 pagineLa Felicità Non EsisteAnna roattaNessuna valutazione finora
- Leopardi Pensiero e PoeticaDocumento14 pagineLeopardi Pensiero e PoeticaAngela CinoNessuna valutazione finora
- Interrogazione Di Italiano L. OPEREDocumento14 pagineInterrogazione Di Italiano L. OPEREMcd ColombiaNessuna valutazione finora
- Teoria Del Piacere Di LeopardiDocumento2 pagineTeoria Del Piacere Di LeopardiCatalina Valeria MocanuNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento2 pagineSchopenhauerEugenio RussoNessuna valutazione finora
- Leopardi ZibaldoneDocumento6 pagineLeopardi ZibaldoneNuria CabreraNessuna valutazione finora
- Schopenhauer e KierkegaardDocumento7 pagineSchopenhauer e Kierkegaard4fykfpjswpNessuna valutazione finora
- 1 SMDocumento22 pagine1 SMLuisEspinozaNessuna valutazione finora
- Desiderio e PsicanalisiDocumento26 pagineDesiderio e PsicanalisiRoberto MarzialettiNessuna valutazione finora
- Esempio Tesina LibertàDocumento13 pagineEsempio Tesina LibertàDoc KongNessuna valutazione finora
- Artur SchopenhauerDocumento11 pagineArtur SchopenhauergiorgiapaiardiNessuna valutazione finora
- Schopenhauer e KierkegaardDocumento8 pagineSchopenhauer e Kierkegaardacc.dinecessitaNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento5 pagineSchopenhauerrimofabio_569973046Nessuna valutazione finora
- SCHOPENHAUERDocumento2 pagineSCHOPENHAUERSteven TaliaNessuna valutazione finora
- Schopenhauer - Libero ArbitrioDocumento11 pagineSchopenhauer - Libero ArbitrioAlessandroSalisNessuna valutazione finora
- ShopenaeuerDocumento3 pagineShopenaeuerLeonardo TovoNessuna valutazione finora
- Arthur SchopenhauerDocumento4 pagineArthur SchopenhauerFrencoNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento4 pagineSchopenhauerDaniela CampoliNessuna valutazione finora
- Schopenhauer AppuntiDocumento4 pagineSchopenhauer AppuntiChiara LonigroNessuna valutazione finora
- ARTE, Schopenahuer e FreudDocumento8 pagineARTE, Schopenahuer e FreudCristiana BelloNessuna valutazione finora
- La Filosofia Di SchopenhauerDocumento2 pagineLa Filosofia Di SchopenhauerFelisia GiannuzziNessuna valutazione finora
- Filosofia e Arte Freud e Surrealismo (Dalì e Ernst)Documento7 pagineFilosofia e Arte Freud e Surrealismo (Dalì e Ernst)De EsguelhoNessuna valutazione finora
- Esperienza Estetica in AbhinavaguptaDocumento11 pagineEsperienza Estetica in AbhinavaguptaIraBiraNessuna valutazione finora
- PaRfUmS Selling. Il manuale del venditore di fragranzeDa EverandPaRfUmS Selling. Il manuale del venditore di fragranzeNessuna valutazione finora
- Tesina Il Dolore Esistenziale Dell'UomoDocumento10 pagineTesina Il Dolore Esistenziale Dell'UomoSubhi BuonaMattina TayebNessuna valutazione finora
- Schopenhauer e NietzscheDocumento6 pagineSchopenhauer e NietzscheMichelaNessuna valutazione finora
- Arthur SchopenhauerDocumento10 pagineArthur SchopenhauerMatilde SantiniNessuna valutazione finora
- Montesquieu Saggio GustoDocumento15 pagineMontesquieu Saggio GustoPedro Porsu CasaNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento11 pagineSchopenhauerMarco TerranovaNessuna valutazione finora
- Occultismo e filosofia - magnetismo, spiritismo e magia nella visione di un grande filosofoDa EverandOccultismo e filosofia - magnetismo, spiritismo e magia nella visione di un grande filosofoNessuna valutazione finora
- Pag.13 n.2: La Posizione Idealistica Fondamentalmente Che Schopenhauer RiprendeDocumento6 paginePag.13 n.2: La Posizione Idealistica Fondamentalmente Che Schopenhauer Riprendefabrizio profetaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento18 pagineGiacomo Leopardiannaa.bii04Nessuna valutazione finora
- ShopenhauerDocumento3 pagineShopenhauerGaia CantaruttiNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento6 pagineSchopenhauerSilvia FerrariNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento7 pagineLeopardiTabatha MazzaboNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento8 pagineGiacomo LeopardiGiuseppe AlloccaNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento4 pagineSchopenhauerncl cprNessuna valutazione finora
- SCH Open AuerDocumento2 pagineSCH Open Auermoney.cioppaNessuna valutazione finora
- Schopenhauer Aurora MirraDocumento2 pagineSchopenhauer Aurora MirraroriNessuna valutazione finora
- Riassunto SchopenhauerDocumento5 pagineRiassunto SchopenhauerAndreaCalabròNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento7 pagineSchopenhaueremanu trekNessuna valutazione finora
- Arthur SchopenhauerDocumento4 pagineArthur SchopenhauerAsia MuscogiuriNessuna valutazione finora
- Il Pensiero, La Poetica Del Vero e Dell'Indefinito Di LeopardiDocumento4 pagineIl Pensiero, La Poetica Del Vero e Dell'Indefinito Di LeopardiSara GioacchiniNessuna valutazione finora
- Filosofia - Schopenhauer, Il Mondo Come Volont - e RappresentazioneDocumento56 pagineFilosofia - Schopenhauer, Il Mondo Come Volont - e RappresentazioneCesare AndreattaNessuna valutazione finora
- Filo SofiaDocumento5 pagineFilo SofiamaggigicaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento8 pagineGiacomo LeopardiSelene De SantisNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento1 paginaGiacomo LeopardiSara Maria RizzoNessuna valutazione finora