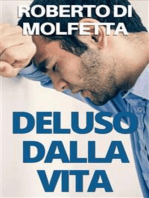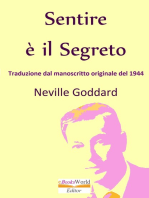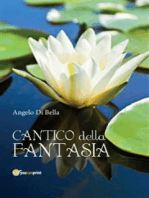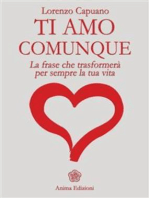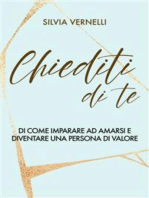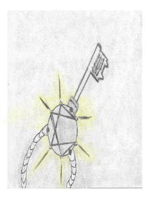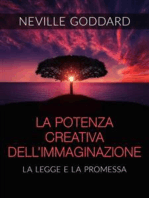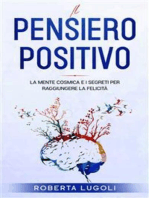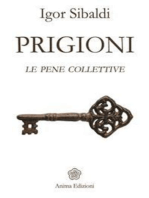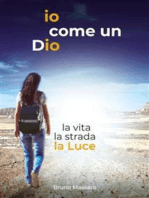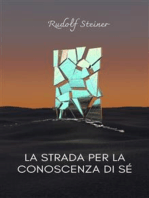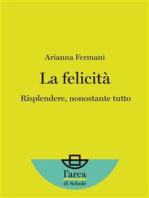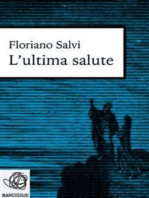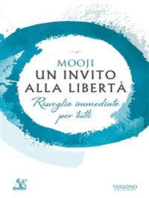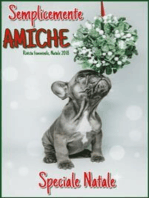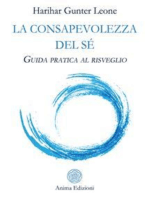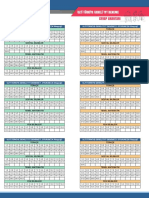Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
La Felicità Non Esiste
Caricato da
Anna roattaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
La Felicità Non Esiste
Caricato da
Anna roattaCopyright:
Formati disponibili
Torna indietro
B3 3
B La teoria del piacere
T 32 T 32
Giacomo Leopardi
Zibaldone
in Tutte le opere, a cura di F. Flora,
L a teoria del piacere costituisce, a partire dal 1820, il nucleo centrale della riflessione
leopardiana.
I
Mondadori, Milano, 1961
1 Il sentimento della nullità di tutte le cose, la insufficienza di tutti i piaceri a
riempierci l’animo, e la tendenza nostra verso un infinito che non compren-
diamo, forse proviene da una cagione semplicissima, e più materiale che spi-
rituale. L’anima umana (e così tutti gli esseri viventi) desidera sempre essen-
5 zialmente, e mira unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla
felicità, che considerandola bene, è tutt’uno col piacere. Questo desiderio e
questa tendenza non ha limiti, perch’è ingenita o congenita coll’esistenza, e
perciò non può aver fine in questo o quel piacere che non può essere infinito,
ma solamente termina colla vita. E non ha limiti 1. né per durata, 2. né per
10 estensione. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli 1. né la sua
durata, perché nessun piacere è eterno, 2. né la sua estensione, perché nessun
piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che tutto esista limitata-
mente e tutto abbia confini, e sia circoscritto. Il detto desiderio del piacere
non ha limiti per durata, perché, come ho detto non finisce se non coll’esi-
15 stenza, e quindi l’uomo non esisterebbe se non provasse questo desiderio.
Non ha limiti per estensione perch’è sostanziale in noi, non come desiderio
di uno o più piaceri, ma come desiderio del piacere. Ora una tal natura porta
con se materialmente l’infinità, perché ogni piacere è circoscritto, ma non il
piacere la cui estensione è indeterminata, e l’anima amando sostanzialmente
20 il piacere, abbraccia tutta l’estensione immaginabile di questo sentimento,
senza poterla neppur concepire, perché non si può formare idea chiara di
una cosa ch’ella desidera illimitata. Veniamo alle conseguenze. Se tu desideri
un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo, e come un tal piacere, ma in
fatti lo desideri come piacere astratto e illimitato. Quando giungi a possedere
25 il cavallo, trovi un piacere necessariamente circoscritto, e senti un vuoto nel-
l’anima, perché quel desiderio che tu avevi effettivamente, non resta pago1.
Se anche fosse possibile che restasse pago per estensione, non potrebbe per
durata, perché la natura delle cose porta ancora che niente sia eterno. [...] E
perciò tutti i piaceri debbono esser misti di dispiacere, come proviamo, per-
30 ché l’anima nell’ottenerli cerca avidamente quello che non può trovare, cioè
una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato.
Veniamo alla inclinazione2 dell’uomo all’infinito. Indipendentemente dal
desiderio del piacere, esiste nell’uomo una facoltà immaginativa, la quale può
concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le cose reali non sono.
35 Considerando la tendenza innata dell’uomo al piacere, è naturale che la facol-
tà immaginativa faccia una delle sue principali occupazioni della immagina-
zione del piacere. E stante la detta proprietà di questa forza immaginativa, ella
può figurarsi dei piaceri che non esistano, e figurarseli infiniti 1. in numero,
2. in durata, 3. e in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella
40 realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le
1. pago: appagato. illusioni ec. Perciò non è maraviglia3 1. che la speranza sia sempre maggior
2. inclinazione: tendenza,
aspirazione. del bene, 2. che la felicità umana non possa consistere se non se nella imma-
3. non è maraviglia: non c’è da
meravigliarsi. ginazione e nelle illusioni. [...]
914 | L’età del Romanticismo | Ritratto d’autore |
Del resto il desiderio del piacere essendo materialmente infinito in esten- B 13
C
45 sione (non solamente nell’uomo ma in ogni vivente), la pena dell’uomo nel T432
provare un piacere è di veder subito i limiti della sua estensione, i quali l’uo-
mo non molto profondo gli scorge solamente da presso4. Quindi è manifesto
1. perché tutti i beni paiano bellissimi e sommi da lontano, e l’ignoto sia più
bello del noto; effetto della immaginazione determinato dalla inclinazione
50 della natura al piacere, effetto delle illusioni voluto dalla natura. 2. perché
l’anima preferisca in poesia e da per tutto, il bello aereo5, le idee infinite.
Stante la considerazione qui sopra detta, l’anima deve naturalmente preferi-
re agli altri quel piacere ch’ella non può abbracciare. Di questo bello aereo,
di queste idee abbondavano gli antichi, abbondano i loro poeti, massime il
55 più antico cioè Omero, abbondano i fanciulli veramente Omerici in questo,
gl’ignoranti ec. in somma la natura. La cognizione e il sapere ne fa strage, e a
noi riesce difficilissimo il provarne. La malinconia, il sentimentale moderno
4. da presso: da vicino. ec. perciò appunto sono così dolci, perché immergono l’anima in un abbisso
5. il bello aereo: le immagini di pensieri indeterminati de’ quali non sa vedere il fondo né i contorni. (12-
vaghe e leggere, come composte
d’aria. 60 13 luglio 1820)
Analisi e interpretazione
L’infinità del desiderio come causa L’immaginazione come facoltà guenza è, ancora, la superiorità degli an-
d’infelicità conoscitiva tichi – la loro poesia è ricca di questo tipo
L’impianto sensistico delle riflessioni leo- La facoltà dell’immaginazione consente di sensazioni – sui moderni (Di questo
pardiane è basato sul presupposto che tuttavia all’uomo di figurarsi mental- bello aereo, di queste idee abbondavano
l’animo avverte solo impulsi di carattere mente piaceri che non esistono nella gli antichi, abbondano i loro poeti, mas-
materiale e non di un’entità esterna e realtà e che sono infiniti in numero, sime il più antico cioè Omero, abbondano
superiore all’uomo (la tendenza nostra durata ed estensione. Ne consegue che i fanciulli veramente Omerici in questo,
verso un infinito che non comprendiamo, l’unica felicità è quella che proviene dal- gl’ignoranti ec. in somma la natura; rr.
forse proviene da una cagione semplicissi- l’immaginazione, dall’illusione dell’infi- 53-56).
ma, e più materiale che spirituale, rr. 2-4). nito (E stante la detta proprietà di questa La ragione distrugge nell’uomo moderno
Le argomentazioni ruotano intorno ad forza immaginativa, ella può figurarsi dei le illusioni e le sensazioni immaginarie,
una contrapposizione: il piacere che l’uo- piaceri che non esistano, e figurarseli infi- perciò i moderni possono provare il pia-
mo sperimenta è circoscritto, limitato niti; rr. 37-38). cere delle sensazioni indefinite solo nella
(il piacere, come ogni cosa nel mondo, malinconia della «poesia sentimentale»
appartiene al dominio del finito) men- La superiorità degli antichi nei confronti (La malinconia, il sentimentale moderno
tre il desiderio è infinito, illimitato, sia dei moderni ec. perciò appunto sono così dolci, perché
per durata nel tempo sia per estensione L’uomo rifiuta tutto ciò che limita le sue immergono l’anima in un abbisso di pen-
nello spazio. Poiché la ricerca del piacere impressioni e tra i piaceri immaginari sieri indeterminati de’ quali non sa vedere
coincide con la felicità, la conseguenza è l’anima preferisce quelli che nascono da il fondo né i contorni; rr. 57-59).
l’infelicità, che deriva dall’insuperabile sensazioni indeterminate (i beni paiano
contrasto tra l’infinità del desiderio e la bellissimi e sommi da lontano... il bello
finitezza del mondo. aereo, le idee infinite; rr. 48-51). La conse-
Attività
1. Finito e infinito 2. La superiorità degli antichi 3. Teoria del piacere: Zibaldone e liriche
Spiega in che consiste la teoria del sensi- Perché Leopardi ritiene la poesia degli Confronta la teoria del piacere dello Zi-
smo e il rapporto tra finito e infinito. antichi superiore a quella dell’età moder- baldone con le immagini che compaiono
na? nella lirica L’infinito (> B3 T36) e con il con-
tenuto di Il sabato del villaggio (> B3 T42).
| Giacomo Leopardi | Ideologia e poetica | 915
Potrebbero piacerti anche
- Teoria Del Piacere Di LeopardiDocumento2 pagineTeoria Del Piacere Di LeopardiCatalina Valeria MocanuNessuna valutazione finora
- Leopardi ZibaldoneDocumento6 pagineLeopardi ZibaldoneNuria CabreraNessuna valutazione finora
- La Teoria Del PiacereDocumento2 pagineLa Teoria Del PiacereMonica De FeoNessuna valutazione finora
- Il Piacere Ossia La FelicitàDocumento2 pagineIl Piacere Ossia La FelicitàLorenza OvallescoNessuna valutazione finora
- Ti amo comunque - La frase: La frase che trasformerà per sempre la tua vitaDa EverandTi amo comunque - La frase: La frase che trasformerà per sempre la tua vitaNessuna valutazione finora
- PaRfUmS Selling. Il manuale del venditore di fragranzeDa EverandPaRfUmS Selling. Il manuale del venditore di fragranzeNessuna valutazione finora
- Il Gusto Di Essere Felici - Matthieu RicardDocumento4 pagineIl Gusto Di Essere Felici - Matthieu RicardLuca CarliNessuna valutazione finora
- Conoscenza IniziaticaDocumento17 pagineConoscenza IniziaticaMiceli AntonellaNessuna valutazione finora
- Teoria Del PiacereDocumento1 paginaTeoria Del PiacereFrancesco Amalia Ruotolo BasilicataNessuna valutazione finora
- Chiediti di Te: Di come imparare ad amarsi e diventare una persona di valoreDa EverandChiediti di Te: Di come imparare ad amarsi e diventare una persona di valoreNessuna valutazione finora
- Desiderio e PsicanalisiDocumento26 pagineDesiderio e PsicanalisiRoberto MarzialettiNessuna valutazione finora
- DidascaliconDocumento66 pagineDidascaliconDIegob0% (1)
- Il Racconto Del Mandarino Del BuddhaDocumento1 paginaIl Racconto Del Mandarino Del BuddhadebenedittisNessuna valutazione finora
- Riflessologia della memoria: La più potente tecnica per liberarsi da paure e condizionamenti legati al passato.Da EverandRiflessologia della memoria: La più potente tecnica per liberarsi da paure e condizionamenti legati al passato.Nessuna valutazione finora
- Il Sentimento È Il Segreto - Neville GoddardDocumento9 pagineIl Sentimento È Il Segreto - Neville GoddardvolpeaudiolibriNessuna valutazione finora
- La Potenza creativa dell'Immaginazione - La legge e la promessa (Tradotto)Da EverandLa Potenza creativa dell'Immaginazione - La legge e la promessa (Tradotto)Nessuna valutazione finora
- Prigionieri di se stessi: Il vero destino degli esseri umaniDa EverandPrigionieri di se stessi: Il vero destino degli esseri umaniNessuna valutazione finora
- Sentiero della Felicità: Sii felice a partire da oggiDa EverandSentiero della Felicità: Sii felice a partire da oggiNessuna valutazione finora
- Il pensiero positivo: La Mente Cosmica e i Segreti per raggiungere la felicitàDa EverandIl pensiero positivo: La Mente Cosmica e i Segreti per raggiungere la felicitàNessuna valutazione finora
- Rudolf Steiner - L'Amore e Il Suo Significato Nel MondoDocumento9 pagineRudolf Steiner - L'Amore e Il Suo Significato Nel MondoPiero Cammerinesi100% (1)
- Montesquieu Saggio GustoDocumento15 pagineMontesquieu Saggio GustoPedro Porsu CasaNessuna valutazione finora
- 01-SI PUO ́ ESSERE FELICI IN QUESTA VITA Baruch Spinoza Dice Di SiDocumento3 pagine01-SI PUO ́ ESSERE FELICI IN QUESTA VITA Baruch Spinoza Dice Di SipaolocollectorNessuna valutazione finora
- Massimo Scaligero - Dell'amore ImmortaleDocumento122 pagineMassimo Scaligero - Dell'amore Immortalezdomjus100% (4)
- Dell'amoreDocumento279 pagineDell'amoreLucaNessuna valutazione finora
- Aforismi e Riflessioni: -per Riflettere, Comprendere, e Conoscere-Da EverandAforismi e Riflessioni: -per Riflettere, Comprendere, e Conoscere-Nessuna valutazione finora
- Trattato Sull'emendazione Dell'intellettoDocumento24 pagineTrattato Sull'emendazione Dell'intellettoAlessia FilippazzoNessuna valutazione finora
- dio ...o se fosse tutto molto più semplice: le piccole animeDa Everanddio ...o se fosse tutto molto più semplice: le piccole animeNessuna valutazione finora
- La consapevolezza del Sé: Guida pratica al risveglioDa EverandLa consapevolezza del Sé: Guida pratica al risveglioNessuna valutazione finora
- Gli Oracoli Caldaici PDFDocumento160 pagineGli Oracoli Caldaici PDF1979Nessuna valutazione finora
- Problemi Svolti (Intensità Di Corrente, Leggi Di Ohm, Potenza.Documento7 pagineProblemi Svolti (Intensità Di Corrente, Leggi Di Ohm, Potenza.Anna roattaNessuna valutazione finora
- La Roba VergaDocumento7 pagineLa Roba VergaAnna roattaNessuna valutazione finora
- Pascoli D'annunzioDocumento2 paginePascoli D'annunzioAnna roattaNessuna valutazione finora
- Il Fanciullino PascoliDocumento10 pagineIl Fanciullino PascoliAnna roattaNessuna valutazione finora
- Quaderno Di Classe Di Religione - Documenti GoogleDocumento5 pagineQuaderno Di Classe Di Religione - Documenti GoogleAnna roattaNessuna valutazione finora
- Ciaula Scopre La LunaDocumento8 pagineCiaula Scopre La LunaAnna roattaNessuna valutazione finora
- Cartina Sentieri Monte IsolaDocumento2 pagineCartina Sentieri Monte IsolaIervo3899Nessuna valutazione finora
- Corpo Spirituale e Terra CelesteDocumento171 pagineCorpo Spirituale e Terra CelesteRita De Cássia MalheirosNessuna valutazione finora
- 13 - Elementi Infless - SLUDocumento41 pagine13 - Elementi Infless - SLUPaolo CantoniNessuna valutazione finora
- Stile, Storia Dell'Arte e Del Costume 1Documento40 pagineStile, Storia Dell'Arte e Del Costume 1monicaNessuna valutazione finora
- I NizaritiDocumento12 pagineI NizaritichiaraNessuna valutazione finora
- Klubzmer Songbook PDFDocumento95 pagineKlubzmer Songbook PDFEpilef HnrqzNessuna valutazione finora
- Ulti̇ Türki̇ye Geneli̇ Cevap AnahtariDocumento1 paginaUlti̇ Türki̇ye Geneli̇ Cevap AnahtariMiki WikiNessuna valutazione finora
- Lezione 3 Dimensione MorfologicaDocumento59 pagineLezione 3 Dimensione MorfologicaCecilia BiscariniNessuna valutazione finora
- Elenco Delle Parti Offese Naufragio "Costa Concordia"Documento70 pagineElenco Delle Parti Offese Naufragio "Costa Concordia"Amanda BrowningNessuna valutazione finora
- Storia Della Disabilità - Dal Castigo Degli Dei Alla Crisi Del WelfareDocumento45 pagineStoria Della Disabilità - Dal Castigo Degli Dei Alla Crisi Del Welfaremartina rispoliNessuna valutazione finora
- Vangelo NichilistaDocumento107 pagineVangelo NichilistaLuigi Milardi89% (9)