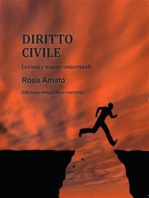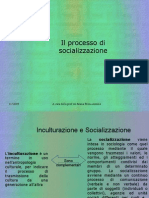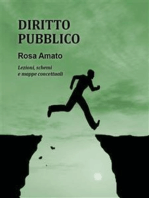Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Manuale Scienza Politica Capano PDF
Caricato da
Zenaida Garay ReynaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Manuale Scienza Politica Capano PDF
Caricato da
Zenaida Garay ReynaCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|3189189
Manuale scienza politica Capano
Science and Public Policy (Maastricht University)
StuDocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 1 – Politica e scienza politica. Approcci, identità, confini
2. Il concetto di “politica” per gli antichi: Aristotele
Il significato attribuito al concetto di “politica” è mutato nel corso del tempo.
Come altri concetti che cambiano il proprio contenuto semantico a seconda degli specifici contesti
storici in cui vengono calati (es. concetto di “famiglia”), anche quello di politica ha subito, nel corso
dell’evoluzione della storia occidentale, trasformazioni decisamente significative.
La politica degli antichi greci è cosa ben diversa dalla politica contemporanea: la parola è la stessa ma
il significato è cambiato radicalmente.
Innanzitutto, nella concezione greca non vi era alcuna distinzione tra “politica” e “società” (come tra
“politica” ed “etica” e, per certi versi, tra “politica” ed “economia”).
Politica era la dimensione collettiva del vivere sociale che differenziava l’umano in quanto tale dagli
altri esseri viventi.
Ecco perché la definizione aristotelica di “essere umano” come “animale politico” in realtà non
definiva la “politica” ma l’“essere umano”: la politica quindi era la dimensione totalizzante del
cittadino greco, che era pienamente umano proprio perché politico, quindi per definizione intriso di
socialità.
In questa prospettiva il fine ultimo della politica non può che essere il bene collettivo.
L’uomo politico per Aristotele
L’uomo è per natura un essere sociale, e chi vive escluso dalla comunità è malvagio o è superiore
all’uomo. […] Perciò, dunque, è evidente che l’uomo sia un essere sociale più di ogni ape e più di
ogni animale da gregge. […] L’uomo è l’unico degli essere viventi a possedere la parola. […] La
parola è in grado di mostrare l’utile e il dannoso, come anche il giusto e l’ingiusto. Questo, al
contrario di tutti gli altri animali, è proprio degli uomini, avere la percezione del bene, del male,
del giusto e dell’ingiusto e delle altre cose. E la comunanza di queste cose crea la casa e la città.
La “politica classica”, pertanto, intesa come il dispiegarsi quotidiano del vivere collettivo, ha poco a
che fare con quella concezione moderna in cui emerge con forza la sua dimensione di verticalità.
Proprio perché dimensione fondante del vivere collettivo, in cui gli individui contribuiscono al
benessere della città, la politica aristotelica è caratterizzata da relazioni orizzontali, proprie del vivere
in comunità.
Non che nella tradizione greca non siano state proposte altre definizioni di politica.
Ma, alla fine, quella che emerge come un pilastro della cultura occidentale, fino ad influenzare il
pensiero politico dei secoli successivi, è proprio la concezione aristotelica, grazie anche alla sua
ricezione e rimodulazione da parte della dottrina Cristiana.
La politica aristotelica, nella sua versione medievale, è dominata dal principio di verità fondato sulla
volontà divina, principio che tiene assieme politica, religione, morale e diritto, e mantiene la sua
finalità di attività primariamente finalizzata al bene comune.
Ciò non significa che nei secoli precedenti a Machiavelli non fosse presente il problema del potere e
delle relazioni verticali tra individui, ceti, gruppi sociali e interessi.
Ma queste tematiche, che al giorno d’oggi sono considerate politiche per eccellenza, venivano definite
in altri modi (regnum, dominium, gubernaculum, principatus).
Nell’epoca classica e in quella medievale da una parte abbiamo la “politica” intesa in senso
aristotelico, quale attività intrinsecamente umana, basata su relazioni orizzontali tra individui che si
determinano sulla base della conoscenza del logos; dall’altra parte il governo della collettività,
caratterizzano da relazioni verticali.
La politica aristotelica, quindi, ha poco a che fare con la lotta per il potere, con il governo della società,
con l’esercizio del potere su una società.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
3. La politica per la scienza politica
Machiavelli viene generalmente considerato il primo pensatore capace di definire la politica in modo
realista e autonomo dalla dimensione morale e religiosa che per secoli l’aveva caratterizzata.
È con Machiavelli che la politica perde la sua teleologia finalizzata al bene comune, si libera dal
“dover essere” per essere ricondotta alla potenza del Principe e dello Stato.
È con Machiavelli che il potere comincia ad emergere come la dimensione fondante dell’azione
politica.
L’essenza della politica per Machiavelli
Colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare, impara più tosto la ruina che la
preservazione sua. […] Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere
essere non buono et usarlo e non usare secondo la necessità.
Con Machiavelli la politica comincia ad assumere un significato più vicino a quello contemporaneo e
inizia quel percorso di autonomizzazione della politica non solo dalla morale e dalla religione, ma
anche dalla società e dall’economia.
Con il processo di costruzione dello Stato moderno, la politica inizia ad essere considerata come
un’attività autonoma da altre sfere del comportamento umano, anche se fortemente legata al potere
statuale.
La sintesi migliore di questo percorso è rappresentata dalla definizione di Max Weber, il quale ha
definito in modo netto e chiaro la natura della politica come intrinsecamente legata al conflitto nello
Stato e tra gli Stati.
Max Weber (1964-1920) è stato uno dei più grandi scienziati sociali della storia.
La sua gamma di interessi di ricerca si è basata su conoscenze interdisciplinari, dalla storia
all’economia politica, dalla filosofia alla scienza dell’amministrazione.
È autore di studi fondamentali sull’influenza della religione nello sviluppo del capitalismo, sulla
razionalizzazione e la secolarizzazione delle società moderne, sulla legittimazione del potere
politico, sui processi di costruzione dello Stato moderno.
È stato uno dei fautori di una posizione metodologica antipositivista, per la quale il fine ultimo
dello scienziato sociale è la comprensione delle motivazioni profonde che spingono l’azione
sociale e politica.
La politica secondo Max Weber
Politica significa aspirazione a partecipare al potere o a esercitare una certa influenza sulla
distribuzione del potere, sia tra gli Stati sia, all’interno di uno Stato, tra i gruppi di uomini che esso
comprende entro i suoi confini. […] Chi fa politica aspira al potere.
Dunque, il percorso inaugurato da Machiavelli giunge con Max Weber alla sua conclusione.
Tuttavia, Max Weber non segna la fine ma, per certi versi, l’inizio vero della storia contemporanea
della politica e della sua analisi.
Con la netta focalizzazione sul potere, la politica trova finalmente un ambito proprio e può essere
studiata in modo autonomo.
La centralità del potere nella definizione di “politica” non risolve comunque un problema intrinseco
della lunga riflessione sul concetto: il fatto cioè che sfugga a qualsiasi tentativo definitorio la
possibilità di individuare un elemento costitutivo del comportamento politico.
A differenza del comportamento morale o di quello economico, per i quali esiste una condivisione
rispetto ai criteri caratterizzanti (rispettivamente il “bene” e l’“utile”), il comportamento politico non è
riducibile ad uno specifico e netto criterio costitutivo.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La stessa enfasi sul potere non individua un elemento assolutamente distintivo dell’azione politica,
poiché esistono diverse forme di potere a seconda dei contesti in cui esso viene esercitato (es. il potere
sociale o quello economico).
Insomma, il potere è importante, ma deve essere inteso come una dimensione costitutiva che va
contestualizzata nelle sedi e nei processi opportuni, mediante i quali la specificità del potere “politico”
si mostra con evidenza.
In questa prospettiva, Giovanni Sartori ha enfatizzato la dimensione verticale della politica,
definendola proprio sulla base di una specifica sede in cui essa si manifesta.
La politica secondo Giovanni Sartori
La sfera delle decisione collettivizzate, sovrane, coercitivamente sanzionabili e senza uscita.
È chiaro che le decisioni politiche investono materie diversissime: possono essere di politica
economica, di politica del diritto, di politica sociale, di politica religiosa, di politica dell’istruzione.
Se tutte queste decisioni sono pregiudizialmente politiche è per il fatto che sono decisioni
collettivizzate sovrane prese da personale collocato in sedi politiche.
La definizione di Sartori, in cui tale dimensione verticale emerge con chiarezza [le decisioni sono
collettivizzate (prese da “alcuni” per “tutti”), sono sovrane (e quindi non hanno altre decisioni
gerarchicamente superiori), sono sanzionabili (perché i decisori sono i detentori del monopolio della
forza) e sono senza uscita (in quanto disegnano i confini delle azioni possibili per i destinatari delle
decisioni stesse)], riecheggia quella di David Easton, per il quale la politica è “allocazione imperativa
di valori”, laddove per “valori” si intendono beni sia materiali che simbolici.
Le definizioni di Sartori e Easton, enfatizzando la dimensione imperativa e verticale della politica,
rischiano di sottostimare una dimensione essenziale della stessa: il fatto, cioè, che l’ambito della
politica si caratterizzi per una strutturale incertezza su quello che può/deve essere fatto per garantire
l’ordine sociale.
Che la politica giri intorno al potere è plausibile e che i politici perseguano il mantenimento del
proprio potere è anch’esso plausibile, ma al tempo stesso questa ricerca/lotta per il potere deve dare
risposte ai problemi collettivi, rassicurando i cittadini rispetto al proprio futuro.
Parafrasando Hugh Heclo, pertanto, la politica non è solo un’attività nella quale incessantemente si
lotta per il potere e in cui si producono decisioni collettivizzate, ma è anche un’attività con la quale si
cerca di affrontare la complessità e la contraddittorietà del vivere sociale al fine di trovare risposte
affidabili per la collettività.
La politica secondo Hugh Heclo
La politica trova le sue risorse non solo nel potere, ma anche nell’incertezza, quando le collettività
si chiedono che fare. I governi non solo esercitano il “potere” ma cercano anche di risolvere
puzzles collettivi. Il policy making è una forma di soluzione di puzzles collettivi per conto della
società.
La politica, quindi, ha almeno due dimensioni portanti: quella del potere e quella della soluzione di
problemi collettivi.
In questo modo, si recupera il tema aristotelico del bene comune, anche se esso oggi viene
concettualizzato non come un dato normativo ma come un elemento da perseguire pragmaticamente
nell’azione politica.
Una volta preso atto della doppia natura della politica, assumono particolare rilevanza le domande con
le quali Harold Lasswell [(1902-1978) è stato uno dei grandi maestri della scienza politica
americana)] ha suggerito di affrontare lo studio della politica: “chi ottiene cosa, dove e come”.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Chi fa la politica?
La risposta più semplice a questa domanda sarebbe: i politici.
In realtà la politica è attività molto più complessa e, tenuto conto della sua centralità nel vivere
associato, essa può essere “fatta” da una miriade di potenziali attori, individuali e collettivi.
Dalle élite socioeconomiche ai gruppi di interesse, dai funzionari amministrativi ai singoli cittadini.
Che cosa si ottiene con la politica?
Il risultato aggregato dell’azione politica dovrebbe essere il perseguimento di un determinato ordine
sociale che è influenzato, ovviamente, dallo specifico contesto socioeconomico e dal tipo di regime
politico.
Ma il risultato aggregato dell’azione politica contiene al proprio interno gli obiettivi singoli dei diversi
attori.
In un regime democratico, ad esempio, l’obiettivo dei partiti è sia quello di ottenere un risultato
elettorale soddisfacente, sia quello di vedere attuate le proprie proposte di politica pubblica, cioè di
soluzione dei problemi collettivi.
L’obiettivo dei cittadini è certamente quello di vedersi dare risposte ai propri problemi, ma anche
quello di vedere il proprio partito vincitore delle elezioni.
L’obiettivo dei gruppi di interesse è quello di vedersi tutelati dalle decisioni politiche, mentre
l’obiettivo di alcuni attori istituzionali è proprio quello di tutelare l’interesse collettivo dal rischio di
eccessiva influenza dai gruppi di interesse.
Ottenere qualcosa in politica deve sempre fare i conti con il fatto che il conflitto tra interessi e idee
divergenti è strutturale.
Come si perseguono i propri fini in politica?
Le modalità mediante le quali gli attori cercano di perseguire i propri obiettivi in politica sono assai
diversificate.
Nei regimi autoritari il “come” è basato sulla prevaricazione e sulla minaccia della violenza fisica nei
confronti di chi non accetta di sottostare alle regole poste dal regime stesso.
Nei regimi democratici, dove la violenza è di solito bandita (ovvero usata solo nei casi di estrema
necessità), il come della politica è caratterizzato da negoziazioni, compromessi, scambi, procedure, a
volte pacifiche proteste di massa, fermo restando che il modo più generale di “ottenere”, per i cittadini
come per i partiti, è quello di vincere le elezioni.
Dove si perseguono i propri fini in politica?
Il dove della politica dipende dalle caratteristiche del contesto in cui opera l’attore che agisce
politicamente.
In linea generale, l’ambito di un’azione politica non può che essere una collettività in cui vi sia un
organismo deputato a prendere decisioni collettivizzate.
Gli ambiti possono essere variegati, ma comunque riconducibili a collettività in cui vi sia il monopolio
dell’esercizio della forza.
4. Nascita e istituzionalizzazione della scienza politica
4.1. Una prima definizione
La scienza politica è la disciplina che studia i fenomeni politici al fine di comprenderne la natura e
spiegarli mediante l’adozione delle metodologie proprie delle scienze empiriche.
La scienza politica, pertanto, vuole comprendere i meccanismi di funzionamento dei fenomeni e delle
azioni politiche al fine di individuarne la regolarità e di spiegarne gli effetti, sia quelli intenzionali, sia
quelli non intenzionali.
Pertanto, la scienza politica è una scienza empiricamente orientata.
Deve dare dimostrazione, attraverso le diverse tecniche del metodo scientifico, che le sue affermazioni
sono sufficientemente suffragate dall’evidenza dei fatti.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4.2. Le origini, tra due mondi
Il fatto che la politica sia sempre esistita non significa che vi sia sempre stata una scienza politica.
Per avere una scienza politica si è dovuto attendere che i cambiamenti storici avvenuti in epoca
moderna e contemporanea “liberassero” la politica dai suoi stretti legami di dipendenza dall’etica,
dalla religione e, infine, dal diritto.
Ed è stato necessario che si acquisisse la consapevolezza che l’oggetto “politica” trattato dalla filosofia
politica è qualcosa di diverso dall’oggetto politica trattato in modo scientifico.
La scienza politica ha bisogno di una definizione di “politica” come attività autonoma dalle altre
attività autonome e, al tempo stesso, di uno specifico contesto storico.
In questo senso non si può non ricordare che la scienza politica ha origini diverse in Europa rispetto
agli Stati Uniti e che ha avuto anche diversi percorsi.
In fondo, anche se se gli studiosi della scuola elitista europea (Mosca, Pareto, Michels) sono
considerati i padri della scienza politica contemporanea, lo sviluppo e la prima definita
istituzionalizzazione della scienza politica sono vicende soprattutto nordamericane.
Gaetano Mosca (1858-1941), considerato, insieme a Vilfredo Pareto, il padre della teoria delle
élites, diede notorietà alla disciplina con gli Elementi di scienza politica (1985).
Per lo studioso siciliano, giurista di formazione, la scienza politica andava considerata come analisi
e osservazione di una realtà politica vista principalmente come lotta e gestione del potere.
In tal modo, la scienza politica si emancipava dal diritto costituzionale e dalla filosofia politica,
stringendo stretti rapporti con la storia.
La sua “dottrina” si articolava in almeno tre distinte teorie: quella della classe politica, che
riguarda lo studio delle forze politiche ed elabora la regola universale circa la distinzione tra
governanti e governati; quella della formula politica, che ha per oggetto i principi e le ideologie
(formule); quella del quadro istituzionale che attiene ai rapporti tra le forze e le formule e, quindi,
all’esercizio e ai limiti posti dal potere.
La scienza politica è una disciplina che, per le sue caratteristiche, può svilupparsi solo in contesto
democratico.
“Ogni regime tende a produrre una politica consonante a se stesso; di conseguenza, ogni regime tende
a produrre una scienza della politica consonante a se stesso”. (Lowi)
La differenza dell’evoluzione politica dei due mondi si palesa con evidenza nei primi autori
empiricamente orientati allo studio della politica.
Se, infatti, in Europa abbiamo gli elitisti, negli Stati Uniti viene pubblicato nel 1908 il libro di Bentley
The Process of Government, in cui la politica è vista, realisticamente, come una lotta tra gruppi di
interesse che, interagendo, influenzano fortemente le decisioni politiche.
Un lavoro ed una prospettiva impensabili nell’Europa di inizio Novecento, dove tutti i paesi erano, a
esclusione della Francia, monarchie costituzionali.
La differenza tra i due mondi persistono durante il periodo tra le due guerre, quando negli Stati Uniti si
sviluppa un’attenzione ad una scienza politica empiricamente orientata: Charles Merriam costituisce
un gruppo di ricerca (c.d. Scuola di Chicago) in cui lo studio tradizionale della politica (basato sul
diritto e sulla storia) viene allargato ai contributi della sociologia, della psicologia e dell’antropologia.
Merriam verrà anche chiamato a lavorare per l’Ufficio del presidente degli Stati Uniti incaricato di
progettare la pianificazione del New Deal.
Inoltre, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, molti scienziati politici americani vengono
chiamati a collaborare con i servizi informativi e di propaganda.
Insomma, negli Stati Uniti la scienza politica trova terreno fertile per una veloce istituzionalizzazione,
tanto da essere pronta già alla fine del conflitto alla consacrazione della rivoluzione comportamentista.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In Europa le cose vanno molto diversamente.
L’evoluzione dei sistemi politici è il retroterra culturale è diverso.
Dopo il contributo degli elitisti, se si eccettua il grande lavoro di Max Weber, l’analisi empirica della
politica trova barriere invalicabili.
La storia europea è anche la storia di quelle gravi crisi del processo di democratizzazione che, a partire
dal primo dopoguerra, getta le basi per la costituzione di quei regimi autoritari che saranno una delle
cause scatenanti la deflagrazione del secondo conflitto mondiale.
In un tale contesto, la possibilità per una naturale evoluzione dello studio scientifico della politica sono
davvero minime.
Con la fine della Seconda guerra mondiale e i processi di ripresa e consolidamento della
democratizzazione in Europa, si riapre uno spazio per una riflessione meno ideologizzata e più
realistica del fenomeno politico che, progressivamente, consentirà alla disciplina di espandersi i
istituzionalizzarsi, seppur con una tempistica diversa a seconda delle caratteristiche culturali e storiche
dei diversi paesi: il processo di istituzionalizzazione è più veloce in Gran Bretagna e nei paesi del
Nord Europa, mentre procede in modo lento e difficoltoso in Germania, Francia, Spagna e Italia.
4.3. La lenta crescita della scienza politica in Italia
Le vicende della scienza politica in Italia seguono, con qualche ritardo, la falsariga di quella europea.
Pur essendo italiani i padri della scienza politica (da Machiavelli a Mosca), la disciplina non riesce a
decollare poiché ogni possibilità in questo senso è risucchiata nel vortice dell’involuzione autoritaria
del sistema politico e si deve confrontare con la forza egemonica del discorso giuridico e filosofico-
idealista sulla politica.
Proprio la forza di questa tradizione scientifico-culturale rende assai impervia la strada dello sviluppo
della scienza politica in Italia, anche con il ritorno alla democrazia e il consolidamento del regime
democratico.
Ciò nonostante, alcuni studiosi (Bruno Leoni, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori) cercano
costantemente, per tutti gli anni Cinquanta, di delimitare uno spazio autonomo per lo studio empirico
della politica.
La disciplina fatica a nascere, e bisogna aspettare gli anni Sessanta per rilevare segnali di una prima
istituzionalizzazione della scienza politica italiana.
In questo decennio una serie di fattori consentono alla disciplina di gettare quelle radici che le
permetteranno, nel decennio successivo, di radicarsi, pur se parzialmente, nelle università.
La nomina nel 1963 a professore ordinario di Giovanni Sartori.
Il padre della scienza politica italiana ottiene in quell’anno la cattedra di Sociologia, per poi passare a
quella di Scienza Politica pochi anni dopo.
Intorno a quella cattedra nascerà il primo nucleo di politologi accademici italiani e la “Rivista italiana
di Scienza Politica” (1971).
La pubblicazione dei primi lavori empirici.
Lo spartiacque è rappresentato dal volume sul parlamento, curato da Sartori (1963), in cui per la prima
volta un tema proprio del diritto costituzionale viene sviscerato sul piano della conoscenza empirica.
L’apertura e il ruolo nei primi network internazionali della ricerca.
Un primo gruppo di giovani studiosi italiani si forma negli Stati Uniti.
Alcuni di essi torneranno in Italia dopo il PhD per innestare di nuova linfa la scienza politica italiana e
costruire assieme agli studiosi formati da Sartori, Bobbio e Leoni i nuclei fondativi della disciplina.
La decisione ministeriale di consentire alle Facoltà di Scienze politiche l’inserimento del corso di
Scienza politica nel primo biennio (1968).
Con queste basi, la scienza politica italiana è pronta a godere della forte espansione quantitativa nel
sistema universitario che si manifesta nel corso degli anni Settanta.
All’esplosione dei numeri degli iscritti segue un consistente aumento dei posti di professori di ruolo,
che consentì un primo significativo reclutamento di scienziati politici nelle università.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
È, infatti, durante gli anni Settanta che la disciplina si irrobustisce, soprattutto in alcuni sede
universitarie (Bologna, Catania, Firenze, Torino).
Finalmente la scienza politica italiana esiste.
5. I confini della scienza politica
5.1. Il consolidamento della disciplina
La scienza politica è ormai una disciplina istituzionalizzata a livello mondiale, pur essendo presente in
modo più strutturato nei paesi occidentali a democrazia consolidata.
Il processo di consolidamento della disciplina ha comportato la definizione non solo dell’oggetto della
stessa, ma anche delle teorie e dei metodi con cui studiarlo.
La scienza politica non ha avuto bisogno solo di una definizione “realista” di “politica” per nascere e
svilupparsi, ma anche di delimitare con chiarezza i propri confini disciplinari.
Si è trattato di un processo complesso che, in realtà, non ha mai avuto fine, perché l’ubiquità della
scienza politica rende i confini tra le discipline spesso labili.
5.2. La scienza politica e le altre discipline: la costruzione di un’identità
La scienza politica nasce dopo le altre discipline che, da una diversa prospettiva analitica, si occupano
della politica.
In particolare, quattro sono le discipline che, preesistendo alla scienza politica, hanno rappresentato i
punti di riferimento e di sfida per la nuova disciplina: la filosofia politica, l’economia politica, il diritto
pubblico e costituzionale, la sociologia.
La scienza politica, per autonomizzarsi, ha dovuto distaccarsi da esse anche se il rapporto non si è mai
interrotto e spesso la nuova scienza politica ha tratto concetti e teorie da queste discipline, seppur
rielaborandole in modo originale.
Scienza politica e filosofia politica.
La distinzione tra “analisi scientifica” e “analisi filosofica” della politica è semplice, ma anche molto
complessa.
Semplice perché, quasi intuitivamente si è portati a ritenere che la filosofia politica si occupi di idee,
mentre la scienza politica si occupi di fatti; che la filosofia politica sia basata solo su concetti mentre la
scienza politica necessiti di prove empiriche per validare le proprie affermazioni.
In realtà le cose sono molto più complesse perché sia la filosofia sia la scienza politica focalizzano
l’attenzione su una domanda costitutiva del comportamento umano: com’è possibile l’ordine politico?
Ovviamente lo fanno in modo estremamente diverso, perché la filosofia politica assume sempre una
prospettiva intrinsecamente normativa, mentre la scienza politica aspira a spiegare il perché un ordine
sociale prevale in un dato momento.
Al tempo stesso, però, è opportuno osservare come anche i filosofi politici tengano in considerazione il
dipanarsi concreto dei fenomeni politici, seppur trattandolo in modo estremamente diverso rispetto agli
scienziati politici.
Per i filosofi politici la realtà della politica viene confrontata con un coerente sistema teorico mediante
il quale viene valutato se ciò che è nella realtà si conforma al principio del dover essere; per gli
scienziati politici, invece, la realtà è fonte dei dati necessari a capire e spiegare perché e come un
determinato fenomeno politico si è manifestato in uno specifico modo.
Questa diversità non può annullare il fatto che il cordone ombelicale tra le due discipline non sia mai
stato rescisso: in primo luogo perché alcuni termini fondamentali della scienza politica vengono dalla
lunga storia della filosofia politica; in secondo luogo perché, ogni qual volta venga proposta una teoria
empirica di un fenomeno politico, essa, per quanto empiricamente articolata, si basa su una fondazione
di tipo filosofico.
Insomma, se ha ragione Bobbio a distinguere la scienza politica rispetto alla filosofia politica, per il
fatto che la scienza politica a) deve verificare empiricamente le proprie affermazioni per validarle
(mentre per il filosofo politico esse sono valide se teoricamente coerenti), b) deve spiegare (mentre la
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
filosofia deve giustificare, ovvero trovare il miglior modo per l’ordine politico), c) deve essere
avalutativa (mentre per definizione il filosofo politico non può esserlo), è anche vero che il cordone
ombelicale tra filosofia e scienza politica persiste.
Scienza politica ed economia.
Tra scienza politica ed economia è stato più semplice individuare i confini e i rispettivi ambiti
disciplinari, almeno fino ad un certo punto.
Innanzitutto, quando si parla di “economia”, bisogna intendersi sul significato attribuito al termine.
Oggi l’economia si divide in microeconomia (che studia il comportamento individuale di chi consuma
e chi produce e le loro interazioni) e la macroeconomia (che studia il comportamento economico di un
sistema e gli interventi – le politiche – mediante i quali è possibile condizionare i comportamenti
microeconomici proprio per cambiare le performance di sistema).
In questo modo, parrebbe non esserci alcun problema nel distinguere la “scienza politica” dalla
“scienza economica”.
Ma, all’atto pratico, si deve rilevare che in fondo vi è un continuo sovrapporsi dell’oggetto della
politica e dell’oggetto dell’economia.
Soprattutto quando si ragiona a livello sistemico e quindi gli interventi – delle politiche economiche –
da porre in essere per migliorare le performance di sistema (es. diminuire la disoccupazione, rendere
equilibrato il sistema pensionistico), gli oggetti dell’analisi politologia ed economica si sovrappongono
quasi perfettamente e, anche se sulla base di approcci teorici diversi, scienziati politici ed economisti
tendono a sconfinare nel terreno disciplinare degli altri.
Inoltre, uno dei principali filoni teorici della scienza politica, la Rational Choice, è basato sull’assunto
di base dell’azione microeconomica, e cioè che “il complesso del comportamento umano può essere
considerato composto da individui che partecipano al fine di massimizzare la propria utilità sulla base
di un insieme di preferenze stabili”.
Questa prospettiva teorica ha reso molto simile l’analisi politologica a quella economica, soprattutto in
quei settori di indagine in cui ci si occupa di analizzare i processi mediante i quali si operano le scelte
collettive.
Al tempo stesso, si deve rilevare come vi siano altri terreni di incontro tra scienza politica ed analisi
economica.
Ad esempio, a partire dagli anni Ottanta, tanto le teorie esplicative degli scienziati politici quanto i
modelli degli economisti tornano a mettere al centro il ruolo delle istituzioni.
Oppure, il recente comune interesse rispetto alla “tragedia dei beni comuni”, cioè al problema della
gestione delle risorse naturali.
Infine, non si può non accennare agli intrecci tra scienza politica ed economia nel compenetrarsi, sia a
livello di analisi interna – Political economy – sia a livello di politica internazionale – International
Political Economy – per spiegare i fenomeni politici e sociali mettendo in relazione le influenze
reciproche tra elementi propri della politica ed elementi propri del sistema economico.
I confini tra “scienza politica” e “scienza economica” parrebbero abbastanza chiari e netti.
Certo, diversi sono gli obiettivi delle due discipline: da una parte spiegare come si struttura l’ordine
politico di un determinato sistema, dall’altra parte come un sistema riesce a raggiungere e mantenere
un determinato equilibrio economico.
Le variabili prese in considerazione sono decisamente differenti, ma la forza della realtà invita
continuamente a sconfinamenti disciplinari e a collaborazioni.
Scienza politica e scienza giuridica.
I confina tra “scienza politica” e “scienza giuridica” sono anch’essi quasi auto evidenti.
In realtà, anche in questo caso, le cose non sono così semplici, e la rivalità tra le due discipline
persiste, soprattutto nei paesi dell’Europa continentale.
Questa rivalità ha origini storiche sedimentate.
La scienza giuridica – in particolare il diritto costituzionale e pubblico – ha rappresentato il linguaggio
costitutivo del passaggio dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale.
Mediante il diritto si sono regolati e depoliticizzati i rapporti tra governanti e governati.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il diritto si è imposto a lungo come il linguaggio dello Stato e per certi versi anche della politica, anzi,
con la giuridicizzazione dello Stato si è giuridicizzata la politica, ovvero si è cercato di convogliare la
lotta per il potere politico all’interno di un sistema di norme.
Con la giuridicizzazione del potere, la fonte del potere politico è esterna ad esso, ed esso stesso nel suo
esercizio deve conformarsi al principio di legalità e legittimità (il potere può essere ottenuto ed
esercitato solo nel rispetto delle regole poste dal sistema di norme vigenti).
Ovviamente, però, occuparsi della legalità e soprattutto della legittimità dei comportamenti politici,
seppur rispetto all’insieme di norme vigenti, consente ai cultori del diritto di entrare anche nel merito
del comportamento politico e quindi di sconfinare nel territorio della scienza politica.
D’altra parte, anche gli scienziati politici sconfinano spesso, soprattutto quando si occupano di riforme
costituzionali, in un territorio che i giuristi considerano di loro assoluta proprietà.
È tuttavia evidente che questi margini di sovrapposizione non possono far dimenticare le intrinseche
differenze disciplinari: la scienza politica studia la concretezza dei fenomeni politici al fine di capirli e
spiegarli, mentre la scienza giuridica analizza i comportamenti politici per valutarne la coerenza, in
termini di legalità e legittimità, con l’ordinamento giuridico esistente.
Scienza politica e sociologia.
I confini tra “sociologia” e “scienza politica” sono assai più labili di quelli con le discipline fin qui
analizzate.
Ciò è dovuto al fatto che la sociologia è una delle sorelle maggiori della scienza politica, e
quest’ultima ha trattato dalla sociologia un insieme assolutamente rilevante di concetti fondamentali.
Senza contare che molti grandi sociologi sono da considerare anche dei classici fondamentali per
chiunque voglia fare scienza politica.
Inoltre, entrambe le discipline sono non solo empiricamente orientate, ma condividono in gran parte le
stesse metodologie di ricerca.
Ovviamente, una si occupa della società e l’altra della politica e, quindi, le loro differenze stanno
soprattutto nel modo di organizzare il rapporto tra cause ed effetti.
Per il sociologo, ad esempio, ogni fenomeno studiato è riconducibile alle caratteristiche del sistema o
della struttura sociale.
Da parte loro gli scienziati politici ritengono la struttura sociale come il prodotto del comportamento
degli attori e delle istituzioni politiche.
Si tratta di una differenza sostanziale e che consente alle due discipline di mantenere confini reciproci
abbastanza netti e di avere, al tempo stesso, una sovrapposizione condivisa e reciprocamente
legittimata.
Gli studi compresi in quest’area di sostanziale sovrapposizione sono spesso ricondotti alla sociologia
politica, ovvero quella disciplina in cui scienza politica e sociologia si ibridano, al fine di studiare le
basi sociali e istituzionali dei fenomeni tipici del comportamento politici (es. comportamento
elettorale), nonché le basi sociali del conflitto e del consenso presenti in una realtà politica.
6. Evoluzione e specializzazione della scienza politica
6.1. Le tappe fondamentali
La scienza politica contemporanea, quella che si consolida a partire dal secondo dopoguerra, origina da
una comune matrice teorica che è quella del comportamentismo.
Si tratta di un movimento epistemologico che, sulla base del pragmatismo di John Dewey e del rifiuto
del formalismo giuridico e delle mere ricostruzioni storiche, spinge a focalizzare l’attenzione degli
studiosi sul reale comportamento politico degli individui, senza prestare attenzione al potere e al ruolo
delle istituzioni.
Sulla base di questo modo di guardare al fenomeno, l’analisi politica deve studiare il comportamento
politico in modo neutrale prestando attenzione ai fatti che devono essere rilevati attraverso tecniche e
metodiche innovative.
In questo modo, la scienza politica può produrre spiegazioni verificabili, attendibili e neutre.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La svolta comportamentista, che risulterà egemonica fino alla metà degli anni Sessanta, è
assolutamente importante perché rappresenta il vero spartiacque verso la costruzione di una disciplina
empiricamente orientata.
È infatti grazie al comportamentismo che la scienza politica acquisisce alcuni elementi costitutivi della
sua autonomia e identità: la ricerca di regolarità; la necessità di verificare empiricamente le
generalizzazioni; l’esigenza di adottare tecniche sofisticate di analisi e dare forma anche quantitativa
all’oggetto analizzato; la sistematizzazione (ovvero l’esigenza di dare una robusta base teorica alla
ricerca empirica).
L’epoca comportamentista produce anche un tentativo di teoria generale per l’analisi politica, quella di
David Easton che, cercando di costruire uno schema generale di analisi politica di stampo
comportamentista, propone il primo approccio teorico in cui lo Stato non è il centro motore della
politica.
Esso viene sostituito dal concetto di “sistema politico”, ossia l’insieme di interazioni interdipendenti
tra attori politici e attività funzionali della società, mediante le quali vengono prodotte e attuate
decisioni politiche e, quindi, allocati valori in una società.
Si tratta di un tentativo ambizioso che, però, non riesce a raggiungere l’obiettivo prefissato di una
condivisa teoria generale per l’analisi della politica.
Progressivamente il comportamentismo, e l’analisi sistemica di Easton, vengono criticati e
abbandonati, anche se alcuni loro elementi persistono nella scienza politica contemporanea.
Il declino del progetto eastoniano ha prodotto una significativa frammentazione, dal punto di vista
teorico, nella scienza politica.
Infatti, attraverso un vero e proprio processo a ondate, la scienza politica ha visto l’emergere e il
coesistere di diversi paradigmi teorici.
Negli anni Settanta si impone con vigore la Rational Choice, e all’interno di questo approccio
incentrato sulla razionalità individuale, i lavori della teoria della scelta pubblica diventano i punti di
riferimento più importanti per gli scienziati politici d’oltreoceano.
L’attenzione per il ruolo delle “istituzioni” torna progressivamente in auge negli anni Novanta.
Contestualmente, emerge un consistente filone di ricerca che enfatizza il ruolo delle idee
nell’influenzare i processi politici.
È questa la fase in cui si sviluppa a partire dagli Stati Uniti un’impressionante letteratura sulla
governance, ovverosia sul problema del modo in cui i processi decisionali vengono governati in
contesti affollati di attori che perseguono i propri interessi su diversi livelli istituzionali.
Il processo di globalizzazione ha ulteriormente influenzato l’evoluzione di questi studi: una parte della
scienza politica si muove oggi in una dimensione terza tra le due classiche aree della politica
comparata (ovvero la comparazione degli Stati) e le relazioni internazionali (la politica tra gli Stati):
la dimensione che vede nella governance multilivello il contesto dove opera l’insieme degli attori
rilevanti – gli enti locali, regionali, lo Stato, gli organismi sovranazionali.
Insomma, dal punto di vista teorico la scienza politica è venuta sedimentando un notevole pluralismo
teorico, oltre che metodologico, che se da una parte ne mostra la vivacità, dall’altra parte mostra il
rischio di difficile o lenta cumulabilità delle conoscenza.
Alla frammentazione teorica ha corrisposto, pertanto, anche una frammentazione tematica.
Questa duplice frammentazione può far pensare al rischio di diaspora che, in realtà, non è nell’ordine
delle cose.
Ciò che tiene insieme la scienza politica è il comune interesse a capire e spiegare la politica in modo
empiricamente orientato e la comune condivisione della comparazione come metodo ineludibile per
fare buona scienza politica quale che sia l’oggetto di analisi e la teoria che guida questa analisi.
6.2. Gli approcci della scienza politica contemporanea
Gli approcci teorici sono i modi in cui possiamo “vedere le cose” ed interpretare i fenomeni (politici).
Un approccio teorico in scienza politica è dunque l’equivalente di un paradigma nelle scienze naturali.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
A seconda dell’approccio teorico prescelto, lo scienziato politico si orienterà verso un certo tipo di
fenomeni e di misurazioni, ignorando altri possibili aspetti della realtà, perché ritiene i primi costitutivi
del fenomeno politico.
Gli approcci teorici sono intimamente legati ai metodi e alle tecniche della ricerca scientifica ed il loro
successo determina la storia della scienza politica.
Quali sono gli approcci oggi riconosciuti nella scienza politica?
Sicuramente va ancora considerato il “vecchio” approccio strutturalista.
Il termine designa tutte le visioni che guardano a fattori strutturali, per lo più socioeconomici, per
spiegare eventi e comportamenti politici.
La teoria marxista della lotta di classe e della rivoluzione proletaria come conseguenza inevitabile
dell’evolvere dei rapporti di produzione è certamente una teoria strutturalista.
Strutturaliste sono anche le teorie che vedono lo sviluppo politico ed economico di un paese come
determinato dalla sua posizione geopolitica.
Nell’approccio strutturalista ricorre spesso la parola “sistema”: non ci stupirà quindi che il più
compiuto tentativo di stabilire delle relazioni generali tra sfere dell’agire sociale, derivante dallo
struttural-funzionalismo di Talcott Parsons, sia l’approccio sistemico (Systems Theory).
Dalle critiche allo struttural-funzionalismo hanno trovato origine o rinnovata attenzione approcci
teorici che hanno poi preso piede in momenti successivi.
L’approccio pluralista di stampo comportamentista, ad esempio, ha ripreso vigore proprio in reazione
a quello sistemico-strutturalista, enfatizzando soprattutto la rilevanza delle azioni e delle interazioni tra
gli attori nell’influenzare gli esiti del processo politico.
A questo orientamento teorico corrispondeva un nuovo orientamento epistemologico: al centro
dell’analisi pluralista vi è la convinzione che il potere politico non si annidi necessariamente nelle
strutture economiche e sociali, ma sia determinato dall’interazione di gruppi di persone che si
mobilitano a favore di questa o di quella issue.
Per studiare il potere occorre quindi osservare il suo esercizio in corso d’opera, analizzando attraverso
l’osservazione partecipata chi fa e decide cosa.
Questo approccio si basava sulla convinzione che l’esercizio del potere potesse osservarsi meglio ad
un livello d’analisi inferiore – quello della comunità locale – e che i risultati di questi studi potessero
essere poi generalizzati.
Caposcuola di questo approccio era Robert Dahl che, che nel suo famoso studio del potere a New
Haven (1961), voleva capire chi governasse la città.
Dallo studio di Dahl emergeva come il potere fosse disperso e come centrale fosse invece la figura
politica (in questo caso il sindaco) cui spettava di decidere a quale pressione societaria dare maggiore
ascolto.
Non tutti gli esponenti del pluralismo erano tuttavia così fiduciosi nella capacità del sistema politico di
rispondere alle esigenze della società.
Piuttosto scettico era, ad esempio Theodore J. Lowi che sottolineava come la mobilitazione fosse
spesso solo una facciata per permettere che le vere decisioni venissero invece prese tra pochi individui.
Nei decenni successivi alla rivoluzione comportamentista, il ruolo delle istituzioni ha avuto un
nuovo rilancio, sia pure con modalità diverse che, nel loro complesso, hanno determinato lo sviluppo
del cosiddetto approccio neoistituzionalista.
A partire dagli anni Settanta, un gruppo sempre più numeroso di scienziati della politica ricominciava a
studiare le istituzioni statali.
Dall’interesse per lo “Stato”, l’agenda istituzionalista si è estesa successivamente a tutte le istituzioni,
pubbliche e private, strutturali e cognitive, fisiche e mentali.
Questo approccio si è venuto differenziando in tre filoni.
In comune, tali filoni hanno l’attenzione alle istituzioni ed alle capacità di influire sui comportamenti
degli attori e sulle decisioni politiche.
Dove differiscono è sui meccanismi di tale influenza.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il neoistituzionalismo storico colloca i processi politici all’interno di percorsi dai quali essi sono
dipendenti sia in relazione alla loro persistenza sia in relazione al loro cambiamento.
Il neoistituzionalismo sociologico-organizzativo sottolinea come il comportamento politico sia
fortemente influenzato dalle modalità mediante le quali le “istituzioni” (intese in senso lato, come
schemi di comportamento persistente di tipo culturale e sociale) formano le preferenze degli individui
e quindi ne influenzano il comportamento.
Il neoistituzionalismo razionale – utilizzando l’analisi razionale propria degli approcci economici –
sviluppa l’esigenza di collocare i comportamenti individuali in contesti istituzionalmente vincolati.
Una famiglia di approcci teorici che periodicamente si riaffaccia, rinnovandosi ed acquisendo
sempre nuovi tratti, è quella culturista.
Alla sua base sta la convinzione che la cultura e i valori siano determinanti fondamentali del
comportamento politico.
Il difetto principale di questi approcci è che non poggiano su alcun tentativo di dimostrare la loro
effettiva consistenza e di spiegarne l’origine.
La “cultura” di questo o quel popolo diventa pertanto una conveniente variabile residuale in cui
scaricare tutta la varianza non spiegata dai fenomeni politici e sociali sotto osservazione.
7. Una scienza utile a cosa
Il tema dell’applicabilità del sapere prodotto dalla scienza politica è diventato molto dibattuto, prima in
America e successivamente anche in Europa.
Ancora oggi esso è un tema fondamentale che ha a che vedere con questioni complesse.
Nonostante sia l’estensione che l’applicabilità della scienza politica non siano ancora certe, è
comunque possibile dare una risposta minimale alla domanda a che cosa serve la scienza politica?.
In primo luogo, serve ad offrire ai cittadini e ai decisori una visione dei fenomeni politici, delle loro
cause e dei loro potenziali effetti, deideologizzata ed empiricamente fondata.
In secondo luogo, la scienza politica è una disciplina che educa alla democrazia perché, “svelando”
come davvero funziona la politica, ne fa emergere, in modo empirico, i vizi e i problemi.
La scienza politica, in definitiva, aiuta la democrazia a correggere i propri errori e a migliorarsi, per
quanto possibile.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 2 – Metodi e strumenti della scienza politica
1. Che cos’è la ricerca politica e sociale
Le procedure di raccolta delle osservazioni, di elaborazione dei concetti e di collegamento fra questi in
proposizioni verificabili – cioè, ciò che consideriamo “ricerca scientifica” – sono storicamente e
culturalmente determinate.
La ricerca politica e sociale non è solo apprendimento autocosciente, ma è anche apprendimento
metodologicamente autocritico.
Non ci basta conoscere in maniera rigorosa, vogliamo anche “sapere come sappiamo”.
Quando ci proponiamo di conoscere in maniera scientifica, compiano due “atti di fede” – meglio detto,
partiamo da due premesse di base che non possiamo provare – magari senza neanche saperlo.
La prima è una premessa di tipo ontologico (aggettivo che si riferisce al discorso sull’esistenza, o
essenza), e consiste nello “scommettere” che la realtà politica e sociale “là fuori” è caratterizzata da
una certa regolarità.
La seconda premessa è di tipo epistemologico (aggettivo che si riferisce al discorso sulla veridicità, o
verità), e consiste nello scommettere che, grazie a disciplinate osservazioni e a rigorosi metodi di
inferenza, possiamo effettivamente conoscere quella realtà.
Insieme, queste due premesse ci consentono di applicare metodi di osservazione, concettualizzazione e
misurazione della realtà che possono portare a conoscenze valide, comunicabili e potenzialmente
replicabili.
Il lavoro degli scienziati politici consiste nel ricercare regolarità all’interno di una realtà che appare
casuale e caotica e che, se così davvero fosse, non potrebbe essere conosciuta sistematicamente.
1.1. Il dibattito sulla scienza: le scienze sociali e le altre scienze
La scientificità delle scienze sociali è stata a lungo oggetto di dibattito.
È un dibattito affascinante e complesso, che parte da lontano.
Gli esponenti del Circolo di Vienna elaborarono la teoria dell’unitarietà delle scienze naturali e sociali.
Per questi studiosi, la conoscenza dei “fatti sociali” non era sostanzialmente diversa dalla conoscenza
dei “fatti naturali”: in entrambi i casi si trattava di stabilire una connessione quanto più precisa e
univoca tra la realtà (oggetto) e l’agente sociale o lo studioso (soggetto).
La “verità” delle scienze e la “validità” della nostra conoscenza consisterebbero nello stabilire questo
nesso nel modo più preciso e univoco possibile.
La posizione filosofica del Circolo di Vienna, a contatto con il naturalismo americano di John Dewey,
generò il metodo neopositivistico che ha dominato le scienze sociali nel dopoguerra.
La realtà sociale, infatti, non si presenta immediatamente al soggetto, ma è mediata dai concetti, dai
termini e dalle teorie con i quali il soggetto rappresenta a sé la realtà.
La verità della conoscenza scientifica e la validità delle proposizioni che la costituiscono dipendono
dallo stabilire un adeguamento sempre più stretto e preciso del concetto-termine al dato osservato.
Il forte impulso empiricista impresso dalla scienza politica americana al dibattito metodologico si era
già affermato negli anni tra le due guerre grazie alle opere di Arthur Bentley e David Truman.
Entrambi avevano impostato lo studio del “processo di governo” come uno studio empirico volto a
cogliere soprattutto i comportamenti e le attività invece che gli stati mentali ed emotivi ad essi
collegati.
Gli oggetti della scienza politica erano, per questi studiosi, dati “duri” (hard data) – comportamenti e
attività – e non “molli” (soft data) – stati mentali ed emotivi.
Trattando i dati duri delle scienze sociali alla stregua di altri dati e quindi cercando di osservarli e
misurarli, Bentley ambiva ad elevare lo status di queste scienze, e in particolare della scienza politica,
a quello delle scienze naturali.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Su un versante opposto si posizionavano invece studiosi che, come Dilthey, erano ben coscienti del
fatto che scienze naturali e scienze umane e sociali erano divise dalla diversa relazione che esiste tra
oggetto e soggetto.
Per Dilthey, così come per Weber, era possibile conoscere la realtà politica e sociale in modo
scientifico, ma ciò a cui occorre rinunciare è la pretesa – illusione – di aver così stabilito una
connessione fra noi e la realtà “là fuori”.
Il passaggio dall’induttivismo – partire dalle osservazioni empiriche per “scoprire” regolarità nella
loro manifestazione – al deduttivismo – partire da una qualche forma di “pre-teoria” che postula
l’esistenza di regolarità per verificare se le osservazioni empiriche si confanno ad esse – ormai
dominante nelle scienze sociali (e naturali) è quasi completato.
Per Karl Popper, compito della scienza è di sottoporre le teorie scientifiche a falsificazioni, al tentativo
cioè di individuarne le debolezze ed eliminarle in un continuo raffinamento e rafforzamento delle
stesse: di qui il termine di “falsificazionismo” con cui si denota la posizione filosofica di Popper.
Non appena un teoria scientifica è falsificata, va abbandonata e sostituita con un’altra che fornisca una
maggiore aderenza dei concetti-termini ai dati.
Popper chiaramente crede ancora nel progresso della scienza.
Affinché la scienza progredisca, il procedimento scientifico deve essere trasparente, replicabile e
pubblico.
Per Thomas Kuhn, invece, la scienza non procede gradualmente per affinamenti incrementali, ma
attraverso “rivoluzioni”.
La scientificità delle teorie non consiste nella loro progressiva sempre migliore aderenza al dato reale,
ma nell’attenersi agli statuti epistemologici in quel momento prevalenti.
Il concetto stesso di “scientificità” è socialmente determinato: la garanzia di una qualche forma di
“oggettività scientifica” risiede nel consenso della comunità scientifica che condivide quell’insieme di
teorie, leggi e procedure che formano un paradigma.
Imre Lakatos tenta una sintesi ed un riavvicinamento tra le posizioni di Popper e di Kuhn, affermando
che se non basta falsificare una teoria per scartarla completamente, il passaggio da una teoria all’altra
non è nemmeno dettato da mode improvvise.
Ogni teoria per Lakatos è collegata ad un “programma di ricerca” costituito da un nucleo centrale di
ipotesi di base che è possibile, anzi doveroso, preservare da falsificazioni affrettate, grazie all’aggiunta
di ipotesi che le rendano più capaci di spiegare la realtà, finché una teoria ed un programma alternativo
di ricerca non vengano sviluppati.
È evidente come nelle scienze sociali contemporanee ci si è allontanati dal concetto di “oggettività”
ottocentesco in virtù di idee fondamentali quali la centralità del momento teorico e la provvisorietà e
reversibilità delle teorie scientifiche.
È la teoria che, nel bene e nel male, condiziona l’intero processo di indagine, consentendo di porre o
non porre dei problemi e prefigurandone soluzioni inadeguate o adeguate.
L’elemento fondante della razionalità scientifica e del suo controllo consiste nella pubblicità,
ripetibilità e controllabilità di ogni proposizione, di ogni indagine, esperimento, enunciazione e legge.
L’indagine scientifica è quell’articolato e non lineare processo che da una situazione indeterminata
(qualcosa che “non torna”, per così dire) conduce alla posizione di un problema, che è tale solo in
quanto, con l’intervento di un abbozzo di teoria, o congettura, risulta affrontabile e risolubile.
1.2. Descrivere, spiegare, prevedere, prescrivere, interpretare
Vi sono molti obiettivi possibili che uno scienziato sociale può voler perseguire nello svolgere
un’indagine scientifica.
In primo luogo, uno scienziato politico può voler descrivere accuratamente un fenomeno politico.
A questo fine, lo scienziato politico deve raccogliere una grande quantità di dati su aspetti che la sua
esperienza gli suggerisce possono essere rilevanti.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In studi descrittivi, la quantità e il tipo dei dati raccolti può essere davvero vastissima e lo scienziato
politico rischia di essere considerato un “cantastorie” (story-teller).
In secondo luogo, uno scienziato politico potrebbe voler spiegare un fenomeno.
È importante precisare che spesso la relazione che gli scienziati sociali riescono a stabilire è di mera
correlazione piuttosto che di vera e propria causazione.
In terzo luogo, un obiettivo che lo scienziato politico può porsi è prevedere un evento o risultato.
Molto interessati alle previsioni sono ovviamente i politici candidati alle elezioni, che vorrebbero
sapere quali comportamenti tenere al fine di massimizzare la probabilità di essere eletti.
Ma anche i legislatori e i policy-maker desiderano prevedere i risultati attesi di una loro decisione.
In quarto luogo, coloro che consigliano i decisori sono esperti che utilizzano i modelli “scientifici”
costruiti per prevedere, ma anche per prescrivere comportamenti.
Il termine “prescrizione” può indicare una semplice raccomandazione basata su una previsione,
oppure, in senso normativo, un precetto a cui è opportuno o giusto attenersi.
La scienza politica del dopoguerra si è astenuta da entrambe queste attività e ha evitato sia di mettere
le proprie conoscenze “a servizio del Principe” sia di intavolare ragionamenti normativi, lasciati ai
filosofi politici.
Infine, occorre ricordare che dal dibattito sulle scienze sociali emerge anche una posizione
epistemologica costruttivista della scienza, che ritiene che la realtà sociale non esiste di per sé “là
fuori”, ma venga “costruita” attraverso le mappe concettuali e valoriali degli attori sociali.
Di conseguenza, gli scienziati sociali devono innanzitutto comprendere le mappe cognitive e le ragioni
profonde che orientano e muovono gli attori sociali e dare così significato ai loro comportamenti e agli
avvenimenti politici e sociali.
In base a questa posizione, pertanto, obiettivo della scienza politica è innanzitutto interpretare gli
avvenimenti e i comportamenti sociali.
2. Gli strumenti della ricerca
Lo studioso di scienze sociali conosce la realtà attraverso concetti a cui vengono associati termini.
I concetti sono lo strumento principale dello scienziato sociale: per questo motivo è imperativo che i
concetti siano definiti con precisione e che a essi siano associati termini univoci.
Fra gli scienziati politici, Giovanni Sartori e Alberto Marradi hanno prodotto contributi fondamentali
all’analisi concettuale, anche su scala internazionale
Giovanni Sartori (1924-) è considerato il padre della scienza politica italiana contemporanea e uno
dei più importanti scienziati politici a livello internazionale.
Filosofo di formazione, è stato il primo professore di Scienza politica in Italia e il fondatore della
“Rivista italiana di Scienza Politica”.
2.1. Concetti e definizioni
Secondo Sartori, ogni concetto identifica un referente
al quale viene assegnato un termine e un significato.
Si viene così a creare una relazione triadica tra
significato, oggetto e termine.
La relazione tra significato e oggetto deve essere
precisa (per evitare il rischio di vaghezza concettuale);
la relazione tra significato e termine deve essere
univoca (per evitare il pericolo di ambiguità
concettuale).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La posizione di Marradi è più sfumata rispetto a quella di Sartori: per Marradi la realtà può essere
suddivisa in molti modi diversi a seconda delle esperienze vissute della popolazione che usa il
linguaggio e delle esigenze del ricercatore.
Famoso è il suo esempio della neve che, nel linguaggio delle popolazioni dell’estremo Nord è indicata
con numerosi termini diversi che indicano altrettanti tipi di neve corrispondenti alle loro molteplici
esperienze.
Per questo motivo le traduzioni da una lingua a un’altra sono così difficili, perché ogni termine
rimanda a un’esperienza che può essere anche molto diversa.
Un esempio meno naturalistico è dato dalle difficoltà che i traduttori del Forum mondiale delle donne
ebbero nel 1999 nel tradurre in alcune lingue il concetto di “donna” senza necessariamente associarlo a
quello di madre, moglie o figlia.
Proprio per questo motivo diventa importante definire con cura ogni concetto che viene usato nella
ricerca scientifica.
Innanzitutto va definito il fenomeno che si intende descrivere, spiegare o interpretare: la variabile
dipendente.
Sartori distingue concetti teorici (che non rimandano ad alcun referente osservabile) da concetti
empirici (che rimandano a referenti osservabili).
“Partito politico” è un concetto empirico, “democrazia” è un concetto teorico.
Indipendentemente dalla loro natura, però, sia i concetti teorici che quelli empirici devono poter essere
definiti con precisione.
La definizione di un concetto deve contenere tutte e solamente quelle proprietà o caratteristiche del
concetto che servono a distinguerlo univocamente da altri concetti affini.
Spesso un concetto e i suoi affini sono accomunati da un certo numero di caratteristiche, ma
differiscono in base ad almeno una di queste.
I concetti stanno in relazione ad altri concetti che si situano a livelli superiori o inferiori nella scala di
astrazione avendo in comune con essi un certo numero di caratteristiche necessarie ma non altre
caratteristiche accessorie.
Aggiungendo caratteristiche al concetto più ampio di partenza si arriva ad un concetto più ristretto.
Chiamando intensione (o connotazione) l’insieme delle caratteristiche che definiscono un concetto-
termine ed estensione (o denotazione) l’insieme dei referenti empirici indicati dal concetto-termine, è
possibile stabilire che tra intensione ed estensione esiste un rapporto inverso: quanto più è limitata
l’intensione (cioè il numero di caratteristiche che definiscono necessariamente un concetto), tanto più
ampia è l’estensione (cioè il numero dei referenti empirici che sono denotati dal concetto) e viceversa.
L’intensione del concetto ci permette quindi di stabilirne con precisione l’estensione, cioè quali casi
empirici vengono denotati dal concetto e possono essere strumento della nostra indagine.
I concetti sono le variabili della nostra ricerca.
Per utilizzarli come tali, dobbiamo tradurre le caratteristiche che compongono la loro intensione in
altrettanti indicatori osservabili e in ciò consiste l’operazionalizzazione del concetto.
Ad esempio, affinché si possa decidere se una determinata associazione è un partito politico dovrò
determinare se è formalmente libera, se il suo scopo è nominare candidati e se questi aspirino a
conquistare il potere politico.
Ciascuna di queste caratteristiche deve a sua volta essere misurata da un indicatore, in modo da
rendere possibile la determinazione della presenza o assenza della caratteristica.
Inoltre, deve essere possibile combinare gli indicatori in indici sintetici, attraverso formule
matematiche o logiche, al fine di arrivare ad una misurazione univoca del referente del concetto.
I concetti sono costrutti sociali e pertanto hanno una loro storia.
Inoltre, i termini che indicano i concetti delle scienze sociali, al contrario dei termini che indicano i
concetti delle scienze naturali o fisiche, sono pericolosamente simili (talvolta identici) ai termini del
linguaggio comune.
Questa circostanza genera due pericolosissime tendenze.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In primo luogo, la tendenza a far perdere precisione al ragionamento socioscientifico, perché anche gli
scienziati della politica possono passare dall’utilizzo di termini precisamente concettualizzati
all’utilizzo di termini del linguaggio comune.
In secondo luogo, la tendenza a credere che chiunque “parli di politica” – letteralmente, il politologo –
sia per ciò stesso uno scienziato della politica.
La vicinanza e somiglianza del linguaggio socioscientifico a quello comune causa due ulteriori
problemi al quale lo scienziato della politica deve prestare attenzione.
Il primo è che, magari per perseguire un’errata concezione del “bello scrivere”, lo scienziato della
politica può essere indotto a utilizzare termini diversi per denotare gli stessi referenti empirici, facendo
così perdere di precisione al testo e di conseguenza al ragionamento.
I sinonimi sono pericolosi perché possono nascondere sottili differenze che possono inficiare una
ricerca scientifica.
Peggio ancora sono gli omonimi (termini identici per denotare referenti empirici diversi), perché
generano immediatamente confusione.
Il secondo problema è che, per utilizzare termini del linguaggio comune in maniera scientifica
(laddove coniare un termine nuovo sarebbe troppo complesso o artificiale), occorre prima depurarli
dalle varie concrezioni linguistiche che vi si sono attaccate nel corso del tempo in seguito all’uso
comune.
Talvolta nemmeno questo lavoro di ricostruzione del termine riesce a depurare il concetto una volta per
tutte delle caratteristiche accessorie che lo rendono meno preciso.
2.2. Classificazioni e tipologie
Come iniziare a formulare un’ipotesi di ricerca quando il fenomeno è del tutto nuovo?
Si entra nella cosiddetta “modalità di scoperta” e si fa come gli entomologi che raccolgono una gran
quantità di esemplari (osservazioni) e li catalogano a seconda delle caratteristiche più evidenti.
Supponiamo che degli entomologi vogliano studiare un tipo di insetto nuovo, mai osservato prima.
Essi ne raccoglieranno molti esemplari e li classificheranno, ad esempio, a seconda della dimensione,
del colore, delle caratteristiche delle zampe, e terranno accurata nota di dove gli hanno catturati.
È questa la fase della classificazione, che può andare dalla classificazione più semplice (in base ad una
sola caratteristica) alle classificazioni più complesse (in base a numerose caratteristiche).
Una volta terminata la fase della raccolta degli esemplari, gli entomologi inizieranno a mettere in
correlazione due o più caratteristiche.
Potrebbero così scoprire che gli insetti più grandi si trovano in zone umide e quelli più piccoli in zone
aride, oppure che la colorazione dell’insetto cambia a seconda della provenienza geografica.
Si potrà così iniziare ad ipotizzare delle correlazioni tra le varie caratteristiche dell’insetto.
Certo, le associazioni dipenderanno in parte da nozioni o teorie già note.
Il fatto che qualsiasi ipotesi venga ispirata da teorie o pre-teorie già esistenti, potrebbe indurre questi
studiosi ad ignorare caratteristiche – e associazioni tra caratteristiche – potenzialmente molto
interessanti, proprio perché nessuna teoria finora aveva suggerito che potesse sussistere tale
associazione.
Se, però, essi si mantengono fedeli alla “modalità della scoperta” allora saranno disposti a formulare
ipotesi mai avanzate prima.
Riprendendo l’esempio dell’insetto, si potrebbe stabilire che la colorazione dell’insetto individua classi
differenzi (si ha, quindi, una classificazione): verde, marrone e rosso.
Qualora, però, vengano identificate delle associazioni sistematiche tra le caratteristiche, la
classificazione dà luogo ad una tipologia.
Il termine “tipo”, infatti, indica una sottospecie del genere che mostra caratteri appunto “tipici”, cioè
facilmente riconoscibili, rispetto ai caratteri “generali”.
Gli studiosi potrebbero scoprire che gli insetti che vivono in zone paludose sono verdi (tipo I), quelli
che vivono in zone temperate sono marroni (tipo II) e quelli che vivono in zone aride sono rossi (tipo
III).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Ecco allora che il colore dell’insetto viene messo in correlazione con l’habitat in cui si trova a vivere e
si costruisce una tipologia.
È facile intuire come la costruzione di una tipologia possa essere, e spesso è, il primo passo verso la
formulazione di ipotesi che, se confermate da successive osservazioni, potrebbero essere elevate a
teorie (in attesa di essere confutate).
Le classificazioni e le tipologie, affinché siano utili al fine di sviluppare ipotesi di ricerca e quindi
generare nuove teorie / confutarne di esistenti, devono risultare collettivamente esaustive, e cioè tutti
gli esemplari devono poter essere posizionati in una casella.
Le caselle delle tipologie non devono essere necessariamente tutte piene; anzi, quanto più gli esemplari
tenderanno a raggrupparsi in tipi distinti, tanto più sarà facile formulare delle correlazioni tra
caratteristiche.
In entrambi i casi, però, nessun esemplare deve poter essere messo indistintamente in una o in un’altra
casella: i tipi devono essere mutuamente esclusivi.
2.3. Proposizioni generalizzate
Le scienze sociali possono al massimo aspirare a generare proposizioni generalizzate – talvolta
chiamate “quasi-leggi” – limitate nel tempo e nello spazio e aventi validità statistica (cioè valide in
una percentuale di casi inferiore al 100%).
Al fine di formulare proposizioni generalizzate di una qualche significatività statistica sulle
rivoluzioni, non solo dobbiamo limitare il numero di variabili indipendenti potenzialmente rilevanti
studiando, ad esempio, solo le rivoluzioni sociali che si sono verificate in Europa in un certo periodo
di tempo – cioè in un contesto abbastanza uniforme dal punto di vista della struttura familiare, della
centralità del controllo della terra come fonte di potere, della tradizione religiosa di stampo giudaico-
cristiana, del passaggio all’industrializzazione in un arco definito di tempo, e così via – ma possiamo
anche aspirare al massimo a formulare proposizioni statisticamente valide.
Questa limitazione ha un’importante conseguenza: nel tentativo di limitare il numero di variabili
indipendenti potenzialmente rilevanti abbiamo drasticamente limitato il numero dei casi osservabili e
quindi abbiamo ridotto l’affidabilità delle nostre conclusioni.
3. Il ciclo della ricerca
3.1 L’oggetto della ricerca
Tutto di solito nasce da una curiosità, dalla sensazione che qualcosa “non torna”.
Da una “situazione che non torna” ci avviamo presto a considerare questi fenomeni come “problemi”
degni di essere studiati scientificamente.
Un problema è un fatto ritenuto socialmente significativo e teoricamente rilevante proprio perché
cozza con prenozioni e pregiudizi, a loro volta radicati in un corpus di conoscenza acquisito.
Data una stessa situazione problematica, scienziati sociali diversi si porranno domande diverse a
seconda della tradizione disciplinare a cui appartengono.
In altre parole, da una situazione problematica possono essere formulati numerosi problemi degni di
spiegazione scientifica.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Solo un problema che abbia una qualche significatività sociale o rilevanza teorica vale la pena di
essere posto e indagato.
Il primo passo per ogni studioso, quindi, è giustificare il quesito della propria ricerca.
A sua volta la ricerca può avere la finalità di esplorare un fenomeno fino a quel momento ignorato
oppure può avere lo scopo di affinare una teoria esistente che, nel caso del fenomeno in questione,
mostra una inaspettata debolezza.
Per partire davvero con la ricerca, occorre definire i propri concetti, cioè stabilire una correlazione
precisa e univoca tra fenomeno, significato e termine.
Ora, ciò che conta è stabilire una stretta connessione tra la domanda, la teoria che viene mobilitata al
fine di rispondere alla domanda e il caso o i casi empirici da studiare al fine di accertarsi che
effettivamente la teoria risponda alla domanda di ricerca
sollevata.
Questa relazione tra domanda (D), teoria (T) e casi empirici (C)
può essere rappresentata come un triangolo.
Delimitati dai lati del triangolo sono i metodi di indagine (M).
Normalmente, si parte dalla domanda.
Ma si può anche partire da una teoria che si vuole testare:
occorrerà allora porsi una domanda e scegliere e dei fenomeni
politici sociali o politici che rappresentano un “problema” alla
luce della teoria prescelta.
Può infine capitare che si voglia studiare uno o più casi empirici (es. dei sistemi politici o dei partiti
politici particolari): occorrerà in questo caso porsi una domanda e selezionare almeno una teoria per la
quale i casi prescelti siano effettivamente rilevanti ai fini di rispondere alla domanda di ricerca.
Insomma, da qualunque parte si voglia iniziare, domanda, teoria e casi dovranno “tenersi” tra loro.
Lo spazio della ricerca così delimitato richiederà poi l’utilizzo di metodi specifici.
Può darsi che si goda di un certo margine di scelta, altre volte i metodi di indagine da utilizzare
saranno praticamente prederminati.
Ciò che non può in nessun caso succedere è che domanda, teoria, casi e metodi vengano selezionati
indipendentemente gli uni dagli altri: il triangolo deve chiudersi e “tenere”.
3.2 Elaborazione e controllo delle ipotesi
Anche nella vita di tutti i giorni ci facciamo guidare da ragionamenti che hanno molte caratteristiche in
comune con il ciclo della ricerca scientifica.
La maggiore differenza tra le decisioni di tutti i giorni e le strategie di ricerca sta nel fatto che lo
scienziato sociale cerca in ogni passaggio di monitorare il proprio ragionamento e di evitare
accuratamente gli errori più comuni.
“Il metodo scientifico è un potenziamento del buon senso” (Isernia).
Gli errori più comuni sono:
1. La sovrageneralizzazione del risultato (concludere che quello che vale per i casi che conosciamo
valga per tutti i casi possibili);
2. Le osservazioni sbagliate, che spesso ci inducono a “vedere quello che vogliamo vedere”;
3. I ragionamenti viziati (rigettare le ipotesi che non derivano dalla nostra teoria preferita o ignorare le
conclusioni che non confermano la stessa oppure ancora trovare ordine e regolarità anche dove non ve
ne siano affatto).
Inoltre, la ricerca scientifica è risultato dello sforzo di un’intera comunità che, per poter permettere la
verifica delle ipotesi e il controllo dei risultati, deve rendere pubblici ipotesi, dati e procedure.
3.3. Le strategie di ricerca
Vi sono numerose strategie di ricerca, spesso determinate dal numero di casi a disposizione, dalla
domanda e dalla predisposizione del ricercatore.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Anche il contesto sociale, politico e culturale nel quale il ricercatore si muove può avere influenza
sulle domande che il ricercatore si pone e sulle strategie di ricerca che mette in atto per rispondervi.
Quando si indaga un fenomeno nuovo, si vorrà innanzitutto interpretarlo, cioè comprenderne le ragioni
profonde, o descriverlo e magari metterne in evidenza le caratteristiche per proporre un termine atto a
designarlo.
Quando, invece, si ha a che fare con un fenomeno già osservato, ma di cui si percepiscono
caratteristiche nuove, si vorrà esplorarne le possibili determinanti, prevedere le sue successive
manifestazioni o indicare azioni che a esso rispondano.
Muovendo invece i primi passi nella formulazione di un’ipotesi o nella verifica di una teoria, è
necessario decidere quanti casi studiare e come: dovremo cioè porci il problema se comparare o meno
e, nel caso, quanti casi comparare.
Occorre accennare ai tipi di analisi che si intendono condurre ed alle strategie che occorre adottare.
Dobbiamo innanzitutto distinguere tra analisi che mirano a spiegare un singolo fenomeno e analisi che
mirano a spiegare una classe di eventi o fenomeni.
Dobbiamo poi decidere se porci in un’ottica prospettiva o retrospettiva, se cioè ci poniamo idealmente
all’inizio della catena di eventi e ci chiediamo quali avrebbero potuto essere i risultati finali, oppure se
partiamo dall’evento finale che intendiamo spiegare e cerchiamo di identificare la sequenza che ha
portato a quello specifico risultato.
Dobbiamo infine impadronirci della terminologia e saper distinguere tra variabili “dipendenti”,
“indipendenti”, “intervenienti” e “di contesto”.
Si chiama variabile dipendente il fenomeno o l’evento che intendiamo spiegare (y).
Sono variabili indipendenti (x1, x2, x3 … xn) quelle condizioni o circostanza che, separatamente o
congiuntamente, determinano il verificarsi dell’evento o fenomeno che vogliamo spiegare.
Queste variabili saranno effettivamente indipendenti se il verificarsi dell’una è indipendente dal
verificarsi dell’altra (assenza di multicollinearità).
Saranno variabili intervenienti quelle variabili che alterano l’intensità, o addirittura il segno, delle
altre variabili indipendenti.
Saranno variabili di contesto quelle variabili che definiscono le circostanza in cui l’analisi
comparata ha luogo.
Un esempio ci aiuterà.
Parlando di “rivoluzioni”, molte teoria hanno messo in luce il ruolo delle condizioni di privazione
assoluta delle popolazioni (es. esosità del regime fiscale, assenza di libertà).
Si è cioè per molto tempo ritenuto che condizioni particolarmente insopportabili di vita dovessero di
per se stesse spingere la popolazione alla rivoluzione.
Visto che ciò non bastava a spiegare le rivoluzioni, è stata allora avanzata l’ipotesi che non fossero
tanto condizioni di privazione assoluta a spingere le popolazioni alla rivoluzione, ma condizioni di
privazione relativa.
Si è cioè notato come le rivoluzioni scoppiassero più facilmente in seguito ad un peggioramento
significativo e improvviso delle condizioni di vita o anche, paradossalmente, in seguito ad un
miglioramento delle stesse piuttosto che in seguito ad un loro graduale peggioramento.
Questa osservazione ha generato a sua volta due ipotesi ulteriori.
La prima suggerisce che non sono i cambiamenti graduali – verso il basso o verso l’alto – a suscitare
una mobilitazione rivoluzionaria, quanto improvvisi e significativi cambiamenti.
La seconda suggerisce che è il contrasto tra una situazione disperata ma considerata inevitabile a
motivare le masse all’azione dà quindi conto, in particolare, del paradosso di rivoluzioni che scoppiano
dopo un miglioramento nelle condizioni di vit.
Nemmeno questo però bastava a discriminare fra rivoluzioni che scoppiavano ma che non avevano
successo – cioè che non portavano ad un mutamento del regime, e quindi denotate come semplici
ribellioni o rivolte – e rivoluzioni che invece non avevano successo.
Tutte le variabili indipendenti identificate precedentemente venivano come condizioni necessarie – in
assenza delle quali il fenomeno non può accadere – ma non sufficienti.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Variabile interveniente fondamentale era invece la presenza di una leadership che potesse spingere e
coordinare le masse alla rivoluzione.
4. Dalle strategie di ricerca alle tecniche
4.1. Metodo comparato, metodo statistico. Metodi quantitativi e qualitativi
Il numero di variabili indipendenti potenzialmente rilevanti e il numero di casi (osservazioni) di cui si
dispone determinano il tipo di strategia di analisi da utilizzare.
Se analizziamo due o più casi in base ad una caratteristica avremo una classificazione.
Se analizziamo due o più casi in base a due caratteristiche potremo generare una tipologia.
Se analizziamo un caso in base a una o più variabili indipendenti avremo una descrizione o uno studio
di caso.
Se analizziamo due casi in base a una o più variabili avremo una descrizione binaria.
Da tre casi a tre a tre variabili indipendenti in poi dobbiamo attrezzarci per poter condurre una
comparazione rigorosa.
Se il numero delle variabili indipendenti rimane inferiore al numero dei casi di studio potremo
scegliere se utilizzare il metodo comparato (qualitativo) oppure il metodo statistico (quantitativo).
È ovvio che quanto più crescono le variabili e i casi tanto più verosimilmente dovremo utilizzare il
metodo statistico perché non potremo più gestire qualitativamente i dati.
Non sarà di fatto possibile sperare di prendere in considerazione tutte le variabili indipendenti
potenzialmente rilevanti, quindi l’ultima riga è una riga dell’impossibilità.
Non così per il numero dei casi: in moltissimi studi elettorali possiamo essere ragionevolmente certi di
contare tutti i voti o di esaminare tutte le amministrazioni comunali.
Il metodo comparato riceve il suo nome in un famoso articolo di Arend Lijphart.
Esso si basa su una selezione giudiziosa dei casi: per limitare il numero potenzialmente elevatissimo di
variabili indipendenti è possibile selezionare i casi in modo da “controllare” alcune variabili
indipendenti.
Per spiegare, ad esempio, la forza elettorale del Partito comunista in Italia nel secondo dopoguerra si
potrebbe in teoria comparare l’Italia con tutti i sistemi politici occidentali in cui c’era in quell’epoca
un partito comunista.
Poiché però le differenze geografiche, sociali, culturali e storiche fra i casi possibili sarebbero
probabilmente molte e significative e i casi insufficienti ad un’analisi quantitativa, sarà allora più
opportuno scegliere di comparare l’Italia con un paese con il quale l’Italia condivide molte
caratteristiche, ad esempio la Francia.
In questo modo, molte variabili indipendenti potenzialmente rilevanti – es. posizione geostrategica,
caratteristiche culturali, situazione sociale e persino qualche dato storico – non varieranno nei due casi
e quindi potremo sperare di isolare quelle pochissime variabili indipendenti (es. il rapporto tra Partito
comunista e Partito socialista) che possono spiegare il diverso radicamento dei due partiti comunisti.
Potremmo così spiegare questa situazione:
Y = f (X1, X2, X3, X4, X5)
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Yi = f (X1, X2, X3, X4, X5)
Yf = f (X1, X2, X3, X4, X5)
Dove Y è il radicamento del Partito comunista (e Yi e Yf sono i valori della variabile dipendente
rispettivamente in Italia e in Francia), X1 è la posizione geostrategica, X2 è la cultura cattolica, X3 è la
percentuale di popolazione attiva impiegata nell’agricoltura, X4 è la dimensione del proletariato
industriale e X5 è la forza del Partito socialista.
Grazie a questa strategia, possiamo sperare di controllare l’effetto delle prime quattro variabili di
contesto e di isolare invece l’effetto della variabile indipendente che la nostra teoria ci induce a
ritenere possa influenzare la variabile dipendente, e cioè la forza del Partito socialista.
Chiaramente, così facendo avremo indagato l’impatto di una sola variabile indipendente che ci è stata
però suggerita dalle nostre conoscenze iniziali o pre-teorie.
I risultati di questa strategia d’analisi sono significativi ma non possiamo attribuire un valore alla loro
validità.
Non sappiamo inoltre in che misura la dimensione del Partito socialista influenza il radicamento del
Partito comunista.
Arend Lijphart (1936-), olandese cresciuto accademicamente negli Stati Uniti, deve la sua fama alla
lunghissima serie di lavori sui modelli democratici.
La discussione sul metodo comparativo non può prescindere dal suo articolo del 1971 Comparative
Politics and the Comparative Method.
Se invece avessimo optato per il metodo statistico (quantitativo), avremmo dovuto studiare un
numero ben più alto di casi.
Così facendo avremmo dovuto necessariamente includere nel nostro campione sistemi politici molto
diversi tra loro e avremmo dovuto raccogliere dati su molte variabili.
Con ogni probabilità alcuni di questi dati sarebbero stati mancanti o di dubbia precisione, ma fare
affidamento su molte osservazioni avrebbe corretto e compensato la scarsa qualità dei singoli dati.
Insomma, i risultati del metodo statistico forse sono meno significativi, ma certamente più affidabili.
La differenza sta in questo: mentre il metodo comparativo genera risultati significativi, perché le nostre
conoscenze dei casi sono approfondite, il metodo statistico genera risultati affidabili, perché i dati su
cui poggiano sono molti e le procedure con cui vengono elaborati sono rigorose.
Nel primo caso, i casi di studio vengono scelti in maniera tale da controllare la maggior parte delle
variabili indipendenti, mentre nel secondo si cerca di massimizzare il numero di dati e osservazioni
disponibili.
È possibile affermare che la scienza politica contemporanea si orienta con preferenza verso i metodi
quantitativi.
4.2. Comparazione sincronica, diacronica. Studio di caso
Succede talvolta che studi molto importanti, che segnano la storia della scienza politica, si incentrino
in realtà su un unico caso.
Questi studi sono effettivamente “scientifici” solo se rispondono ad alcuni criteri.
Innanzitutto, se la teoria che intendono verificare o refutare è ben specificata.
In altre parole, si suppone che la teoria che il caso testa sia stata elaborata sulla base di un accurato
studio comparativo di tipo tradizionale.
Si tratterà, allora, di un caso critico: un caso in cui tutte le variabili indipendenti, intervenienti e di
contesto si comportano esattamente come dice la teoria.
Un’altra fattispecie di studio va per certi versi nella direzione opposta: invece di poggiare su una
teoria già bella e formata, lo studio di caso serve a ipotizzare una certa relazione tra variabili, relazione
che dovrà poi essere verificata successivamente tramite uno studio più convenzionale.
Si parla in questo caso di caso clinico.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Anche gli studi più convenzionali, che contengono osservazioni su molteplici casi, possono rispondere
ad esigenze diverse.
È possibile voler studiare come mai casi apparentemente simili mostrino invece comportamenti della
variabile dipendente divergenti dalle aspettative: si tratta in questo caso di un disegno di ricerca dei
casi più simili volto appunto a identificare comportamenti devianti inaspettati.
Al contrario, è possibile voler mostrare la presenza di un trend molto potente che attraversa sistemi
politici anche molto diversi tra loro: si opterà allora per un disegno di ricerca che coinvolga casi che,
nelle variabili indipendenti, siano il più possibile dissimili tra loro, in modo da far risaltare ancora di
più la potenza della variabile trasversale che li influenza tutti.
Un modo semplicistico ma efficace di pensare a queste diverse strategie di ricerca è immaginare che vi
siano ricercatori che amano trovare nei fenomeni politici elementi comuni (i lumpers) e ricercatori che
amano trovare differenze (gli splitters).
Quando il disegno della ricerca coinvolge lo stesso caso in momenti differenti della sua evoluzione
o storia avremo uno studio diacronico.
Gli esempi più famosi di studi diacronici appartengono per lo più ad all’ambito dello sviluppo
economico e politico.
Ad esempio, Alexander Gerschenkron ha elaborato una teoria dello sviluppo economico in base alla
quale i primi paesi a industrializzarsi hanno potuto fare affidamento su una industrializzazione
graduale finanziata con i proventi dell’agricoltura (Regno Unito, Stati Uniti); i paesi della seconda
ondata di industrializzazione, subendo già la competizione dei primi paesi industriali, hanno dovuto
mobilitare risorse più ingenti e finanziare l’industria nascente tramite prestiti bancari (Belgio, Francia,
Germania); infine i paesi di terza industrializzazione hanno dovuto superare condizioni ancora più
competitive e si sono potuti industrializzare solo grazie all’intervento dello Stato stesso (Italia, Russia,
Cina).
4.3. Le tecniche di ricerca della scienza politica
Possiamo sintetizzare gli elementi fondamentali in materia di tecniche di ricerca partendo dalla
classica distinzione tra “analisi primarie” ed “analisi secondarie” dei dati.
Quando il ricercatore ha l’opportunità di “costruire” i propri dati, ordinando le informazioni attraverso
una specifica attività di raccolta ed eventuale codifica, può condurre un’analisi primaria dei dati.
Quando invece, dovendo occuparsi di fenomeni non direttamente osservabili, sarà necessario adattarsi
ai dati esistenti, si dovrà procedere a una analisi secondaria, che verosimilmente sarà associata a
strategie di ricerca condotte su un ampio numero di casi ma sviluppata su molte variabili.
L’analisi del contesto comporta l’immersione del ricercatore nel mondo dove si esplica il
fenomeno da spiegare. Se questo ha a che vedere con comportamenti individuali o sociali, la tecnica
per eccellenza è quella della partecipazione. La partecipazione pura – che avviene quando il
ricercatore non interferisce o non è visibile agli occhi degli osservati – ricorda la dimensione
sperimentale propria delle scienze sociali. Più di frequente, tuttavia, si ha un’osservazione
partecipante, nella quale il ricercatore è riconoscibile da parte degli attori e la sua attività viene
tollerata, se non facilitata.
L’analisi dei messaggi si rifà invece al tentativo di interpretare in modo sistematico le informazioni
contenute in documenti tra loro comparabili che costituiscono l’unità di analisi di una specifica ricerca:
la dettagliata analisi di prospettiva storica della serie dei discorsi di un determinato leader, o l’esame
minuzioso di un processo dal quale è scaturita un’importante decisione di policy costituiscono due
esempi di questo tipo di tecnica.
Infine, i ricercatori possono misurarsi con l’analisi delle risposte dei soggetti indagati.
Queste sono le tecniche forse più celebrate nella scienza politica, poiché qualsiasi problema
politologico ha a che vedere con le opinioni di alcuni singoli o di interi gruppi sociali.
È evidente che più grandi sono i gruppi da sondare, più difficile sarà condurre interviste “aperte”,
ricche di stimoli creativi. Lo strumento tipico per questa situazione sarà quello del sondaggio di
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
opinione (survey), che ha avuto una vera e propria esplosione negli ultimi decenni grazie
all’introduzione di vari mezzi di comunicazione.
CAPITOLO 3 – Regime, sistema politico, Stato
1. I regimi politici
Per regime politico si intende il particolare complesso di istituzioni politiche o, meglio, l’insieme di
regole e procedure con i relativi valori o principi di riferimento.
Tal nozione costituisce uno strumento analitico generale valido a indicare un qualunque assetto
strutturale che dà forma e organizza la lotta per il potere.
Inoltre, la nozione è strettamente collegata a quella di sistema politico.
In particolare, il primo costituisce una componente cruciale del secondo – assieme alla comunità
politica e alle autorità.
In senso lato, regime è sinonimo di “ordinamento”, cioè di un insieme di norme volte a organizzare in
modo stabile e regolare qualche aspetti ritenuto rilevante della nostra esistenza.
In prima approssimazione, per regime politico intendiamo la struttura dei rapporti che legano assieme
le autorità e la comunità politica.
L’insieme di questi tre elementi (autorità, regime e comunità) costituisce per David Easton un “sistema
politico”.
Le componenti del sistema politico per David Easton
Per autorità Easton intende le “posizioni cui competono le responsabilità di governo”, cioè i ruoli
coinvolti nella produzione delle decisioni vincolanti e che, in una società avanzata, sono costituite
dalla classe politica nelle sue molteplici articolazioni (governativa, rappresentativa, partitica).
La comunità politica si riferisce al “gruppo di individui che si identificano reciprocamente sul
piano politico, ossia, si considerino come un’entità soggetta alle stesse regole fondamentali per
effettuare delle allocazioni autoritative”, o decisioni vincolanti.
Si possono distinguere due accezioni di “comunità politica”: la comunità di cittadinanza, che
rimanda al complesso di diritti civili, politici, economici e sociali di cui si avvalgono i cittadini nei
confronti delle autorità; la comunità di sentimento, che fa riferimento all’appartenenza e
all’identificazione di uomini e donne in una comune storia e tradizione, al riconoscimento reciproco e
solidaristico che individua un dato gruppo (o comunità) rispetto ad altri gruppi (o comunità).
Il concetto di regime politico riguarda il “modo in cui il potere è distribuito tra i vari ruoli e le
varie posizioni all’interno del sistema politico. Questo viene spesso chiamato ordinamento
costituzionale, e può essere fissato in un documento scritto oppure essere semplicemente il frutto di
una tradizione orale”.
In questa nozione rientrano le costituzioni e le altre istituzioni politiche (parlamento e governo) e, più
in generale, l’insieme di norme, regole e procedure volte a definire l’accesso alle cariche pubbliche e
il funzionamento del processo politico; ma anche i principi di riferimento (valori condivisi) nei quali
si riconosce una data comunità politica.
Gli elementi che contraddistinguono il regime politico sono: il territorio; l’organizzazione o “strutture
di governo”; la classe politica (inclusione, selezione, compiti); il tipo di legittimazione su cui si fonda
il sistema politico.
1.1. Il controllo della coercizione
Un regime politico costituisce una forma di potere (politico) stabilizzato, cioè un sistema strutturato di
relazioni volto a produrre decisioni e comandi al fine di modificare il comportamento altrui nella
direzione desiderata (dalle autorità o governanti).
Tale possibilità implica il ricorso, sia pure come mezzo di ultima istanza, alla forza fisica.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In termini di effettività, forza militare ed eserciti rappresentano un requisito necessario per la
sopravvivenza del regime, della comunità e delle autorità politiche.
1.2. Il territorio
I regimi territoriali sono entità territoriali l’appartenenza alle quali è definita da confini
geograficamente identificabili.
Del resto, sfogliando dei testi di diritto pubblico, è facile imbattersi nell’elenco degli elementi
costitutivi dello Stato: la sovranità, il popolo e, appunto, il territorio.
Il carattere della territorialità sembra talmente connaturato all’esistenza stessa dello Stato moderno che
oggi la deterritorializzazione, vale a dire la perdita di rilevanza dei confini verso l’esterno
(globalizzazione, europeizzazione) e/o verso l’interno (regionalizzazione, federalizzazione) viene
considerata uno dei sintomi più evidenti della crisi dello Stato occidentale.
Di seguito, ai regimi politici individuati da Finer, ne aggiungeremo uno:
1. le città-Stato (le polis), si tratta di città autonome e sovrane che controllano un territorio in genere
non molto ampio; talvolta sono organizzate in una lega di città autonome; possono essere governate
secondo modalità chiuse o gerarchiche (es. Sparta) o in forme più aperte e, per lo più, democratico-
repubblicane (es. Atene, Repubblica di Roma, comuni medievali); talvolta sviluppano sensibilmente i
loro possedimenti finendo per assumere le caratteristiche di altri tipi di regimi politici (signorie); la
formazione dello Stato moderno in Europa portò alla progressiva esautorazione di queste realtà locali;
2. gli Stati in senso stretto, che potremmo definire secondo l’uso storiografico europeo “moderni”;
Finer li distingue in Stati territoriali, nei quali esiste il controllo amministrativo (e militare) di un certo
territorio ben più ampio di quello delle città-Stato, ma che non è necessariamente accompagnato dalla
diffusione tra gli abitanti della coscienza di costituire una “comunità”, e in Stati nazionali, dove invece
è centrale la consapevolezza di far parte di una stessa comunità politica; un tale sentimento è rafforzato
dall’omogeneizzazione culturale dei sudditi sulla base di criteri linguistici, religiosi, storici;
3. gli imperi, sono caratterizzati dall’estensione territoriale su larga scala; i loro confini sono flessibili
e aperti; hanno una composizione plurale sotto il profilo culturale, etnico, linguistico, religioso, il che
spesso comporta delle asimmetrie nelle forme di cittadinanza e dei diritti; possono presentare forme di
decentramento, di autonomia territoriale e istituzionale;
4. le federazioni, costituiscono delle modalità di coesistenza e di associazione tra entità politiche
autonome e sovrane sulla base di rapporti contrattuali piuttosto che di una sottomissione imposta
dall’alto come negli imperi e negli Stati territoriali; le forme di unione tra Stati possono assumere
gradazioni diverse, dalle alleanze interstatuali alle confederazioni fino ad arrivare ai sistemi federali,
dove, pur nel rispetto dell’autonomia degli Stati membri, il processo di integrazione si è spinto molto
oltre nella costruzione di organi deputati alla produzione di decisioni vincolanti.
In questo quadro, l’Unione Europea non è più una semplice confederazione di Stati ma non è ancora
uno Stato federale o, come è stato detto, forse è semplicemente un “impero postimperiale”.
Samuel Finer (1915-1993), scienziato della politica inglese dalla profonda sensibilità storica, ha dato
un contributo notevole all’istituzionalizzazione della scienza politica britannica.
Tra le sue opere merita un’attenzione particolare The History of Government from the Earliest Time,
monumentale e originale analisi comparata delle “strutture di governo” che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità, dal 3500 a.C. ai primi del Novecento.
1.3. L’organizzazione stabile e specializzata
Un regime politico si può descrivere grazie a tre tipi di regole decisionali che ne assicurano il
funzionamento, rispettivamente relative alla:
1. distribuzione della capacità decisionale tra diverse istituzioni e attori (“forma di governo”);
2. limitazione del potere del governo e definizione dei controlli o meccanismi di equilibrio reciproco
tra istituzioni (“istituzioni di garanzia”);
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
3. distribuzione territoriale delle competenza decisionali, cioè la ripartizione dell’autorità sovrana tra
il livello statale, sub statale e sovrastatale (“forma di Stato”).
I primi due tipi di regole attengono alla cosiddetta “divisione orizzontale” dei poteri, cioè alla
ripartizione delle funzioni tra organi o istituzioni che in un dato sistema politico detengono la
sovranità, ovvero il potere autonomo e stabile di prendere decisioni vincolanti e di farle applicare.
Il terzo insieme di regole fa riferimento , invece alla “divisione verticale” dei poteri che dà alle
architetture istituzionali una configurazione più o meno centralizzate o decentralizzate rispetto alle
istanze che emanano i territori.
1.4. La legittimità
La legittimità è un elemento necessario affinché le forme di dominio si stabilizzino e durino nel tempo.
Un dato ordinamento è riconosciuto come vincolante, non solo per paura o per convenienza, ma perché
le sue decisioni sono credute giuste e quindi vengono accettate.
Monopolio della forza e legittimità danno ai regimi politici la massima capacità obbligante poiché
nessun individuo o gruppo che ricade entro la loro giurisdizione (territorio) si può sottrarre alle
decisioni prodotte dalle autorità.
Come precisa Ferrero, la legittimità serve a “umanizzare e addolcire” le relazioni tra gli individui e chi
detiene il potere politico. Solo così il rapporto altrimenti terribile tra chi domina e chi viene dominato
cessa di essere una mera imposizione.
Per Mosca la legittimità corrisponde a un reale bisogno degli uomini di obbedire ai comandi non per
mera forza ma sulla base di qualche principio morale.
Del resto, se le autorità (i governanti) poggiano le loro pretese di dominio su principi morali, riescono
a conservare in maniera più efficace l’egemonia sui subordinati.
Weber ricerca il fondamento della legittimità non tanto su un qualche tipo di evento oggettivo o forza
esterna, ma sull’“atteggiamento del soggetto legittimante rispetto al potere da legittimare”.
Le motivazioni interiori che rendono il potere accettabile per Weber sono rispettivamente: le credenze
nelle doti straordinarie del leader (legittimità carismatica); nella sacralità della tradizione e nella
deferenza verso gli interpreti autorizzati (legittimità tradizionale); nella correttezza delle procedure
formali e delle norme che regolano in modo impersonale l’accesso ai ruoli di autorità, e consenso della
maggioranza (la legittimità popolare di Finer) o nella capacità di risposta ai bisogni dei cittadini (la
legittimità eudemonistica di Gehlen).
In tutti questi casi possiamo parlare di potere legittimo o autorità.
2. La prospettiva sistemica
2.1. Le origini
In scienza politica la prospettiva sistemica diviene celebre agli inizi degli anni Cinquanta grazie a
David Easton che in quel periodo dà alla stampe il volume intitolato, appunto, The Political System.
Così, il concetto di sistema politico finisce per porre l’attenzione sulla relazioni tra elementi politici,
ovunque queste siano presenti e si sviluppino, anche al di fuori dello Stato e dei rapporti formali.
David Easton (1917-2014), nato e formatosi in Canada, si è poi trasferito negli Stati Uniti, dove ha
svolto la sua attività di ricerca e di insegnamento.
Il suo nome è legato indissolubilmente alla vicenda della rivoluzione comportamentista e all’analisi
sistemica della politica.
Per quanto oggi sia difficile parlare di “approccio” o “prospettiva” sistemica, non dobbiamo
dimenticare che le sue radici concettuali ed epistemologiche hanno lasciato tracce evidenti nel
linguaggio della scienza politica internazionale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Va ricordato che negli anni Settanta lo studioso italiano Paolo Farneti elaborò una visione originale del
sistema politico, centrata sulla sua funzione d’ordine e di mediazione dei conflitti che prendono corpo
nella società civile.
Per Easton “l’idea di un sistema politico si rivela un punto di partenza appropriato e anzi inevitabile”
di una scienza politica empirica.
Molto difficilmente la politica si può separare di netto dagli altri aspetti della vita sociale (parentela,
religione, economia, rapporti informali ecc.).
In questo modo la sfera del politico non si risolveva più nella poderosa costruzione giuridica
rappresentata dalla Stato: “al massimo il concetto di Stato è di solito niente di più che un esempio di un
particolare tipo di fenomeno politico”.
Il sistema politico per Paolo Farneti
In un sistema politico complesso come quello che si forma nel corso dello sviluppo della società
industriale e dell’avvento del potere di una borghesia prima indipendente e poi il larga parte
manageriale, si possono distinguere tre strutture portanti della realtà politica: la società civile, le
istituzioni statali e la società politica.
Per società civile si intendono i rapporti di potere di fatto – potere dell’uomo sull’uomo – per
l’appropriazione, riproduzione e distribuzione di risorse.
Rientra nella struttura della società civile anche una serie di rapporti che si contrappongono ai rapporti
di potere di fatto: sono i rapporti di intimità e solidarietà, propri della struttura familiare e associativa.
Unità intermedia tra la società civile e la società politica è la subcultura.
La società politica raccoglie tutto ciò che è espressione di volontà politica non statuale: essa si
pone come concorrente al monopolio del politico da parte dello Stato.
Le strutture della società politica corrispondono dunque a tutte le forze di aggregazione e di
mobilitazione di una volontà privata per fini collettivi, sia essa spontanea come nei movimenti di
piazza, sia essa organizzata come nei partiti politici.
Struttura intermedia tra società politica e istituzioni statali sono il parlamento e il governo.
Le istituzioni sono il complesso più eterogeneo delle tre sfere di fenomeni e di indagine che
abbiamo individuato.
Di solito, si trovano nella sfera istituzionale la burocrazia centrale e locale (ma anche la burocrazia
degli enti parastatali); la magistratura (ma anche la polizia) e, infine, l’esercito.
2.2. La dinamica del sistema politico
Prendiamo come punto di partenza una versione semplificata del sistema politico di Easton.
Un primo aspetto da sottolineare è l’esistenza di un regolare scambio o relazione tra il sistema –
concettualizzato come un scatola nera o black box – e il suo ambiente di riferimento.
Lo studioso spiega che l’ambiente di un sistema ha natura plurale, può essere biologico, geografico,
sociale ed internazionale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Da tutti questi ambienti il sistema politico riceve pressioni, shock e in senso più neutro input, ai quali
deve cercare di rispondere se vuole adattarsi e sopravvivere.
Il che avviene attraverso la produzione output (o decisioni) vincolanti.
Gli input che arrivano dall’ambiente sono di due tipi.
In primo luogo, abbiamo le domande, che sono delle rivendicazioni o richieste di assegnazioni
imperative di beni e valori.
In ogni sistema esistono varie unità di input che assolvono tale funzione di “trasmissione delle
domande” come le burocrazie, i partiti politici, i sindacati, i gruppi di interesse, l’opinione pubblica, i
mass media, i rapporti personali e finanche familiari.
Tuttavia, la funzione di espressione o di immissione delle domande nel sistema non è né scontata né
automatica.
In secondo luogo, i sistemi politici hanno bisogno di sostegni, vale a dire di “energia” che consenta
al sistema di funzionare.
Si tratta di apporti che hanno carattere materiale o che sono associati all’obbedienza che individui e
gruppi devono alle decisioni politiche.
Tale sostegno può essere specifico, quando la conformità alle decisioni è frutto dei benefici e delle
convenienze che più o meno direttamente ci si aspetta di ricavare dalle politiche pubbliche (es. un
aumento delle pensioni potrebbe produrre un maggiore consenso per il sistema da parte dei
pensionati), oppure diffuso, come forma di accumulazione originaria di credito e quindi di legittimità,
per cui indipendentemente dalla natura delle decisioni (spesso anche negative, come un aumento delle
tasse), i cittadini sentono il dovere morale o civico di accettarne le conseguenze e, quindi, si
conformano.
[Il sostegno, fornisce legittimità al ruolo del governo. Il sostegno può essere specifico quando deriva
da risposte positive del sistema alle domande della società; è invece sostegno diffuso (a lungo
termine) quando si riferisce a un generale senso di consenso verso il governo al potere].
Come Easton ha fatto notare, esiste una famiglia di domande, chiamate within-input, che provengono
dall’interno dello stesso sistema e che arrivano direttamente dai leader, partiti e istituzioni.
Cosa sono le norme sul finanziamento dei partiti o sulla legge elettorale, se non richieste dove si assiste
all’identificazione tra decisori e destinatari delle decisioni?
Il che spiega perché in questi ambiti è piuttosto difficile realizzare delle riforme.
Del resto, se le intraimmissioni diventano eccessive, aumenta il rischio di autoreferenzialità della classe
politica, che così finirebbe per comportarsi come una casta di privilegiati.
Inoltre, non tutte le domande riescono ad accedere al sistema, essendo la loro trasmissione regolata da
alcuni meccanismi di filtraggio e selezione noti come gatekeepers (letteralmente “portieri”), indicati
dall’area in grigio nella figura.
Tali meccanismi manipolano le domande, bloccano quelle pericolose o innovative, ne riducono il
volume quando cresce oltre le capacità di risposta del sistema e, quindi, controllano il rischio di
sovraccarico (overload) che caratterizza i sistemi politici, specie se democratici.
Si potrebbe sostenere che i sistemi democratici presentano domande facili e risposte difficili.
Per contro, i sistemi autoritari hanno risposte facili, perché imposte autoritariamente dal leader o dalla
sua coalizione dominante e senza badare alle reazioni dal basso, e domande difficili, poiché non c’è
pluralismo e libertà di opinione che permettono ai cittadini di esprimere le loro preferenze e di
contestare apertamente i governanti e le loro scelte.
2.3. Conversione e funzioni di processo
La dinamica di un sistema politico implica una relazione tra domande conversione risposte
con il relativo feed-back, cioè l’effetto ritorno per cui le risposte inevitabilmente finiscono per incidere
sulle condizioni che hanno alimentato le domande, ad esempio tacitandole, spostando l’interesse dei
cittadini e delle stesse unità di input (es. i partiti, raggiunto un certo obiettivo, si possono dedicare ad
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
altro), favorendone una radicalizzazione quando non sono prese in considerazione o lo sono solo in
maniera apparente.
Si pone ora il problema di cosa accade dentro la black box, vale a dire nella fase di conversione delle
domande in risposte.
Soffermiamoci sul lavoro di Almond e Powell, nel quale il processo di conversione viene spacchettato
in quattro funzioni che a loro volta determinano altrettante fasi o subprocessi del sistema politico.
Articolazione degli interessi
Il processo politico è messo in moto quando gruppi o individui formulano una “domanda” politica che
ha a che fare con i loro interessi, bisogni, preoccupazioni, e la indirizzano al sistema politico.
L’analisi dell’articolazione degli interessi e della trasmissione della domanda richiede la ricostruzione
di due aspetti:
1. le caratteristiche delle strutture politiche coinvolte, a partite dalla distinzione tra “strutture a-
specifiche” (partiti, burocrazie, militari) e “strutture specializzate” quali i gruppi di interesse;
2. i diversi canali di accesso al sistema politico (legali e illegali).
Aggregazione degli interessi
Ogni sistema politico deve in qualche modo cercare di aggregare le domande che riceve.
L’aggregazione implica la formulazione di programmi e di politiche generali attraverso le quali gli
interessi vengono presi in considerazione, sono combinati, resi coerenti e armonizzati.
L’espletamento di tale funzione richiede la mobilitazione di risorse politiche (voti, maggioranze
parlamentari, consenso di gruppi di interesse, ricorso o minaccia di ricorso alla forza) e, quindi, la
costruzione di coalizioni a sostegno dell’aggregazione.
Centrali nell’espletamento di questa funzione sono i partiti politici.
Esistono tre stili di aggregazione che corrispondevano ad altrettanti tipi di partito:
1. la negoziazione, basata su compromessi e flessibilità (partiti pragmatici);
2. il riferimento a valori assoluti che comporta l’affermazione di principi rigidi (partiti ideologici);
3. la tradizione dove prevale la rappresentanza di interessi settoriali o territoriali (partiti
particolaristici).
Formulazione delle politiche pubbliche o “produzione delle norme”
In questa fase le domande vengono propriamente convertite in decisioni dotate di autorità e ciò implica
la mobilitazione del consenso (quanto meno della maggioranza e spesso anche dell’opinione pubblica)
e il paziente lavoro di costruzione di coalizioni attorno a particolari temi o policy (es. ambiente,
welfare, relazioni internazionali).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Almond e Powell individuano quattro categorie di output:
1. estrattivi, appropriazione di risorse di qualche tipo proveniente dall’ambiente esterno, tassazione,
ma anche nella forma di servizi obbligatori (es. servizio militare) e che nelle forme più estreme di
un’occupazione militare di un territorio possono assumere la forma del bottino e della spoliazione;
2. regolativi, controllo-sanzione dei comportamenti di individui e gruppi nella società;
3. distributivi, allocazione a individui e gruppi, su basi universali o particolaristiche, di denaro, beni
materiali, servizi, cariche pubbliche, status e opportunità;
4. simbolici, volti a rafforzare la legittimità del sistema politico e le identificazioni dei cittadini;
comprendono discorsi politici, rituali e cerimonie, feste civili, iconografia politica.
Esecuzione e amministrazione giudiziaria delle politiche
Una volta formulate, le politiche devono essere attuate, il che avviene di norma seguendo due canali:
da un lato, quello burocratico, il che implica l’applicazione e messa in opera delle decisioni da parte
delle burocrazie pubbliche; dall’altro, quello giudiziario, che ha a che fare con la funzione di
amministrazione della giustizia e di regolazione dei conflitti a opera della magistratura.
In entrambi i casi, si pongono dei problemi circa la natura del rapporto tra burocrazia/magistratura e la
politica.
Anzi, la prospettiva sistemica vede il rapporto tra questi attori non in termini dicotomici, ma come un
continuo in cui prevalgono interdipendenze e invasioni di campo.
In sostanza, né le burocrazie pubbliche né tanto meno le magistrature possono essere viste come
semplici “bocche della legge”.
Dalla contingenza di questi rapporti derivano due rischi patologici per qualunque sistema politico,
tanto più se democratico: la politicizzazione della burocrazia e dei giudici e, per converso, la
burocratizzazione e giudizializzazione della politica.
3. Lo Stato
3.1. Tra idealtipi e realtà multiformi
Lo Stato – che siamo soliti accompagnare con la definizione di moderno – come lo conosciamo in
Europa costituisce solo una delle possibile forme di regime politico.
Si deve a Machiavelli, già nell’incipit de Il Principe (1513), il merito di aver fissato e volgarizzato il
significato moderno della parola “Stato”.
Come sottolinea Poggi, per quanto sia possibile e legittimo applicare il termine “Stato” alle “polity che
erano esistite in contesti premoderni”, è corretto assumere che il termine “Stato” sia “più
appropriatamente usato per designare le polity caratteristiche dell’ambiente politico moderno, il quale
venne alla luce in Europa occidentale alla fine del Medioevo, approssimativamente tra il XIII e il XV
secolo”.
In questo senso, le due espressioni di “Stato” e “Stato moderno” finiscono per essere equivalenti.
Da parte sua, Finer afferma che “contrariamente a quanti molti ritengono, l’Europa non ha inventato
lo Stato. L’Europa lo ha reinventato dopo un lungo periodo in cui al crollo (dell’Impero romano) era
seguita una condizione di quasi anarchia e successivamente di feudalesimo. Tuttavia, il risultato della
reinvenzione era per molti aspetti diverso da qualunque altra forma-Stato apparsa in precedenza.
Questa forma-Stato è diventata adesso l’unità fondamentale di tutto il mondo”.
A partire dalla culla (europea e occidentale), questo oggetto si sarebbe “globalizzato”, propagandosi nel
resto del mondo.
La questione terminologica, però, non può essere disgiunta da un problema metodologico che risalta
con forza quando si prova a definire lo Stato e il suo processo di sviluppo.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Lo sforzo di ricavare delle generalizzazioni valide da una ricostruzione storica che abbraccia svariati
secoli e che riguarda tutto il globo, a partire dalla culla originaria europea, pone notevoli problemi di
concettualizzazione e comparazione.
Ad esempio, è indubbio che la “territorialità” costituisca un carattere determinante dello Stato
europeo, il che implica il controllori un territorio possibilmente contiguo – a parte le colonie.
Questa, in effetti, è una “invenzione” europea.
Tuttavia, non è l’unico tipo di Stato possibile (es. theatre state, Stato spettacolo).
Le nostre generalizzazioni attorno al concetto di “Stato” sono sempre parziali e, pertanto, vanno prese
con estrema cautela.
Inoltre, non solo esistono una molteplicità di traiettorie di sviluppo e di percorsi distinti, ma sono
sempre possibili delle eccezioni, dei ritardi nello sviluppo, come delle regressioni (la costruzione dello
Stato può fallire).
D’altra parte, le nostre società sono quasi inconcepibili se non si tiene conto del fatto che si sono
strutturate come “Stati” o, meglio, “Stati-nazione” o “Stati-nazionali”.
È questa la tesi dello Stato come container, come contenitore del complesso delle relazioni sociali,
economiche e culturali che si svolgono in un dato territorio.
Per di più, molti autori hanno visto nello Stato una potente e macroscopica forza di civilizzazione della
società e di strutturazione della stessa mentalità degli individui.
3.2. La formazione dello Stato territoriale
I tratti necessari senza i quali non si ha un regime-Stato sono:
1. il monopolio della violenza legittima;
2. la territorialità, che riguarda il processo di costruzione dei confini entro i quali ha effettività il
controllo della coercizione;
3. la sovranità, che implica di “non riconoscere alcun potere superiore a se stesso”;
4. i rapporti con la popolazione, che attengono al grado di partecipazione dei cittadini/sudditi e alla
loro omogeneità culturale e identità;
5. un ambiente costituito da una pluralità di Stati sovrani indipendenti, con la conseguenza che
l’ordine internazionale o, meglio, interstatale si presenta fin dall’origine non regolato, né regolabile,
poiché si sviluppa “all’ombra della guerra”; l’unico fattore di ordine sulla ribalta internazionale non
poteva che essere l’equilibrio di potenza.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Tutti questi caratteri (idealtipici) sarebbero stati acquisiti in paesi coma la Spagna, l’Inghilterra e la
Francia già nel corso delle prime fasi del processo storico di costruzione dello Stato (State-building),
che Poggi definisce di consolidamento territoriale.
Tale espressione, però, comporta anche qualcosa in più oltre all’acquisizione dei tratti originari.
Da un lato, implica la neutralizzazione e sottomissione al sovrano dei “contropoteri” costituiti dalla
Chiesa, dai nobili e dal sistema cetuale, dalle città autonome e dalle magistrature indipendenti.
Dall’altro, la “nascita di strutture posizionali di dominio (o apparati di dominio) che si formano
attorno alla posizione centrale di un signore”.
Questo macroprocesso non è stato lineare e, in gran parte, non è stato neanche un processo
intenzionale, ma piuttosto il sottoprodotto della lotta per la sopravvivenza tra élite che ha dato luogo al
“circuito estrattivo-coercitivo” (tassazione-guerra) con la conseguente formazione di apparati
amministrativi fiscali, militari e civili al servizio dei sovrani.
Tale costruzione, comunque, non è solo un’impresa militare e amministrativa ma ha anche una
dimensione culturale e simbolica manifestata nel “distacco dell’ordinamento politico dalla sua
caratterizzazione religioso-spirituale”.
La formazione dello Stato produsse una formidabile spinta alla secolarizzazione della società, alla
sostituzione della legittimazione trascendente e spirituale dei regimi politici con una legittimazione
immanente e funzionale.
La formazione degli apparati amministrativi specializzati non si esaurisce in questa prima e lunga fase,
ma caratterizza anche la seconda fase di sviluppo dello Stato, che Poggi chiama di razionalizzazione
del dominio.
Questa costituisce un macroprocesso che ha avuto inizio grosso modo nello stesso periodo in cui si
sono fissati gli aspetti militari dello Stato moderno, per inoltrarsi molto oltre, fino al XIX e ai primi
anni del XX secolo.
È proprio nel corso di questa fase che si definiscono pienamente l’insieme di elementi accessori che
vanno dalla razionalità tecnica della burocrazia, alla giuridicizzazione o sottoposizione al diritto
dell’azione statale.
Militari, burocrati e magistrati sono in questo processo i principali alleati del sovrano, ma allo stesso
tempo possono tramutarsi in avversari nella lotta per il potere e il privilegio.
Sul versante esterno del rapporto con la società, lo Stato moderno creò le condizioni che avrebbero
consentito la formazione e lo sviluppo di istituzioni economiche competitive ed efficaci in grado di
alimentare la ricchezza della comunità.
Ciò richiese la garanzia della legge e dell’ordine pubblico, il rispetto dei diritti di proprietà e dei
contratti, la costruzione di infrastrutture (opere pubbliche) e di servizi pubblici.
In breve, la costruzione del mercato.
Secondo Bartolini, è proprio questa particolare idea di “integrazione” tra diversi tipi di rapporti sociali
e, in particolare, economici che differenzia lo Stato moderno europeo da qualunque altro tipo di regime
politico che lo ha preceduto.
3.3. La costruzione della nazione e la democratizzazione originaria
Gli aspetti e le dinamiche che caratterizzano le prime due fasi di sviluppo dello Stato – consolidamento
e razionalizzazione – avrebbero avuto ulteriori e significativi sviluppi nella terza fase che sempre con
Poggi possiamo chiamare di espansione.
Tale stadio implica la sovrapposizione tra la costruzione della nazione, la democrazia rappresentativa e
lo Stato del benessere.
Il che ha come conseguenza la crescita delle funzioni di cui lo Stato si fa carico e l’espansione degli
apparati amministrativi.
Per quanto questa terza fase sia più circoscritta rispetto alle precedenti – si potrebbe farla iniziare con
la fine del XVIII e la metà del XIX secolo per farla terminare con la metà del secolo successivo – è
quella che ha dato maggiore impronta al panorama politico contemporaneo.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Non si deve pensare, però, che ci troviamo di fronte ad un susseguirsi meccanico di stadi idealtipici: le
vicende che hanno caratterizzato lo sviluppo dello Stato moderno sono il frutto dei percorsi storici
complicati, prodotti da conflitti tra periferie e centri, tra classi e gruppi sociali, e che sovente hanno
visto la partecipazione della gente comune.
La storia politica dell’Europa che ha fatto seguito all’età delle rivoluzioni liberali (XVII-XVIII secolo)
può essere riassunta nel progressivo ampliamento delle chance di partecipazione alla vita politica di
gruppi sociali e classi prima escluse.
Quella che è stata chiamata la “seconda venuta della democrazia” dopo l’esperienza originaria greca
presuppone dei processi di lunga durata che hanno reso gli individui politicamente attivi,
trasformandoli da sudditi in cittadini.
In realtà, il processo che avrebbe condotto alle prime democratizzazioni, si sovrappone e si intreccia,
specialmente in Francia e nell’Europa continentale, con il processo di costruzione della nazione.
Soffermiamoci su due ricostruzioni teoriche riguardanti le “prime democratizzazioni”.
La prima è quella di Charles Tilly, che prende in esame i processi di democratizzazione in Europa,
così come quelli di de democratizzazione, lungo l’arco temporale che va dal 1650 al 2000.
Per Tilly la realizzazione della democrazia consiste nell’instaurarsi di una relazione (orizzontale e
aperta) tra autorità e cittadini che comporta “uno spostamento complessivo verso una consultazione [o
competizione] più ampia, uguale, protetta e vincolante”.
Le forme e i risultati di tale macroprocesso dipendono anche dalla “capacità dello Stato di mettere in
pratica le decisioni politiche che assume” o, più semplicemente, dalla “capacità di governo”.
Ne consegue che se è vero che gli Stati forti sono di ostacolo alla democratizzazione nel breve periodo,
nel lungo ne favoriscono l’instaurazione e la stabilità; per converso, gli Stati deboli possono ricevere
dei contraccolpi disgreganti dalla democratizzazione.
Inoltre, nel lungo periodo, gli Stati con elevata capacità di governo e che hanno sviluppato istituzioni
inclusive e responsabili (democrazia rappresentativa) avrebbero mostrato un maggiore sviluppo
economico e sociale.
Per Robert Dahl, le democrazie di massa sono contraddistinte dalla capacità di “rispondere” alle
preferenze espresse dai cittadini considerati politicamente uguali.
Storicamente, questa capacità è il frutto di due subprocessi.
Il primo è la liberalizzazione o libertà di contestazione, che si riferisce al grado in cui in un regime
vengono affettivamente garantiti il diritto di opposizione, la pubblica critica e la competizione aperta
per il governo tra le forze politiche diverse e rilevanti.
Ciò richiede il riconoscimento di quell’insieme di libertà personali, diritti civili che rientrano nella
nozione di “cittadinanza civile”.
Nella misura in cui questi diritti vengono estesi a porzioni sempre più ampie della popolazione,
subentra il secondo processo di inclusione o partecipazione, vale a dire l’estensione della porzione di
popolazione che è legalmente titolare dei diritti politici, la “cittadinanza politica”.
4. Trasformazioni e sfide dello stato contemporaneo
4.1. Una quarta fase nello sviluppo dello Stato?
Molti studiosi preferiscono etichettare la situazione in cui oggi versano le istituzioni pubbliche crisi
dello Stato, per alcuni si tratterebbe di una vera e propria quarta fase.
Questa fase può assumere non solo le forme familiari, per noi europei e occidentali, dell’“eccesso dello
Stato”, ma anche quelle più esotiche della “carenza dello Stato”.
In entrambi i casi, comunque, la sopravvivenza dello Stato deriverebbe tanto dalla sua legittimità che
dalla sua efficacia.
Vale a dire, sia dalla base di giustificazione morale e dai principi che consentono di accettare le sue
decisioni, che dalla qualità delle sue performance nel risolvere i problemi collettivi e nel fornire beni
pubblici agli individui e gruppi che vivono entro i suoi confini.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4.2. Crisi per eccesso di Stato
Innanzitutto, non va dimenticato che la forma più esasperata di eccesso dello Stato ha riguardato la
politicizzazione integrale della società civile a opera dei “sistemi totalitari”.
La crisi storica dei totalitarismi di destra, con la fine della Seconda guerra mondiale, e di sinistra, con il
crollo del Muro di Berlino, ha gettato le premesse per delle successive ondate di democratizzazione.
Qui, però, ci interessa soffermarci sulla situazione di eccesso dello Stato democratico nell’ultimo
trentennio – a partire dalla cosiddetta “rivolta fiscale”.
La questione dell’eccesso di Stato è stata affrontata esplorando il tema della ingovernabilità dei sistemi
politico-amministrativi.
L’ingovernabilità è stata vista come l’esito non intenzionale del pluralismo e della facilità di accesso
dei gruppi sociali opportunistici alle sedi delle decisioni imperative – al fine di condizionarne il
contenuto – quale conseguenza del gigantismo dello Stato contemporaneo e del conseguente
sovraccarico di funzioni.
Pertanto, per questi autori, la “debolezza” delle istituzioni statali va ricercata nelle conseguenze della
scarsa autonomia dello Stato rispetto all’ambiente sociale o nel deficit di capacità amministrativa e
fiscale, frutto del moltiplicarsi senza tregua delle funzioni pubbliche.
D’altra parte, lo sviluppo della globalizzazione economica e finanziaria, la crescente complessità dei
problemi collettivi (es. temi ambientali) e lo sviluppo diseguale e squilibrato a livello mondiale (con le
conseguenze che alimenta in termini di migrazione transnazionale e di rischi endemici di conflitti) sono
questioni che assai difficilmente lo Stato è in grado di fronteggiare con efficacia da solo.
Una delle conseguenze di questo nuovo scenario mondiale è stata la riduzione della responsabilità
politica degli Stati, il che si verifica in tre direzioni distinte ma convergenti negli esiti di indebolimento
dello Stato così come lo abbiamo conosciuto:
1. quella della tecnocrazia, ovvero la devoluzione di poteri e responsabilità ad apparati ed istituzioni
non elettive, le cosiddette “istituzioni non maggioritarie”, che decidono sulla base di criteri tecnici e
non politici (quanto meno non democratici) – Banche centrali, istituzioni monetarie e finanziarie
internazionali, burocrazie professionali;
2. quella della cosiddetta multi-level governance, le formazioni statali diventano semplicemente dei
livelli in una struttura più ampia nella quale si sviluppano interdipendenze istituzionali tra entità
sovrastatali (es. Unione Europea) e substatali (es. regioni, enti territoriali) volte a produrre politiche
codecise;
3. quella della ri-mercificazione, per cui sempre maggiori servizi e funzioni vengono sottratti al
controllo pubblico-statuale e devoluti al mercato attraverso le privatizzazioni.
4.3. Crisi per carenza di Stato
Alcune delle dimensioni che possono provocare un deficit di statualità sono la crisi del monopolio della
forza, la perdita dei confini, l’eterogeneità della comunità politica.
4.4. Perdita del monopolio della forza legittima
Ciò che distingue i regimi politici non è tanto la forma di governo ma il loro grado di governo.
Non la forma, ma la forza.
Si pensi alla classificazione dei regimi statali sulla base del rischio della loro dissoluzione: Stati dissolti
(collapsed states), falliti (failed states), in via di fallimento (failing states) e deboli (weak states).
Secondo l’indice degli Stati falliti stilato da Found for Peace nel 2013, che riguarda la valutazione di
178 paesi, lungo una scala che varia da 120 (massima allerta e rischio di collasso) a 0 (massima
sostenibilità dello Stato), i paesi con più elevato rischio sono caratterizzati da: pressione demografica;
massicci flussi di rifugiati; vendette tribali o private; squilibri economici e povertà; corruzione e
delegittimazione dello Stato; deterioramento dei servizi pubblici essenziali; violazioni dei diritti umani
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
e ricorso arbitrario alla violenza; perdita di controllo della forza da parte degli apparati di sicurezza;
interferenza di attori sovranazionali.
I casi estremi della graduatoria, con un punteggio medio di 112, sono la Somalia, il Congo e il Sudan.
Paesi quali l’Iraq e l’Afghanistan, negli anni scorsi in situazioni altrettanto critiche, presentano un lieve
miglioramento.
Per contro, i paesi con gli Stati più sostenibili sono la Finlandia e la Svezia, con punteggi intorno a 19.
L’Italia compare al 147° posto su 178 paesi.
Tale ranking, o altri simili, non risolvono però la questione della concettualizzazione.
Potremmo dire che mentre il fallimento si può definire funzionalmente “come l’incapacità dello Stato
di esercitare il suo ruolo principale, ossia monopolizzare l’uso legittimo della forza all’interno del suo
territorio”, il collasso (o dissoluzione) va considerato istituzionalmente e indica il “tracollo
dell’organizzazione statale e la sua sostituzione da parte di enti privati o subnazionali”.
Quest’ultimo è il caso di quei paesi controllati dai cosiddetti “signori della guerra” quali la Somalia, il
Sudan o l’Afghanistan – si pensi anche al Ghana, Ciad, Sierra Leone, Libano, Haiti – dove milizie e
gruppi privati finiscono per sostituirsi al controllo esclusivo e legittimo da parte di funzionari e
apparati riconosciuto come legittimi da tutte le parti in campo.
In tutti questi casi l’organizzazione statale sperimenta un vuoto di autorità e lo Stato si riduce a una
“mera espressione geografica, un buco nero nel quale un sistema politico è caduto”.
La questione del fallimento può riguardare anche le performance dello Stato su specifiche porzioni di
territorio come nel caso della Colombia o del Venezuela dove si è parlato di “regimi autoritari locali”,
cioè di porzioni territorio dove il rispetto dei diritti umani e la presenza dello Stato è inesistente.
Una situazione di questo tipo, però, si potrebbe verificare anche nelle società occidentali, quando lo
Stato perde il controllo del territorio a favore di gruppi criminali: si pensi ad ampie zone del Meridione
o ai quartieri di grandi città come Scampia o Secondigliano a Napoli o lo Zen a Palermo.
4.5. Deterritorializzazione e perdita di rilevanza dei confini
La globalizzazione ha messo in evidenza le forze volte alla “trascendenza dei confini”.
Questo, ad esempio, si è verificato con lo sviluppo dell’economia e del sistema capitalistico, sia nella
loro componente produttiva che finanziaria.
Ma anche con il processo di europeizzazione, con il trasferimento volontario da parte degli Stati
tradizionali di porzioni significative si sovranità a uno “strano” attore sovranazionale (l’Unione
Europea).
Se lo Stato moderno era caratterizzato dai processi di confinamento e di saturazione dei territori, lo
Stato del XXI secolo è invece alle prese con il processo inverso di deterritorializzazione, di perdita dei
confini, il che equivale a dire perdita di sovranità, ora verso l’alto ora verso il basso.
4.6. Incongruenza tra Stato e nazione
I regimi del XXI secolo, tanto le democrazie mature quanto le neodemocrazie non pienamente
consolidate, mostrano svariate incongruenze tra Stato e nazione.
Tali incoerenze e contraddizioni sono il riflesso della sovrapposizione di fenomeni distinti legati ai
processi di globalizzazione.
Il primo, riguarda l’avvento degli Stati-multinazionali o delle cosiddette nazioni-Stato.
Il secondo è relativo alle ricadute dei massicci flussi migratori che attraversano il globo (dai paesi più
poveri ai paesi più ricchi) sul grado di eterogeneità delle comunità politiche.
Per di più, sia la sfida del multiculturalismo sia quella dell’immigrazione sono destinate a crescere di
intensità in futuro.
Da qui la centralità dei cosiddetti regimi della tolleranza, cioè della questione della convivenza delle
diversità e delle soluzioni istituzionali appropriate a tale scopo.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Linz individua quattro modi di ricombinare demos e nazione, cioè di conciliare costruzione dello Stato
e della nazione.
Tipo I: regimi mononazionali.
Ricordano l’idealtipo dello Stato moderno; nella situazione odierna, l’identificazione del demos con la
nazione può condurre all’espulsione degli alieni “o, quanto, meno, all’incoraggiamento sistematico a
seguire l’opzione exit”.
Tipo II: regimi etnici.
Si accetta la differenziazione tra demos e nazione, il che getta le premesse per una cittadinanza
asimmetrica, poiché alle minoranze residenti nel territorio si riconoscono i diritti civili e sociali, ma
non quelli politici. Ciò non esclude che i gruppi minoritari si possano in qualche modo organizzare e
talvolta anche mobilitare per rivendicare diritti e per denunciare le loro condizioni di vita.
Tipo III: regimi assimilatori.
In questo caso assistiamo a “uno sforzo massimo per integrare le minoranze nella cultura nazionale
mentre a esse non annette alcuno status speciale o alcun diritto culturale”.
Le minoranza, del resto, hanno come obiettivo principale il raggiungimento, magari nello spazio di
qualche generazione, della piena integrazione.
Le “società di immigrati” come gli Stati Uniti e la Francia rientrerebbero in queste fattispecie.
Tipo IV: regimi multinazionali.
In questo caso ci troviamo nel quadro di una soluzione inclusiva delle minoranze, e “ciò comporta
l’accettazione di una società pluralistica nella quale la diversità non è considerata diversamente. Ci
sono molti modi in cui riconoscere diritti collettivi e individuali, il bilinguismo nelle scuole o negli
uffici pubblici, i diritti delle comunità religiose. In alcuni casi, la democrazia consensuale e il
federalismo possono creare le premesse di un Stato plurinazionale democratico basato sulla lealtà nei
suoi confronti, senza che ciò comporti una integrazione nazionale: avremo così una nazione-Stato
piuttosto che uno Stato-nazione”.
Tuttavia, non si deve credere che queste soluzioni riguardino solo l’attualità: i grandi imperi del
passato, da quello austroungarico a quello ottomano e ancora quello romano sono tutti regimi
etnicamente e culturalmente plurali.
Se l’enfasi sulle situazioni del tipo I rende difficili gli sviluppi democratici (rischia di diventare una
democrazia razziale come il Sudafrica dell’apartheid prima degli anni Novanta), il tipo III appare
difficile da realizzare in presenza di gruppi minoritari che rifiutano di essere integrati, mentre le
strategie di tipo II “sono un ripiego” che può aprire la strada alle soluzioni multiculturali del tipo IV.
Anche Dahl arriva alla conclusione che oggi “nella maggior parte dei casi è il multiculturalismo a
rappresentare l’alternativa possibile” alla stretta coincidenza tra popolo e nazione.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 4 – Modelli democratici e regimi antagonisti
1. Il significato della democrazia nella storia
1.1. Dimensioni e definizioni
Il significato della nozione di “democrazia” non è stato sempre lo stesso: secondo Aristotele, la
democrazia era quel sistema di governo che garantiva l’accesso a un numero di soggetti più vasto
possibile, ma costituiva una forma corrotta, perché orientata al soddisfacimento del bene dei soli
governanti e non della collettività.
La forma benefica del governo di molti era dunque la politeia, il cui significato etimologico è più
vicino al concetto di res-publica che oggi riferiamo alla forma di Stato (repubblicana vs. monarchica)
ma che è tornato in modo ricorrente nella teoria politica per etichettare un preciso modello normativo
di democrazia.
L’evoluzione storica della nozione di “democrazia” ha attraversato una vera e propria mutazione della
società e della politica.
Se la democrazia classica (comunemente denominata “ateniese”, per sottolineare la dimensione
ridotta e urbana della sua tipica comunità) rappresentava l’avvento di quel principio di legittimità per
cui i “cittadini” devono godere di uguali diritti politici che consentono loro di governare ed essere nel
contempo governati, lo sviluppo di un sistema più complesso di principi si deve alle varianti di quel
repubblicanesimo che nei secoli ha connotato il pensiero democratico.
Ma, questi principi, sono oggi parte di una sorta di “archeologia democratica”.
Al contrario, il regime che, per quanto assai imperfetto e discusso, oggi celebriamo come vincente, è
connesso alla nozione di democrazia liberale, sviluppatasi all’indomani delle grandi rivoluzioni
nazionali del XVIII e XIX secolo.
La democrazia liberale trova fin dalle sue prime formulazioni una sostanziale ambivalenza tra una
versione protettiva ed una di sviluppo.
La democrazia protettiva promuove il culto della libertà individuale nato nelle prime monarchie
costituzionali europee (Regno Unito e Olanda su tutti) e poi riadattato dai padri della Costituzione
americana, all’indomani della prima grande rivoluzione liberale, quella del 1776, che aveva portato
all’indipendenza degli Stati Uniti.
La democrazia di sviluppo insiste invece sulla concreta difesa dei diritti degli individui.
Di tutti gli individui.
Lo Stato rimane “minimo”, come da tradizione liberale, ma capace di garantire effettiva tutela dei
diritti e politiche orientate alla rimozione degli ostacoli per la libertà individuale.
Il modello liberale, in sostanza, costituisce il Dna della nostra democrazia, il minimo comune
denominatore di quelle che possiamo definire le applicazioni contemporanee dello schema
democratico.
È evidente come esistano una pluralità di alternative democratiche, e cosa in concreto della significare
questa nozione rimane una questione fortemente divisa.
Definizione 1. La democrazia è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al
quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il
voto popolare (Schumpeter).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Definizione 2. La democrazia è un regime politico caratterizzato dalla continua capacità di risposta
(responsiveness) del governo alle preferenze dei suoi cittadini, considerati politicamente uguali (Dahl).
La prima definizione, inserita nel noto lavoro di Schumpeter, solitamente associato alla fondazione
di una concezione elitistica della democrazia, enfatizza due elementi: il forte collegamento tra
inclinazione democratica e presupposti della competizione elettorale, e l’inevitabile delega a una classe
politica chiamata, tra una elezione e l’altra, a esercitare un potere di fatto non bilanciabile in alcun
modo dall’azione della “gente comune”.
La seconda definizione, frutto dell’operazionalizzazione di Dahl, coglie la dinamica di
trasformazione della democrazia contemporanea, focalizzando le garanzie della permanenza e
dell’effettività di quella libertà di scelta che formalmente distacca il cittadino di una comunità
democratica rispetto al suddito di un qualsiasi regime illiberale.
Joseph A. Schumpeter (1883-1950). L’economista austriaco, trapiantato negli Stati Uniti negli anni
Trenta, è autore di scritti fondamentali su sviluppo e ciclo economico, ma la sua notorietà è assai più
ampia rispetto alla disciplina madre; gli scienziati sociali impegnati nello studio della democrazia
liberale lo considerano un riferimento obbligato.
Per gli studiosi empirici della democrazia, l’elemento forse più rilevante è la critica schumpeteriana
all’enfasi partecipatoria della democrazia del popolo, a favore di una forte concezione elitistica
incentrata sulla competizione aperta tra leader.
Si è soliti far risalire a Schumpeter il modello della democrazia procedurale.
Per sviluppare un’analisi autenticamente comparata non si può prescindere dall’esplicitazione di tutti
quegli elementi operativi che giudichiamo necessari per catalogare come democratico un dato regime.
Naturalmente, può essere riscontrata una miriade di definizioni empiriche della democrazia.
Ci limitiamo a sintetizzare il dibattito con la definizione empirica di “regime democratico” ricostruita
proprio da Dahl:
Il regime democratico è un regime che presenta a) un suffragio universale maschile e femminile
effettivamente esercitato tramite b) elezioni libere, competitive, ricorrenti, corrette; c) più di un partito
e d) diverse e alternate fonti di informazione.
1.2. Varianti ed effetti della prima democratizzazione
La prima fase di democratizzazione degli attuali sistemi politici ha rappresentato uno degli eventi
globali più rilevanti nella storia umana.
Tuttavia, tale fenomeno deve essere distinto dai processi di democratizzazione avvenuti
successivamente nelle realtà che già avevano conosciuto un’esperienza democratica, evidentemente
rientrata o fallita.
La sociologia storica ha prodotto fondamentali contributi per spiegare la predisposizione di alcuni
sistemi politici “precoci” nei loro processi di democratizzazione.
Barrington Moore ha fornito un’accurata ricostruzione dei macrofattori capaci di spiegare tali processi:
l’equilibrio tra gli “Stati” (nel senso di ceti) dell’antico regime che bilancia e rende moderna la
monarchia, l’indebolimento dell’aristocrazia a vantaggio della borghesia, l’avvento della tecnologia
mercantilistica come metodo per lo sviluppo di un’economia industriale, e infine la presenza di afflati
rivoluzionari come quelli che condussero a eventi violenti o comunque “di rottura” rappresentati dalla
Rivoluzione gloriosa nel Regno Unito e successivamente dalle rivoluzioni francese e americana.
Altri contributi, di taglio esplicitamente comparato, hanno aiutato a comprendere la variabilità del
fenomeno.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il lavoro di Dahl è ancora un riferimento irrinunciabile, per classificare i diversi risultati dei processi di
formazione delle protodemocrazie (poliarchie) del primo Novecento.
Negli stessi anni, un altro capostipite della moderna politica comparata, il norvegese Stein Rokkan,
mise a fuoco la sequenza di circostanze storiche che hanno caratterizzato la ricorrenza del processo di
democratizzazione: Rokkan definì tale sequenza attraverso il superamento di quattro soglie:
1. legittimazione, ovvero l’effettivo riconoscimento delle libertà;
2. incorporazione, ovvero l’espansione della cittadinanza politica:
3. rappresentanza, ovvero l’allargamento del circuito elettorale e istituzionale a tutti i tipi di partito,
espressione del nuovo pluralismo sociale;
4. democratizzazione del potere esecutivo, ovvero la fissazione delle regole che ancorano l’esistenza
di un governo legittimo ad un organico principio di scelta elettorale.
Lo studio di Rokkan sulle modalità di accesso a queste soglie, da parte dei vari paesi europei,
disegnava una mappa storica assai precisa dei percorsi di democratizzazione.
Il Regno Unito, ad esempio, aveva mostrato il superamento precoce delle prime due soglie, mentre le
nazioni late-comer sullo scenario europeo avevano mostrato dei processi più lenti.
La Germania offriva un esempio di ritardo nel superamento della soglia di legittimazione, a cui
Bismarck aveva posto rimedio con l’espansione improvvisa dei diritti politici, durante il Secondo
Reich.
Analogamente, anche le ultime due soglie avevano evidenziato differenze nette tra i paesi europei: le
garanzie della rappresentanza si risolvevano in larga parte dei paesi continentali con la concessione di
qualche tipo di sistema elettorale proporzionale che avrebbe favorito la presenza istituzionale dei
nascenti partiti di massa e protetto il pluralismo.
La soglia del potere esecutivo appannaggio anche delle vecchie “opposizioni” metteva anch’essa in
evidenza la maggiore reattività dei sistemi della fascia dei sistemi politici “nordici” (Regno Unito,
Belgio, Norvegia) rispetto all’Europa continentale.
2. Mutamento dei regimi e dinamiche di democratizzazione
2.1. Mancato consolidamento e crisi democratica nella prima metà del XX secolo
Il processo di prima democratizzazione ha presentato una estrema variabilità, non solo nei tempi ma
anche negli esiti.
Leonardo Morlino ha dimostrato che le possibilità di stabilizzazione di questi regimi sono affidate ad
un delicato equilibrio tra i soggetti e i meccanismi protagonisti del consolidamento democratico.
Questo concetto è definito come il processo di formazione delle strutture democratiche nei suoi
caratteri essenziali (es. garanzie per una competizione libera) e di adattamento di quelli secondari (es.
diverse possibili modalità nei rapporti tra i gruppi sociali).
In realtà, non si tratta di un processo lineare, né facilmente prevedibile.
Nei primi vent’anni del XX secolo gran parte dei paesi europei aveva sperimentato un processo di
democratizzazione.
L’unica parziale eccezione è rappresentata dal caso russo, passato direttamente da un regime ancora
arcaico (nonostante la sperimentazione dell’istituzione rappresentativa della Duma e le tardive riforme
orientate a liberalizzazioni e inclusione sociale) alla dittatura del proletariato nella versione leninista,
che aprì la strada al totalitarismo staliniano.
Nei regimi europei di stampo “liberale”, invece, il destino del consolidamento democratico ha portato a
due esiti opposti: continuità democratica o crollo della democrazia.
Sappiamo, ad esempio, che il caso italiano ha purtroppo offerto un esempio di crollo della democrazia:
vale la pena allora utilizzare il racconto della crisi dell’Italia liberale per applicare le teorie costruite
dai politologi comparatisti per spiegare i diversi modelli di mutamento nei regimi a seguito della prima
democratizzazione.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Possiamo riconoscere nelle vicende italiane tra il 1918 e l’avvento del fascismo esempi lampanti dei
fenomeni indicati da Linz nel suo lavoro fondamentale sulla caduta dei regimi democratici.
In primo luogo, il venir meno di una “coalizione dominante”: fenomeno evidente nell’Italia postbellica
con la riduzione dell’area dei liberali (peraltro molto divisi al loro interno) e con la frattura tra lo stesso
establishment “ministeriale” e i due partiti di massa che avevano ottenuto grande successo nelle
elezioni del 1919: i popolari di Sturzo e i socialisti (a loro volta divisi tra riformisti e massimalisti).
In secondo luogo, è presente una radicalizzazione del conflitto che in Italia si esplicitò con le lotte del
“biennio rosso” e con una polarizzazione sociale senza precedenti, che dette origini a manifestazioni di
inaudita violenza.
Infine, bisogna ricordare la ricollocazione degli attori socioistiutuzionali cruciali per il destino della
democrazia.
È fuori dubbio che il comportamento accondiscendente della monarchia e lo stesso atteggiamento della
chiesa costituirono due perni per l’avvento non illegale di un ordine fascista che non aveva certo,
all’inizio della transizione italiana degli anni Venti, un seguito popolare molto forte.
2.2. L’ancoraggio democratico e il problema della stabilità
Alla fase della legittimazione segue una più complessa serie di meccanismi che Morlino ha denominato
ancoraggio democratico, e che si connota con l’emergere di una serie di strutture istituzionali e sociali
in grado di stabilizzare il processo di acquisizione dei valori democratici.
Le ancore tipiche nel processo di consolidamento sono:
1. lo sviluppo di una serie di partiti e soggetti politici all’interno di un sistema sufficientemente
robusto da non lasciare spazio a nuovi cambiamenti rivoluzionari;
2. l’assestamento di un sistema pluralistico costruito su rapporti stabili tra i partiti stessi e gli interessi
organizzati;
3. lo sviluppo di un sistematico ma limitato numero di rapporti clientelari che unisca i cittadini ad
alcuni degli assetti politici partitici in cambio di limitate erogazione di risorse pubbliche;
4. lo sviluppo di una serie di accordi triangolari (imprenditori, sindacati, Stato) che consentano la
stabilizzazione del regime trovando soluzione in ampi e cruciali settori del policy making attraverso le
pratiche neocorporative.
Evidentemente, l’ancoraggio democratico può essere relativamente “leggero” laddove le condizioni
storiche e politiche della democratizzazione non comportano problemi di rigetto per la coalizione
dominante.
Dunque, la teoria dell’ancoraggio postula una correlazione inversa tra numero e “consistenza” delle
ancora e grado di legittimità già goduto da un sistema democratico nel momento della sua nascita.
2.3. La rinascita democratica e le ondate di democratizzazione
I lavori pubblicati da Samuel P. Huntington a partire dalla metà degli anni Ottanta hanno fatto il punto
sul successo della democrazie nei regimi contemporanei, avanzando alcune spiegazioni circa la natura
e la tempistica delle ondate che hanno caratterizzato l’allargamento dell’area interessata a questo
fenomeno.
Samuel P Huntington (1927-2008), professore a Harvard e alla Columbia University, consigliere
politico del presidente Carter, è stato uno dei più noti studiosi dei fenomeni di democratizzazione.
I suoi scritti, ed in particolare quelli sulla democratizzazione del tardo XX secolo, confluiti in La terza
ondata (1991), restano un riferimento obbligato per quanti studiano la dinamica democratica.
Tali ondate possono essere riassunte come nel prossimo schema:
Prima ondata: il periodo interessato a questa ondata è compreso nei cento anni che vanno dai
primi moti democratici degli anni Venti del XIX secolo alla Grande depressione.
Si tratta della trasformazione democratica collegata alla modernizzazione e alla rivoluzione
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
industriale, che ha interessato praticamente tutto l’emisfero nordoccidentale, sia pure con tempi
differenti, diversi casi di crisi e periodi di riflusso.
Seconda ondata: collocata nel periodo compreso tra il 1943 e il 1962, questa ondata si sarebbe
collegata essenzialmente a fattori di ordine politico e militare, e quindi alla trasformazione di una
serie di paesi (principalmente paesi europei, ma anche latinoamericani ed ex colonie) con la fine di
una serie di esperienza dittatoriali ed autoritarie.
Terza ondata: iniziò nel 1974, durante la fase delicata di riorganizzazione su scala globale delle
democrazie, impegnate allora a superare la crisi fiscale attraverso la globalizzazione economica e il
consolidamento di varie organizzazioni sovranazionali.
A seguito di questa ondata, molti regimi del terzo e quarto mondo, legati proprio ai processi di
globalizzazione, avrebbero aperto una nuova prospettiva democratica, portando appunto il numero
delle democrazie a un livello mai raggiunto prima.
In questa ondata ha giocato un ruolo fondamentale il crollo dei regimi comunisti legati all’ex Unione
Sovietica, molti dei quali hanno attraversato un rapido processo di nuova democratizzazione.
Secondo Huntington, la terza ondata di transizione alla democrazia avrebbe avuto una matrice
completamente diversa dalle precedenti, essendo il risultato di cinque forme di mutamento economico,
sociale e culturale (occorse singolarmente oppure in combinazione tra loro):
1. la crisi di legittimazione dei regimi autoritari, anche in virtù di fallimentari politiche pubbliche;
2. una crescita economica globale senza precedenti;
3. il nuovo ruolo della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II;
4. il cambiamento della politica estera di alcuni attori, a cominciare dagli Stati Uniti, ma anche da
parte dell’allora Comunità europea;
5. il ruolo dei media nel processo di condivisione globale da parte dell’opinione pubblica.
In quegli anni si discuteva la tesi certamente riduttiva ma di estremo fascino che faceva riferimento al
concetto di fine della storia con cui Francis Fukuyama aveva descritto la superiorità del modello della
democrazia di mercato.
Huntington non negava l’impatto che la fine delle ideologie “concorrenti” aveva comportato, ma
denunciava, al cospetto delle tesi sulla superiorità del modello democratico occidentale, un nuovo forte
motivo di tensione legato alla dimensione culturale.
Su questo terreno, ovvero sulla distanza tra culture più o meno compatibili con il modello democratico,
lo scienziato politico americano immaginava l’avvento di un nuovo scenario mondiale, caratterizzato
da uno scontro di civiltà.
Egli teorizzava l’incompatibilità democratica e perfino la maggiore inclinazione alla violenza di alcune
civiltà alternative a quella occidentale, in primis quella islamica.
2.4. Quante democrazie? La situazione attuale
Secondo Freedom House, una delle think tanks che si occupano della misurazione e del monitoraggio
del livello democratico dei regimi contemporanei, sono oltre cento i paesi che negli ultimi quindici
anni hanno garantito una performance democratica accettabile.
Freedom House misura in realtà una delle condizioni fondamentali della democrazia, che possiamo
definire “libertà complessiva”, attraverso due indici, che coprono rispettivamente l’estensione dei
diritti civili e l’estensione dei diritti politici.
La diffusione democratica sembra oggi essere definitivamente consolidata nel “vecchio” emisfero
occidentale, ovvero l’Europa e il continente americano, nonostante la persistenza di regimi semiliberi
nell’America Latina.
Il cammino della democratizzazione sembra avviato anche negli altri continenti, ma il numero dei
regimi semiliberi rimane predominante, così come resiste una fascia di regimi non liberi che attraversa
l’intera Africa subsahariana per arrivare all’Estremo Oriente, dove la Cina rimane probabilmente il
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
regime più interessante da studiare in questa fase storica, viste le contraddizioni di un sistema che ha
mescolato elementi di totalitarismo comunista con la penetrazione del libero mercato.
Ampie critiche sono state sollevate nei confronti della logica di misurazione di Freedom House, i cui
dati sono tuttavia utili in una presentazione semplificata.
3. Le democrazie contemporanee
3.1. Le tipologie democratiche
La scienza politica non si è limitata a spiegare i processi di democratizzazione, ma si è interrogata sui
modi per perfezionare la democrazia e renderla più stabile e più vicina alle aspettative della gente.
Un problema ricorrente è stato quello di capire se l’intervento all’interno di un dato paese, attraverso
riforme strutturali di diverso ordine, potesse cambiare la funzionalità se non addirittura il rendimento di
una democrazia.
Ad esempio, si è a lungo discusso sui benefici dell’introduzione di un sistema elettorale proporzionale
o di un maggiore potere nelle mani del leader dell’esecutivo, o del ricorso a forme di “devoluzione”
subnazionale con la rinuncia di parte della sovranità del governo centrale.
Con il procedere di una già significativa storia della democrazia, sia pure relativamente breve e
limitata sotto il profilo geografico, l’analisi comparativa dei regimi poliarchici è diventata più precisa.
Le domande che si sono posti gli studiosi che hanno osservato le democrazie consolidate in una chiava
comparata sono innumerevoli.
Possiamo classificare tali problemi su tre diversi livelli di investigazione: questioni cognitive, tese cioè
a chiarire l’estensione empirica di un fenomeno come la democrazia contemporanea; interpretative,
finalizzate a stabilire precisi nessi causali alla base delle diverse affermazioni di un tale fenomeno;
normative, orientate cioè a prescrivere una specifica modalità del fenomeno, giudicata come
preferibile.
Interrogativo cognitivo: una volta raggiunto un soddisfacente accordo sulla definizione delle
garanzie democratiche, in quali e in quanti modi si possono applicare tali principi e, in ultima analisi,
quanto sono dissimili tra loro i modelli democratici, guardando al funzionamento delle istituzioni e
alle concrete realizzazioni dei principi teorici di inclusività dei cittadini, partecipazione ai processi
decisionali e responsabilizzazione dei detentori del potere nei confronti di tutti i soggetti associati alla
cosa pubblica?
Interrogativo interpretativo: posta la nostra capacità di distinguere tra diversi tipi di regime
democratico, quali sono i fattori che spiegano il consolidamento di un determinato modello o
perlomeno la tendenza di un dato regime ad avvicinare in modo più marcato i connotati di un tipo
ideale rispetto a un altro?
Interrogativo normativo: esiste un modello di democrazia che risulta più desiderabile e, sulla base
di evidenze inconfutabili, più capace di esprimere elevate performance rispetto alle finalità essenziali
della democrazia stessa?
Le varianti democratiche studiate nel corso del primo Novecento enfatizzavano essenzialmente le
differenze tra i sistemi di governo e nei canali di legittimazione dell’esecutivo.
Successivamente, l’attenzione si è spostata su un tema di grande successo come l’emergere di possibili
forme di democrazia diretta rispetto alle comuni forme di democrazia rappresentativa.
In realtà, la natura rappresentativa della democrazia non è mai stata messa in dubbio, rimanendo gli
strumenti della democrazia diretta (in particolare il referendum) essenzialmente degli elementi
complementari nell’architettura dei regimi poliarchici contemporanei.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Soltanto alcune visioni radicalmente antagonistiche alla democrazia occidentale, come il socialismo e,
soprattutto, il comunismo hanno promosso la nozione di “democrazia diretta”, ma non hanno poi
prodotto esempi concreti di regime capaci di rispettare i criteri e le aspettative della democrazie.
Tale discussione è stata tuttavia fondamentale per mostrare il bisogno continuo di “democrazia dal
basso”.
A seguito dello sviluppo della rivoluzione comportamentistica e della rinascita dell’approccio empirico
allo studio della politica, fu possibile, a partire dagli anni Sessanta, sviluppare più profonde riflessioni
sulla diversa natura dei vari regimi democratici.
Gabriel Almond, tra i fondatori della moderna politica comparata, aveva ragionato sulla differenza tra i
sistemi democratici sulle due rive dell’Atlantico, utilizzando il livello di omogeneità della cultura
politica come principale fattore esplicativo.
Ma lo studioso che da allora ha
incessantemente approfondito
questo aspetto è senza dubbio
l’olandese Arend Lijphart,
mettendo a fuoco il modello
consociativo di democrazia, al
fine di spiegare la tendenza di
alcuni sistemi dell’Europa
continentale creare le condizioni
di un governo “allargato” con
maggioranze
sovradimensionate, coalizioni
ideologicamente complesse e
svariati meccanismi di “contrappeso costituzionale” rispetto al governo maggioritario, espressione del
vincitore elettorale.
La prima tipologia di Lijphart si basava su due dimensioni di analisi: la configurazione della società
(culturalmente omogenea oppure eterogenea) e i rapporti tra le élite (consensuali oppure
prevalentemente conflittuali).
La tipica democrazia consociativa, di cui l’Olanda costituiva un esempio empirico paradigmatico,
rappresenta l’incrocio tra una cultura politica tendenzialmente eterogenea ed élite orientate al
compromesso, capaci dunque di generare un equilibrio impossibile nel caso di democrazie
centrifughe, connotate da cultura eterogenea ed élite conflittuali.
3.2. Democrazia maggioritaria e democrazia consensuale
Nel volume Le democrazie contemporanee (1984), Lijphart lanciava una proposta più forte, con una
tipologia nuova e, soprattutto, la proposta di una ricerca sistematica su tutte le democrazie rilevanti.
La proposta si basava sui due modelli polari, denominati, rispettivamente, modello maggioritario e
modello consensuale di democrazia, che venivano discussi prima sul piano teorico, attraverso la
creazione di due dimensioni (“partiti/esecutivo” e “natura unitaria/federale dello Stato”), e poi
scandagliati attraverso una serie di dati empirici, le cui distribuzioni spingevano l’autore a confermare
la bontà dei due idealtipi e la tendenza delle democrazie a variare le proprie caratteristiche in modo
coerente con essi.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Oltre a fornire un’affascinante mappa delle democrazie contemporanee, Lijphart rilanciava con forza la
tesi del migliore rendimento complessivo di un modello “più gentile” di democrazia come quello
consensuale, capace appunto di offrire politiche più confacenti sotto il profilo del rispetto dei diritti e
dell’inclusività, senza peraltro perdere terreno a vantaggio delle democrazie maggioritarie sul piano
delle politiche economiche.
La netta propensione dell’autore per il tipo consensuale è stata fortemente criticata, ma gran parte della
riflessione sulla variabilità democratica nell’ultimo ventennio si è appoggiata su questa fondamentale
ricerca.
3.3. La visione economica e razionale della democrazia
Dai tempi dell’illuminista Condorcet è noto il paradosso che porta il suo nome, per cui un gruppo
composto da tre decisori razionali non mostra necessariamente un set di preferenze ordinate in quanto
collettività.
A questo paradosso si ricollega il teorema della im(possibilità) di Keneth Arrow, che mostra come in
ogni processo decisionale, al fine di superare l’impossibilità di creare un’unica funzione del benessere
sociale attraverso l’aggregazione delle preferenze individuali, può essere necessario sacrificare una
delle condizioni teoriche della democrazia.
Nella formalizzazione di Arrow, tali condizioni sono la non dittatorialità, l’ammissibilità universale di
ogni tipo di preferenza, l’ottimalità paretiana ed infine l’indipendenza di alternative irrilevanti.
Uscendo dalla terminologia formale, la garanzia di un’aggregazione certa delle preferenze individuali,
e quindi la formazione di una vera maggioranza, può avvenire, in sostanza, rendendo un individuo più
importante degli altri nel processo, oppure limitando le preferenze degli attori in gioco (es. facendo
scegliere in un ballottaggio la meno peggiore tra due opzioni già scartate da un elettore), oppure
rinunciando a degli esiti stabili in un dato processo decisionale, determinando costi talvolta elevati da
pagare in futuro.
Rimanendo sul piano teorico, la visione della democrazia contemporanea, derivata dagli strumenti
dell’analisi economica e appoggiatasi all’idea di “razionalità” dei decisori, conobbe nel secondo
dopoguerra un’importante filiera di studi.
Anthony Downs arguiva che le preferenze politiche aggregate in un contesto competitivo (e quindi
democratico) sono funzione della capacità degli elettori/consumatori di ordinare le proprie preferenze
massimizzando razionalmente la propria utilità individuale.
Ovviamente, innumerevoli sono le ricadute sul piano dell’applicazione empirica discese dall’immagine
di un mercato elettorale composto dall’insieme delle preferenze individuali, a partire da concetti oggi
familiari a molti cittadini come voto utile o voto strategico.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4. I regimi antagonisti e l’area grigia della quasi democrazia
4.1. I modelli del passato
Conoscere le alternative alla democrazia significa capire i limiti della proposta democratica,
immaginare le eredità che le esperienze non democratiche, spesso lunghe, lasciano ai rispettivi sistemi
politici, e in qualche misura esorcizzare i rischi di crisi e crollo della democrazia stessa, una volta che
essa è stata ristabilita.
È necessario operare delle differenziazioni tra le varie “non democrazie”.
Una prima fondamentale distinzione riguarda i regimi del passato.
Si tratta di regimi che non hanno a che vedere con le vicende della democrazia moderna, perché
preesistevano alla modernizzazione o al massimo hanno convissuto parallelamente alle prime forme di
democratizzazione.
Solitamente, la letteratura distingue tra i regimi tradizionali, che presentano la sopravvivenza di
antiche forme di governance predemocratica, e i primi regimi non democratici moderni, nati appunto
dall’epoca della democratizzazione di massa per ridurne o annullarne la portata rivoluzionaria.
Tra i regimi tradizionali spiccano gli ultimi retaggi storici delle monarchie assolute o i cosiddetti
regimi sultanici.
Tra i regimi non democratici di stampo moderno possiamo invece far rientrare alcuni ben noti esempi
che caratterizzarono in Europa la fase di transizione verso le poliarchie: il Secondo Reich dell’epoca
bismarchiana, caso interessante di oligarchia competitiva può costituire un eccellente esempio.
4.2. I regimi non democratici recenti: autoritarismi e totalitarismi
Veniamo ai regimi democratici della fase storica più recente.
Secondo Juan Linz una generica ma fondamentale distinzione da fare è quella tra regimi autoritari e
regimi totalitari.
Juan J. Linz (1926-2013), studioso europeo, trasferitosi negli Stati Uniti, fu professore alla Columbia
University e a Yale, ma non dimenticò mai le proprie origini, indagando a fondo i regimi europei e
contribuendo in modo cruciale alla rinascita della scienza politica in Spagna e in Europa.
Il suo principale terreno di studi fu quello della crisi democratica.
I regimi autoritari sono sistemi con pluralismo politico limitato e non responsabile, senza un’elaborata
ideologia-guida, ma con mentalità caratteristiche, senza mobilitazione politica estesa o intensa, se non
occasionalmente, e con un leader o un piccolo gruppo dirigente che esercita il potere entro limiti
formalmente mal definiti ma abbastanza prevedibili nella realtà.
La definizione può essere applicata, ad esempio, alla Spagna di Franco (1939-1975).
Certamente si è trattato di una dittatura, che tuttavia non condivideva fino in fondo la condizione
ideologia di un totalitarismo come quello messo in piedi da un alleato come la Germania hitleriana.
Questa natura non ideologia era legata alla persistenza di un limitatissimo pluralismo composto da
attori preesistenti al regime (i militari, da cui Franco proveniva, gli ambienti della monarchia, i
potentati economici che finanziarono la falange franchista).
Il leader del nuovo regime fu senza dubbio cruciale, con il suo carisma, nella fase di instaurazione
seguita alla sanguinaria guerra civile, ma è indubbio che egli fu affiancato da un limitato gruppo di
detentori del potere centrale.
A differenza dei regimi totalitari, i leader dei regimi autoritari non rispondono ad una organizzazione
ferrea che funge da vestale ideologica e giustifica l’uso estremo del potere e della violenza, ma
piuttosto a una serie di mentalità caratteristiche, ad esempio il mito della patria o quello della famiglia,
e anche quel quieto vivere in cui si rifugiò proprio la Spagna franchista dopo la guerra civile,
sopravvivendo da paese neutrale al conflitto bellico.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il regime totalitario è un sistema caratterizzato da monismo politico, ruolo indiscusso del partito unico,
ideologia codificata, articolata e finalizzata alla realizzazione di un programma di politicizzazione della
società, continue azioni di concreta mobilitazione sociale con persecuzione sistematica di ogni attore
non rispondente al programma, uso indiscriminato della violenza repressiva e limiti non prevedibili
rispetto all’uso del potere gestito dal partito e dal gruppo dirigente in nome del leader stesso.
Tale definizione può essere applicata alla Germania nazista e all’Unione Sovietica del periodo
staliniano.
Esistono delle differenze tra le due versioni: il totalitarismo nazista si appoggiava ad un’ideologia
tipicamente nazionalista, mentre quello staliniano muoveva, teoricamente, dai principi di un’ideologia
internazionalistica.
La soppressione del pluralismo si muove nel nazismo in una retorica di accentuazione del leaderismo,
mentre la retorica comunista enfatizza la missione egalitaria dell’ideologia dominante.
I rapporti nelle élite dominanti pure alcune differenze, come l’elogio dell’organizzazione paramilitare
nel nazismo, e quello della burocrazia di partito nel caso dell’Unione Sovietica.
Il razzismo nazista è un elemento ideologico cruciale, che condurrà a politiche aberranti, mentre la
violenza di massa nell’Urss staliniana si giustificava essenzialmente con operazioni di “controllo
sociale”.
Infine, il rapporto con la religione è significativamente diverso, propugnando il nazismo una sorta di
“religione civile” intrisa di elementi esoterici, mentre il regime comunista era essenzialmente ateo.
Ma che dire di un regime come quello fascista?
Il problema è delicato perché, da un lato, il fascismo si autodefiniva totalitario e rappresentò per molti
versi il modello sperimentale per la costruzione del nazismo.
Tuttavia, guardando a elementi come la persistenza di un limitato pluralismo (si pensi alla persistenza
del ruolo di attori sociali come proprietà agraria, gerarchie militari e in qualche misura anche la Chiesa
romana), alla centralità relativa del partito unico e alla prevalenza di messaggi patriottici rispetto a
quelli ideologici, il fascismo sembra più assomigliare ad un autoritarismo che non a un totalitarismo.
Merita ricordare la presenza di varie forme di autoritarismo di mobilitazione: accanto a quello
fascista troviamo dei regimi che utilizzarono tale strumento per rimanere agganciati ad un ideale
rivoluzionario e continuare a costruire consenso.
Rientrano in questa galassia di regimi le democrazie popolari che si richiamavano più o meno
direttamente all’Unione Sovietica (e specialmente quelle che dal totalitarismo prendevano la maniacale
cura per il culto della leaders, ad es. la Romania di Ceausescu), i regimi nazionalisti africano costruiti
sull’ideologia della negritudine e anche il regime di rivoluzione religiosa che caratterizzò gli anni del
potere di Khomeini in Iran.
Tra i regimi civili-militari sono emerse varie forme: ad esempio gli autoritarismi nei quali le forti
componenti militari hanno contribuito solo in parte a formare la cerchia del leader (come i regimi
parafascisti instauratisi in Spagna e Portogallo negli anni Venti e Trenta); oppure gli autoritarismi
“populistici”, basati sul carisma di un establishment rivoluzionario più che sulla portata ideologia (es. il
castrismo a Cuba); quelli che hanno lentamente costruito un partito-Stato la cui leadership era
sostanzialmente sovrapposta all’esercito.
Dovremmo citare al riguardo il caso di Saddam Hussein: politico “promosso” in un secondo tempo
come capo militare, capace di costruire un unico corpo di fedelissimi che univano il partito, l’esercito e
in qualche misura anche la cerchia della propria parentela.
Il confine con un tipo di confine che è stato definito “neosultanistico” qui è molto vicino, come è
abbastanza facile confondere il regime esercito-partito con un sottotipo dei regimi militari puri, ovvero
quello del militare “governante”.
Tuttavia, in quest’ultimo caso la componente militare risulta al centro dell’azione di rovesciamento
dell’ordine preesistente con varie forme – es. il golpe o alzamiento – come nella tradizione
latinoamericana.
Statisticamente, tuttavia, gli studiosi hanno rilevato che i militari protagonisti dell’interruzione
democratica sono stati generalmente più propensi a rimanere in una dimensione non centralissima nella
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
fase matura del regime, fenomeno che porta alla costituzione di oligarchie militari presenti come
guardiani se non come mediatori nei ruoli di potere.
Si può dunque concludere che, paradossalmente, mentre alcuni regimi civili-militari o anche civili di
mobilitazione tendono a militarizzare la figura del leader o dei loro uomini forti (si pensi a Mussolini, o
ad un caso più recente come Saddam Hussein), per dare continuità alla propria azione i regimi militari
puri, nel tentativo di depoliticizzare la società, cercano di ridimensionare la visibilità dei propri leader,
finendo per proiettarne un’immagine quotidiana e talvolta non militare.
4.3. I regimi autoritari di oggi. La storia si ripete?
A seguito della “terza ondata di democratizzazione” abbiamo assistito negli ultimi due decenni ad una
nuova “infornata” di regimi dai profili nuovi, che, peraltro, in molte aree del mondo si sono instaurati
in comunità politiche diverse dagli Stati-nazione originari, oppure in regioni dotate sì da una propria
identità, ma inglobati per decenni in sistemi politici più vasti: le repubbliche caucasiche, la Bielorussia
e l’Ucraina sono forse tra gli esempi più noti di questa difficile transizione.
Gli esiti dell’ultima fase di espansione democratica rimangono promettenti, ma l’evoluzione storica
recente ha reso le condizioni per la realizzazione di processi robusti di democratizzazione molto dure e
complesse.
Alcune delle configurazioni tipiche delle fasi di transizione occorse già nel XX secolo sono: la pseudo-
democrazia, regime pluralista fantoccio in realtà ancora completamente sotto il controllo della
coalizione di attori protagonisti dell’esperienza autoritaria; la democrazia protetta – forma transitoria
in senso stretto – nella quale la liberalizzazione non è ancora sostenuta da un processo elettorale
adeguato; la democrazia elettorale, dove avviene sostanzialmente il contrario, ovvero una
competizione già aperta ma in assenza di adeguate riforme relative ai diritti civili.
La questione dell’area grigia o, se vogliamo, l’incertezza sull’effettivo successo della prospettiva
democratica va molto al di là del novero dei sistemi politici nei quali erano già apparsi dei regimi di
transizione.
La continua alterazione e la variabilità presentata nel mondo arabo è forse l’esempio più nitido di
questa fase di fluidità.
Se da un lato gli ultimi decenni hanno testimoniato la capacità di persistenza di forme autoritarie come
la teocrazia iraniana o quella presente in Arabia Saudita, le note vicende che hanno connotato l’area
nordafricana dopo le recenti primavere arabe non hanno dispiegato prospettive solide di
democratizzazione.
Analogamente, in ampie zone dell’Asia il livello di democrazia acquisito da molti regimi semiliberi
continua a oscillare pericolosamente.
Il modello che ha da ultimo ha preso piede nella letteratura comparata – quello di regime ibrido – deve
essere distinto concettualmente rispetto alla vecchia nozione di regime di transizione, proprio per
l’incertezza sulla sua dinamica di medio periodo.
Come è evidente, la partita della democrazia è ancora tutt’altro che vinta, e non soltanto per la capacità
di persistenza dei regimi antagonisti.
La sfida democratica continua a giocarsi anche all’interno delle democrazie stesse, contro un
complesso di questioni che mettono a rischio la solidità dei regimi più giovani e anche la
legittimazione di quelli più vecchi e consolidati.
Tali questioni vengono rappresentate da fenomeni, connessi l’uno con l’altro ma capaci di indicare le
tante sfumature del disagio democratico: disillusione, alienazione, sfiducia (nelle istituzioni, nella
classe politica, ecc.) egoismo, fino al sentimento antipolitico che può diventare antidemocratico.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 5 – Partiti, elezioni e sistemi di partito
1. Che cosa sono i partiti e che cosa fanno
1.1. I partiti politici nell’accezione contemporanea
Per un verso, i partiti sono considerati indispensabili alla nascita e al funzionamento della democrazie,
per l’altro sono considerati tra le istituzioni più screditate del nostro tempo, almeno agli occhi dei
cittadini.
Agenti di rappresentanza delle domande e degli interessi presenti nella società, ma anche i “cavalli di
Troia” che hanno permesso alla corruzione e allo spirito fazioso di diffondersi oltre modo nelle nostre
democrazie.
Da un certo punto di vista i partiti politici moderni sono visti come costitutivi della stessa esperienza
democratica: le nostre democrazie rappresentative sarebbero inimmaginabili senza i partiti.
Talvolta, però, si prende atto che il loro ruolo è profondamene mutato.
Essi non esperiscono più le tradizionali funzioni di mobilitazione e integrazione sociale, di
socializzazione politica e di rappresentanza.
Per contro, sarebbero quasi esclusivamente impegnati – e per contrappeso con maggiore intensità e
veemenza di prima – a reclutare il personale politico, a garantire il funzionamento delle istituzioni, a
controllare le risorse pubbliche e a cercare di influenzare le politiche pubbliche.
Minimi e deboli in input sul versante della società, sono ancora massimi e forti in output, sul versante
dello Stato – specie in termini di withinput.
Già negli anni Cinquanta Maurice Duverger aveva evidenziato, interrogandosi sulla loro nascita a
cavallo delle grandi rivoluzioni politiche ed economiche che avevano trasformato il volto dell’Europa
nel corso del XVIII secolo, che nel tempo si erano succedute diverse definizioni di partito, da quelle
incentrate sull’ideologia (il partito-dottrina della tradizione liberale), sulla base sociale (il partito
classe della tradizione marxista) e, infine, sulla struttura (il partito-organizzazione socialista).
Maurice Duverger (1917-) ha dato un contributo fondamentale allo studio scientifico dei partiti.
Impegnato da sempre nel dibattito sulle riforme costituzionali, ha avuto una breve esperienza politica
come europarlamentare, eletto (nel 1989) non nel proprio paese ma in Italia (come indipendente nelle
liste del Partito comunista).
Ma c’è di più. I partiti politici, specie nel contesto dei moderni regimi democratico-rappresentativi, non
potevano essere ricondotti esclusivamente a questi ambiti.
Un ulteriore componente andava esplicitata: la qualità dei rapporti (competiti e/o cooperativi) che ogni
partito intrattiene con gli altri.
Così, a partire dal secondo dopoguerra, si sono sviluppate le definizioni di partito-squadra o team di
leader che concorrono per il voto popolare.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Un’immagine, questa, strettamente associata con la visione competitiva della democrazia.
Quest’ultima prospettiva ci ricorda che ciò che contraddistingue le democrazie è l’esistenza di una
pluralità di partiti liberi di competere, con mezzi pacifici e legali, per il controllo del potere politico.
Democrazia e competizione sono strettamente associate.
La definizione dal quale prendiamo le mosse deriva proprio dalla prospettiva competitiva, ed è quella
di Giovanni Sartori.
Un partito è un qualsiasi gruppo politico identificato da un’etichetta ufficiale che si presenta alle
elezioni, ed è capace di collocare attraverso le elezioni candidati alle cariche pubbliche.
Questa definizione, ci dice l’autore, è minima, poiché punta l’attenzione sulle caratteristiche necessarie
di un partito, innanzitutto la competizione per i voti popolari.
Per il resto, proprio perché minima, essa ci dice poco o nulla circa altri aspetti.
Comunque sia, tale definizione costituisce un utile strumento per distinguere i partiti da altri tipi di
organizzazioni o gruppi che tali non sono.
Negli ultimi due decenni, in molte democrazie vecchie e nuove, appaiono soggetti politici che si
presentano alle elezioni e che lottano per l’assegnazione delle cariche pubbliche, rifiutando l’etichetta
di “partiti”: movimenti, leghe, unioni, alleanze.
Il criterio di Sartori ci dice che se tali neoformazioni, anche qualora dovessero rifiutare l’appellativo di
partiti, avessero successo alle elezioni e riuscissero a conquistare posizioni di autorità in parlamento e
nel governo, allora sarebbero da considerare senz’altro partiti politici.
Un possibile passo avanti nell’analisi si può compiere se consideriamo con maggiore attenzione le
poste in gioco per le quali i partiti competono.
Le quali sono riconducibili alla: a) ricerca dei voti (vote seeking); b) assegnazione delle cariche
pubbliche (office seeking); e c) al controllo delle politiche pubbliche (policy seeking).
Tali obiettivi vanno considerati primari poiché dal loro conseguimento dipende la capacità dei partiti di
soddisfare le domande dei rappresentati, ma anche la loro adattabilità e la stessa sopravvivenza.
Inoltre, l’enfasi su l’uno o l’altro di questi obiettivi serve a differenziare i tipi di partito.
Così, ad esempio, i partiti elettorali o “pigliatutti” sono vote seeking, i partiti clientelari e i partiti di
cartello sono office seeking, mentre i partiti di massa e i partiti programmatici sono policy seeking.
A questo punto non ci resta che proporre una definizione più estesa.
I partiti sono associazioni di donne e uomini, più o meno organizzate ma comunque in grado di durare,
che competono per i voti popolari, al fine di fare accedere i loro leader e aderenti alle cariche
pubbliche e, quindi, cercare di influenzare le scelte collettive.
Le funzioni principali dei partiti possono essere raggruppate in due macroambiti: quello bottom-up (dal
basso verso l’alto), della rappresentanza o sociale, e quello top-down (dall’alto verso il basso), della
decisione o istituzionale.
Riprendendo una distinzione classica, possiamo parlare di funzioni di input e funzioni di output.
1.2. Funzioni di input o rappresentative
Integrazione e mobilitazione dei cittadini
L’azione dei partiti rende operativa nella mente e nei cuori dei cittadini l’idea di una più ampia
comunità politica. I partiti, anzitutto, “organizzano la partecipazione”.
Tale attività implica l’integrazione, cioè la capacità di creare collegamenti stabili tra centro e periferia,
tra elettori e istituzioni, tra governanti e governati.
Tale funzione è preziosa in tutte quelle fasi, di costruzione della nazione e dello Stato e delle
transizioni alla democrazie, in cui si tratta di “canalizzare” nel sistema politico masse disorganizzate di
cittadini prima escluse.
Si tratta però di un compito non univoco: i partiti sono “sì canali per integrare individui e gruppi
nell’ordine politico esistente, ma sono anche strumenti per modificare o sostituire tale ordine”.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
I partiti, quindi, emergono quali agenti di ordine (integrazione) e di conflitto (disintegrazione).
Anche se, nei regimi democratici, è più rilevante la capacità di regolazione e moderazione dei conflitti,
di trasmissione delle domande nelle sedi istituzionali, di limitazione dell’intensità e della portata della
lotta politica.
Strutturazione del voto
Rientrano in questa funzione tutte quelle attività definite genericamente di electioneering e che hanno a
che fare con la formazione degli orientamenti politici e delle opinioni degli elettori, con la propaganda,
con la necessità di assicurare un collegamento tra candidati e partiti e con l’organizzazione delle
campagne elettorali.
La strutturazione del voto è collegata alla funzione precedente di integrazione, ma in termini operativi
essa è svolta nei riguardi del territorio.
Aggregazione degli interessi
È la funzione con la quale si entra nel cuore del processo di rappresentanza politica.
Con essa le molteplici domande trasmesse al sistema politico vengono trasformate in alternative
politico-programmatiche generali.
L’azione dell’aggregare implica sempre un mediare e regolare, valutare e interpretare.
A monte questa funzione implica l’esercizio di un ruolo di gatekeeper (filtro): si tratta, più
precisamente, del ruolo giocato dai partiti nel controllare l’accesso dei gruppi di interesse e delle élite
alle sedi decisionali e nello stabilire le priorità degli interessi rispetto alle domande.
1.3. Funzioni di output o di governo
Reclutamento dei leader e del personale politico
I partiti hanno finito per controllare, in modo quasi esclusivo, il reclutamento del personale per le
cariche pubbliche.
Il monopolio di tale funzione è massimo rispetto alla selezione dei titolari di cariche elettive e delle
cariche di governo, ma si presenta anche esteso con riferimento alle cariche amministrative.
Da questo punto di vista, i partiti sono un modo per sottrarre il controllo delle posizioni di potere alle
vecchie élite.
Con la politica di massa si sviluppa un sistema di reclutamento misto rigidamente controllato dai partiti
in cui la cooptazione (o nomina politica) dei candidati precede la loro elezione.
Organizzazione e conduzione del governo
Essa costituisce un aspetto cruciale del funzionamento dei sistemi politici.
In primo luogo, perché i partiti svolgono una funzione costituente e fondante dello stesso regime
democratico.
Si delineano due livelli del gioco politico: a) quello delle politiche e delle decisioni dove la
competizione è aperta a tutte le posizioni in campo; b) quello del regime e delle istituzioni che, invece,
richiede una limitazione della competizione.
In secondo luogo, non va dimenticato che i partiti assolvono a importanti compiti procedurali o
istituzionali, nel senso che risolvono complessi problemi di coordinamento e di operatività impliciti nel
funzionamento delle singole istituzioni e nei rapporti tra istituzioni – a partire dalla fondamentale
connessione tra esecutivo e legislativo (sistema di governo).
Influenza delle politiche pubbliche
Questa funzione ha a che fare con la capacità di problem solving, i partiti cioè cercano di trovare
soluzioni ai problemi collettivi e di controllare il policy making, cioè la formulazione e, spesso, anche
l’implementazione delle politiche pubbliche.
Il che richiede di convertire i problemi programmatici, rispetto ai quali si è chiesto il consenso degli
elettori, in decisioni autoritative.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Ma anche di affrontare con tempestività gli shock esterni, le emergenze (disastri naturali, crisi
economiche, problemi umanitari, crisi internazionali) che investono il sistema politico e che richiedono
spesso di deviare dagli impegni elettorali.
Non solo per queste ragioni, va ricordato che il “governo dei partiti” è sempre più limitato, sia da
costrizioni interne al sistema politico (natura delle coalizioni, complessità politica, ruolo della
burocrazia, reazioni dei gruppi di interesse) che esterne (influenza di decisioni sovranazionali,
europeizzazione, relazioni internazionali, globalizzazione).
Tali vincoli si possono spingere al punto di ridurre gli spazi di competizione anche a livello delle
politiche, finendo per svuotare la qualità stessa della rappresentanza dando vita a democrazie
semisovrane
I partiti di massa, la cui nascita è associata ai processi di democratizzazione e di industrializzazione,
sono agenzie di collegamento (linkage) tra società è Stato, in una parola sono principalmente partiti di
rappresentanza (integrazione/mobilitazione, aggregazione e strutturazione del voto).
Via via che i regimi democratici si sono consolidati, tali funzioni (di input) sono diventate meno
rilevanti per il sistema politico.
Per lo più continuano ad essere centrali per i cosiddetti partiti di testimonianza, formazioni a base
ideologica, etnico-territoriale o religiosa, spesso su posizioni estreme che articolano domande di gruppi
ristretti di elettori o di porzioni di territorio.
Per contro, le funzioni di output o istituzionali (reclutamento, procedurali/gestionali delle istituzioni e
di policy making) hanno finito per prevalere.
I partiti della fine del XX secolo e dell’inizio del XXI sono minimi quali strumenti di rappresentanza
politica, sono invece massimi quali organi dello Stato – dal quale ricevono cospicui finanziamenti.
Tuttavia, nell’ambito delle stesse funzioni istituzionali, quelle decisionali e di problem solving
appaiono sempre più vincolate, mentre le uniche funzioni residue sembrano essere quella di nomina a
ruolo pubblici e quella di gestione delle istituzioni.
Che cosa fanno i partiti nei regimi autoritari?
Anche i partiti autoritari o, meglio, totalitari sono caratterizzati da specifiche funzioni.
La distinzione, in questo caso, passa tra “partiti egemoni”, che ammettono l’esistenza di formazioni
satelliti minori e “partiti totalitari” o “partiti unici”.
Con riferimento a questi ultimi, Linz richiama delle funzioni importanti:
1. “la politicizzazione delle masse: incorporazione, inquadramento, integrazione, presa di coscienza e
conversione”;
2. “il reclutamento, l’esame, la selezione e la formazione di una nuova élite politica”;
3. “il controllo di una gamma di istituzioni o posizioni specializzate che potrebbero trasformarsi in
centri di potere non politici indipendenti” quali esercito, polizia, magistratura;
4. e, infine, forse la più importante, una funzione di direzione e di guida che implica di “occupare le
cariche politiche di ogni livello di governo con individui eletti o nominati dal partito”.
2. I partiti come organizzazioni
2.1. Tipologia dei partiti
I partiti possono essere analizzati ricorrendo ad una serie di elementi, sia esterni, quali rapporti con la
società e lo Stato, con i gruppi di interesse e con i movimenti, che interni, quali ideologia, struttura,
leadership, strategie.
Dalla combinazione di questo quadro ricaviamo un certo “modello di partito” o tipo di partito.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
2.2. I partiti di élite
Si tratta di partiti “aristocratici” e “borghesi” o, se si preferisce, conservatori e liberali, che si
affermano prima in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, poi, nel resto dell’Europa.
Il contesto istituzionale in cui si collocano è quello del parlamentarismo classico.
I partiti di élite si limitano a svolgere una funzione di “rappresentanza individuale”, nel senso che
trasmettono le domande che emanano da segmenti ristretti di elettori socialmente omogenei.
La loro unità organizzativa elementare è formata dal “comitato elettorale” costituito da gruppi ristretti
di persone scelte per cooptazione.
Sotto il profilo strutturale i comitati sono degli organismi instabili, temporanei e leggeri, che si attivano
soltanto durante le campagne elettorali.
In tali formazioni politiche, non a caso dette “partiti di notabili”, risalta la deferenza sociale e
l’esistenza di tratti patrimoniali.
La politica costituisce ancora un’attività volontaria (non produce redditi stabili), il che però non
significa che non alimenti rendite politiche anche illegali (corruzione).
I rappresentanti eletti per via partitica una volta approdati nel parlamento hanno al possibilità di seguire
nella loro attività la propria coscienza.
Occorreva, quindi, un meccanismo che evitasse che questa contingenza istituzionale degenerasse in
anarchia e che consentisse di dare un minimo indirizzo a quelli che sono stati definiti “partiti
flessibili”.
2.3. I partiti di massa
I mutamenti che investirono i sistemi politici occidentali, in seguito all’allargamento del suffragio e
alla prima democratizzazione, condussero ad uno scenario di “grande trasformazione” che avrebbe
gettato le basi per l’instaurazione di un nuovo tipo di regime basato sulla politica di massa: la
democrazia dei partiti. In questo scenario
i partiti portavano i rappresentanti più vicino alla base, rendendo possibile la nomina di candidati che
avevano una posizione sociale, una maniera di vivere e delle preoccupazioni vicine a quelle dei
militanti. Si ebbe l’impressione che la democrazia dei partiti accrescesse il ruolo della volontà
popolare nella conduzione degli affari pubblici.
Il protagonista di questa nuova stagione politica fu il “partito di massa”.
Con questi mutamenti istituzionali cambiano sia le strutture organizzative che le funzioni dei nuovi
partiti.
L’integrazione di elettori che da poco avevano acquistato la cittadinanza politica costituisce una sfida
per questo partito, per affrontare la quale occorrevano nuove forme di integrazione sociale e di
mobilitazione delle risorse, come il tesseramento e il lavoro volontario dei militanti.
Ma occorrevano anche nuove soluzioni organizzative.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il partito di massa, infatti, “cerca per prima cosa di dare un’educazione politica alla classe operaia (e
ai ceti popolari): gli iscritti sono la materia stessa del partito, la sostanza della sua azione. Dal punto
di vista finanziario, il partito si basa essenzialmente sulle quote versate dai suoi membri: primo dovere
della sezione è assicurare la regolare esazione”.
La sezione è un’unità aperta a tutti e alla quale ci si può iscrivere liberamente; ciò che conta è adesso il
numero degli aderenti ancor prima del loro profilo sociale.
Entrare in una sezione e prendere parte alle sue attività comporta lo sviluppo di regole formali
(tesseramento, statuti, regolamenti interni) e di un’attività ordinaria su base quotidiana.
I problemi organizzativi centrali delle sezioni erano la socializzazione o educazione politica degli
aderenti e la mobilitazione di risorse attraverso l’autofinanziamento.
I partiti socialisti furono i primi a ricorrere a simili soluzioni organizzative che ben presto, però,
sarebbero state imitate da tutti i partiti democratici a base popolare.
Tale processo di diffusione ha fatto parlare di un “contagio da sinistra”.
In realtà, non tutti i partiti di massa avrebbero dato vita a unità organizzative territoriali (sezioni): i
partiti comunisti sarebbero stati caratterizzati dalle cosiddette cellule – un gruppo più piccolo della
sezione, a base professionale (si strutturano nei posti di lavoro e nelle fabbriche più che nel territorio)
– mentre i partiti fascisti avrebbero dato vita alla milizia – vero e proprio organismo militare stabile e
molto attivo, che nelle sue attività non escludeva il ricorso alla violenza.
L’organizzazione del partito comportava la capacità di alimentare e mantenere legami solidaristici con i
militanti, iscritti, simpatizzanti, e allo stesso tempo rapporti di convenienza attraverso i quali
remunerare i carrieristi e capi che non solo vivono per ma, soprattutto, di politica.
2.4. I partiti elettorali
Con la fine degli anni Sessanta la politica in Europa registra una cesura cruciale.
Nelle democrazie occidentali si aggira un nuovo soggetto politico, destinato a diventare ben presto
egemone: il partito elettorale.
In quegli anni, sulla scia del dibattito sul declino delle ideologie, si celebrò la definitiva crisi della
prassi del partito di massa.
Come tutte le organizzazioni postmoderne, il partito elettorale considera l’organizzazione un sosto più
che una risorsa.
Non stupisce, quindi, se questo tipo di partito si è mostrato incline a realizzare configurazioni
organizzative leggere e intermittenti; a testimonianza di ciò basta ricordare termini oggi in voga quali
club, comitati, unità per indicare gli elementi base di questi partiti – mentre il termine “sezione”
sembra un anacronismo.
Il modello organizzativo dei partiti sembra ispirarsi a logiche di scopo, come per le imprese
economiche, e così si è parlato di “partiti di professionisti”, data la rilevanza dei nuovi esperti
(sondaggisti, esperti di immagine), di “partiti come campaign organizations”, in riferimento alla
centralità delle campagne elettorali (oggi permanenti), di “partiti in franchising”, in considerazione del
carattere decentrato e flessibile delle organizzazioni di partito nel territorio.
Ciò non vuol dire che questo tipo di partito sia del tutto disinteressato agli iscritti, anzi sovente spende
cospicue energie per offrire ai simpatizzanti opportunità di partecipazione più democratiche (primarie,
procedimenti deliberativi, referendum), anche se tali soluzioni non sempre rispondono all’esigenza di
realizzare forme autentiche di partecipazione, ma spesso diventano strumenti di pura lotta tra leader.
Da una prospettiva più ampia, la stessa partecipazione, elettorale e associativa, diventa problematica.
Da un lato, aumentano i fenomeni dell’assenteismo e di disinteresse degli elettori, dall’altro, la stessa
qualità della partecipazione è seriamente pregiudicata dal fatto che nella politica di fine millennio
svolgono un ruolo rilevante le tecniche di persuasione e di manipolazione dell’opinione.
In questo scenario i “partiti personali” sembrano essere meglio adatti a ricucire i rapporti con gli
elettori, tanto più grazie ai mass media che enfatizzano l’immagine dei leader.
L’affermazione dei partiti personali riflette una tendenza generale che investe partiti grandi e piccoli,
vecchi (che si sono personalizzati) e nuovi (che nascono come partiti personali).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Quest’ultimo è il caso, ad esempio, di Silvio Berlusconi e di Forza Italia nel 1994.
Alcuni studiosi, sulla centralità del leader o sul carattere proprietario che per questo ha il partito, hanno
parlato di “partito imprenditoriale” o di “partito-azienda”.
La finanza è un altro aspetto critico di queste nuove formazioni politiche, anche per la lievitazione dei
costi della politica.
In sequenza storica, le diverse fonti di finanziamento sono state reperite dalla società civile per i partiti
di élite (finanza privata o liberale), dalla società politica per i partiti di massa (finanza associativa),
dalle istituzioni statali per i partiti elettorali (finanza pubblica o statale).
La prevalenza di un tipo di finanziamento piuttosto di un altro è correlata a svariati fattori.
In uno scenario in cui le risorse finanziarie interne si fanno più evanescenti (declino degli iscritti) e
dove, contestualmente, i costi della tecnologia dell’informazione e della comunicazione crescono a
dismisura “i partiti hanno dovuto cercare altrove le loro risorse e, in questo caso, il loro ruolo come
governanti e legislatori ha reso facile per loro rivolgersi allo Stato”.
La “statalizzazione” del finanziamento pubblico diventa un imperativo categorico.
Tale evoluzione ha contraddistinto lo sviluppo di un nuovo modello di partito, il cartel party, o
“partito centrato sullo Stato”.
Ne consegue che i principali partiti piuttosto che competere apertamente ricorrono a collusioni e forme
di protezione che assicurano l’autoconservazione (leggi sul finanziamento) e la prevedibilità della
competizione (riforme elettorali dis-rappresentative tese a penalizzare i partiti outsiders).
La “cartellizzazione”, però, ha dei costi che si evidenziano nella polarizzazione tra privilegi, di cui i
partiti godono grazie all’accesso allo Stato, e legittimità sociale, poiché percepiti negativamente dai
cittadini.
Proprio questa divaricazione spiega la diffusione del sentimento antipartitico nelle opinioni pubbliche
delle democrazie occidentali.
3. I partiti come agenzie di rappresentanza
Poiché i partiti sono anche – soprattutto in democrazia – delle agenzie di rappresentanza, riflettono le
divisioni fondamentali e i conflitti (cleavages) che attraversano stabilmente la società.
Tale tema costituisce il cuore del contributo di Lipset e Rokkan sulla nascita dei partiti e dei sistemi di
partito in Europa occidentale.
Stein Rokkan (1921-1979), tra i fondatori della scienza politica europea e precursore degli studi di
politica comparata condotti su ampi dati-base, ha indagato i processi di costruzione degli Stati
nazionali, il rapporto centro-periferia e l’individuazione delle fratture storiche alla base dei sistemi di
partito europei.
Dopo aver costituito un tema fondamentale per la sociologia (e la scienza) politica), la questione del
rapporto tra fratture sociali e partiti è ancora attuale nel dibattito scientifico.
In un recente manuale di politica comparata, gli autori alla domanda “da dove vengono i partiti?”
rispondono ricorrendo a due prospettive analitiche che chiamano rispettivamente “primordiale” e
“strumentale”.
La prospettiva primordiale rimanda alla teoria dei cleavages e “vede nei partiti i rappresentanti
naturali di persone che hanno interessi comuni. Questa prospettiva dà per scontata l’esistenza di
divisioni naturali all’interno della società. Con il formarsi di gruppo intorno a queste fratture, i partiti
emergono e si evolvono per rappresentare questi interessi”.
Tale prospettiva pone due ordini di problemi.
1. Nella letteratura sociologica e politologica internazionale non è sempre chiaro cosa si intende con
“frattura” o cleavage.
Da qui la proliferazione di definizioni e tipologie eterogenee e non sempre conciliabili.
Qui prendiamo le mosse dalla definizione dei cleavages come fratture che dividono i membri di una
comunità in gruppi.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Va da sé che non si tratta di una qualsiasi divisione, ma di divisioni politiche fondamentali.
2. Proprio perché fonti di conflitti, le fratture sono anche fattori di aggregazione e di identificazione
dei membri di una collettività e in questo modo finiscono per assolvere a una funzione di mobilitazione
di individui e gruppi sociali sulla base dello schema binario “amico-nemico”.
Pertanto, esse appaiono collegate alla costruzione di identità collettive, attorno alle quali nascono
movimenti e partiti politici, che si riconducono ad una serie di “famiglie ideologiche o politologiche”.
Dobbiamo a Lipset e Rokkan la più nota tipologia di fratture sociale, anche se applicabile alla sola
Europa occidentale.
Nella loro analisi troviamo quattro tipi fondamentali di fratture, interpretati come prodotti delle due
maggiori rivoluzioni del XIX secolo: la rivoluzione nazionale e la rivoluzione industriale.
Alla rivoluzione nazionale (Rivoluzione francese e le sue conseguenze) sono collegate la frattura
centro-periferia e la frattura Stato-Chiesa, alla rivoluzione economica (a partire dalla metà
dell’Ottocento) la frattura industriale o urbano-rurale e la frattura capitale-sociale.
Fin qui lo schema di Rokkan suggerisce la possibilità della comparsa di sistemi partitici di cinque o sei
partiti posizionati sul continuum destra-sinistra: un partito conservatore, un partito agrario, un partito
liberale, un partito confessionale, un partito socialista.
Il formato del sistema si complica dopo la “rivoluzione internazionale del 1917” in quei casi dove si
registra l’aggiunta di partiti antisistema di origine comunista o fascista.
Per quanto riguarda il periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, secondo la nota “tesi del
congelamento” dei sistemi di partito europeo, nella politica del dopoguerra c’era poco di nuovo rispetto
al passato.
In realtà, alcune fratture, come quella Stato-Chiesa e, soprattutto, quella tra operai e datori di lavoro,
hanno lasciato tracce profonde sulle altre e hanno acquistato una maggiore importanza politica dando
l’impronta alla competizione politica – si pensi alla rilevanza della distinzione sinistra-destra.
Oggi le cose sono molto diverse, e la questione del rapporto tra teoria dei cleavages e cambiamento
politico si pone con forza.
In generale, le fratture mutano in uno dei seguenti modi o loro combinazione:
1. perdita di rilevanza delle fratture tradizionali: declino elettorale dei partiti storici (classisti e
religiosi);
2. riattivazione di fratture latenti: comparsa dei partiti etnoregionalisti e di partiti fondamentalisti;
3. attivazione di nuove linee di divisione: formazione dei partiti ecologisti o dei partiti populisti o
magari antieuropei.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In tempi più recenti si sono delineate nuove linee di divisione e di conflitto politico, dalla divisione tra
politica ed antipolitica, alla riattivazione di vecchie fratture come quella religiosa, basti pensare ai
nuovi conflitti tra Stato e Chiesa su temi ad alta valenza simbolica (aborto, eutanasia, ricerca sulle
staminali, unioni omosessuali).
Inoltre, si è registrata una riattivazione dei conflitti centro-periferia spesso collegata all’integrazione
europea e alla divisione tra “europeisti” e “antieuropeisti” e, soprattutto, al revival della frattura
territoriale con la formazione un po’ in tutta Europa di partiti di volta in volta definiti “etnici”,
“nazionalisti”, “regionalisti”.
Di recente, Clark, Golder e Golder hanno introdotto una seconda prospettiva per lo studio dei
partiti, quella strumentale (o top-down), per la quale i partiti sono “squadre di persone interessate ad
ottenere cariche pubbliche”.
Non si tratta tanto di enfatizzare una visione realista o cinica della politica, quanto del fatto che
“stando a questo approccio dall’alto”, la comparsa dei partiti diventa il frutto dell’azione di élite
politiche e di imprenditori politici che interpretano e manipolano le domande degli elettori, ne attivano
gli interessi creando dal nulla le linee di divisione.
Ciò non vuol dire che i leader di partiti creino dal nulla le divisioni sociali, ma che date certe linee di
conflitto presenti in una società, si impegnano in complesse strategie volte a definire la loro rilevanza e
ampiezza (oggi sempre più grazie ai media), il grado di coinvolgimento e di mobilitazione dei
sostenitori e del pubblico, la costruzione di alleanze e coalizioni, e così via.
“Per capire la natura del conflitto tra partiti è necessario considerare la funzione delle fratture
utilizzate dai partiti nella loro battaglia per la supremazia. Poiché lo sviluppo delle fratture è un
eccellente strumento di potere, il partito che è in grado di imporre la sua definizione delle questioni,
probabilmente conquisterà il governo”.
4. I partiti come istituzioni pubbliche e i sistemi elettorali
Se è indubbio che i moderni partiti politici sono i “figli della rivoluzione industriale” e della
trasformazioni che ne conseguono, è pur vero che la loro formazione è impensabile senza il verificarsi
di rilevanti cambiamenti istituzionali, quali la realizzazione di un governo responsabile nei confronti
del parlamento, il progressivo allargamento del diritto di voto fino al suffragio universale maschile e
poi femminile, il passaggio da sistemi elettorali maggioritari a sistemi proporzionali.
Il risultato di questi cambiamenti sarà “una corsa all’organizzazione per il reclutamento del sostegno e
pei il consolidamento delle identità politiche”, cioè la, comparsa dei moderni partiti politici.
Un passaggio cruciale in questi processi è dato dall’estensione del diritto di voto e dalla riforma del
sistema elettorale.
Non a caso, la tendenza dominante in Europa – se si esclude la Gran Bretagna – è stata la
proporzionalizzazione delle leggi elettorali.
Un sistema elettorale è una serie di leggi e di regole di partito che disciplinano la competizione
elettorale tra e all’interno dei partiti [Cox].
Questa definizione pone l’accento su due aspetti:
in primo luogo, enfatizza la dimensione strategica della competizione politica: i sistemi elettorali
fissano la “regole del gioco” che definiscono i vincoli e le opportunità per i giocatori (elettori, partiti,
candidati, leader) in campo;
in secondo luogo, tali regole non sono solo quelle poste dalla legislazione, ma possono anche
derivare da regolamenti e statuti dei partiti (es. un partito che nel proprio statuto stabilisce che la
selezione dei candidati per le elezioni avvenga tramite elezioni primarie).
Ciò che la citazione di Cox non dice espressamente è che, da un punto di vista tecnico, regole e
meccanismi elettorali riguardano la traduzione o conversione dei voti in seggi.
Tuttavia, possiamo avere anche una definizione più ampia, come traspare dalla distinzione classica di
Douglas W. Rae tra election law, ovvero legislazione sulle elezioni (elettorato attivo e passivo,
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
procedimento elettorale, campagna elettorale, finanziamento ai partiti: sistema elettorale in senso lato)
ed electoral law, ovvero legge elettorale (formula elettorale, ampiezza della circoscrizione, soglie di
sbarramento, premio in seggi, tipo di scheda: sistema elettorale in senso stretto).
Al di là degli aspetti classificatori, per la scienza politica i sistemi elettorali hanno rilevanza per le
conseguenze che producono sui sistemi di partito e, quindi, sui partiti.
Partendo dalla nozione si “sistema elettorale” in senso tecnico, la distinzione classica e più semplice è
quella che distingue tra sistemi elettorali “maggioritari”, “proporzionali” e “misti”.
Nei sistemi maggioritari vale la regola elementare che il partito più forte nel singolo collegio vince
il seggio in palio.
In realtà, i sistemi maggioritari si possono distinguere sulla base della regola che utilizzano per definire
la maggioranza che vince il seggio.
Se questa è data dal numero di voti più alto senza altri requisiti, possiamo parlare di “maggioranza
relativa” o “maggioranza semplice”, o di plurality.
Il candidato che ottiene anche un solo voto in più degli altri viene eletto immediatamente: ne consegue
che il sistema plurality è un sistema a turno unico in collegi uninominali.
Il problema con questo tipo di scrutinio è che può arrivare al traguardo e vincere il seggio un candidato
poco “rappresentativo”, il che dipende dal livello di astensionismo che si verifica nel collegio e dal
numero di candidati concorrenti, fattori questi che abbassano il numero dei voti necessari per vincere.
Per contro, anche per correggere la distorsione rappresentativa del plurality, il sistema detto majority
stabilisce che per ottenere il seggio in palio occorre conseguire la maggioranza assoluta (il 50% + 1).
Con questa regola non si avranno candidati poco rappresentativi, poiché almeno la metà più uno degli
elettori iscritti nel collegio avrà votato per il vincente (fatti salvi gli astenuti).
Cosa succede se nessuno dei candidati raggiunge la soglia richiesta della maggioranza assoluta?
Le soluzioni escogitate sono due.
La prima, quella più semplice, chiama gli elettori a votare nuovamente (dopo una o due settimane), e
questa volta per vincere il seggio basta la maggioranza relativa.
Per tale ragione si parla di “sistema a doppio turno”.
Al secondo turno per chi può votare l’elettore?
In passato, il sistema a doppio turno considerava il passaggio di tutti i candidati del primo turno che
non intendevano ritirarsi e anche l’entrata di nuovi candidati.
Oggi, l’orientamento è che al secondo turno l’elettore deve trovare un numero ridotto di candidati, in
genere i primi due (allora si parla di ballottaggio), o i primi tre o quattro.
Si può anche decidere di fissare una soglia percentuale di voti per passare l secondo turno: ad esempio,
nelle elezioni legislative francesi, tale soglia è oggi fissata al 12,5% degli aventi diritto al voto.
Va da sé che più il filtro per accedere al secondo turno è selettivo, più lo scrutinio a doppio turno
produce effetti dis-rappresentativi.
Il secondo meccanismo è il “sistema del voto alternativo” vigente in Australia.
Questa volta invece di chiedere all’elettore di ritornare a votare dopo qualche settimana, gli si chiede di
esprimere un voto ordinale, ovvero di graduare (ordinare) per preferenza tutti i candidati presenti nel
collegio; se nessuno ottiene la maggioranza assoluta di prime preferenze, il candidato meno votato (con
le prime preferenze) viene eliminato e si procede a distribuire tra i candidati “sopravvissuti” i suoi voti
sulla base delle seconde preferenze indicate nelle schede; se anche in questo caso nessuno ottiene la
maggioranza assoluta si procede a oltranza finché un candidato non riesca a conseguire il seggio.
L’altra grande famiglia è quella dei sistemi proporzionali.
In questi sistemi i seggi in palio nelle circoscrizioni (plurinominali) sono suddivisi tra i partiti in
proporzione alle quote di voti ottenute.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Invero, va precisato che i sistemi proporzionali variano molto tra loro e si possono distinguere in base
al grado di dis-proporzionalità introdotto dai diversi meccanismi che li caratterizzano.
Basti pensare che si può arrivare alla situazione di un sistema elettorale nominalmente proporzionale
che di fatto produce effetti maggioritari e talvolta ancora più dis-rappresentativi dei sistemi che portano
questo nome (il caso del sistema italiano introdotto nel 2005 e noto come Porcellum).
La distorsione della proporzionalità oltre che dalla formula elettorale, dipende anche da altri elementi:
ampiezza della circoscrizione, soglie legali, premi in seggi, ampiezza dell’assemblea da eleggere.
Per quanto riguarda, invece, le formule elettorali proporzionali da adottare per l’allocazione dei seggi,
nel corso del tempo e per far fronte a situazioni diverse, ne sono state escogitate molte che per lo più
prendono il nome da chi le ha elaborate.
La formula Hare utilizzata in Olanda e Israele o la formula d’Hondt utilizzata in Spagna e in Italia
(nella Prima e nella Seconda Repubblica) sono entrambe regole che assegnano i seggi in proporzione
ai voti, ma la prima è maggiormente proporzionale, mentre la seconda penalizza i partiti più piccoli.
Si ricava che esistono sistemi elettorali proiettivi, che favoriscono la rappresentatività (quanto più si
approssimano alla proporzionale pura), e sistemi elettorali selettivi, che agevolano la governabilità (i
maggioritari in entrambe le varianti, plurality e majority, e i proporzionali corretti da meccanismi dis-
proporzionali), nel senso che questi ultimi, riducendo il numero dei partiti, creano le condizioni
politiche della stabilità.
Negli ultimi decenni sono stati ingegnati dei sistemi elettorali misti che vorrebbero in qualche
modo contemperare le esigenze della rappresentanza e quelle della governabilità/stabilità e a tal fine
fanno sì che gli elettori scelgano i propri rappresentanti con regole elettorali ibride: una parte dei seggi
sono attribuiti con regole maggioritarie, l’altra con lo scrutinio proporzionale.
Al riguardo, vale la pena ricordare la distinzione tra sistemi misti indipendenti e dipendenti.
Nel primo caso – si parla anche di “sistemi paralleli” – i due tipi di regole (maggioritarie e
proporzionali) coesistono in autonomia e non interferiscono, o il loro utilizzo avviene a livelli elettorali
distinti – in Russia, ad esempio, 225 deputati sono eletti con lo scrutinio maggioritario a turno unico a
livello di collegio, mentre altri 225 sono eletti con il sistema proporzionale in un collegio unico
nazionale.
Nel secondo caso, invece, l’operatività proporzionale dipende dalla distribuzione dei seggi prodotta dal
comparto maggioritario – è il caso del sistema in vigore in Italia dal 1993 al 2005 noto come
Mattarellum.
L’individuazione dei seggi elettorali è rilevante per le conseguenze che questi hanno sui sistemi di
partito e quindi anche sulla stabilità e funzionalità dei regimi democratici.
Il primo ad aver trattato il tema in maniera scientifica è stato Duverger, dalla cui analisi si fanno
discendere le cosiddette “leggi di Duverger”, o meglio una legge e un’ipotesi, che postulano delle
relazioni causali tra tipo di scrutinio e numero di partiti:
1. legge di Duverger, il sistema maggioritario a turno unico (plurality) tende al dualismo dei
partiti (bipartitismo);
2. ipotesi, il sistema a doppio turno (majority) o a rappresentanza proporzionale tende al
multipartitismo.
La valutazione della legge e dell’ipotesi di Duverger richiede un passaggio ulteriore.
Lo studioso francese è convinto che il punto di partenza dell’analisi sulla formazione dei partiti è dato
dalla struttura economico-sociale e dai conflitti che vi hanno luogo (come per la teoria dei cleavages);
tuttavia, il fatto che le diverse fratture riusciranno a dar vita a partiti elettorali, attivi nella
competizione, e ancor di più a partiti parlamentari che ottengono dei seggi, dipenderà dal tipo di
regole elettorali.
Quanto più un sistema elettorale è proporzionale, tanto più facile sarà per i partiti superare la “soglia di
rappresentanza”, per contro tanto più un sistema è maggioritario, o meglio dis-proporzionale, tanto più
i partiti piccoli verranno penalizzati e i grandi favoriti dalla competizione.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Si tratta di ciò che Duverger chiama effetti meccanici o “effetti diretti” del sistema elettorale.
Proprio per evitare o attutire tali effetti, gli elettori sono indotti a ricorrere al voto strategico, cioè a
scegliere non il partito al quale si sentono più affini (e per il quale esprimerebbero un voto sincero) e
che, se piccolo, correrebbe il rischio di non aver successo, ma il partito più prossimo alle loro
preferenze originarie che ha più realistiche possibilità di vittoria – un’alternativa al voto strategico
potrebbe essere l’astensionismo strategico: se il mio partito non ha possibilità di vincere tanto vale non
recarsi alle urne.
D’altra parte, al comportamento strategico ricorrono anche i leader di partito che per evitare la sconfitta
optano per costruire alleanze elettorali o apparentamenti con altri partiti (ingresso strategico), o
possono negoziare delle desistenze, cioè accordi con altre liste in campo per non presentare candidati
forti o per non sostenere attivamente il proprio candidato in un collegio, in cambio dello stesso favore
in un altro collegio. Tutti questi casi
rientrano in ciò che Duverger chiama
effetti psicologici o “effetti indiretti”
dei sistemi elettorali.
Sartori ha sostenuto
convincentemente che le leggi di
Duverger vanno precisate ricordando
che la loro efficacia è tanto più forte
in relazione al grado di strutturazione
del sistema partitico.
Il che dipende sia dall’esistenza di
partiti minimamente organizzati e
stabili su scala nazionale che dal
consolidamento di fedeltà prevedibili degli elettori.
Più queste condizioni si allentano, più i sistemi elettorali perdono di efficacia nei tre ambiti sviluppati
da Fisichella (a) manipolazione delle scelte dell’elettore, b) sotto e sovrappresentazione dei partiti, c)
influenza sul numero dei partiti), in particolare nel terzo.
Dal ragionamento di Sartori si ricava che i sistemi elettorali forti, maggioritari o altamente dis-
proporzionali, hanno un effetto riduttivo del numero dei partiti, ma solo se il sistema partitico è
strutturato su base nazionale (democrazie maggioritarie dell’Europa occidentale).
Se il sistema partitico è organizzato solo a livello locale, gli effetti riduttivi si avranno solo a livello di
collegio, da qui l’anomalia di un sistema plurality che alimenta la frammentazione partitica (es. India).
Se, per contro, il sistema partitico è fortemente strutturato e il sistema elettorale debole (proporzionale)
si possono avere ancora esiti bloccanti o controbilancianti che derivano dalla logica di funzionamento
del sistema partitico (es. Irlanda, Malta)
Elementi tecnici di un sistema elettorale
Formula elettorale: regola matematica che converte i voti i seggi. Le formule elettorali si distinguono in
“maggioritarie” (a maggioranza assoluta e relativa o semplice) e “proporzionali”. Queste ultime, a loro volta, si
classificano in regole del divisore e della quota (o del quoziente). Il quoziente è il numero dei voti che
assicurano un seggio in una data circoscrizione (tipicamente, il rapporto tra voti validi e seggi in palio). Nei
sistemi basati sulla regola del quoziente si procede a rapportare tale quota al numero complessivo dei voti
conquistati da ogni partito. Rientrano in questa categoria le formule Hare, Drop e Imperiali. Questo modo di
assegnare i seggi genera, però, il problema dei resti o dei seggi residui. Per distribuire questi seggi si ricorre a
tre espedienti: il resto più grande, la media più elevata e la media più elevata modificata. Le formule d’Hondt,
Sainte-Langue e Sainte-Langue modificato si basano invece sulla regola del divisore, per cui le cifre dei voti
ottenute dai diversi partiti in una circoscrizione vengono divise per una serie di numeri (i divisori, appunto) in
modo da ridurre il quoziente “naturale” e stabilire i seggi sulla base dei quozienti più alti.
Ampiezza delle circoscrizioni: per “circoscrizione” (o “distretto elettorale”) si intende la ripartizione del
territorio nazionale in ambiti geografici in base ai quali assegnare i seggi. In genere, il numero dei seggi da
attribuire a una circoscrizione dipende dalla popolazione residente. Nel caso dei sistemi proporzionali tale
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
ambito mantiene il termine “circoscrizione” ed è plurinominale, mentre nei sistemi maggioritari, dove si parla
spesso di “collegio”, tali ambiti possono essere plurinominali quanto uninominali (anche se quest’ultimo è oggi
più frequente). L’ampiezza o magnitudine di una circoscrizione elettorale indica il numero di seggi assegnati ad
un determinato ambito territoriale. Più ampia è la magnitudine più il sistema è proporzionale e viceversa. In
altri termini, quanto più il numero dei seggi è elevato, tanto più si abbassa il costo elettorale di un seggio, per
cui anche i partiti più piccoli possono sperare di conquistarne uno.
Soglie elettorali o “di rappresentanza”: sono dei correttivi del carattere proporzionale di un dato sistema
che stabiliscono un numero minimo di voti necessari a un partito per ottenere dei seggi (soglia legale). Il caso
più noto è quello del sistema elettorale tedesco che stabilisce una soglia del 5% affinché un partito possa essere
…
rappresentato. In realtà, la legge elettorale stabilisce anche una seconda soglia di esclusione meno nota, nel
senso che un partito può essere rappresentato al Bundestag pur non raggiungendo il 5%, purché ottenga la
vittoria in almeno tre collegi uninominali. Possono anche esistere sistemi elettorali con soglie multiple come
quello italiano introdotto nel 2005, dove la soglia di esclusione varia se il partito si presenta coalizzato (2%) o
non coalizzato (4%), mentre è del 10% per la coalizione.
Premio di maggioranza: il premio in seggi è un espediente usato per consentire a un partito o coalizione che
ottiene la maggioranza relativa di ottenere una maggioranza assoluta o ancora più ampia. Giovanni Sartori
considera i sistemi con premio di maggioranza come sistemi a sé e, in effetti, molto difficilmente per gli esiti
che producono possono essere considerai dei sistemi proporzionali corretti. La logica operativa del sistema
proporzionale con premio di maggioranza dipende da due profili: l’entità del premio e l’esistenza di eventuali
condizioni, in genere il raggiungimento di una soglia minima per farlo scattare. L’Italia ha avuto una lunga
tradizione di sistemi proporzionali con premio di maggioranza, dalla legge Acerbo in piena era fascista, alla
legge truffa del 1953, fino al cosiddetto Porcellum del 2005.
Tipi di scheda: la funzione della scheda elettorale è quella di strutturare la scelta dell’elettore. Nello
specifico, esistono due tipi di schede: quelle dette categoriali o nominali, che impongono all’elettore di
scegliere in maniera netta il partito e/o il candidato, e quelle ordinali, dove l’elettore ha a disposizione una
scelta più articolata che gli consente di esprimere più preferenze. Nel primo caso l’elettore oltre a votare per un
partito può scegliere o meno un candidato, il che avviene grazie al cosiddetto voto di preferenza, se ha questa
possibilità si parla di lista aperta; altrimenti si parla di lista bloccata o chiusa, in questo caso i candidati eletti
sono stabiliti in base all’ordine che ricoprono nella lista. Questo è attualmente il caso dell’Italia, con l’entrata in
vigore della legge elettorale del 2005.
5. I partiti come squadre di leader in competizione
La nozione di sistema partitico coglie la dimensione orizzontale della relazione tra partiti.
Tuttavia, da tempo si è fatta strada la consapevolezza che andrebbero considerata anche altre
dimensioni: legittimità del sistema; grado di nazionalizzazione e grado di penetrazione dei partiti nella
società; i diversi “siti decisionali” dove essi competono.
Proprio considerando questo ultimo aspetto, alcuni studiosi hanno proposto di allargare l’ambito di
riferimento del concetto di “sistema partitico” riferendolo a diversi livelli territoriali (nazionale,
regionale, locale o sovranazionale) o istituzionali (elettorale, parlamentare o di governo).
Il punto rilevante da enfatizzare è che nelle democrazie avanzate la competizione per il potere politico
si svolge in diversi ambiti tra loro interdipendenti.
Tale situazione caratterizza i regimi politici federali (Stati Uniti, Canada, Svizzera) o con forti
componenti di decentramento (Belgio, Spagna, Regno Unito) e dove esistono processi di
territorializzazione dei partiti su basi ideologiche (Germania, Austria, Italia, Francia).
Se si esclude l’ultimo caso, oggi in declino un po’ ovunque, le altre due situazioni autorizzano a parlare
della coesistenza a livelli territoriali diversi di più “sistemi di partito”.
I sistemi partitici si possono analizzare sulla base di tre criteri principali: a) il numero dei partiti (o
formato); b) le loro dimensioni (o forza); c) le loro relazioni che ne definiscono la logica di
funzionamento (o meccanica).
L’operatività di questi fattori influenza l’orientamento di voto degli elettori, la formazione dei governi,
la loro stabilità e il rendimento della stessa democrazia.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Non c’è tipologia dei sistemi di partito che non faccia riferimento a questi criteri.
Tuttavia, il criterio numerico costituisce senza dubbio uno degli aspetti più evidenti che permette di
cogliere un aspetto cruciale del funzionamento di ogni sistema politico, vale a dire la concentrazione o
frammentazione del potere al suo interno.
La distinzione classica è quella tra sistemi mono, bi e multipartitici.
Secondo Duverger, il primo tipo, il monopartitismo, individua un “genere” relativo ai “regimi non
democratici”, quindi un tipo di regime politico più che un sistema partitico.
Per Duverger il tipo più importante, poiché “sembra presentare un carattere naturale” dato da un
dualismo di tendenze, è il sistema bipartitico.
L’approccio duvergeriano, comunque, fu presto sottoposto a diverse critiche.
Innanzitutto non tutti i regimi democratici avevano un solo partito.
C’è, infatti, una certa differenza tra sistemi a “partito egemonico” che, comunque, ammettono
l’esistenza di piccoli partiti satelliti, e un regime a “partito unico”, dominato dal partito totalitario.
Inoltre, nel panorama democratico, i bipartitismi sono più unici che rari: è il caso di ricordare che in
Gran Bretagna – per lungo tempo la culla della democrazia maggioritaria e del bipartitismo – nelle
elezioni politiche del 2010 ben dieci partiti hanno ottenuto seggi in parlamento, e la buona
affermazione del terzo partito (i liberaldemocratici) ha generato per la prima volta dalla Seconda guerra
mondiale un governo di coalizione.
Infine, la categoria del “pluripartitismo” contiene molte varianti che ne fanno un insieme assai
eterogeneo.
D’altra parte, non era neanche vero che il bipartitismo fosse l’unico sistema partitico funzionante, basti
pensare all’esperienza dei multipartitismi delle piccole democrazie europee (Olanda, Svizzera, Belgio).
Soprattutto, la classificazione di Duverger non chiariva come contare i partiti.
La questione del conteggio, in realtà, porta con sé il secondo aspetto relativo alla forza dei partiti.
Al fine di dar conto della taglia parlamentare ed elettorale delle forze politiche un primo criterio
piuttosto pragmatico è quello di conteggiare solo i partiti che riescono a superare una certa percentuale
di seggi (o di voti) – ad esempio, il 3 o 5%.
È evidente che si tratta di un’opzione arbitraria e, d’altra parte, la rilevanza dimensionale non coincide
sempre con la rilevanza politica – il Partito liberale italiano, ad esempio, con il 2% dei voti ha
esercitato una notevole influenza sui governi democristiani della Prima Repubblica.
La classificazione che ha costituito il paradigma per l’analisi dei sistemi di partito nella seconda metà
del XX secolo è quella di Sartori.
Lo studioso fiorentino ha suggerito, innanzitutto, di risolvere la questione del conteggio dei partiti e dei
reciproci rapporti di forza (che non dipendono solo dalle dimensioni ma anche dal ruolo strategico),
fissando delle regole di conteggio volte a discriminare tra i partiti “che contano” e quelli che vanno
tralasciati perché irrilevanti.
Tali regole sono due:
1. un partito, per quanto piccolo, deve essere contato se ha potenziale di coalizione, cioè se è
indispensabile per formare maggioranze di governo;
2. un partito che non abbia affinità coalizionali deve, comunque, essere contato se ha potenziale di
ricatto, cioè se la sua presenza condiziona la direzione della competizione e la produzione delle
politiche pubbliche.
Una volta che i partiti sono stati contabilizzati adeguatamente, il loro numero (corretto), costituisce il
formato del sistema partitico.
Ma, per capire come funziona un sistema partitico, è necessario sapere qualcosa anche sulla natura
delle interazioni che vi si svolgono (il terzo criterio).
Al riguardo, il profilo discriminante è individuato da Sartori nel ruolo dell’ideologia, che nel caso dei
sistemi partiti democratici viene concettualizzata come distanza ideologica tra i partiti o polarizzazione,
mentre nel caso dei regimi autoritari va considerata in termini di intensità dell’inquadramento
ideologico e di repressione.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Da questo ulteriore aspetto deriva per i sistemi competitivi la meccanica, cioè la logica di
funzionamento del sistema.
Dalla combinazione tra formato e meccanica si ricavano tre configurazioni sistemiche.
La prima configurazione, quella unipolare, è tipica delle situazioni monopartitiche non
democratiche, senza competizione e ricambio dei gruppi al potere, che tuttavia può presentarsi anche
nelle democrazie qualora la dinamica competitiva è limitata non già da elementi coercitivi ma dai
comportamenti degli elettori che, per svariate ragioni, orientano il loro sostegno sempre verso un solo
partito producendo un sistema a partito predominante.
La seconda configurazione, quella bipolare, che assorbe i casi bipartitici e i multipartitismi
moderati, mostra una direzione della competizione centripeta e con elevata probabilità di produrre
alternanza tra governo e opposizione – in questo quadro i sistemi a partito predominante si possono
interpretare quali bipartitismi in cui il dislivello di forza tra i due partiti rilevanti è tale da non
consentire l’alternanza.
La terza configurazione, quella multipolare, che coincide con i multipartitismi estremi dove la
competizione tende ad essere centrifuga, presenta forze estremizzate e opposizioni bilaterali, mentre
l’alternanza al governo lascia il monopolio del governo ai partiti di centro, tra i quali può esservi un
partito dominante, capace di controllare anche per lunghi periodi la maggioranza relativa dei seggi,
rimanendo l’attore centrale (o pivot) delle coalizioni di governo, come la Dc in Italia fino al 1994.
L’unica forma di avvicendamento possibile al governo in questo caso è costituita dal cosiddetto
“ricambio periferico”, in cui il partito dominante resta al governo mentre cambiano i partner minori di
coalizione.
La tipologia di Sartori può essere utilizzata anche per dar conto del mutamento dei sistemi di partito.
Da questo punto di vista, il cambiamento implicherebbe un’alterazione del formato e/o della
meccanica del sistema partitico, ovvero del numero di partiti rilevanti e del grado di polarizzazione.
In sostanza, si tradurrebbe nello slittamento da un tipo all’altro dei casi previsti.
Per Sartori lo spostamento più interessante è quello che da sistemi multipartitici polarizzati conduce a
sistemi multipartitici moderati.
Insomma, il passaggio da sistemi multipolari a sistemi bipolari.
Del resto, le trasformazioni che hanno caratterizzato le democrazie occidentali negli ultimi decenni
sembrano testimoniare proprio la diffusione di questo tipo di transizione, al punto che la categoria dei
“sistemi multipartitici estremi e polarizzati” sembra essersi svuotata, mentre quella dei “sistemi
moderati” appare oltremodo ricca.
Ma non è tutto. In effetti, anche la classe dei sistemi a partito predominante nell’ultimo ventennio si è
praticamente svuotata.
Così come la categoria dei “sistemi bipartitici” sembra sempre più contraddistinta da anomalie.
L’unica classe che sembra sopravvivere nella tipologia è quella del “multipartitismo moderato”.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 6 – Assemblee e circuiti rappresentativi
1. Lo sviluppo storico delle assemblee rappresentative
1.1. Origini del parlamentarismo moderno
I sistemi politici hanno sempre enfatizzato, accanto alle figure di leader o condottieri, l’influenza di
istituzioni collegiali, più o meno “elitarie”, che in qualche misura raffigurano la comunità alla base del
sistema stesso.
L’impero romano vedeva nel Senato il proprio architrave istituzionale, nonché il principale bacino di
formazione e selezione della élite politico militare.
Anche i regimi feudali e quelli assolutistici che successivamente connotarono il continente europeo
contavano su strutture collegiali più o meno istituzionalizzate, le quali assecondavano e talvolta
limitavano il potere del leader.
Dalla mitica Tavola rotonda della leggenda celtica ai consigli imperiali di epoca rinascimentale,
passando per le libere assemblee repubblicane dell’età comunale, tali strumenti conobbero in taluni
casi un grande rilievo istituzionale anche se non si trattava di organi sovrani come oggi siamo soliti
definire i nostri parlamenti.
La spinta che legittimava queste istituzione era infatti la necessità di bilanciare dei poteri dati, ovvero
la monarchia o più generalmente il leader, con forme imposte dalla stessa iniziativa regia, dai feudatari
o da altri soggetti capaci di esprimere qualche forma di autorità.
La differenza principale tra le assemblee parlamentari premoderne e quelle contemporanee sta dunque
nella collocazione delle prime in un contesto di legittimazione dualistico, dove il parlamento non
esprime una sovranità popolare ma piuttosto una funzione di bilanciamento rispetto alla legittimità del
sovrano.
Non vanno ovviamente dimenticati altri connotati propri dei parlamenti feudali e premoderni, ad
esempio la disuguaglianza tra le sue articolazioni interne, che rende la morfologia degli antichi
parlamenti assai bizzarra ai nostri occhi: i membri delle assemblee di stampo feudale non erano “tutti
uguali”, non condividevano le stesse funzioni e spesso nemmeno lavoravano collegialmente.
La loro natura di rappresentanti non si riferiva a una idea di “pluralismo sociale e politico” ma alla
dimensione di “ceto”, e questa compartimentalizzazione della rappresentanza corrispondeva ad una
rappresentazione corporativa piuttosto che individualistica.
Inoltre, il livello di consolidamento organizzativo dei parlamenti premoderni era mediamente assai più
modesto rispetto alle assemblee dell’era contemporanea.
Queste differenze hanno dato agli studiosi un buon motivo per enfatizzare i momenti di distacco
rispetto a quel tipo di istituzione assembleare che ha accompagnato la nostra storia fino alle grandi
rivoluzioni nazionali.
La nascita delle moderne assemblee pluralistiche ha costituito un vero momento rivoluzionario.
1.2. I centri della rappresentanza democratica moderna
La portata rivoluzionaria dell’avvento delle assemblee pluralistiche della democrazia moderna è ancora
visibile, in molti paesi, nella celebrazione delle date fondamentali che hanno trasferito poteri importanti
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
a queste istituzioni, facendone la culla e il simbolo di una democrazia che abbiamo chiamato
rappresentativa.
Tuttavia, usiamo termini molto diversi per indicare l’attuale configurazione di queste istituzioni:
parlamenti, congressi, corti, consigli, diete, assemblee, solo per ricordare i termini più diffusi.
La nozione di parlamento, dunque, non può essere esaustiva rispetto alla categoria generale delle
“assemblee rappresentative democratiche”, poiché si attaglia soprattutto all’esperienza democratica
europea, dove ha prevalso il sistema di fusione dei poteri.
Laddove si è imposto, sull’esempio degli Stati Uniti, il modello della separazione dei poteri, il termine
che indica la tipica istituzione legislativa nazionale è invece quello di Congresso.
Le assemblee pluralistiche hanno vissuto percorsi complessi e diversificati, che non hanno riguardato
solo i loro poteri formali e la loro collocazione in un sistema di regole, ma anche la loro credibilità.
Un processo di istituzionalizzazione avviene quando una serie di valori e comportamenti di un
determinato organismo si consolidano e si mostrano universalmente accettati, cristallizzandone le
azioni e il ruolo. L’organismo in questione diventa così un’ “istituzione” perdendo i caratteri di
provvisorietà e mutevolezza, e acquisendo una forma stabile e generalmente riconosciuta.
Sulla base di questa definizione, possiamo dire che un’assemblea rappresentativa è istituzionalizzata
quando mostra chiaramente i propri confini non solo ai suoi membri, ma anche agli altri attori del
sistema politico, delimitando i ruoli e favorendo le interazioni tra più istituzioni.
Tenendo presente la diversa evoluzione storica, i comparatisti hanno riposto la propria attenzione sui
tratti comuni presentati dalle istituzioni assembleare delle attuali democrazie.
Generalmente tali caratteri distintivi sono presentati nel seguente modo.
Natura assembleare: a differenza del passato, i membri delle democratiche istituzioni
rappresentative hanno pari dignità, lavorano assieme e condividono le stesse prerogative sotto forma di
funzioni, benefici e responsabilità.
Natura rappresentativa: tale caratteristica è garantita dal legame con la dimensione comunitaria
della politica che non può prescindere dalla garanzia e dall’effettivo svolgimento di libere elezioni.
Pluralismo interno: questa caratteristica risponde alla semplice idea che nell’istituzione
rappresentativa le voci siano plurali e garantiscano uno specchio sufficientemente fedele delle visioni
presenti nella comunità dei rappresentati.
Permanenza dell’istituzione rappresentativa: questa nozione connota non solo l’esigenza della sua
continuità storica ma anche la sua capacità di autoconvocazione. Benché le regole costituzionali
possano prevedere delle sessioni obbligatorie, i parlamentari hanno la garanzia di una totale autonomia
nell’organizzare il proprio lavoro.
Potere legislativo: benché assai diverse nel loro reale impatto nei processi concreti di produzione di
norme, tutte queste istituzioni si propongono come organi legislativi, e associano a tale facoltà una
serie di importanti funzioni.
Secondo queste coordinate, arriviamo ad una definizione operazionale: si tratta di organi legislativi
elettivi, formati da una pluralità di rappresentanti dei soggetti (partiti) che si occupano di selezionare il
ceto politico e che vengono organizzati in modo assembleare.
2. Idee e pratiche della rappresentanza
2.1. L’evoluzione del concetto in ambito democratico
Successivamente all’età delle rivoluzioni ed in parallelo allo sviluppo dello Stato liberale, la riflessione
sulla nozione di “rappresentanza” si è concentrata sugli effetti reali del rapporto politico che si
instaura tra rappresentanti e rappresentati.
Si deve attendere l’epoca della democrazia matura per una definizione teorica di “rappresentanza”
come quella di Hanna Pitkin, considerata unanimemente un riferimento ancora essenziale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Hanna Pitkin (1931-) è una studiosa di origine tedesca cresciuta negli Stati Uniti e a lungo attiva
all’Università della California. Pitkin è nota soprattutto per il suo contributo sulla rappresentanza
politica. In particolare, il suo The Concept of Representation ha avuto il merito di far ripartire il
dibattito sulle implicazioni dell’applicazione empirica della rappresentanza e le problematiche che tali
pratiche creano nel funzionamento delle istituzioni contemporanee.
Pitkin focalizzava dapprima l’idea di “rappresentanza” nei classici del pensiero politico, per giungere a
definire quattro varianti teoriche: quella “simbolica”, quella “descrittiva”, quella “formalistica” e infine
quella “sostantiva”.
Pitkin argomentava che non può esistere una perfetta correlazione tra l’applicazione di uno di questi
significati e una specifica variante di rappresentanza politica.
Nel caso delle nostre democrazie, ad esempio, si può dire che la rappresentanza simbolica e la
rappresentanza descrittiva siano meno rilevanti, ma certamente non sono del tutto assenti:
l’evocazione di certe figure istituzionali (es. il capo dello Stato) che raffigurano ad esempio l’unità
nazionale, è una forma frequente di rappresentanza simbolica, mentre sono ancora presenti in molte
democrazie delle istituzioni di rango costituzionale, sia pure non sempre cruciali (in Italia, ad es., il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) costruite per proiettare nel sistema politico un qualche
specchio della struttura sociale del paese, ripercorrendo elementi di quella rappresentanza sociale o
corporativa che fu invece tipica nelle assemblee di alcuni regimi non democratici, inclusi il fascismo e
l’Unione Sovietica.
Merita invece soffermarsi sulle altre due nozioni di rappresentanza.
Relativamente alla nozione di rappresentanza formalistica, Pitkin rileva i due concetti fondamentali
a) dell’autorizzazione conferita dalla comunità ai governanti e b) della responsabilità che muove questi
ultimi nel tentativo di condurre al meglio il compito che viene loro affidato.
Entrambi i concetti sono centrali nella nostra accezione di “rappresentanza democratica”, perché
evocano i due aspetti sostanziali della teoria della delega: il conferimento dell’autorità è fondamentale
per riconoscere al delegato (o agente) un ruolo formale di unico soggetto chiamato a sviluppare in
termine di azioni il mandato rappresentativo.
La responsabilità (accountability) è necessaria per richiamare detta azione ai principi e ai valori alla
base del mandato, che in democrazia è per definizione volontario e revocabile.
[La rappresentanza sostantiva fa riferimento all’azione concreta del rappresentante. Il rappresentante
è tale se agisce nell’interesse del rappresentato, anche se tale “agire nell’interesse” dovesse
discostarsi da una interpretazione formale del mandato ricevuto. Questa accezione sembra più vicina
ad una visione del rappresentante come fiduciario].
2.2. Rappresentanza partitica, circuiti alternativi e approcci individualistici
Il consolidamento di un sistema dei partiti ha costituito un fattore fondamentale per forgiare il
comportamento dei rappresentanti popolari.
In Europa, in particolare, i partiti sono divenuti il fulcro del sistema politico proprio perché sono stati
in grado di sviluppare circuiti della rappresentanza sociale, rendendo gli attori collettivi presenti nella
società – gruppi di interesse e movimenti sociali – in larga misura dei fiancheggiatori del proprio
establishment.
Questa formula storica, legata alla fase aurea dei partiti di integrazione di massa e poi dei catch-all
parties, può essere definita come rappresentanza partitica, e prevede come condizioni fondamentali il
pieno controllo da parte di queste organizzazioni sia sulla fase di selezione del personale da destinare
alle assemblee rappresentative che sulla disciplina dei rappresentanti eletti.
La penetrazione partitica nelle assemblee rappresentative ha costituito un passaggio fondamentale nel
percorso di maturazione della democrazia.
Analogamente, oggi si può sostenere che la capacità dei partiti di porsi come latori di domande e
interessi proiettati coerentemente e ordinatamente attraverso le loro articolazioni parlamentari
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
rappresenti un elemento di criticità, anche laddove i partiti contano molto: a seconda della faccia
organizzativa del partito che prendiamo in considerazione (i politici eletti, i dirigenti centrali e la base)
il risultato della proiezione delle idee e del programma del partito nel comportamento di chi lo
rappresenta è molto diverso.
Inoltre, la capacità del partito “centrale” di controllare l’operato dei parlamentari ha avuto un ulteriore
ridimensionamento con la diminuzione della forza organizzativa dei partiti, anche a causa di una serie
di elementi di antipolitica e di sfiducia, che rende più difficile il predominio di un attore come quello
partitico.
In virtù di ciò, si sono sviluppati vari circuiti alternativi rispetto alla classica modalità della
rappresentanza politica.
La letteratura ha modellato dei circuiti chiaramente alternativi ad un predominio totale dei partiti nelle
arene rappresentative: il primo di essi è determinato da un accentuato assetto neocorporativo, tipico di
alcune democrazie – ad esempio quelle nordiche – la cui articolazione di interessi consente di produrre
molte rilevanti decisioni attorno ad un tavolo governativo al quale ha accesso una gerarchia ordinata e
chiusa di attori sociali (es. i rappresentanti di industria e del sindacato generale), lasciando al
parlamento partitico un compito notarile di “validazione” degli accordi.
Il neocorporativismo finisce per incidere inevitabilmente sul funzionamento delle istituzioni
rappresentative, che si trovano ad agire “ a valle” e non più “a monte” delle decisioni.
Anche il modello pluralista di rappresentanza degli interessi, quello basato su una società
estremamente aperta e frammentata in tanti gruppi sociali tra loro in competizione (es. Stati Uniti), può
tuttavia condurre al declino del ruolo dei partiti.
I singoli rappresentanti eletti possono essere portati ad “assomigliare” o addirittura “inseguire” il
proprio universo sociale di riferimento, tralasciando la mediazione partitica, prendendo strade diverse a
seconda della competenze e delle sensibilità individuali.
Il tema si è manifestato anche in Italia durante la recente transizione, durante la quale sono stati notati
fenomeni interessanti, e al tempo stesso preoccupanti, come l’aumento di comportamenti di voto di
dissenso all’interno dei gruppi parlamentari e soprattutto gli episodi di abbandono del gruppo partitico
originario.
Il ricorso all’argomentazione del tipico dettato costituzionale liberale del divieto di mandato
imperativo da parte del singolo eletto può essere un mezzo per superare l’immagine di un parlamento
addomesticato dagli apparati partitici, ma anche una scusa per mettere in campo una serie di
comportamenti opportunistici.
2.3. Parlamenti e sistemi elettorali
Partiamo da un sistema proporzionale puro come quello olandese: una camera eletta con metodo di
lista e voto di preferenza, in cui i seggi sono ripartiti in misura del risultato riportato a livello nazionale.
Anche il caso del Knesset israeliano è senza dubbio da annoverare tra i proporzionali puri.
La bassa soglia di ammissione al riparto (2%), e la “lista bloccata” che implica la selezione preventiva
del partito (o dei suoi iscritti/simpatizzanti attraverso forme di “elezioni primarie”) dei candidati nella
posizione di vertice della lista, non incidono certamente sul livello di proporzionalismo.
Un proporzionalismo più temperato può essere garantito attraverso varie forme di correzione del
sistema elettorale: quello per l’elezione del Bundestag tedesco, ad esempio, prevede un doppio tipo di
voto, dovendo i cittadini esprimersi per un candidato all’interno di una competizione uninominale e per
una lista partitica.
Questo secondo voto è decisivo per la composizione finale della camera, assicurando il bilanciamento
proporzionale a livello nazionale attraverso l’attribuzione della metà dei seggi in misura della cifra
elettorale nazionali di ogni lista, tenuto conto dei seggi già incamerati dai partiti attraverso la
competizione uninominale.
L’elemento fondamentale per limitare il proporzionalismo è assicurato dalla soglia abbastanza elevata
(5%) che comporta l’esclusione di vari partiti.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Anche il sistema spagnolo offre una sostanziale limitazione al proporzionalismo, senza aggiungere un
secondo livello di voto ma semplicemente moltiplicando le circoscrizioni (che in Spagna
corrispondono alle province).
In pratica, i partiti piccoli (a meno che non abbiamo grandi performance in specifici territori, come
accade ad alcune formazioni regionaliste), vengono esclusi dall’elevata soglia implicita, alla quale si
aggiunge una soglia circoscrizionale del 3%.
Anche in Italia, dopo la lunga stagione proporzionale della Prima Repubblica sono stati introdotti dei
correttivi, per garantire maggiore stabilità al governo, battendo tuttavia strade molto diverse.
Il sistema usato tra il 1994 e il 2001 era in senso stretto “misto” perché combinava l’uso dei collegi
uninominali (per il 75%) con liste circoscrizionali che garantivano un qualche bilanciamento
proporzionale.
Il sistema in vigore dopo il 2006 è invece un sistema proporzionale che garantisce – con la logica del
“premio di maggioranza” – un minimo del 55% dei seggi alla coalizione maggioritaria a livello
nazionale. Tecnicamente, si tratta di una vistosa correzione maggioritaria, che però può essere
“spalmata” in modo assai diverso, a seconda della natura della coalizione stessa.
Passiamo ai sistemi maggioritari.
Se il sistema britannico si risolve semplicemente con la vittoria del candidato più votato in ogni
collegio, il modello francese richiede una maggioranza assoluta di collegio.
In mancanza di vincitore, si va al ballottaggio, al quale sono ammessi i candidati con almeno il 12,5%
dei voti, aprendo nel quel caso i giochi all’eventuale convergenza dei voti degli esclusi o anche
possibili “desistenze” di candidati pure ammessi al ballottaggio che tuttavia preferiscono rinunciare ad
un piazzamento non remunerativo per sostenere il male minore tra i due competitori più popolari.
In qualche modo a metà tra questi due ultimi modelli, il voto alternativo adottato in Australia offre un
meccanismo diverso per il raggiungimento di una maggioranza assoluta in un contesto uninominale,
attraverso l’obbligo per gli elettori di ordinare le proprie preferenze sui vari candidati, che consente, in
caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta da parte di nessun candidato, la
redistribuzione di ulteriori preferenze subordinate.
Riepilogando:
Olanda – Proporzionale puro
Israele – Proporzionale puro
Germania – Tendenzialmente proporzionale
Spagna – Proporzionale molto corretto
Italia (2006-2013) – Forte correzione maggioritaria
Italia (1994-2001) – Maggioritario con ampia correzione proporzionale
Francia – Maggioritario (ma con maggioranza “assoluta”)
Australia – Maggioritario (ma con maggioranza “assoluta”)
Regno Unito – Plurality
Converrà chiarire sin da subito che un “buon sistema elettorale” è sempre definito sulla base di quella
che è la propria visione della democrazia, per cui non abbiamo la possibilità di migliorare i nostri
parlamenti e quindi la democrazia affidandoci semplicemente all’ingegneria elettorale.
Tuttavia, una sana analisi dei dati ci aiuta a capire quali sono i sistemi elettorali “sbagliati”, perché non
risolvono determinati problemi endemici e anzi ne creano altri.
Non si può non menzionare il caso della riforma del 2005 che ha reintrodotto in Italia il sistema
proporzionale (questa volta utilizzato nella variante a lista bloccata), spazzando via i relativi effetti
benefici creati nel decennio precedente dall’uso (parziale) dei collegi uninominali, ma senza rispondere
all’esigenza di governabilità.
Infatti, nel 2006, le elezioni hanno visto un esito molto incerto al Senato (con la maggioranza della
frammentatissima coalizione di centro-sinistra consistente in appena due soli senatori) e nel 2013
l’incredibile “pareggio” tra Pd, Pdl e Movimento 5 stelle ha determinato una situazione gestibile
soltanto attraverso la creazione di grandi coalizioni o convergenze occasionali diverse rispetto agli
schieramenti originari.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In generale, sappiamo che i sistemi elettorali provocano effetti diretti o indiretti.
I primi sono effetti evidenti nella diversa trasformazione dei voti in seggi, mentre i secondi riguardano
le reazioni nel mutamento della domanda e dell’offerta elettorale: ad esempio, le reazione strategiche di
partiti e candidati (offerta) e degli elettori (domanda) di fronte a un cambiamento delle regole del
gioco.
Inoltre, è necessario fissare la differenza tra effetti “macro” (ovvero sul funzionamento dei meccanismi
del sistema politico) oppure a livello “micro” (ovvero nel rapporto tra chi ha votato e l’eletto o gli eletti
espressi da una determinata circoscrizione). La scelta di un singolo elettore di un collegio (uninominale
maggioritario) di non esprimere preferenza per il proprio candidato (del tutto escluso dalla lotta) al fine
di sostenere il “migliore dei mali” tra gli altri candidati è un effetto indiretto a livello locale.
Concentrandoci sugli effetti del sistema elettorale connessi alla mera capacità rappresentativa di
rappresentanti e assemblee, possiamo classificare essenzialmente tali effetti in tre tipi:
1. effetti meccanici (o diretti) sul livello macro della rappresentatività degli eletti;
2. effetti meccanici sul livello micro dell’autonomia individuale e della responsabilità degli eletti;
3. effetti indiretti sulla strategia di azione rappresentativa di eletti e dei loro selettori.
La letteratura sulla rappresentanza di genere nei moderni parlamenti è unanime sulla generalizzazione
per cui i sistemi proporzionali generano maggiori opportunità per un bilanciamento più rapido della
rappresentanza femminile.
Questo è un esempio del primo tipo di effetti sopra richiamato.
L’argomentazione che la vita di un candidato all’interno del suo territorio e il cosiddetto costuency
service (impegno legislativo e di promozione degli interessi del collegio) sia favorito da una
indicazione diretta e personale (e quindi dal voto uninominale) costituisce un esempio tipico del
secondo tipo.
3. Funzioni e strutture delle assemblee rappresentative democratiche
3.1. Il problema del bicameralismo
I parlamenti possono essere distinti in “parlamenti unicamerali” e “parlamenti bicamerali”.
Storicamente, l’articolazione in due (o anche più) camere rappresentava la necessità di distinguere i
ceti sociali ammessi alla rappresentanza, i quali però non potevano essere confusi tra loro mantenendo
prerogative e gradi di influenza distinti.
Il bicameralismo britannico costituisce il retaggio più evidente di tale struttura, con la Camera dei Lord
che appare oggi una sorta di “vestigia”, un braccio parlamentare marginalizzato oscillante tra
l’omaggio alla tradizione ed una “riconversione” a lungo dibattuta e per ora senza effetti.
In genere, i bicameralismi servono a qualcosa di più concreto: ad esempio, a bilanciare la
rappresentazione tra le tante “comunità” presenti in un sistema politico, oppure rendere possibile una
più meditata azione (legislativa, piuttosto che di controllo o di inchiesta) condotta sulla base di
sensibilità e competenze più ampie rispetto a quelle garantite da un’unica camera.
Se è vero che il declino delle componenti predemocratiche ha inevitabilmente trasformato alcune
assemblee bicamerali in unicamerali – mentre il contrario non è mai avvenuto a partire dal secondo
dopoguerra – è altrettanto vero che tale dinamica sembra essersi arrestata, lasciando ai bicameralismi
un netto predominio (Lijphart, 14 unicameralismi su 36 democrazie).
Vi è una netta correlazione tra impiego del bicameralismo e dimensione del sistema politico, così come
è evidente che i paesi federali e complessi sotto il profilo culturale tendono a sviluppare seconde
camere con poteri istituzionalmente rilevanti.
Ma sarebbe altrettanto facile provare che queste dimensioni non sono le uniche in gioco, come
dimostra il caso del Canada, paese grande e federale, che tuttavia ha una seconda camera piuttosto
debole e non legittimata dal voto popolare.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
È allora più corretto partire da una situazione opposta: l’unicameralismo è una situazione istituzionale
perseguibile nel caso di sistemi politici semplici, relativamente piccoli e connotati da omogeneità
politico-culturale.
La figura riprende le tipologie
presentate da Lijphart. In sostanza, i
bicameralismi più influenti (o forti)
sono connotati da poteri equivalenti
nelle due camere e diversa capacità
rappresentativa.
Le seconde camere deboli, quelle
caratterizzate da poteri molto inferiori
rispetto alle prime, possono distinguersi
tra forme di palese incongruenza
rappresentativa, come le camere di
rappresenta nobiliarie o nomina (Regno
Unito, Canada), o parti di un sistema di
divisione funzionale dei compiti legislativi nel quale, pur rivestendo ruoli inferiori (pareri, revisione
non vincolante delle iniziative legislative ecc.), esse possono “specializzarsi” grazie ad alcune facoltà
residuali, adatte ad un corpo politicamente legittimato che rappresenta le varie componenti di una
nazione complessa.
I due esempi del senato irlandese e del Bundestrat austriaco, entrambi formati da parlamentari delle
assemblee subnazionali, ne costituiscono altrettanti esempi.
La quarta categoria, quella delle seconde camere con poteri uguali ma con una forte congruenza nelle
modalità rappresentative al cospetto delle prime, determina quello che è stato chiamato bicameralismo
ridondante, dove le seconde camere, pur “forti”, finiscono per indebolire il sistema senza aggiungere
una capacità rappresentativa alternativa o complementare.
L’Italia repubblicana è stata un esempio paradigmatico di questo tipo di formato bicamerale, formato
che però è divenuto un problema dopo che il sistema elettorale introdotto nel 2005 non ha potuto
garantire una politica coerente con la Camera dei deputati.
In questo caso, un braccio parlamentare di uguali dignità politica e con pari poteri, ma con una
composizione diversa, diventa un incredibile punto di veto istituzionale, capace di tenere in scacco
l’intero processo politico.
3.2. Articolazione strutturali interne alle assemblee legislative
Gli organi legislativi mostrano una grande varietà di soluzioni strutturali in relazione a molte
dimensioni.
In primo luogo, esse possono essere più o meno “vaste”.
Si è soliti fare riferimento ad una correlazione evidente tra la grandezza della comunità da
rappresentare e l’ampiezza delle camere, e qualche autore ha formalizzato tale correlazione con una
equazione tra numero di rappresentanti eletti e radice cubica della popolazione nazionale.
Tale legge è tuttavia rispettata con grande approssimazione , e questo lascia supporre che alcuni paesi
con evidenti problemi di complessità e “compromessi istituzionali” difficilmente negoziati tra partiti e
componenti sociali (es. Italia del secondo dopoguerra) abbiano avuto bisogno di un parlamento
particolarmente numeroso.
In secondo luogo, non va sottovalutata la struttura di coordinamento e conduzione istituzionale delle
assemblee.
È pur vero che la pari dignità degli eletti non consente una distinzione sul ruolo eminentemente
politico, dando al presidente un voto più “pesante” come si fa spesso negli organi esecutivi.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Al contrario, in molti parlamenti il presidente, per prassi, tende a non esprimere il proprio voto per
preservare il suo ruolo di garante all’interno dell’assemblea.
Ma è anche vero che i poteri di calendarizzazione dei lavori, stralcio di pratiche o proposte non
consone e accelerazione di alcuni processi utilizzando leve come la convocazione di “sessioni
straordinarie”, costituiscono facoltà molto importanti concentrate nelle mani degli speakers o, al
massimo, di ristretti uffici di presidenza delle camere.
Questi poteri possono essere in qualche misura “annacquati” dalle prerogative di ulteriori articolazioni
interne in cui una grande camera si divide per organizzare i propri lavori con ritmi di lavoro e
competenze più idonee: sono le commissioni parlamentari, le quali tuttavia costituiscono un insieme
eterogeneo di meccanismi strutturali.
Le più importanti sono le commissioni permanenti, soggetti molto autorevoli (soprattutto sul piano dei
processi legislativi e nel controllo sul governo) che possono sviluppare competenze e conoscenze
specifiche: se assistite da una qualche autonomia decisionale e da adeguate risorse conoscitive, tali
articolazioni possono diventare le vere protagoniste della centralità politica di un dato organo
legislativo.
Lo stereotipo dell’articolazione legislativa interna forte è rappresentato dalle commissioni permanenti
nei due bracci del Congresso Usa, che concentrano tutti gli elementi appena menzionati: poteri di
iniziativa, poteri di istruttoria e anche di emendamento sui testi in discussione; poteri di controllo e di
interrogazione nei confronti del governo; poteri di consultazione e audizione anche in materie come
nomine pubbliche e rapporti internazionali, staff molto professionalizzati e competenti nel settore
scientifico coperto dalle mansioni della commissione.
Infine, è tipico delle commissioni del Congresso il grande prestigio delle loro cariche apicali, che
diventano un’“ambizione” politica non secondaria al cospetto di cariche come membro del governo,
capo del partito parlamentare o membro dell’ufficio di presidenza.
Le commissioni parlamentari italiane, benché complessivamente meno efficaci di quelle americane, a
causa di un impatto istituzione inferiore, sono collocate idealmente in alto in una classifica di
“decentramento delle facoltà parlamentari”, anche per il potere – unico nel suo genere – di sostituzione
integrale rispetto all’aula nell’adozione di alcune misure legislative (sia pure non quelle più rilevanti).
In terzo luogo, naturalmente, è cruciale anche l’articolazione interna all’assemblea relativa allo
sviluppo di gruppi partitici.
I gruppi possono rappresentare lo strumento principale per il controllo delle organizzazioni partitiche
esterne sui propri eletti, ma anche un modo per opporre all’apparato di partito un secondo
establishment avvantaggiato alla sua centralità istituzionale.
Infine, un elemento fondamentale da analizzare è quello relativo alla posizione che il governo
riveste nelle stese articolazioni parlamentari: lo spazio dedicato al governo è infatti un indicatore
evidente del tipo di rapporto che si intende favorire all’interno di un’aula parlamentare.
Nella Camera dei comuni britannica, la posizione “schierata” nei primi banchi di una delle due ali in
cui si divide l’aula indica l’ideale fusione tra i membri di un governo molto presente e la maggioranza
parlamentare.
Nei parlamenti tendenzialmente consensuali, sia nei paesi (come l’Italia) nei quali l’estrazione dei
ministri è tendenzialmente parlamentare che (a maggior ragione) in quelli dove il personale di governo
viene reclutato fuori dal parlamento, i banchi del governo sono ubicati in una posizione esterna al
tipico emiciclo (generalmente al centro, sotto gli scranni dell’ufficio di presidenza).
Ma la posizione del governo può essere misurata anche con indicatori non relativi alla sua presenza
“fisica”: una serie di precise facoltà possono infatti consentire all’esecutivo di “dominare” l’agenda
parlamentare, imponendo i propri temi e le proprie iniziative.
Tra queste, la possibilità di incidere sull’agenda parlamentare, imponendo una corsia privilegiata alle
proprie iniziative, quella di comunicare in modo urgente particolari decisioni attraverso messaggi o
discorsi in aula dei propri componenti, e quella di intervenire in tutte le sedi legislative (commissioni o
aula) anticipando rispetto alla discussione il proprio orientamento.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4. Come cambiano le funzioni parlamentari
4.1. Dalle definizioni classiche all’analisi delle funzioni parlamentari
Walter Bagehot è l’autore che per primo ha evidenziato la funzionalità dei parlamenti moderni.
In La Costituzione inglese (1867), Bagehot offriva una mirabile esemplificazione di come le assemblee
fossero capaci di allargare e riqualificare lo spettro delle proprie facoltà, divenendo la fondamentale
cerniera istituzionale di quel regime che cominciava ad assomigliare a una democrazia rappresentativa.
In questa visione, accanto alla tradizionale funzione elettiva, trovavano posto la funzione espressiva
(capacità di raggiungere tutti i cittadini con una corretta rappresentazione di diritti e doveri), quella
educativa (capacità di contribuire alla crescita collettiva della nazione), quella finanziaria (capacità di
fissare e rendere trasparente gli impegni di spesa e il reperimento delle risorse pubbliche) e infine la
classica funzione legislativa.
La classificazione di Bagehot appare oggi per molti aspetti superata: alcune funzioni storiche si sono
sovrapposte e comunque assumono un significato completamente diverso rispetto al passato.
I lavori di politica comparata che hanno classificato parlamenti e congressi incrociando le loro funzioni
formali con l’effettiva capacità di influenza semplificano le dimensioni funzionali in tre aggregati:
1. come agente del corpo elettorale e, in definitiva, del popolo sovrano, i parlamenti e i congressi
devono rappresentare le istanze e trasferirle nel sistema decisionale (funzione rappresentativa);
2. come “principale” rispetto ai meccanismi decisivi del sistema politico, essi devono sostenere precise
richieste ai titolari delle tante amministrazioni e monitorarne i comportamenti (funzione di controllo
sul governo, anche se nel sistema parlamentare rimane fondamentale la funzione “elettiva”, ovvero il
ruolo del parlamento nella formazione del governo);
3. infine, la “vecchia” funzione legislativa, che comprende la funzione finanziaria individuata da
Bagehot, vista la natura normativa di gran parte degli odierni strumenti di finanza pubblica.
4.2. Vecchie e nuove capacità rappresentative
Gli eletti nelle assemblee fanno tante cose, a cominciare da un continuo lavoro di proiezione delle
visioni presenti nella società.
La condizione necessaria per mettere in atto tale funzione è un sufficiente pluralismo interno.
Su questo piano, torna ovviamente utile il confronto tra la visione consensuale e quella maggioritaria
della politica democratica: il parlamento tipico della democrazia consensuale, scelto con un accentuato
principio di proporzionalità, risulta naturalmente orientato a rappresentare le molte voci di una società
frammentata.
I parlamenti bipartitici delle democrazie maggioritarie, al contrario, rappresentano essenzialmente le
due parti (ovvero i due partiti) che incarnano le visioni politiche preponderanti, lasciando tuttavia ai
singoli rappresentanti il compito di difendere, attraverso l’iniziativa legislativa “personale” il proprio
collegio e quindi il “territorio” in esso compreso.
Tuttavia, molti sono i fattori in gioco nello svolgimento della funzione rappresentativa: alcuni aspetti
della rappresentanza specchio sono stati riproposti recentemente, causando una profonda
trasformazione nella capacità rappresentativa dei nostri parlamenti.
L’elemento forse più evidente di questa evoluzione è stato negli ultimi decenni l’aumento esponenziale
della presenza femminile nelle assemblee, che tuttavia non corrisponde necessariamente ad un effettivo
superamento del gender gap in politica, sia perché il ruolo rappresentativo delle donne elette non
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
necessariamente anticipa un cambiamento delle politiche di pari opportunità, sia perché, più
banalmente, il risultato complessivo in termini di rappresentanza femminile è in realtà la sintesi di una
distribuzione ancora largamente sbilanciata.
Ad esempio, il caso italiano, presentava fino al 2013 un tasso di presenza parlamentare femminile
inferiore al 20%.
Altri elementi della trasformazione di lungo periodo dei profili delle élite parlamentari ci dicono delle
loro mutate capacità rappresentative.
I nostri rappresentanti tendono a “inseguire” i cambiamenti sociali sul piano delle loro competenze
tecniche e della loro preparazione culturale: le esperienze ingegneristiche e tecnico-scientifiche stanno
bilanciando la prevalenza della cultura umanistica e soprattutto la grande presenza di giuristi.
La capacità rappresentativa delle assemblee sta inoltre rispondendo alle sfide poste alle antiche
funzioni educativa e informativa.
Molti parlamenti e congressi democratici (ma anche i singoli eletti) hanno sviluppato una propria
mansione di “collettore”, attraverso il web e i social network, delle istanze provenienti dalle periferie
anche più lontane della società.
4.3. Parlamenti, leggi e processi decisionali
Possiamo identificare tre dimensioni sulle quali misurare l’effettivo impatto decisionale delle
istituzioni rappresentative: a) reputazione individuale del rappresentante, b) estensione dei poteri
legislativi in senso stretto, e c) capacità di interdizione dei rappresentanti sul flusso e sulla qualità della
produzione legislativa.
La reputazione dei singoli rappresentanti eletti costituisce una prerogativa fondamentale per fare di
un singolo individuo un attore credibile nei processi decisionali.
Sotto questo aspetto, non si può certo dire che i parlamentari, pur formalmente uguali dentro l’aula,
debbano sempre avere un peso decisionale simile: chi riveste un ruolo di difensore del territorio o di
esperto in uno specifico settore decisionale – ad esempio, la politica agricola – dovrà verosimilmente
faticare per vede emergere il proprio progetto di legge o i propri emendamenti.
Al contrario, i leader del gruppo parlamentare e i vertici di commissione e di aula possono contare sulle
proprie prerogative politiche, nonché sul proprio potere di influire sull’agenda dei lavori, al fine di
regolare ampi “pacchetti” di proposte e dare al flusso del processo decisionale un preciso ordine.
Quanto alla dimensione delle facoltà legislative in senso stretto, gioca una parte fondamentale la
quantità di poteri rimasti in mano ai parlamentari di fronte alle facoltà di agenda, iniziativa e riserva
legislativa delegati al governo.
Sul piano della capacità di interdizione durante i flussi decisionali, un fattore fondamentale è costituito
dalle regole che consentono ai legislativi di rallentare se non bloccare l’azione del governo: tali regole
disegnano il livello di concentrazione del controllo sul processo legislativo.
Non è facile tuttavia stabilire una misura di tale livello, dato l’intrecciarsi di dettami costituzionali,
leggi ordinarie e soprattutto le importantissime regole interne alle assemblee che spesso fanno la
differenza. Contano naturalmente anche le prassi che si instaurano tra gli attori.
In Italia, il compito di sbrogliare la matassa di un’agenda controversa, cade spesso su un’altra
articolazione tendenzialmente consensuale: la conferenza dei capigruppo, che rappresenta tutti i partiti
parlamentari e che coadiuva il presidente di assemblea nella determinazione del calendario o nella
scelta di una specifica procedura.
Un intreccio complesso di regole e pratiche spiega anche il ruolo del parlamento nei processi di
correzione della finanza pubblica – l’antica funzione baghettiona di bilancio.
Recentemente, un fortunato filone di studi ha approfondito proprio il tema della disciplina di bilancio,
ovvero la ricerca di una procedura adatta per favorire un comportamento esemplare di tutte le
istituzioni coinvolte nel processo, e in questo contesto la riduzione dell’opportunismo dei parlamentari,
unitamente alla ricerca di una performance efficace ed efficiente (tempi chiari, decisioni chiare,
previsioni giuste) nel rispetto dei vincoli di tipo costituzionale, che solitamente danno al governo la
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
riserva di iniziativa ma alle assemblee il voto e in molti casi significativi poteri di emendamento su
bilanci e norme annuali di assestamento (leggi finanziarie, leggi di stabilità, ecc.).
4.4. Il controllo sul governo
Il rapporto tra organo legislativo ed esecutivo costituisce un tema classico di confronto per gli studiosi
della politica comparata.
Tutte le interpretazioni sul ruolo dell’articolazione maggioranza-opposizione, mettono in evidenza
l’importanza di una misurazione della forza “istituzionale”. Ma anche la natura unitaria o meno del
sostegno politico di maggioranza.
L’intreccio di queste variabili genera una grande varietà di configurazioni con le quali un legislativo
può contrastare e controllare le attività di governo.
Tuttavia, a questo tipo di controllo meramente “politico”, orientato soprattutto a garantire le minoranze
e le forze non rappresentate nell’esecutivo, si aggiunge una più ampia e fattiva attività tecnica di
screening dei singoli parlamentari, esercitata sia ex ante sulla fase ascendente dei processi che ex post
sui riflessi e sui risultati delle amministrazioni.
La storia parlamentare italiana recente può fungere come esempio.
Nella Prima Repubblica si parlava costantemente della centralità parlamentare discesa dalla
Costituzione e dai regolamenti parlamentari repubblicani, che esaltavano proprio le ampie facoltà di
controllo politico del legislativo, con il conseguente indebolimento della capacità di formulazione delle
politiche del governo.
A lungo si è parlato del bisogno di razionalizzazione del rapporto parlamento-governo, finalità
inseguita con l’adozione di alcune leggi, di alcuni importanti cambiamenti nei regolamenti
parlamentari e anche di alcuni tentativi di emendamento della stessa Costituzione.
Tuttavia, i due decenni successivi alla “rivoluzione” del 1994 mostrano chiaramente che i vincoli dati
dalla frammentazione nella maggioranza (non necessariamente tra i partiti ma anche nei partiti), quelli
di natura costituzionale e procedurale (es. la capacità dei parlamentari di tenere in scacco i governi
emendando e bloccando le sue più rilevanti iniziative) e la strenua difesa del proprio ruolo da parte
degli eletti nelle due camere, finiscono per determinare esiti non molto diversi da quelli a cui il sistema
politico italiano era tradizionalmente abituato in termini di rapporto tra governo e parlamento.
Evidentemente, la razionalizzazione del rapporto legislativo-esecutivo è un processo lungo che implica
trasformazioni dell’intero impianto democratico di un sistema, non facilmente ottenibili con delle
operazioni di lifting delle regole parlamentari.
Venendo alla dimensione della quotidiana sorveglianza sulle attività di governo, è palese
l’osservazione del nesso tra forza di questa attività e i meccanismi rappresentativi di base: il collegio
uninominale favorisce una naturale propensione al rapporto con la comunità locale.
Analogamente, si può dire che la lista bloccata sia un formidabile mezzo per centralizzare la scelta
degli eletti rendendoli funzionali (se non subordinati) alle strategie complessive dei loro selezionatori.
Tuttavia, in entrambi i casi, la densità e la complessità delle organizzazioni che fungono da
selezionatore (ovvero i partiti) nonché il livello di autonomia tradizionalmente riservato ai membri
dell’assemblea rappresentativa possono fare la differenza.
In sintesi, gli strumenti di controllo da parte dei legislatori rispetto a governo e amministrazione
possono essere classificati nel seguente modo:
1. question time direttamente rivolto ai responsabili della conduzione di governo;
2. azioni di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze);
3. audizioni nell’ambito delle facoltà informative e legislative;
4. inchieste.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il question time e le azioni volte specificatamente ai responsabili dell’azione di governo sono uno
strumento tipico dei sistemi maggioritari, dove l’esecutivo, “fuso” con la sua maggioranza
parlamentare, viene incalzato dall’opposizione.
Le altre attività di potere “ispettivo” possono invece contenere gli obiettivi più diversi: semplice
“voglia di rappresentare”, oppure più o meno sottili tentativi di orvietane l’agenda del governo, ricerca
di convergenza con gli altri partiti parlamentari, o semplicemente (si tratta del caso più frequente)
volontà di apparire nelle cronache al fine di portare avanti l’obiettivo individuale per eccellenza: la
rielezione.
Le audizioni costituiscono uno strumento utile per varie finalità, ma orientato essenzialmente a
conoscere il punto di vista e le informazioni provenienti dalla società civile così come da altri poteri
dello Stato.
Le inchieste, infine, si rifanno alle facoltà aggiuntive degli organi legislativi ed alla loro autonomia
rispetto agli altri poteri dello Stato.
Se unito ad un’adeguata struttura informativa, tale strumento fa di alcune commissioni dei potenti
“giudici aggiunti”: è il caso di alcune celebri commissioni di inchiesta del Congresso Usa –
temutissime dallo stesso entourage presidenziale – ma anche istituzioni come la Commissione
parlamentare di inchiesta sulla Mafia in Italia.
5. Le assemblee rappresentative oltre la dimensione nazionale
5.2. Il ruolo delle assemblee territoriali nel sistema politico
Il primo elemento da mettere a fuoco è quello della crescita funzionale e “reputazionale” delle
assemblee territoriali.
Negli ultimi anni, sia il livello complessivo di “potere legislativo” delle assemblee subnazionali che la
loro capacità di controllo sull’operato del governo centrale è aumentato in modo consistente, tanto da
spingere gli autori a parlare di un’“era di regionalizzazione”.
Tale crescita risente di diversi fenomeni. In parte, si tratta di processi di pressione dal basso che hanno
determinato l’erosione dello Stato centrale e la dinamica federalizzazione in molte realtà (soprattutto
europee).
Negli ultimi decenni si sono imposti anche percorsi più complessi di collaborazione interistituzionale
che attribuiscono alle assemblee regionali compiti di monitoraggio su specifici processi decisionali o
addirittura la competenza su interi settori di politiche pubbliche che vengono così sottratte al
legislatore centrale, per effetto di un poderoso percorso di decentramento o per la sopraggiunta
imposizione di un modello di sussidiarietà.
È il caso del sistema politico italiano, che dopo la riforma costituzionale del 2001 ha sicuramente
potenziato e comunque reso più evidente l’esistenza di potestà legislative esclusive oppure concorrenti
da parte degli enti regionali.
Tuttavia, gli osservatori sono concordi nell’affermare che il processo di istituzionalizzazione dei
parlamenti regionali è legato a un complesso di elementi strutturali che va ben al di là della pur
importante “emancipazione” sul piano legislativo.
Possiamo individuare le cause di tale processo in tre dimensioni fondamentali.
1. La percezione pubblica della rappresentanza subnazionale.
Alcuni fattori recentemente studiati dall’analisi comparata dei parlamenti locali, come l’aumento del
livello di professionalizzazione (e quindi l’introduzione di cospicui salari per gli eletti, il
potenziamento delle risorse organizzative e la sempre più incisiva copertura mediatica) ci mostrano
che il destino della rappresentanza politica subnazionale sembra essere più luminoso rispetto ai
tradizionali parlamenti.
2. Lo sviluppo dei parlamenti subnazionali come vere e proprie arene politiche.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In qualche misura si può considerare lo sviluppo di questa dimensione come una conseguenza della
precedente.
Infatti, una diversa visibilità dei rappresentanti locali e territoriali dovrebbe automaticamente favorire
l’aumento del prestigio rivestito da tale ruolo anche per gli stessi politici.
Non ci sono dubbi che nell’ultimo scorcio storico il “posto” da membro elettivo di assemblea regionale
(o statale, se ci troviamo in un contesto federale) diventa sempre più ambito, perché garantisce non
solo una buona remunerazione finanziaria ma anche politica.
3. L’evoluzione del ruolo rappresentativo.
Molto spesso, i parlamenti regionali diventano anche portatori di un’idea diversa di “rappresentanza”.
Ridotti nella dimensione ma più vicini alla popolazione, questi snodi istituzionali si propongono di
rappresentare in modo diverso gli strati della popolazione meno presenti nell’establishment, le
minoranze e i “nuovi arrivati” all’interno di una comunità nazionale.
Sono infatti queste le istituzioni che per prime si fanno si fanno carico di forzare i sistemi normativi
tradizionali, sperimentando pratiche diverse, oppure introducendo sistemi di quota di genere o di
minoranze etniche, o anche abbassando la soglia di età per l’elettorato passivo.
Tutte queste soluzioni hanno il compito di esplorare modalità sperimentali di qualità democratica che
successivamente potranno essere “esportate” anche nei parlamenti nazionali.
5.3. Il ruolo delle assemblee parlamentari sovranazionali
Accanto allo sviluppo delle assemblee subnazionali, dobbiamo considerare anche la crescente
importanza di alcune assemblee parlamentari collocate sul versante sovranazionale (o internazionale);
le quali, tuttavia, hanno modalità di formazione e livelli di legittimazione abbastanza diversi l’una
dall’altra.
Una modalità sicuramente importante sul piano della legittimazione di queste istituzioni è ovviamente
la presenza di una forma di “elezione diretta”.
Sotto questo profilo il Parlamento europeo rappresenta una vera e propria eccezionalità, dato il suo
connotato di corpo di rappresentanti direttamente eletti da un “popolo” europeo che conta oltre450
milioni di individui.
Tuttavia, non possiamo non considerare l’influenza di quelle assemblee elette indirettamente da parte
di una serie di parlamenti nazionali.
Sono esempi di questo tipo, per quanto attiene la partecipazione dell’Italia, le assemblee parlamentari
del Consiglio d’Europa, dell’Unione dell’Europa occidentale, della Nato, dell’Unione per il
Mediterraneo.
Un’altra forma di rappresentanza assembleare indiretta fortemente innovativa è quella del Comitato
delle regioni dell’Unione Europea, che è composto da rappresentanti delle istituzioni subnazionali, che
si ritrovano a discutere e proporre una legislazione di tipo comunitario, saltando il passaggio della
“mediazione” da parte dei legislativi nazionali.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 7 – Istituzioni e livelli di governo
1. Il Governo
1.1. La reinvenzione del governo
Si è soliti affermare che il governo è una componente essenziale della politica perché non è mai esistita
un’esperienza di comunità nella quale non sia emersa un’entità capace di esprimere quelle funzioni di
coordinamento e di guida che associamo a questo concetto.
In realtà, tale affermazione è suscettibile di qualche critica, poiché assume sia sempre possibile
identificare il soggetto capace di svolgere la “funzione di governo”.
L’esistenza di ordinamenti giuridici semplificati come quelli che vigevano in passato (ma non del tutto
scomparsi) – es. micro comunità dotate di autonomia, realtà tribali – rende difficile questa
identificazione: lo spazio semantico corrispondente al concetto di “governo” può risultare molto
ristretto oppure estremamente vasto, portandoci ad identificare degli attori assai diversi tra loro.
Un esempio del primo caso è il monarca degli Stati assoluti premoderni: la loro piena legittimità ne
faceva sicuramente i detentori unici della sovranità, ma è evidente che le funzioni di governo venivano
esercitate assieme ad una serie di altri soggetti, dapprima la nobiltà e poi quella classe di funzionari
che fu alla base della nascita delle moderne burocrazie.
Come esempio di accezione “larga” del significato di “governo” possiamo invece portare il caso delle
città-Stato dell’antica Grecia o i comuni medioevali: in omaggio alla dimensione comunitaria e
“orizzontale” di questi ordinamenti, il governo corrispondeva all’assemblea dei cittadini che, in quanto
tali, potevano partecipare alle decisioni critiche.
Tuttavia anche all’interno di queste realtà sarebbe presto emerso un qualche gruppo intermedio di
gestori e di garanti delle decisioni stesse.
Dunque, l’idea di un governo autorevole, riconducibile nelle sue funzioni e capace di influenzare in
modo decisivo i processi politici grazie ad una forte legittimazione che lo eleva a istituzione centrale
del sistema politico nasce relativamente di recente, a seguito delle fasi rivoluzionarie.
In questo senso, si può dire che il governo è stato reinventato dalla politica, il parallelo al processo di
reinvenzione dello Stato moderno.
È più corretto affermare che, più del governo come istituzione, è il problema del governo a porsi prima
o poi in qualsiasi forma politica, proprio perché ogni fenomeno definibile come “politica” evidenzia la
necessità di alcuni soggetti di conquistare una sfera effettiva di autorità ed esercitare le funzioni che ne
discendono.
Questa necessità fa del governo il fine stesso dell’agire politico.
Seguendo questa strada ci imbattiamo tuttavia in un’accezione ancora molto ampia del concetto.
Il termine “governo”, infatti, abbraccia tutte le funzioni nella sfera della politica e finisce per assumere
le vesti di una miriade di soggetti istituzionali.
Del resto, la parola inglese government include tutti gli attori che esplicano le funzioni tipiche in cui si
ripartisce il potere: il legislativo, l’esecutivo, il giurisdizionale.
Stringendo lo spazio semantico, è possibile adottare una sostanziale equazione tra il concetto di
“governo” e quello di organo esecutivo: in pratica, le istituzioni responsabili dell’indirizzo politico,
che assumono tuttavia anche la guida dei principali comparti dell’amministrazione pubblica
Il governo è l’invenzione comunemente ritenuta più importante nella fenomenologia politica.
Tuttavia, rimane un oggetto imperfetto e vago.
Proprio per questo, l’analisi empirica riparte doverosamente da una definizione restrittiva.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
1.2. Lo sviluppo del governo democratico
L’esecutivo di una democrazia è un’istituzione, ovvero un sistema di regole formali e informali,
all’interno della quale agiscono particolari attori politici, come i leader legittimati dalla vittoria
elettorale e il personale politico selezionato da partiti e altri soggetti istituzionali rilevanti, i quali
esercitano la funzione di comando, ovverosia influenzano i processi decisionali vitali per la
democrazia stessa.
Le regole formali e quelle informali (es. prassi che determinano il tipico processo di formazione di un
governo) scandiscono l’intera vita di un esecutivo.
Prima della formalizzazione delle norme (spesso scritte, talvolta consuetudinarie) che hanno
accompagnato l’impegno solenne degli esecutivi democratici ad agire con senso di responsabilità e
“per volontà della nazione”, la loro era una struttura relativamente semplice: il monarca ne costituiva
la componente necessaria e i suoi ministri, pur diventando con il tempo fondamentali, erano comunque
subordinati all’esistenza di un detentore unico della sovranità.
Le cose cambiarono, evidentemente, con i passaggi relativi alla formazione del cosiddetto governo
costituzionale, seguita dalle grande rivoluzioni borghesi del XIX secolo.
Durante tale fase, si affermò il principio della responsabilità collettiva in una squadra di governo
composta da esponenti di élite accomunati dallo stesso livello di legittimazione, che nelle realtà
europee si intrecciò con il consolidamento di un legame di fiducia tra parlamento ed esecutivo stesso.
Questo portò all’introduzione della nozione di monarchia parlamentare, per sottolineare la nascita di
un sistema di governo che favorisce la simbiosi tra governo e parlamento (o, meglio, tra governo e
maggioranza parlamentare).
Le figure istituzionali createsi durante questa fase sono ancora oggi, in molte realtà democratiche, le
stesse di cui ci raccontano ogni giorno e media.
Con l’avvento dei gabinetti ministeriali, in particolare, nascono il primo ministro, il ministro delegato
ad alcuni settori cruciali di politica pubblica, i ministri senza portafoglio con deleghe circoscritte e
senza la responsabilità di direzione di un dicastero, ovvero un centro di spesa amministrativo, i
sottosegretari, a loro volta delegati su specifici progetti, in particolare nella fase di analisi parlamentare
dei disegni di legge.
Tuttavia, la forza e la complessità della macchina dominata da tali figure è cambiata in modo
consistente nel corso del XX secolo.
Semplificando il lavoro di Richard Rose, possiamo riassumere tale dinamica con le tre fasi storiche
dello Stato minimo, Stato produttore e Stato sociale.
Richard Rose (1933-), americano trapiantato in Europa, si è dedicato allo studio del governo.
Ha lavorato anche sui sistemi politici comparati e sul terreno degli studi elettorali.
Ripercorriamo questa dinamica osservando l’evoluzione della struttura di governo nel caso italiano.
Il gabinetto ministeriale della monarchia costituzionale piemontese, che nel 1861 divenne in governo
del neonato Stato unitario, era composto da una manciata di ministri che garantivano la continuità delle
funzioni tradizionali, in primis la difesa dell’ordine interno e le capacità militari.
L’istituzione del ministero del Tesoro e dei primi sottosegretari di Stato, durante il governo Crispi
(1888), costituisce un primo allargamento del governo verso figure specializzate che ricevevano
deleghe innovative ed importanti.
Ma è durante l’età giolittiana che il numero e la natura dei comparti amministrativi, e le conseguenti
deleghe politiche alle figure incaricate della direzione di tali comparti, assumono le dimensioni di un
gabinetto ministeriale numeroso.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Paradossalmente, anche durante il fascismo nacquero nuove figure e nuove funzioni di governo.
Sono i decenni dello Stato produttore, che anche in Italia scopre funzioni importanti come l’intervento
nell’economia e la necessità di capillari servizi sociali.
Non a caso, è in questo periodo che il governo italiano comincia a pianificare il proprio intervento
nell’economia acquistando imprese e costituendo quell’amministrazione parallela fatta di strutture
pubbliche che sostituivano l’impresa e l’industria in alcuni settori cruciali.
Nel contempo, si realizzava un nucleo ancora basilare ma rilevante di politiche destinate alla
cittadinanza: le assicurazioni sociali, sul lavoro e la previdenza sociale, corrispondevano ad una
espansione della macchina di governo: alla nascita di ministri e sottosegretari dedicati a queste
deleghe, faceva seguito un adattamento dell’’intero sistema burocratico, dagli uffici centrali a quelli
territoriali, che si dovevano occupare di una moltitudine di servizi.
Lo Stato sociale, nato all’indomani della completa democratizzazione e della conquista della sfera del
governo da parte dei grandi partiti di massa, corrisponde invece ad uno sforzo più ingente e ad un
impegno sistematico in tanti settori della politica pubblica che favoriscono politiche di redistribuzione
e di crescita complessiva della società.
La salute e la scuola pubblica sono naturalmente le prime voci di questo nuovo corso, che in Italia si
verifica soltanto negli anni della ricostruzione, successivi alla guerra e alla caduta del fascismo.
Ma ci sono anche nuovi tipi di assicurazione sociale e nuovi impegni dello Stato in economia,
testimoniati dalla nascita di ministeri specifici per le politiche di bilancio e programmazione
economica (1947) e per le partecipazioni statali (1956).
Questa fase di espansione quantitativa e qualitativa si completa in realtà nei decenni successivi, con la
nascita di due ministeri oggi rilevanti come quello per l’ambiente (1986) e quello per la ricerca
scientifica e tecnologica (1989).
Sono gli anni di un big government che peraltro è già stato messo in allarme da una crisi di natura
globale, quella seguita allo shock petrolifero degli anni Settanta che ha imposto una inversione di
tendenza quasi paradossale: si deve spendere meno ma continuando a spendere aumentando gli ambiti
di spesa nei quali le risorse pubbliche finiscono.
Anche questa è una fase – per qualcuno un vero e proprio smantellamento del welfare – che ha
significato molto per la struttura dei governi.
2. I sistemi di governo
2.1. Una tipologia semplificata
Guardando al tipo di legittimazione del vertice dell’esecutivo, relativamente alle varie forme di
governo, si distingue in presidenzialismo, nel quale il capo del governo viene scelto dal popolo
attraverso un’elezione diretta, e parlamentarismo, nel quale viene selezionato dall’assemblea dei
rappresentanti del popolo.
Gli scienziati politici, però, si orientano a proporre una modellistica di sistemi di governo invece che di
forme o di idealtipi, esplorando la complessità attraverso una serie di classificazioni e tipologie.
Di recente, Cheibub ha proposto una classificazione che distingue tra “sistemi presidenziali” (nei quali
il governo risponde al presidente e non al legislativo), “sistemi parlamentari” (dove il governo è
responsabile di fronte al legislativo, e il presidente non è eletto in modo indipendente, o comunque non
ha poteri sul governo) e “sistemi misti”.
Questi ultimi sono i cosiddetti semipresidenzialismi, dove un presidente demo-eletto mostra qualche
potere su un esecutivo che pure rimane responsabile di fronte al parlamento.
È possibile costruire una tipologia attraverso due dimensioni continue:
il tipo di legittimazione del capo del governo, che può essere popolare o indiretta (ovvero mediata
dal parlamento);
la durata dell’ufficio del capo di governo, che può essere costituzionalmente determinata oppure
vincolata al persistere di un rapporto fiduciario da parte dell’organo legittimante.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Gran parte delle democrazie contemporanee si dispongono nell’area individuata dall’ovale di forma
allungata, riproducendo la già citata triade di modelli (presidenziale, parlamentare, semipresidenziale).
Ad un estremo dell’area ovale troviamo il presidenzialismo (es. Stati Uniti) che prevede una forte
legittimazione popolare derivata dall’azione popolare.
Al suo opposto, nel parlamentarismo classico (es. Regno Unito) la nomina del capo dell’esecutivo
è di competenza del parlamento (o, meglio della camera elettiva del parlamento) che può in qualsiasi
momento ritirare tale delega con un voto di sfiducia che interrompe l’azione dell’esecutivo.
La variabilità più evidente si conferma attorno al terzo tipo interno all’area più densa, quello del
semipresidenzialismo, identificato di solito nella sua forma originaria con il sistema della V
Repubblica francese, che consta di un governo rispondente al legislativo, coerentemente con il
parlamentarismo di stampo europeo, e un capo di Stato elettivo, che condivide i poteri esecutivi con il
primo ministro. Anzi, egli di fatto tende ad azzerare la figura del primo ministro, specialmente quando
quest’ultimo è dello stesso colore politico del presidente stesso.
Il modello rappresenta oggi una categoria in espansione.
Fuori dall’area ad alta densità di casi empirici trovano posto altri due modelli, certamente meno
rilevanti ma effettivamente corrispondenti ad altrettante esperienze.
Il direttorio è da circa due secoli il sistema con cui si governa la confederazione svizzera: dopo
ogni turno elettorale, il governo si forma con un’ampia partecipazione dei partiti che si riconoscono in
una coalizione di soggetti uniti dall’interesse nazionale.
Il legislativo sostiene l’operazione attribuendo la presidenza del governo, a turno, ai leader dei vari
partiti, con una turnazione rigidamente annuale.
Al contrario, il premierato elettivo è una forma di governo nella quale la legittimazione personale
e popolare del leader (eletto direttamente) non corrisponde ad un mandato “garantito” ma deve essere
confermato nel tempo dalla fiducia parlamentare
Tale sistema è effettivamente esistito soltanto nell’esperienza israeliana tra il 1996 e il 2003, ma un
ampio dibattito su pro e contro del premierato si è recentemente sviluppato in molte realtà – in
particolare in Italia – nelle quali si erano palesati evidenti problemi di incertezza e di ingovernabilità
del sistema di governo parlamentare.
2.2. Formazione, fiducia e crisi. Vincoli costituzionali e procedurali sul sistema di governo
In tutti i parlamentarismi il governo è legittimato per via indiretta attraverso le camere, ma il suo
processo di formazione può essere regolato assai diversamente.
In alcune democrazie del modello maggioritario la procedura appare semplificata, in quanto il
connotato semplificato del sistema partitico consente la proiezione immediata verso la nomina a primo
ministro del vincitore delle elezioni (il leader del partito di maggioranza).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Altrove, il processo di formazione dell’esecutivo è più complesso: dopo le elezioni, o all’indomani di
una crisi di governo non culminata nel nuovo voto, può iniziare una fase di confronto che coinvolge i
gruppi parlamentari, le delegazioni dei partiti interessati, talvolta la mediazione del Capo dello Stato e
occasionalmente anche altri soggetti istituzionali o rappresentanti delle parti sociali.
Grazie al ricorso all’accordo di coalizione pre o postelettorale tra i partiti che si candidano a comporre
la coazione di governo si può porre un rimedio ai rischi di ingovernabilità indotti da un
parlamentarismo consensuale.
La Francia della IV Repubblica e l’Italia (soprattutto della Prima Repubblica) rappresentano esempi
evidenti di democrazie a governo instabile, connotate da cambiamenti continui nella composizione
delle maggioranza e lunghe crisi durante le quali si proponevano vari tipi di soluzione prima di optare
per l’extrema ratio del voto anticipato.
In seconda battuta, l’esistenza di una tipica procedura per celebrare la fiducia parlamentare è un
ulteriore elemento che sposta nell’arena parlamentare e nella fase postelettorale alcune importanti
decisioni su chi e come governerà.
Laddove questa procedura non esiste (c.d. “fiducia tacita”, parlamentarismo negativo) sono, di nuovo,
i risultati elettorali e quindi le decisioni prese dai componenti partitici prima della competizione
elettorale a trovare un’automatica applicazione.
La formalizzazione di procedure costituzionali di fiducia non tacita può rivelarsi un ostacolo al
consolidamento di un governo capace di guidare il sistema.
Un esempio è il paradossale impasse sopraggiunto in Italia nel 2013, con la nascita di un governo di
larghe intese sopraggiunto per l’impossibilità di formare un esecutivo basato sulla coalizione di
maggioranza (al Senato soltanto relativa) di centro-sinistra.
Tuttavia, esistono anche varianti costituzionali del parlamentarismo positivo che lo proteggono dal
rischio di eccessiva instabilità.
È il caso dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva vigente in Germania e in Spagna: la camera
bassa può ritirare la sua fiducia a un dato governo, in corso di legislatura, avanzando tuttavia un nuovo
nome per la guida del governo che viene investito con lo stesso voto.
In pratica, è possibile mandare a casa un primo ministro solo nel momento in cui si attribuisce fiducia
a un altro, e ciò favorisce la continuità dell’azione dell’esecutivo.
2.3. La delega ministeriale e il rapporto tra capo del governo e ministri
Cosa succede all’interno del ristretto novero dei membri di un governo democratico?
Come davvero vengono prese le decisioni che competono all’esecutivo?
Il presidenzialismo (v. Stati Uniti) rappresenta la paradossale continuità di un principio monocratico,
tipico dello Stato predemocratico, all’interno della moderna forma di Stato repubblicana.
L’effetto di questo paradosso è di creare una situazione di governo del leader capace di dominare il
consiglio dei propri collaboratori (che significativamente non prendono neanche il nome di ministri)
con poteri assoluti di delega, nomina e licenziamento.
Questa enorme estensione del potere esecutivo viene bilanciata non dentro il governo, ma attorno ad
esso, con i pesi e i contrappesi disegnati nel sistema federale a poteri separati: un forte legislativo, una
Corte suprema a tutela del sistema giurisdizionale, l’autonomia e la pressione degli Stati membri.
In Europa, così come nelle altre democrazie sparse per il mondo che si affidano ad un sistema di
governo retto sul rapporto di fiducia tra legislativo ed esecutivo, lo spazio di variazione nel rapporto
tra capo di governo e ministri spazia tra una significativa applicazione del principio monocratico
grazie alla quale il capo del governo ha pieni poteri di scelta sulla squadra ministeriale, e ne dirige il
lavoro obbligando i singoli ministri a determinate azioni, fino alla piena applicazione del principio
collegiale, nella quale un primus inter pares, pur essendo formalmente l’attore che propone e in taluni
casi nomina i ministri, governa assieme a essi.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
In questo caso, il termine che possiamo usare per descrivere l’azione del capo di governo è quello di
coordinamento, mentre i processi decisionali seguono la regola dell’unanimità, o comunque vincolano
il titolare del governo a cercarsi di volta in volta adesioni significative da parte degli altri membri
dell’esecutivo.
Il primo dei due modelli, esemplificato storicamente dal caso britannico, è stato definito nella storia
come governo del primo ministro oppure premiership.
All’estremo opposto troveremo un governo collegiale, come quelli che hanno caratterizzato alcuni
parlamentarismi europei, tra i quali il Belgio, l’Olanda e l’Italia della Prima Repubblica.
Approcci recenti, capaci di combinare una dettagliata analisi empirica di lungo periodo, hanno
elaborato ampie riflessioni sulla variabilità tra i sistemi di governo democratici, al fine di controllare
l’effettivo comportamento delle diverse soluzioni istituzionali.
In particolare, l’utilizzo della teoria della delega, nell’analisi dei processi di formazione e interruzione
dei governi conferma l’evidente distanza di due modelli che possono essere empiricamente associati al
modello parlamentare (nella versione primo-ministeriale) e presidenziale (nella versione pura degli
Stati Uniti).
Il modello della delega perfetta comporta una catena di deleghe dove l’unitarietà e quindi la coesione
di ogni agente rispondono al proprio principale sulla base di una chiara attribuzione di deleghe.
Questo idealtipo è dunque caratterizzato da primi ministri con una forte delega parlamentare, ministri
con ampio spazio di manovra (ma strettamente limitato ai settori di competenza) sottoposto allo
screening del premier stesso che con il suo staff potrà “giudicare” i suoi ministri, e infine un rapporto
ugualmente biunivoco e trasparente tra i ministri – ora divenuti principali – e i rispettivi agenti, ovvero
le agenzia dipartimentali che dovranno fattivamente realizzare gli interventi.
Il modello della delega duale è invece connotato da rapporti ugualmente biunivoci e trasparenti, che
tuttavia sviluppano due strade parallele, poiché l’elettorato presidenziale e quello del Congresso sono
tecnicamente diversi, pur se attivati contestualmente, durante l’election day (martedì di novembre).
Il presidente ha ampi poteri di delega, ma è anch’esso sottoposto allo screening del congresso.
3. Governi, partiti e teoria delle coalizioni
3.1. La dimensione partitica del governo
In senso lato, la democrazia moderna esprime un governo di partito, nel senso che la corrispondenza
tra leader partitici in competizione e futuri governanti, così come tra manifesti elettorali e future
agende di governo è diretta e spesso addirittura simmetrica.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Gli scienziati politici sanno che non esiste un governo di partito perfetto.
Ma sanno anche che è difficile pensare a un governo democratico avulso dalla dimensione partitica.
Il loro lavoro è stato pertanto orientato innanzitutto a esplorare questo rapporto tanto importante
quanto complicato, per poi giungere a delle generalizzazioni, per quanto deboli ma capaci di
controllare ipotesi su un universo di casi comparabili.
Il politologo americano Richard S. Katz ha messo a punto un’elaborazione empirica del concetto di
party government.
Il governo di partito si realizza quando a) le decisioni vengono prese da un personale di partito eletto
nelle cariche più rilevanti dell’esecutivo; b) le politiche pubbliche sono decise all’interno dei partiti,
che agiscono con sufficiente coesione nella difesa di tali piattaforme; c) i detentori delle cariche sono
reclutati e agiscono come rappresentanti del proprio partito nella loro esperienza di governo.
3.2. Le teorie delle coalizioni
Le domande a cui i fautori delle teorie delle coalizioni – a partire dai “pionieri” William Gamson e
William Riker, già attivi alla fine degli anni Cinquanta – hanno cercato di rispondere sono:
Chi forma una coalizione?
Come vengono distribuiti i portafogli ministeriali?
Quali fattori spiegano l’equilibrio della coalizione o, al contrario, la fine di un’esperienza di coalizione?
William H. Riker (1920-1993) è stato un caposcuola della cosiddetta Rational Choice, la corrente
che, a partire dagli anni Sessanta, ha applicato modelli formali e razionali di teoria dei giochi allo
studio della politica. Come molti sostenitori di tale corrente, aveva un background da economista.
Tuttavia, si era presto dimostrato molto attento alle logiche della trasformazione politico-istituzionale.
[v. fig. 7.4 (pag. 222)]
Le risposte fornite al classico interrogativo su “chi forma una coalizione” danno un’idea
dell’evoluzione attraversata da questo interesse nate approccio.
I primi contributi formalizzati negli anni Settanta introducevano il semplice assunto della coalizione
minima vincente, ovvero quella coalizione che diventa perdente con la sottrazione di un solo
giocatore, una coalizione dunque “risicata” che tuttavia garantirà ai partner la più conveniente
allocazione delle spoglie in palio.
Questa argomentazione razionale dovrebbe essere sufficiente per premettere la formazione di un
governo composto dai due partiti che raggiungono la più risicata delle maggioranza possibili in
parlamento (A+E).
Una versione leggermente diversa dello stesso assunto si basa sul conteggio del numero dei giocatori.
La coalizione minima vincente sarà la coalizione con il minor numero di partiti, a prescindere
dall’esistenza di soluzioni con maggioranze ancora più risicate.
La coalizione più probabile sarà, quindi, quella C+E, assumendo che il partito di maggioranza relativa
– il primo in una logica formalizzata nelle procedure istituzionali a giocare, ricevendo l’incarico di
formare un governo – cercherà il suo partner in un’area politica meno lontana rispetto al partito A.
Proseguendo con l’argomentazione relativa all’importanza della contiguità politica degli attori,
l’ulteriore contributo teorico della maggioranza minima connessa impone un esito diverso.
In questo caso i partiti E e C dovranno favorire l’inclusione del piccolo partito D nella coalizione, cosa
che costerà loro qualche ministero ma garantirà coerenza politica alla maggioranza che ora occupa
appunto uno spazio continuo grazie all’impegno di tre forze politicamente contigue.
Ulteriori spunti hanno aggiunto realismo e sostanza alle ricerche sulla formazione dei governi di
coalizione. Gli studi basati sulla teoria delle coalizioni a distanza minima introducono il tema della
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
riduzione della distanza ideologia tra i partner, che comporta la conoscenza dell’effettiva affinità nelle
posizioni programmatiche.
Una coalizione A+B+C che investe tre partiti collocati sul versante del centro-destra sembra a prima
vista la soluzione più nitida in questa prospettiva.
Tuttavia, se il partito estremo viene considerato antisistema, o comunque non così vicino agli altri
partiti collocati su quel versante politico, e quindi con un potenziale di coalizione troppo basso,
potrebbe scattare un seconda soluzione centrista (C+D+E) comprendente i due partiti maggiori dello
scenario politico.
Tuttavia, possono formarsi coalizioni oversized, cioè coalizioni fatte di un numero di partiti più alto
rispetto a quello atteso, in modo d condividere gli onori ma anche gli oneri di un difficile governo.
Proprio dall’argomentazione del calcolo costi-benefici di una data coalizione si sono mossi i contributi
sull’approfondimento delle reali capacità coalizionali degli attori in lizza.
La seconda generazione di coalition theories si è infatti concentrata sull’esistenza di compensazioni
per la partecipazione ad un’esperienza di coalizione.
Ecco spiegata l’importanza del bargaining set (spazio di contrattazione) che genera risultati assai
diversi a seconda della possibilità di accordi interpartitici sulle questioni centrali sull’agenda.
I risultati più noti delle ricerche di questo filone, sintetizzabili genericamente come teoria delle
coalizioni a maggioranza contrattata, giungono a modelli più verosimili.
Laver e Shepsle [1996] formalizzano un modello dove le preferenze dei vari attori partitici in almeno
due settori di politica pubblica generano spazio per compromessi accettabili (i cosiddetti win sets) la
cui sovrapposizione sarà capace di spiegare la propensione a determinate coalizioni piuttosto che ad
altre. Tendenzialmente, sono i partiti che controllato l’elettore mediano ad avere un win sets più
compatibile con gli altri e quindi la possibilità di costruire una futura coalizione.
Tuttavia, aumentando le variabili interventi e la complessità nelle preferenze degli attori, è possibile
che nessuna soluzione si riveli accettabile per gli attori chiamati al governo.
Questa situazione è alla base della spiegazione di un fenomeno diametralmente opposto alla ricerca
della maggioranza, ovvero il governo di minoranza, monocolore o anche di microcoalizione, ovvero
un esecutivo da affidare a un partito o cartello comunque significativo considerato non estremistico o
antisistema, tenuto in vita da un appoggio esterno o anche dall’astensione di alcuni attori partitici che
non lo boicottano ma preferiscono non entrarvi.
In un’ottica di emergenza, si tratta di una soluzione residuale e transitoria, o comunque connotata da
un qualche limite alla delega attribuita al governo.
In questo senso, i governi di minoranza sono classificabili vicino a quelli integralmente tecnici
comparsi occasionalmente in situazioni di crisi, ovvero dei governi delegati a poche azioni in un
settore molto definito.
Come si allocano le spoglie ministeriali tra i partiti della coalizione?
Da una generalizzazione intuitiva ma incapace di spiegare tutte le implicazioni del fenomeno – la
legge della proporzionalità rispetto al peso elettorale dei partiti – siamo passati a teorizzazioni più
raffinate, basate sul potenziale di coalizione e poi sulla natura policy seeking di alcuni partiti.
4. La configurazione attuale dei governi democratici
4.1. Molte similitudini, poche (ma cruciali) differenze
Relativamente alla struttura degli esecutivi, non è difficile riscontrare le tante analogie tra istituzioni
che si sono sviluppate in parallelo e in condizioni storiche simili.
Ad esempio, la numerosità dei ministeri delle principali democrazie contemporanee è convergente,
come simili sono le loro rispettive competenze.
Inevitabilmente, una ulteriore similitudine appare guardando alla loro collocazione nella cittadella
politica posta nel cuore delle varie capitali, e molto somigliante è perfino il modo con il quel queste
istituzioni si presentano oggi sulla rete virtuale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Meno intuitivo è isolare le differenze che persistono nella configurazione dei governi democratici.
Con qualche semplificazione, possiamo ridurre a quattro le principali dimensioni nelle quali è possibile
riscontrare una variazione consistente: i “poteri formali e informali”, l’“organizzazione interna” al
gabinetto, i “meccanismi di selezione del personale”, e da ultimo la “durata dei governi” stessi.
Relativamente ai poteri formali, oltre alle fondamentali facoltà costituzionali che discendono dal
sistema di governo, diventano fondamentali le facoltà attribuite dalle prassi o dalle regole di
funzionamento interne ai parlamenti.
A prescindere dal sistema di governo, un esecutivo è tanto più “forte” quando può contare su
un’architettura di norme scritte che esaltano la sua autonomia e tutelano la sua iniziativa legislativa.
Tuttavia, anche un governo molto “forte” sul piano del suo rapporto con il parlamento, può denotare
un certa gracilità interna dovuta ad una scarsa capacità organizzativa.
Qui subentra la seconda variabile, quella della dimensione strutturale interna dell’esecutivo.
Storicamente, i governi nascono come insiemi più o meno formalizzati di delegati (del monarca).
Nello sviluppo storico delle democrazie, in alcuni casi sono stati premiati i destinatari della prima
delega (diretta o indiretta), ovvero i capi di governo, mentre in altri paesi sono stati i ministri, in
quanto capi delle varie amministrazioni, a massimizzare le risorse organizzative.
Possiamo sintetizzare attraverso il confronto tra Regno Unito e Italia: mentre il primo ministro inglese
è storicamente il primo a dotarsi di una serie di risorse umane, unità di consulenti e anche di immobili
da “prestare” alle proprie agenzie, il presidente del Consiglio in Italia non ha mai avuto una sede
propria fino al 1925 (quando si insedia con Mussolini al Viminale, che tuttavia ospitava già anche il
ministero degli Interni). La sede esclusiva (Palazzo Chigi) sarà raggiunta solo nel 1961.
Inoltre, la legge che garantisce risorse autonome al presidente del Consiglio italiano arriva solo nel
1988, quarant’anni dopo il suo “annuncio” nell’art. 96 della Costituzione.
Quanto alla selezione del personale ministeriale, poste le caratteristiche convergenti dell’élite di
governo – si tratta molto spesso di politici “navigati”, grazie ad una lunga militanza partitica e alle
precedenti esperienze politico-istituzionali, ancora oggi prevalentemente maschi con un’origine sociale
e culturale sicuramente privilegiata rispetto alla media della popolazione – l’elemento di differenza che
salta tradizionalmente agli occhi è quello relativo alla provenienza parlamentare: nelle democrazie
Westmister, a cominciare da quella britannica, i ministri non solo provengono dal parlamento, ma sono
tenuti a mantenere il proprio seggio durante il mandato di governo.
Al contrario, nei presidenzialismi e anche in alcuni parlamentarismi vicini al modello consensuale (es.
Olanda) i ministri non possono ricoprire la carica di parlamentare e quindi, nell’eventualità che dei
parlamentari vengano nominati ministri, essi devono lasciare il proprio seggio.
Infine, la capacità di persistenza (o, al contrario, la caducità) rappresenta la dimensione più studiata
nell’analisi del funzionamento di quei sistemi di governo – parlamentari o semipresidenziali –
connotati da una durata “incerta” degli esecutivi.
Il tema della governabilità deve essere inquadrato in un contesto più articolato: innanzitutto, accanto
alle regole elettorali e al numero degli attori partitici, altre variabili come la disciplina dei legislatori di
maggioranza e la coesione interna ai partiti di governo incidono sulla stabilità dell’esecutivo.
In ogni caso, la durata formale dei governi non è perfettamente correlata con il dinamismo delle loro
azioni o con il successo dei rispettivi leader.
È utile a questo proposito ricordare le cifre relative alla (in)stabilità di governo in Italia nella Prima
Repubblica: 47 governi formatisi tra il 1948 e il 1993, con una durata media di soli 320 giorni.
Non vi sono dubbi sul fatto che si è trattato di un esempio di governo collegiale debole, con un primo
ministro perennemente esposto al rischio della crisi, e quasi mai capace di imporre una propria agenda,
o di cambiare a proprio piacimento la squadra dei ministri.
Tuttavia, se guardiamo a quell’esperienza dal punto di vista della stabilità della classe politica,
scopriremo la robustezza dell’élite che guidò il paese in quella fase storica.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Un’élite perfettamente impersonata da Giulio Andreotti che in quella lunga stagione fu 28 volte
ministro e 7 volte presidente del Consiglio.
4.2. Evoluzioni recenti: “core executive”, presidenzializzazione e tecnocrazia
È necessario passare in rassegna la recente trasformazione nei rapporti di delega all’interno dei governi
democratici.
Un primo elemento sul quale riflettere è quello dello sviluppo di un nucleo duro del governo,
osservato nella lunga storia del governo britannico ma che avrebbe caratterizzato anche molte altre
democrazie consolidate.
La nozione di core executive è particolarmente utile perché permette di distinguere gli attori che
effettivamente esercitano i poteri di indirizzo politico rispetto ai meri esecutori, al di là della comune
appartenenza a un corpo collettivo di ministri o membri di governo.
Questa immagine è importante anche in un contesto come quello dell’Unione Europea nel quale alcuni
attori istituzionali nazionali sono più importanti degli altri per il fatto di partecipare a particolari
processi decisionali sovranazionali.
Questo genera un distacco netto tra le competenze e le opportunità di partecipazione ai processi
decisionali di alcuni ministri al cospetto di altri
Il secondo elemento da tenere in considerazione è quello dell’accentuazione della forza dei leader.
Questa osservazione, motivata da una moltitudine di fattori, tra i quali la crisi dei partiti, la “campagna
elettorale permanente” e il potere dei media che valorizza il carisma dei singoli al cospetto delle élite
nel loro complesso, è applicabile in realtà a tutti i sistemi e sarebbe rubricabile con il termine
leaderalizzazione.
Il processo interessa in modo particolare i sistemi parlamentari, nei quali il ruolo del capo del governo
appare sfumato e talvolta non decisivo.
Accurati studi empirici hanno mostrato come in tutti questi regimi una serie di risorse organizzative e
informative si sono accentrate al cuore degli esecutivi e, sempre più spesso, alle dirette dipendenze del
capo di governo.
La conquista della leadership, e quindi le caratteristiche personali del candidato migliore per questa
finalità, sono divenuti gli elementi dominanti nei processi elettorali, attirando sempre di più
l’attenzione degli elettori alla ricerca della “persona giusta” più che del partito o degli stessi
programmi.
Il terzo elemento di mutamento nella struttura di governo è il rapporto sempre più intrecciato tra
figure politiche e figure di tipo tecnico.
In parte questo fenomeno riguarda la crescita dei policy advisors (consulenti esperti) e di altre forme di
staff reclutate direttamente dai politici per avere un supporto di competenze diverse rispetto a quelle
fornite dalla burocrazia.
In questa veste troviamo reclutate sempre più spesso delle figure senza un vero e proprio retroterra
politico, e non sono infrequenti anche i casi di commissioni di studio bipartisan dove un governo
recluta tra i propri consulenti anche esperti considerati vicini ai partiti di opposizione.
Alcune competenze dei tradizionali dicasteri (soprattutto nel settore economico e nelle politiche
regolative) vengono oggi assorbite dal ruolo molto più “tecnico” delle cosiddette autorità indipendenti,
strutture di nomina governativa o parlamentare che tuttavia godono di un’estrema autonomia politica e
che sono chiamate a compiti molto specifici di attuazione e interpretazione delle politiche (es. stabilire
le sanzioni per i comportamenti non rispettosi dei principi della libera concorrenza).
In altri casi sono cambiati i criteri di selezione e di reclutamento di alcuni dei membri stessi
dell’esecutivo.
La presenza di tecnici nel governo si è moltiplicata negli ultimi decenni nell’intero universo
democratico e soprattutto nei parlamentarismi europei, mostrando soprattutto in alcuni ruoli – gestione
di politiche economiche ad alto contenuto tecnico come salute, ricerca, ambiente, infrastrutture – un
“utilizzo” copioso di personalità estranee alla politica che hanno interpretato il proprio ruolo come
quello di un puro policy expert, senza essere troppo interessati alla dimensione complessiva del ruolo
di governo.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4.3. Un quadro riassuntivo
Certamente, i modelli non parlamentari sviluppano una verticalizzazione che può essere gerarchica e
totalmente incentrata sul principio monocratico (presidenzialismo Usa) o “duale” come quello del
semipresidenzialismo francese.
Altrettanto certamente, il modello del Direttorio svizzero consolida un principio opposto, integralmente
collegiale, dal momento che ai sette membri del Consiglio federale viene sì conferita una delega, ma
essi ruotano attorno a tali “dicasteri” senza avere alcuna autonomia circa l’istruzione delle varie
pratiche che conducono alle decisioni.
Inoltre, il fatto che il presidente della Confederazione (cioè il consigliere che pro tempore presiede le
sedute) non abbia alcun potere di guida e nemmeno di coordinamento del collegio, rende impossibile
alcuna verticalizzazione delle facoltà interne al governo elvetico.
Le differenze più vistose emergono all’interno del pianeta delle democrazie parlamentari.
Al loro interno, troviamo casi di dispersione del potere (power-sharing) molto evidenti, come quello
belga, quello italiano e quello olandese, tre sistemi che si sono posti il problema della
razionalizzazione dei poteri e dell’organizzazione del governo, ma che sono rimasti sostanzialmente
connotati da esecutivi deboli.
Sotto il profilo procedurale, è proprio il caso italiano, con la complessa procedura del doppio voto di
fiducia e con la tradizionale ricerca dell’unanimità in Consiglio dei ministri a costituire il caso più
“difficile” sotto il profilo della dispersione.
Al contrario, il noto meccanismo della sfiducia costruttiva ha rafforzato il ruolo del primo ministro e
quindi ha reso più stabile l’intero processo di governo in Spagna e Germania.
Si devono considerare altre due dimensioni di variazione fondamentali: la prima è costituita
dall’impatto del sistema partitico sul funzionamento dei governi.
Con questa espressione si indica il livello più o meno policentrico dell’equilibrio istituzionale
raggiunto nel sistema di partiti presenti nelle istituzioni rappresentative, al fine di dare al governo
flussi decisionali stabili e coerenti.
Sotto questo aspetto, i governi di coalizione più “litigiosi” e compositi sul piano ideologico (es. Belgio,
Olanda, Italia) non possono garantire un equilibrio molto stabile, proprio per la natura frammentata
del sistema partitico, anche laddove in realtà non vi sia una grande probabilità di alternanza (es. Italia
della Prima Repubblica).
I governi a maggioranza minima e in particolare quelli monopartitici garantiscono invece un
funzionamento avversariale nel confronto tra governo e parlamento, e sono solitamente connotati da
più lunga durata e da spiccate capacità decisionali.
Tuttavia, per definire un governo davvero “forte” nel confronto con le altre istituzioni centrali, è
necessario osservare una terza dimensione, che è quella della capacità di controllo amministrativo
degli esecutivi.
Qui si fa riferimento a tutte quelle proprietà tipiche della fase successiva rispetto a quella di
formulazione delle politiche e di presa delle decisioni: la presenza di uno staff capace di monitorare
l’applicazione delle politiche stesse, l’effettiva disponibilità di risorse conoscitive tali da rendere
efficace un controllo sulle procedure e rispondere in modo convincente alle “interrogazioni” dei
legislatori, la reputazione dei direttori delle varie branche amministrative e delle agenzie che fanno
capo al governo centrale.
Si è soliti dire che la macchina di governo italiana è assai meno funzionante rispetto al modello
francese e a quello tedesco, proprio perché le debolezze della fase amministrativa ricadono sulla
performance complessiva dell’esecutivo.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
5. Lo sviluppo delle istituzioni di governo territoriale
Nell’ultima fase storica, il contenimento del potere degli Stati nazionali a favore di un crescente
numero di organizzazioni sovranazionali e lo sviluppo di un sistema di governance multilivello hanno
determinato una serie di cambiamenti, esaltando anche il rilievo delle istituzioni subnazionali.
Oggi la dimensione del governo locale o subnazionale (dai comuni al livello medio, provinciale o
dipartimentale, a quello regionale) è percepita come un rilevante assetto nel processo di governo.
L’analisi empirica ha evidenziato i risultati di questo processo che è stato definito come erosione dello
Stato centrale a favore di una serie di livelli territoriali e funzionali di governo.
Probabilmente, il punto più rilevante dello sviluppo del governo territoriale, è quello relativo
all’impatto esercitato dalla sfera locale sul sistema di governo complessivo.
In questa fenomenologia possiamo convogliare molte pratiche: ad esempio i patti territoriali o di
stabilità interna che legano la continuità degli interventi a sostegno del territorio finanziati dai governi
centrali, alle caratteristiche o ai meriti delle amministrazioni locali, oppure vere e proprie nuove arene
interistituzionali permanenti, come il sistema delle conferenze Stato-regioni che da tempo in Italia sta
avendo il ruolo di volano per favorire il coordinamento tra le funzioni di governo sui vari livelli.
Più in generale, le istituzioni del governo locale e metropolitano sono oggi i veri protagonisti di un
sistema crescente di condizionamenti e di interventi pubblici che non si esplica tanto nell’attività
istituzionale ordinaria, quanto nella formazione di soggetti misti, come le agenzie territoriali e le
aziende partecipate, che hanno il compito di spendere risorse (anche) pubbliche per garantire servizi e
implementare politiche pubbliche locali.
È evidente che la crescita della governance locale ha effetti indiretti sulla struttura delle élite politiche
e sulla stessa leadership “centrale”.
Inoltre, laddove il sistema normativo consente un cumulo di mandati, questa modalità è diventata uno
strumento importante di costruzione di una reputazione politica (o la ragione del suo declino).
Rispetto a pochi decenni or sono, è aumentato il peso di colore che optano per una carriera
bidirezionale o integrata.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 8 – Amministrazione e burocrazie
1. Burocrazia ovvero la gestione quotidiana del potere
In questo capitolo, la questione delle burocrazie viene affrontata dalla prospettiva del loro ruolo
all’interno dell’azione politica e dei processi decisionali attraverso i quali essa produce i suoi effetti sui
cittadini.
Il tema viene affrontato trattando in modo separato il doppio significato si “burocrazia”: da una parte,
la burocrazia come uno specifico modo di organizzare un insieme di persone, dall’altra parte come
uno specifico modo di organizzare un insieme di uffici.
2. I concetti di “burocrazia” e di “pubblica amministrazione”
Anche se la burocrazia è un fenomeno antico, il termine è relativamente recente, il che connota un
passaggio storico significativo che ha reso necessario inventare una parola nuova, al fine di leggere
una realtà emergente.
Il nuovo termine si deve alla creatività di Vincent de Gournay, un funzionario pubblico francese
vissuto nella prima parte del XVIII secolo, il quale, riflettendo sulla propria esperienza personale, coniò
il termine “burocrazia”, proprio per stigmatizzare come la Francia fosse dominata da una casta di
impiegati e funzionari.
Non è dunque un caso che la nuova parola coniughi il termine kratos, dominio/potere, e il termine
francese bureau, che significa “scrivania” o “ufficio”.
Il concetto moderno di burocrazia nasce, pertanto, con quella accezione negativa che, nei secoli
successivi, tante volte riaffiorerà nel dibattito pubblico.
Max Weber traghetta il dibattito sulla burocrazia dall’ambito della filosofia e della teoria politica
all’ambito delle scienze sociali e ne dà una definizione che rappresenta il punto di partenza di ogni
analisi del fenomeno stesso.
Per Max Weber la burocrazia è l’apparato amministrativo tipico del potere legale, e distingue
quest’ultimo dal potere tradizionale, il cui apparato amministrativo è costituito dalla nobiltà, e dal
potere carismatico, che è dotato di un apparato amministrativo appena abbozzato e poco
professionalizzato.
Per Weber la burocrazia è l’elemento fondante della formazione dello Stato moderno e della
trasformazione della sua natura.
La burocrazia si caratterizza per i seguenti elementi costitutivi (Weber):
gerarchia e onniscienza gerarchica;
divisione del lavoro;
imparzialità dei comportamenti e impersonalità nelle relazioni interne ed esterne;
elevata specializzazione e professionalizzazione;
reclutamento basato su regole certe e promozioni basata sul principio di anzianità o sul merito.
Questo tipo di organizzazione è per Weber non solo l’espressione della prevalenza del potere legale
(rispetto al potere tradizionale e a quello carismatico) ma è anche un forma di organizzazione efficiente
delle funzioni statuali.
Per Weber l’organizzazione burocratica è da considerarsi come quella tecnicamente più razionale.
Inoltre, le suddette caratteristiche della burocrazia ne fanno la più adatta a comportamenti imparziali
(trattando i cittadini nello stesso modo, dal punto di vista formale, e agendo in modo politicamente
neutrale) e a un ruolo esecutorio, quindi di meccanismo servente della decisione politica.
Tali caratteristiche costitutive rendono le burocrazie particolarmente capaci di produrre un senso di
affidabilità nei decisori politici e di godere di una persistente legittimazione agli occhi dell’opinione
pubblica.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
L’idealtipo burocratico di Max Weber è un punto di riferimento essenziale per l’analisi del
comportamento amministrativo e per il ruolo che le amministrazioni pubbliche svolgono nel processo
politico. Esso rappresenta il metro di paragone per ogni analisi dell’eventuale cambiamento della
pubblica amministrazione.
Il concetto di “pubblica amministrazione” è più ampio di quello di “burocrazia”.
Se infatti è vero che la gran parte delle organizzazioni pubbliche hanno caratteristiche di tipo
burocratico, è anche vero che in queste stesse amministrazioni possono coesistere elementi
organizzativi di tipo non burocratico.
Basti pensare a quelle nomine politiche dei dirigenti pubblici che avvengono non in base a una logica
meritocratica ma sulla base del criterio di fedeltà e di lealtà del nominato rispetto ai detentori del
potere politico.
Inoltre, possono anche esistere amministrazioni pubbliche senza Stato (es. organizzazioni
internazionali: Unesco, Onu, ecc.).
È necessario, pertanto, focalizzare l’attenzione sulla definizione di “amministrazione pubblica”.
La pubblica amministrazione può essere definita in termini funzionali o in termini strutturali.
Seguendo Peters, dal punto di vista funzionale, l’“amministrazione” può essere intesa come un insieme
di attività mediante le quali si attuano norme, ovvero la traduzione di regole generali, formulate per
l’interesse collettivo, in decisioni specifiche.
Dal punto di vista strutturale, le pubblica amministrazioni sono l’insieme degli apparati organizzativi
la cui primaria finalità è quella di svolgere le funzioni richieste dalle decisioni politiche formalizzate.
B. Guy Peters (1944-) è uno dei principali contemporanei di analisi delle politiche pubbliche e di
comportamento amministrativo. Nella sua vasta attività di ricerca brillano gli studi comparati sulle
caratteristiche strutturali e culturali delle pubbliche amministrazioni e sul rapporto tra politici e
burocrati.
3. Gli elementi costitutivi della pubblica amministrazione
3.1. Quattro livelli di analisi
Le caratteristiche più significative che influenzano il funzionamento delle amministrazioni sono: la
struttura e l’organizzazione; il personale; le procedure; la cultura amministrativa.
3.2. La struttura e l’organizzazione
Per struttura intendiamo l’insieme dei principi costitutivi mediante i quali i sistemi amministrativi
nazionali vengono configurati.
Per organizzazione facciamo riferimento alle caratteristiche mediante le quali le amministrazioni
impostano le proprie attività (come si dividono il lavoro, come si coordinano, ecc.).
Luther Gulick sottolinea l’esistenza di quattro principi mediante i quali articolare gli assetti strutturali
delle pubbliche amministrazioni: l’area territoriale servita, i tipi di processi e di procedure impiegati, i
destinatari o l’oggetto di riferimento, l’obiettivo da raggiungere.
Il criterio territoriale è probabilmente quello in cui le differenze tra le diverse tradizioni e storie
amministrative appaiono più evidenti.
Questo criterio distingue tra quei sistemi amministrativi nazionali che sono tendenzialmente
centralizzati, e che quindi hanno unità amministrative centrali che operano su tutto il territorio
nazionale con uffici decentrati, e sistemi amministrativi che, operando in sistemi politici altamente
decentrati, hanno una segmentazione di apparati amministrativi che insistono nella stessa area di
politica pubblica.
Si tratta di un criterio, pertanto, la cui evidenza empirica dipende dalle caratteristiche della forma di
Stato (Stato unitario/Stato regionale o federale).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il criterio del processo rimanda alle modalità sistemiche mediante le quali le pubbliche
amministrazioni operano e all’articolazione della divisione del lavoro tra le strutture amministrative.
Ad esempio, nell’organizzazione dei processi amministrativi tipica degli Stati accentrati, i ministeri
svolgono al tempo stesso l’attività di progettazione, attuazione e controllo delle loro attività (es.
ministero dell’Interno).
Vi è poi il caso di strutture organizzative in cui vi è una separazione tra l’apparato che ha il compito di
progettare e controllare gli interventi e l’apparato pubblico che ha il compito di attuare le politiche.
È la pratica, originata negli Stati Uniti, ma sempre più diffusa nel resto del mondo, di assegnare ad
agenzie (sotto la supervisione e il controllo delle assemblee legislative o dei ministeri) l’attuazione
delle politiche da perseguire in determinati settori di politica pubblica.
Un’altra modalità di articolare i processi amministrativi è rappresentata dalla creazione di autorità
indipendenti che hanno al finalità di regolare o indirizzare un settori di politica pubblica al fine di
preservare e tutelare l’interesse collettivo (es. autorità antitrust, banche centrali, autorità che regolano
specifici settori economici).
Il criterio relativo ai destinatari o all’oggetto trattato fa riferimento al fatto che l’articolazione
istituzionale delle amministrazioni può andare a configurarsi su uno specifico gruppo di interesse o
settore dalla società.
Si tratta di un tipo di organizzazione che può essere confusa con l’organizzazione per specifici settori
di politica pubblica (sanità, ambiente, ecc.) ma che in realtà si caratterizza per il fatto di concentrarsi su
uno specifico gruppo di riferimento (es. dipartimenti per gli affari indiani o per gli aborigeni in paesi
come gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia).
Questo criterio può essere decisivo nell’influenzare le attività dell’amministrazione, laddove la
funzione primaria (es. politiche di sviluppo economico) viene organizzata per sottounità organizzative
(assistenza alla piccola impresa, artigianato, grandi imprese, ecc.) che possono produrre un
meccanismo di rapporto privilegiato e favorevole rispetto ai destinatari dell’azione amministrativa.
Il criterio organizzativo dell’obiettivo da raggiungere è particolarmente problematico poiché, se è
vero che ogni struttura amministrativa viene creata con un fine specifico, è anche vero che, nel corso
della sua evoluzione, l’obiettivo organizzativo originario può modificarsi anche in modo significativo.
Infatti, ogni organizzazione pubblica viene istituita per un fine che è simbolicamente rappresentato
nella denominazione (es. ministero dell’Istruzione, Cassa del Mezzogiorno, ecc.).
Quindi, ogni struttura amministrativa nasce con una mission ben definita.
Nel corso del tempo, però, le finalità organizzative iniziali possono mutare, sia a causa di richieste da
parte della politica o del sistema sociale, sia per dinamiche interne all’amministrazione stessa.
[Le dimensioni organizzative fondamentali sono: il livello di formalizzazione, le modalità di
distribuzione dell’autorità, il tasso di specializzazione, il livello di centralizzazione, il livello e il tipo
di professionalizzazione].
3.3. Il personale
Le pubbliche amministrazioni non sono fatte solo di procedure e organizzazioni, ma anche di persone.
La rilevanza del personale pubblico è massima non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche –
poiché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni costituiscono, in tutti i paesi avanzati, una
componente significativa degli occupati e della cittadinanza – dal punto di vista più generale del
sistema politico (soprattutto in termini elettorali).
Le modalità con cui il personale pubblico viene reclutato, selezionato, promosso e incentivato
costituiscono un elemento chiave per indirizzare le capacità e l’azione amministrativa.
L’organizzazione del personale pubblico del modello burocratico tradizionale è caratterizzata da: una
selezione in entrata basata sul titolo di studio; generalismo; scarsa mobilità verso il privato; forme
accentrate di reclutamento; inamovibilità del posto; elevato spirito di corpo; progressione in carriera
basata sull’anzianità; rapporto di lavoro fondato per lo più sulla legge con poco spazio per la
contrattazione.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Nel corso degli ultimi decenni, sono stati introdotti principi di organizzazione del personale pubblico
che hanno fortemente ridotto le rigidità del modello storicamente sedimentato.
Principi come la specializzazione professionale, l’elevata mobilità tra impiego pubblico e impiego
privato, le forme decentrate di reclutamento, la contrattazione collettiva, i meccanismi meritocratici di
merito, la retribuzione parzialmente legata alla performance individuale, sono stati variamente
introdotti nei paesi occidentali.
L’esito di questi processi di riforma ha drasticamente cambiato il quadro dell’organizzazione del
personale delle pubbliche amministrazioni.
Ad esempio, il ridimensionamento dei dipendenti pubblici (anche mediante il licenziamento) non è più
un tabù come nel passato.
3.4. Le procedure
Anche le procedure con le quali le pubbliche amministrazioni operano hanno subito notevoli
trasformazioni nel corso dell’ultimo secolo.
Il modello burocratico tradizionale è caratterizzato da una logica procedurale basata semplicemente sul
rispetto delle leggi e delle norme.
Lo scopo dell’amministrazione, in questo contesto, è quello di applicare o attuare la legge.
Ovviamente vi sono differenze sostanziali tra i paesi dell’Europa continentale e quelli del mondo
anglosassone.
In particolare, negli Stati Uniti, le procedure amministrative non sono mai state, come nel caso dei
paesi europei, unidirezionali (semplici regole di azione della burocrazia) ma si sono caratterizzate per
un forte coinvolgimento dei gruppi di interesse e un ruolo spesso decisivo dei giudici.
Questa differenza tra le modalità procedurali, dovuta alla tradizione storica delle singole
amministrazioni nazionali, è venuta, nel corso degli ultimi due decenni, a ridursi.
Anche in questo caso, il modello burocratico di azione amministrativa è stato progressivamente
contaminato, se non proprio trasformato, dall’introduzione di nuovi strumenti e di nuovi principi
procedurali, mutuandoli dal mondo delle organizzazioni private.
La pianificazione degli obiettivi, la valutazione del personale e delle performance istituzionali, la
trasparenza e il diritto di accesso dei cittadini, l’utilizzo massiccio dell’e-government hanno
radicalmente innovato le modalità di azione delle amministrazioni.
Il fatto che le nuove procedure implichino maggiori possibilità di interazione tra attori esterni (sia
quelli organizzati, sia i singoli cittadini) e pubbliche amministrazioni, e che queste siano obbligate a
rendere costantemente trasparenti le loro azioni, conduce ad aumento consistente della complessità dei
processi decisionali: essi non sono più lineari, in quanto caratterizzati da un’azione unidirezionale delle
pubbliche amministrazioni, ma sono basati su continue interazioni tra più attori.
3.5. La cultura amministrativa
Il concetto di “cultura amministrativa” rimanda all’insieme di valori e di credenze condivise che
informano l’azione delle pubbliche amministrazioni.
Essendo un concetto complesso, è meglio distinguere tra dimensione esterna e dimensione interna
della cultura amministrativa.
Quindi, per tener conto di queste due dimensioni, il concetto di “cultura amministrativa” deve essere
suddiviso in: “cultura dell’amministrazione” e “cultura organizzativa”.
La cultura dell’amministrazione (d.e.) identifica l’insieme degli orientamenti, delle opinioni e
delle aspettative che i membri di una società hanno nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Ovviamente in questo ambito assume un particolare rilievo la concezione dell’amministrazione che
hanno gli attori politici e i portatori degli interessi più rilevanti.
Comunque sia, per quanto sia ragionevole assumere che le caratteristiche della cultura sociale e/o
politica incidano in modo significativo sulla cultura organizzativa, appare difficile sostenere che
quest’ultima sia passivamente determinata dalla dimensione culturale esterna.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La cultura organizzativa (d.i.) riguarda l’insieme dei valori e delle pratiche condivise all’interno
dell’organizzazione pubblica.
I valori concernono sia il proprio ruolo come amministrazione sia gli obiettivi da raggiungere (e
possono basarsi non solo su elementi normativi o legislativi, ma anche su tradizione, miti, ideologie);
le pratiche riguardano le modalità condivise mediante le quali l’organizzazione pubblica agisce (e
possono essere fondate sull’eredità storica e su una forte componente affettiva piuttosto che su una
prescrizione legislativa).
La cultura organizzativa delle amministrazioni viene spesso considerata come irriducibile a
generalizzazioni classificatorie. In realtà, in letteratura disponiamo di alcuni sforzi classificatori delle
culture organizzative e delle pubbliche amministrazioni.
Pierre [1995] distingue due tipi di culture organizzative: la “cultura del Rechstaat” e la “cultura per
l’interesse pubblico”.
Si tratta di una classificazione semplice, basata sulla sedimentazione storica dei processi di costruzione
dello Stato e sull’evoluzione dei sistemi politici.
Ovviamente, questi due tipi di cultura organizzativa individuano due “famiglie” di sistemi politici (e,
quindi, di sistemi amministrativi) occidentali: quella dei paesi dell’Europa continentale e quella dei
paesi anglosassoni.
La cultura organizzativa del Rechstaat è caratterizzata da un profondo senso di gerarchia, da una
forte concezione elitistico-legalistica dell’azione amministrativa, da un’attitudine all’adempimento che
considera il rispetto delle procedure un criterio legittimante la propria azione, e da una formazione
prevalentemente giuridica dei funzionari.
Questo tipo di cultura amministrativa che accomuna gran parte dei paesi dell’Europa continentale, ha
mostrato un’insolita resistenza nel mantenimento di alcune caratteristiche genetiche, anche dopo le
consistenti ondate di riforma amministrativa orientate all’attuazione di tecniche manageriali perseguite
dai governi negli ultimi tre decenni;
La cultura organizzativa dell’interesse pubblico origina dall’esperienza storica dei paesi
anglosassoni, in cui i rapporti tra potere politico e cittadini si sono articolati in modo meno
asimmetrico rispetto a quelli in uno nei paesi dell’Europa continentale.
Si tratta di un’esperienza storica in cui la parola “Stato” viene sostituita dalla parola “governo” che è
considerato un male necessario e, quindi, deve essere fortemente delimitato nei suoi poteri rispetto alle
libertà individuali dei cittadini.
L’azione amministrativa viene percepita come punto di equilibrio e di mediazione tra i diversi interessi
in gioco e l’obiettivo della stessa è costituito primariamente dal raggiungimento dei risultati.
I valori fondanti sono pertanto l’equità, l’indipendenza e la propensione a risolvere i problemi.
È una cultura organizzativa che socializza i dipendenti pubblici a ritenersi dei cittadini uguali agli altri
e che richiede una formazione o generalista oppure specialistica ma non necessariamente giuridica.
Questa dicotomizzazione è ovviamente semplificatrice.
Esistono, infatti, delle differenze significative tra paesi dell’Europa continentale (dove può essere
individuata una coppia di sottofamiglie culturali, gravitanti attorno al modello tedesco e a quello
francese). Così come è opportuno osservare che i paesi del Nord Europa costituiscono degli esempi di
ibridi in cui le due tradizioni culturali prevalenti si sono mescolate.
4. Politica e amministrazione
4.1. Due dimensioni analitiche
Il rapporto tra politica e amministrazione rappresenta una delle questioni più dibattute dell’analisi
politologica del comportamento amministrativo.
Il tema deve essere affrontato individuando due tipi di relazioni:
a) il rapporto tra politici e burocrati, quindi tra decisori e dirigenti amministrativi;
b) il ruolo delle amministrazioni nei processi politici.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4.2. Politici e burocrati: dicotomia, conflitto, integrazione?
Il dibattito sul rapporto tra politica e amministrazione si è storicamente focalizzato sul problema del
rapporto tra decisori politici e dirigenti amministrativi rispetto al fondamento basilare del processo
decisionale e cioè chi deve decidere.
Si tratta di una questione che ha essenziali applicazioni non solo teoriche ma anche normative
(laddove, nella teorica democratica, si assume che le decisioni politiche debbano spettare a coloro i
quali sono stati eletti).
È proprio su questa base normativa che il rapporto tra politica e amministrazione è stato a lungo
definito come “dicotomico”, postulando la separazione tra politica e amministrazione.
Da una parte i decisori politici, che detengono il potere sulla base del criterio dei legittimazione
vigente in un determinato sistema politico, dall’altra parte l’amministrazione, che deve attuare le
decisioni sulla base della legittimazione dovuta alla propria competenza tecnica.
A partire dagli anni Trenta, però, in conseguenza del New Deal rooseveltiano, che vede coinvolti nei
processi decisionali, come consulenti, molti scienziati sociali, cominciano a emergere le prime
perplessità rispetto al fatto che la separazione tra politica e amministrazione sia realistica.
Grazie ad alcuni studi [anni Quaranta] viene smantellato il dogma della separazione tra politica e
amministrazione e il rapporto tra politici e burocrati diventava non scontato e un oggetto di ricerca sul
quale applicarsi sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista empirico.
Peters (1987) ha individuato cinque modelli idealtipici di relazioni tra politici e burocrati nei processi
decisionali.
Il modello formale identifica le posizioni tradizionali sul rapporto tra politica e amministrazione.
Anche se il dogma della separazione è stato confutato da molte ricerche, è importante osservare,
comunque, che la separazione tra politica e amministrazione non solo è prevista da molte costituzioni e
legislazioni nazionali, ma è anche fortemente interiorizzata, come schema di ruolo comportamentale,
dalle burocrazie.
Il modello del village life assume che vi sia una forte omogeneità sociale, culturale e politica tra i
politici di vertice e alti funzionari, tanto da farne un’unica comunità coesa.
In questo modello relazionale, caratterizzato da integrazione orizzontale, la condivisione dei medesimi
valori e la comune socializzazione rendono le relazioni a-problematiche producendo una sostanziale
unitarietà di intenti e azioni.
Il modello funzionale designa relazioni anch’esse integrate, come nel caso del village life, ma in
senso verticale su linee di policy.
In questo caso, le relazioni, basate su un comune interesse e una comune visione dei problemi,
integrano tra loro politici e burocrati ai diversi livelli decisionali e istituzionali, costituendo il nucleo
portante di relazioni più ampie, di network, con i rappresentanti degli interessi sociali ed economici di
riferimento del settore di politica pubblica.
Il modello antagonista assume che i politici e i burocrati competano tra loro per ottenere posizioni
di potere e di controllo su un determinato ambito di politica pubblica.
I motivi del conflitto possono originare sia da una contrapposizione valoriale, sia dall’interesse
burocratico a salvaguardare la propria organizzazione (es. i tentativi di riorganizzazione che vogliono
ridimensionare gli organici che, molto spesso, vedono forti resistenze da parte delle amministrazioni).
Il modello dello Stato amministrativo assume che i processi decisionali vengano dominati dalla
burocrazia. Tale supremazia può essere giustificata da vari punti di vista.
Ad esempio, vi è chi sottolinea come la competenza tecnica superiore della burocrazia costituisca un
punto di veto insormontabile per i politici.
Inoltre, la scienza politica ha mostrato come la supremazia burocratica possa affermarsi nelle
situazioni di persistente instabilità politica e di vuoto di potere.
Infine, emerge con chiarezza come le burocrazie siano capaci di prevalere a livello non solo di
implementazione delle politiche ma anche a livello di formulazione.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il modello dello Stato amministrativo, quindi, sottolinea l’esistenza di un intrinseco rischio di
supremazia burocratica del quale i politici sono ben consapevoli e che essi cercano costantemente di
prevenire e controllare.
È evidente, infatti, come la prevalenza del modello della supremazia burocratica ingeneri un vulnus
estremamente pericoloso alla democraticità dei processi decisionali, e la politica adotta costantemente
alcune strategie per cercare di prevenire questo rischio.
In letteratura si incontra spesso la definizione di politica burocratica per individuare la difficoltà a
distinguere con chiarezza i diversi ruoli svolti dai politici e dai burocrati.
Questa prospettiva cerca di tenere insieme le diverse caratteristiche idealtipiche stilizzate nei cinque
modelli, suggerendo di non enfatizzare a priori un tipo di relazione rispetto a un’altra.
Le più recenti ricerche empiriche mostrano che la tendenza generale delle relazioni tra politici e
burocrati sembra fondarsi su una negoziazione continua.
Fra l’altro, i ruoli spesso si scambiano e si contaminano: i politici entrano in questioni amministrative e
gestionali, mentre i burocrati entrano nella formulazione delle decisioni e anche nella definizione die
problemi da affrontare.
Nella sostanza, si tratta di una relazione in cui vi è un interesse reciproco a collaborare e, pertanto, si
struttura mediante negoziazioni e scambi: i politici cercano lealtà, i burocrati cercano stabilità di
posizione e benefici materiali.
Inoltre, tanto i burocrati quanto i politici non sono attori liberi di scegliere, ma sono vincolati dal
contesto politico-istituzionale in cui operano.
I politici sono vincolati dalle preferenze dell’opinione pubblica e dal contesto politico-economico
ereditato, i burocrati sono vincolati dalla propria cultura organizzativa e dall’esigenza di evitare
contestazioni successive.
Comunque, senza integrazione, entrambi gli attori possono trovarsi in una situazione di difficoltà.
4.3. L’amministrazione e i processi decisionali
Le amministrazioni, nella loro azione quotidiana, interagiscono continuamente con la società e con il
sistema politico, a tutti i livelli istituzionali.
Pertanto, merita dedicare attenzione alle modalità con le quali le amministrazioni agiscono nei processi
decisionali e, soprattutto, ai tipi di relazione che esse possono instaurare con i principali portatori degli
interessi sociali ed economici.
I gruppi di interesse svolgono continuativamente la loro attività di pressione a tutti i livelli dei
processi decisionali.
Essi svolgono questa attività non solo rispetto ai politici, ma anche rispetto alle amministrazioni.
Questa tendenza dei gruppi di interesse non viene vissuta passivamente dalle amministrazioni.
Infatti, esse hanno un’evidente convenienza ad interagire con i gruppi di interesse.
Le amministrazioni, interagendo con i gruppi di interesse, ottengono risorse importanteiper la loro
azione: informazioni, relazioni, potere.
In questo senso, le amministrazione, come tutte le organizzazioni, hanno bisogno di strutturare
relazioni con l’ambiente esterno, alla ricerca di quelle interdipendenze che consentano loro di
sopravvivere, scambiando risorse.
Peters ha individuato quattro tipi di relazioni che le amministrazioni possono instaurare con i gruppi di
interesse.
Le relazioni legittime sono quelle relazioni che sono consentite, se non addirittura formalmente
richieste, all’interno di un sistema politico.
Questo tipo di relazioni è sempre più diffuso nei sistemi occidentali dove la legislazione, in molti
settori di politica pubblica, richiede che vi sia il coinvolgimento diretto, nella fase di attuazione di una
politica, dei principali portatori di interesse all’interno della stessa.
È una tendenza che è riscontrabile in molti ambiti di politica pubblica, da quello ambientale a quello
industriale.
Il coinvolgimento si verifica anche a livello di formulazione delle decisioni.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Le relazioni di clientela sono quelle che per l’amministrazione si verificano quando un gruppo di
interesse diventa il rappresentante esclusivo di un determinato settore di politica pubblica.
Si tratta di un effetto che può scaturire dalla capacità di pressione di un gruppo di interesse rispetto agli
altri in un determinato settore e che può portare alla “cattura” dell’amministrazione di riferimento.
In questo caso, la relazione assicura il totale monopolio del gruppo di interesse in termini di
rappresentanza e un rapporto di dipendenza totale da parte dell’amministrazione.
Si tratta di una situazione meno rara di quanto si possa pensare e che rappresenta un rischio costante
delle relazioni tra amministrazioni e gruppi di interesse.
Le relazioni di parentela sono relazioni che sussistono quando un gruppo di interesse ottiene dei
benefici diretti e costanti dalle amministrazioni grazie alla stretta vicinanza con un partito di governo.
In questi casi, il gruppo di interesse ottiene un accesso diretto all’amministrazione di riferimento che,
vista la sponsorizzazione politica del gruppo stesso, non può che conformarsi alle sue richieste.
Questo tipo di relazioni, che vede svolgere un ruolo relativamente passivo all’amministrazione
pubblica, è più raro rispetto alla relazione clientelare, perché ha bisogno di determinate condizioni per
potersi sviluppare.
Particolarmente favorevoli sono le situazioni in cui vi sia una forte ideologizzazione della
competizione politica oppure una significativa persistenza temporale al governo del medesimo partito
o della medesima coalizione.
Le relazioni illegittime sono quelle che si verificano quando sono presenti gruppi di interesse che
non si vedono riconosciuta sufficiente rappresentanza oppure che sono esclusi per motivi politico-
ideologici da relazioni significative con le amministrazioni.
È un tipo di relazione particolare, nella quale le amministrazioni possono avere sia un ruolo passivo
(accettando l’input politico che induce ad escludere certi gruppi), oppure un ruolo attivo (decidendo
autonomamente se e quali gruppi considerare interlocutori non legittimi).
Si tratta di una relazione che è rara nei sistemi democratici, anche se può manifestarsi in quei settori di
politica pubblica caratterizzati da relazioni clientelari o di parentela.
5. Democrazie e problemi dell’amministrazione
5.1. L’amministrazione come problema democratico?
Vi è una continua tensione tra le burocrazie e la democrazia.
Le burocrazie sono, infatti, delle organizzazioni con un elevato tasso di gerarchia, basate sulla
competenza tecnica, che offrono alla politica democratica il modo per poter realizzare le politiche, ma
sono anche istituzioni che possono sviluppare logiche autonome di funzionamento e culture
organizzative che non necessariamente sono coerenti con le esigenze della politica democratica.
I principi della burocrazia possono collidere con la piena attuazione del principio democratico (sulla
base del quale le decisioni rilevanti per la collettività devono essere prese da personale eletto).
Un esempio di possibile frizione è quello relativo alla qualità delle prestazioni pubbliche: se da una
parte gli eletti devono garantire che le loro promesse elettorali vengano realizzate, dall’altra parte le
amministrazioni possono opporsi al perseguimento degli obiettivi elettorali posti dagli eletti,
adducendo una serie di motivazioni fondate sulla loro esperienza tecnica (mancanza di risorse,
infattibilità organizzative, problemi di coerenza con l’ordinamento giuridico esistente, ecc.).
Si tratta di un tema intricato e per certi versi teoricamente irrisolto.
5.2. Performance, delega e “accountability”
La questione dell’accountability burocratica può essere riepilogata come l’esigenza che le
amministrazioni rendano conto del loro operato in modo trasparente e continuativo ai responsabili
politici e quindi alla collettività.
Tale esigenza si è evidenziata nel corso degli ultimi decenni, a causa di quelle trasformazioni della
politica contemporanea che hanno aumentato la pressione della domanda sociale sulle istituzioni
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
democratiche: i governi sono obbligati a garantire performance efficienti ed efficaci delle loro
politiche, in contesti in cui le domande sociali sono spesso contraddittorie e conflittuali.
I governi si trovano pertanto di fronte alla necessità di controllare l’operato delle burocrazie, alle quali
vengono spesso delegate competenze decisionali.
Delega politica e accountability burocratica sono due facce della stessa medaglia.
Gli elettori chiedono sempre più conto ai loro eletti della loro capacità di risolvere problemi collettivi e
questa pressione democratica necessariamente viene scaricata sulle amministrazioni.
Storicamente, il tema dell’accountability burocratica si è imposto prima negli Stati Uniti ed è emerso
successivamente nei paesi europei.
Pertanto, la questione dell’accountability non è solo un dato intrinseco dei processi decisionali, dovuto
al fatto che per definizione le burocrazie sono chiamate ad attuare le decisioni politiche, ma è anche il
prodotto di strategie di delega che i decisori pongono in essere, scaricando sulle burocrazie
responsabilità decisionali.
Si tratta di una dinamica di delega che i decisori politici perseguono in modo sistematico per motivi
diversi che possono essere così riassunti:
per lasciare margini di manovra all’esecutivo assumendo che le sue maggiori competenze tecniche
siano garanzia di migliori performance;
per evitare la diretta responsabilizzazione rispetto a scelte impopolari;
perché si preferisce applicarsi ad attività più vantaggiose dal punto di vista elettorale;
per il timore di non venire percepiti credibili rispetto agli obiettivi da raggiungere.
Le deleghe che i decisori politici possono assegnare alle burocrazie comportano due rischi.
Nel primo caso, quello dell’azzardo morale, il rischio è quello che gli apparati amministrativi
utilizzino la discrezionalità concessa per perseguire fini propri, incoerenti o incongruenti con quelli
previsti; si tratta di un’eventualità che è costantemente presente nei processi decisionali, laddove le
burocrazie coinvolte non condividano gli obiettivi statuiti o siano chiamate a porre in essere procedure
distanti dalle proprie routine.
Nel secondo caso, quello della selezione avversa, il rischio è quello di sbagliare nella scelta della
burocrazia oppure del meccanismo burocratico a cui si affidano determinati compiti.
5.3. Controllo politico della burocrazia e “accountability” burocratica
Possiamo distinguere tra meccanismi di controllo politico della burocrazia e meccanismi generali per
l’accountability burocratica.
Per quanto riguarda i meccanismi di controllo politico delle burocrazie, essi possono essere
esercitati sia a livello legislativo sia a livello di esecutivo.
I meccanismi propri delle assemblee legislative sono di tipo procedurale e di tipo strutturale.
Per quanto riguarda gli strumenti procedurali, i più rilevanti sono:
la produzione di una legislazione dettagliata al fine di limitare la discrezionalità burocratica;
l’individuazione di meccanismi di monitoraggio che allertino i legislatori rispetto a eventuali anomalie;
l’uso di strumenti finanziari stringenti e vincolanti;
l’uso di indicatori di performance;
la richiesta di report periodici;
l’uso di strumenti di acquisizione di informazione come le audizioni.
Lo strumento strutturale più importante riguarda la possibilità legislativa di decidere a quale o a quali
amministrazioni affidare l’attuazione di determinate scelte.
A livello di esecutivo, lo strumento principale di controllo della burocrazia è rappresentato dalla
politicizzazione delle cariche dirigenziali.
Si tratta di uno strumento il cui uso si è andato ampliando in modo consistente negli ultimi decenni in
tutte le democrazie occidentali.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
L’accountability burocratica si inserisce in uno specifico regime di accountability che è
caratteristico di ogni sistema politico.
In ogni regime di accountability esistono degli specifici strumenti con i quali si cerca di assicurare
l’accountability burocratica.
Essi possono essere distinti in a) strumenti di tipo legale-giudiziario, b) strumenti valutativi, c)
strumenti informativi, d) strumenti rappresentativi e partecipativi.
Gli strumenti legali-giudiziari vanno dalla giustizia amministrativa in alcuni paesi dell’Europa
continentale (in cui esistono corti speciali dedicate al controllo dell’amministrazione) alla rule of law
dei paesi anglosassoni, nei quali non esiste un diritto particolare per gli apparati pubblici e, quindi,
ogni cittadino può adire alle corti di giustizia qualora si senta discriminato dall’azione amministrativa.
Gli strumenti valutativi sono quelli tipici delle nuove tecniche manageriali: la valutazione delle
performance istituzionali e individuali (alle quali vengono legati sanzioni e incentivi, spesso di tipo
finanziario); l’individuazione di indicatori di performance da raggiungere; la balance score cards
(ovvero sistemi di gestione che obbligano le burocrazie a prestare attenzione alla performance
complessiva di una politica e non solo a quella di alcune sue componenti).
Gli strumenti informativi sono legati a obblighi di trasparenza (al fine di rendere pubblici gli atti
rilevanti) e sono riconducibili alla presentazione di report periodici sulle proprie attività e all’auditing
– cioè l’attività di valutazione, da parte di un soggetto terzo, della conformità contabile e procedurale
di un’attività amministrativa e la sua corrispondenza sostantiva agli obiettivi prefissati.
Gli strumenti rappresentativi e partecipativi riguardano sia quelle pratiche di democrazia
deliberativa che si stanno introducendo in molti paesi, seppur in modo estremamente controllato, sia la
presenza di burocrazie rappresentative della composizione della popolazione (per genere, razza, lingua,
religione).
6. Burocrazie e amministrazioni nel XXI secolo: le sfide della globalizzazione
Il ruolo delle amministrazioni pubbliche e quello delle burocrazie è stato sottoposto a continue
pressioni al cambiamento nel corso del Novecento e soprattutto degli ultimi tre decenni del secolo.
Sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di un’evoluzione neoweberiana dello Stato e delle
burocrazie e di una riscoperta della burocrazia, in cui il vecchio e il nuovo si mescolano.
Una burocrazia rinnovata, che si trova ad agire in processi decisionali sempre più articolati sia a livello
nazionale sia a livello sovranazionale.
CAPITOLO 9 – Opinione pubblica, partecipazione e comunicazione
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
1. Politica orizzontale e opinione pubblica
Con l’età delle rivoluzioni (politiche e industriale) del XVIII secolo e la conseguente massificazione
della politica, alla visione verticale della politica si sarebbe sostituita quella orizzontale.
Il capitolo è dedicato a tre processi che hanno contraddistinto e accompagnato il processo di
democratizzazione: la formazione dell’opinione pubblica, la partecipazione politica e la
comunicazione politica.
Per entrare nel vivo nei temi della politica orizzontale possiamo ricordare che, per quanto sia
indubbio che il funzionamento dei regimi democratici si incentri sulle elezioni e sulla competizione tra
partiti e/o leader, è pur vero che le elezioni, da un lato, registrano le opinioni degli elettori e, dall’altro,
rendono possibile un governo in sintonia con la pubblica opinione.
Il significato di opinione pubblica muta radicalmente nel corso del tempo.
In via generale, si può dare la seguente definizione.
L’opinione pubblica è l’insieme delle rappresentazioni o immagini che gli individui e i gruppi si
formano, più o meno autonomamente, e che ne orientano il comportamento.
Le rappresentazioni o immagini delle quali parliamo devono avere a che fare con la politica, così come
le scelte e le azioni conseguenti devono in qualche modo essere collegate a questa.
“Un’opinione viene detta pubblica non solo perché è del pubblico, ma ancora perché investe oggetti o
materie che sono di natura pubblica: l’interesse generale, il bene comune e, in sostanza, la res
pubblica” (Sartori).
Possiamo individuare tre diverse definizioni di “opinione pubblica” che ne colgono lo sviluppo storico.
La prima concezione, detta classica (o liberale) affonda le radici nell’illuminismo francese e
attraversa tutto il XIX secolo arrivando fino a noi.
Costituisce una interpretazione normativa e filosofica che ha assunto valutazioni contrastanti a seconda
dei proponenti.
Così, ad esempio, i pensatori liberali e i riformatori democratici vedevano la formazione e la diffusione
delle grandi correnti di opinione come espressione degli interessi e delle idee della borghesia
illuminata, come segno di progresso e modernità e soprattutto come un formidabile meccanismo di
controllo pubblico del governo e dei suoi eccessi.
D’altra parte, i conservatori fin dall’inizio vedevano nell’opinione pubblica una manifestazione della
crisi morale e intellettuale delle élite politiche e sociali, il prevalere del giudizio di maggioranza
disinformate, inclini alle suggestioni e quindi pericolose.
Ad ogni modo, tale interpretazione fa emergere due elementi importanti sotto il profilo istituzionale.
1. L’idea che l’opinione presuppone un terreno di coltura facilmente riconducibile ai cambiamenti
politici ed economici che sconvolsero l’Europa del XVIII secolo e che portarono alla formazione della
cosiddetta sfera pubblica.
Questa costituisce uno spazio intermedio che si colloca tra lo Stato (inteso come la “sfera del potere
pubblico”) e la società civile (che in senso stretto copre l’ambito della vita privata sia essa economica
che familiare) e che risulta affollato da nuove e svariate istituzioni.
Tra queste, i caffè in Inghilterra, i salotti a Parigi e le società conviviali tedesche.
A queste, possiamo aggiungere le società letterarie, accademie, club, circoli, tute strutture che non solo
avevano finalità formative e ricreative, ma sempre di più di critica da parte di pubblici (i cittadini), in
pubblico (trasparente), sul pubblico (il governo).
In tutto ciò, un posto di particolare rilievo ha assunto lo sviluppo della stampa e delle tipografie, con la
moltiplicazione di libri e giornali. Tutte attività che presto a avrebbero dato vita a vere e proprie nuove
professioni con al centro la figura degli intellettuali di professione (letterati, filosofi, giornalisti).
2. L’autorità dell’argomento finiva per soppiantare l’autorità del rango sociale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La sfera pubblica, e quindi l’opinione che ne scaturiva, era la sede della critica razionale, del discorso
ragionato, della conversazione attiva e della contrapposizione discorsiva degli argomenti.
La seconda concezione, definita collettiva (o sociologica), si diffuse con la fine del XIX secolo e i
primi decenni del successivo e fu strettamente collegata all’influsso della psicologia delle folle di
Gustave Le Bon.
L’attenzione si sposta sul soggetto, il pubblico, che diventa un fenomeno sociale come le folle, il
panico, le masse, riconducibile al genere del “comportamento collettivo”.
L’opinione pubblica diventa un fenomeno di aggregato, sostanzialmente collettivo, “un prodotto
cooperativo di comunicazione e influenza reciproca”.
Ciò che differenzia il pubblico dalle altre espressioni della condotta collettiva erano i tratti strutturali
quali la transitorietà del gruppo, la sua debole organizzazione e contingenza, nel senso che si attivava
in risposta a specifici problemi di rilevanza collettiva.
Tuttavia, a differenza dei fenomeni di panico e delle mode, non si trattava di una semplice
manifestazione di irrazionalismo.
La formazione di un’opinione pubblica comportava una certa capacità di pensare e ragionare con gli
altri, di convincere e farsi convincere.
Il terzo tipo, che possiamo chiamare individuale (o psicologica), si risolve nella mera aggregazione
delle opinioni di individui all’interno di una collettività.
Le opinione diventano osservabili attraverso gli strumenti (sondaggio) e i metodi (campionamento)
della scienza demoscopica.
Dal punto di vista della teoria politica il passaggio a questa terza concezione è radicale.
Alla funzione storica, di controllo sul governo e sulle autorità, dell’opinione pubblica si affianca quella
di monitoraggio permanente dell’elettorato o di suoi segmenti ai fini di legittimazione.
Resta il rischio che l’opinione pubblica oltre ed essere ascoltata possa venire manipolata a fini politici.
Più che un soggetto della politica orizzontale, del controllo del potere, si ridurrebbe a un oggetto
dell’intervento della politica verticale.
Sartori avvertiva che “l’opinione pubblica è tale non perché ubicata nel pubblico, ma perché fatta dal
pubblico”. Però, non solo il pubblico di norma non è attento e interessato, ma soprattutto nell’era dei
mass media può benissimo darsi che “l’opinione nel pubblico non sia per niente un’opinione del
pubblico”.
Riguardo alla formazione dell’opinione pubblica, Sartori propone tre teorie.
La teoria della cascata vede la formazione dell’opinione pubblica come l’esito di una serie di
passaggi (o cascate) che mettono in comunicazione dei serbatoi o livelli diversi.
Nelle democrazie tali livelli di raccolta delle opinioni sono cinque: quello delle élite economiche e
sociali, delle élite politiche e di governo, dei mezzi di comunicazione di massa, dei leader di opinione
e, infine, del pubblico di massa o generale.
Il fattore che qualifica il modello è il continuo rimescolamento di idee, opinioni e influenze che
avviene all’interno di ogni serbatoio, ma anche tra i diversi livelli.
La teoria del ribollimento punta l’attenzione su un’opinione pubblica che emerge dal basso.
“Di tanto in tanto il pubblico reagisce in modo inaspettato, non previsto e non desiderato, da chi sta
nei bacini superiori”.
In questi casi si può parlare di vere e proprie “correnti di opinioni” dotate di un notevole potere di
pressione sulla classe politica e le istituzioni, si tratta di “maree di opinioni che fanno davvero risalire
il corso delle acque”.
Tali maree hanno una notevole forza nella formazione dell’agenda dei temi da affrontare da parte delle
autorità.
La teoria dei gruppi di riferimento sposta l’attenzione sulle identificazioni come fattori costitutivi
dell’opinione pubblica.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Gli uomini e le donne anche nelle società individualizzate del XXI secolo sono pur sempre degli “io-
in-gruppo che si integrano nei gruppi e, con i gruppi, istituiscono i loro punti di riferimento”.
Più esattamente, questo modello implica l’esistenza e l’attività di specifici gruppi di riferimento:
famiglia, gruppo di lavoro, partiti, gruppi religiosi, di classe, etnici, ecc.
Oggi probabilmente i partiti, come i sindacati, sono più deboli nel produrre identificazioni durature,
mentre ritorna ad essere rilevante il ruolo dei gruppi primari, dei gruppi di lavoro o professionali e
soprattutto dei mass media.
2. La partecipazione politica
Anche del concetto di partecipazione politica esistono svariate definizioni.
Un punto di partenza è definire il concetto come il “coinvolgimento dell’individuo nel sistema politico
a vari livelli di attività, dal disinteresse totale alla titolarità della carica politica” (Rush).
Tale definizione è utile perché enfatizza tanto il coinvolgimento dal basso quanto l’esercizio
professionale dei ruoli politici.
Da questo punto di vista, la partecipazione non è solo un affare occasionale di “privati cittadini” e
quindi manifestazione della politica orizzontale, ma anche, se non soprattutto, espressione della
politica verticale.
Resta il fatto che la partecipazione politica sembra rispondere alla regola per cui nelle società
modernizzate, molti partecipano poco e pochi partecipano molto.
Il prendere parte alla vita politica si distribuisce lungo una “scala della partecipazione” i cui gradini
implicano, via via che si sale, una intensità crescente di impegno (in termini di risorse, tempo, energie,
capacità) e una maggiore influenza sulle decisioni, alle quali corrisponde un restringimento del numero
dei partecipanti.
La definizione di Rush è così estesa da finire per confondere e sovrapporre la partecipazione con ogni
tipo di azione politica.
Preferiamo, quindi, riformulare la definizione di “partecipazione politica”.
La partecipazione politica è l’insieme di tutte quelle occasioni in cui, nell’ambito di un certo contesto
(Stato, collettività o associazione) dal quale si fa parte (dove), donne e uomini, singolarmente o in
gruppo (chi), fanno uso di un certo repertorio di azioni, convenzionale o non convenzionale (come),
per cercare di influenzare la selezione e le decisioni di chi ricopre cariche pubbliche rappresentative e
soprattutto di governo (che cosa), al fine di modificare o conservare il sistema di interessi e di valori
dominante (perché).
Per quanto sia facile riconoscere le forme della partecipazione politica, resta che “è un vero e proprio
miracolo che la partecipazione politica avvenga”.
Da un punto di vista razionale, sembra che i benefici che gli uomini e le donne ricavano dall’azione
diretta siano di gran lunga inferiori ai costi sopportati in termini di energia personale, tempo, risorse
impegnate e talvolta, nei regimi autoritari, anche del rischi che la partecipazione porta con sé.
Alcuni studiosi americani hanno sostenuto che nelle democrazie avanzate sarebbe opportuno invertire
il quesito e chiedersi piuttosto “perché la gente non partecipa?”.
La loro risposta era che le persone non si impegnano principalmente per tre ragioni: a) non possono, a
causa di fattori strutturali che impediscono o ostacolano la partecipazione; b) non vogliono, in
conseguenza degli orientamenti psicologici o soggettivi che spingono o meno un individuo alla
partecipazione; c) infine, nessuno glielo chiede, a causa dei fattori organizzativi e associativi che
supportano la partecipazione.
Non possono
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Questa prima risposta ha a che fare con gli ostacoli derivanti dalle disuguaglianza sociali degli
individui e dei gruppi.
Guardiamo, ad esempio, a variabili quali la distribuzione della ricchezza o il grado di sviluppo
economico, al livello di istruzione e all’esposizione degli altri elementi della modernizzazione sociale
(mobilità, informazione, tecnologie); si pensi anche ai mass media ed alle opportunità di
comunicazione che offrono.
È facile riscontrare come in presenza di condizioni socioeconomiche deprivate si possa assistere a
processi di spoliticizzazione e di alienazione degli individui e dei gruppi.
In questo modo perifericità socioeconomica e perifericità politica si sovrappongono e si rafforzano
reciprocamente alimentando una vera e propria “trappola dell’esclusione”.
Altri fattori ostativi alla partecipazione politica hanno, invece, carattere istituzionale.
Anche nelle democrazie mature si pongono problemi di inclusione, cioè di riconoscimento della
cittadinanza politica.
Se è vero che la questione del suffragio universale maschile e femminile in buona parte dei paesi
occidentali è stata risolta a cavallo delle due guerre, è pur vero che in alcuni casi il diritto di voto alle
donne avrebbe ancora dovuto aspettare (Francia, 1945; Italia, 1946; Svizzera, 1971).
Altra questione politicamente rilevante è quella del diritto di voto per gli immigrati residenti o nati nei
paesi ospiti.
Infine, si possono menzionare altri meccanismi istituzionali che condizionano la partecipazione
elettorale:
1. il voto obbligatorio (in Italia fino al 1993);
2. i sistemi elettorali proporzionali;
3. la registrazione automatica degli elettori nelle liste elettorali al compimento della maggiore età (non
prevista negli Stati Uniti);
4. la previsione di particolari giornate per il voto;
5. l’esistenza di elezioni simultanee (c.d. election day)
6. la scheda elettorale, semplicità di espressione del voto e libertà offerta all’elettore (liste aperte
piuttosto che liste bloccate o chiuse);
7. norme sul finanziamento delle attività dei partiti e di movimenti politici aperte anche a formazioni
minori e nuove.
Non vogliono
La seconda risposta alla domanda di partenza rimanda alle motivazioni, cioè al coinvolgimento
psicologico associato con il grado di interesse, di informazione e di efficacia politica dei partecipanti.
Atteggiamenti e orientamenti soggettivi sono il riflesso delle caratteristiche della situazione, dei
processi di socializzazione che si verificano durante l’infanzia e dell’esposizione ai mass media,
nonché delle esperienze compiute in età adulta rispetto alla politica e al governo.
Nessuno glielo chiede
Nonostante tutto, il motivo per cui la gente partecipa e vota resta un mistero.
L’interrogativo rimanda al “paradosso dell’azione collettiva” (Olson), per cui per l’individuo comune
sarebbe più razionale non partecipare e attendere di incassare i benefici dell’impegno degli altri. Con la
conseguenza che se tutti si comportassero in questo modo la partecipazione diverrebbe impossibile.
Una possibile risposta al paradosso è che, quando si impegnano, le donne e gli uomini finiscono per
considerare gli sforzi sostenuti non come costi ma piuttosto come parte dei benefici.
La partecipazione è il riflesso del coinvolgimento in networks di reclutamento, attraverso i quali
vengono sollecitate, mediate, attivate le richieste di partecipazione. Ciò ha due implicazioni:
la prima è che in queste reti si produce e si capitalizza una speciale risorsa costituita dalle
“competenze civiche”, cioè l’insieme di capacità organizzative e comunicative che sono essenziali per
prendere parte attivamente;
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
la seconda, è relativa alle sedi dove queste competenze possono essere acquisite, in genere il ricco
tessuto delle istituzioni sociali secondarie e prepolitiche (scuole, associazioni, chiese ecc.).
Questi elementi sono alla base del cosiddetto modello del volontariato civico.
Per cui, alla base della partecipazione, troviamo la vecchia concezione di Tocqueville delle
associazioni e delle istituzioni della società civile come scuola di democrazia.
A questo elenco di associazioni integrative vanno aggiunti – specie nel passato – i partiti.
La partecipazione sarebbe, così, il prodotto di attività quali l’educazione e la socializzazione,
l’organizzazione e la mobilitazione, il coinvolgimento in azioni dimostrative o in campagne (elettorali
o di sensibilizzazione).
Tutte cose che per molto tempo hanno offerto i partiti di massa, grazie alla loro capacità di distribuire
incentivi.
Tipi ideali di cittadino (Almond, Verba)
Il cittadino civico. Combina coinvolgimento e mobilitazione attiva assieme con adesione
passiva e apatia, comunque, accomunati da una fiducia di fondo verso il sistema e una deferenza
per le autorità pubbliche (c.d. “cultura civica”).
Il cittadino insoddisfatto. Con l’esplosione della contestazione studentesca e del movimento
operaio nel 1968, il cittadino rispettoso delle istituzioni democratiche e dei suoi protagonisti, lascia
il posto o, comunque, viene affiancato dal “cittadino insoddisfatto e protestatario”, più attivo
politicamente, più democratico, più istruito del partecipante standard.
Il cittadino autoespressivo. Le ondate di protesta che hanno attraversato la società occidentale
dalla fine degli anni Sessanta, da un lato, le trasformazioni sociali, economiche e culturali che si è
soliti associare all’avvento della società postindustriale e individualizzata, dall’altro, hanno
provocato delle trasformazioni profonde nei modelli di cultura politica prevalenti.
Nelle società avanzate le generazioni più giovani avrebbero sperimentato un indebolimento
dell’attaccamento ai “valori materialisti” del benessere, della sicurezza materiale e della stabilità
economica, a favore dell’emergere di valori, per contrasto con i primi, detti “postmaterialisti”.
Questo cambiamento intergenerazionale avrebbe portato alla ribalta temi inusitati e scottanti – la
qualità della vita, l’ambiente, il bisogno di autorealizzazione, l’affermazione delle identità di
genere, il soddisfacimento intellettuale ed estetico – così come ad una più forte rivendicazione di
democrazia partecipativa, di azione diretta e di decentramento.
I valori postmaterialisti sarebbero poi stati ridefiniti come “valori autoespressivi”.
Il cittadino apatico. Ci si riferisce a uomini e donne non necessariamente insoddisfatti ma
semplicemente disinteressati, poco informati e scarsamente attivi.
Questi cittadini non sono del tutto marginali, anzi, di norma tengono d’occhio la sfera politica per
cogliere le scelte e le situazioni che minacciano i loro interessi.
Sono cittadini selettivi, magari esposti a flussi di comunicazione di bassa qualità (es. talk show)
ma che non appena percepiscono temi che li toccano direttamente si attivano per protestare o
punire questo o quel partito.
In un certo senso è come se fossero in stand-by, disaffezionati ma vigili.
3. La comunicazione politica
Come in ogni altro ambito delle relazioni umane, anche in politica vale il principio per cui “non si può
non comunicare”.
Più che una scelta, la comunicazione è una necessità alla quale è difficile sottrarsi.
Del resto, anche la non comunicazione veicola significati.
Per non parlare della potenza simbolica che in politica riveste la comunicazione non verbale – basti
pensare all’importanza dei gesti come un pugno alzato, un braccio teso, un saluto romano.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La comunicazione politica riguarda gli scambi e le interazioni che hanno a che fare con l’interesse
generale, anche se talvolta si tratta di temi rispetto ai quali c’è un accordo di fondo, talaltra sono
controversi e allora diventano fonte di mobilitazione di schieramenti pro e contro.
D’altra parte, dal punto di vista delle élite, governare una società comporta un costante ricorso alla
comunicazione per informare i cittadini, per consentire la trasmissione e l’applicazione delle decisioni
vincolanti, così come la trasparenza delle istituzioni.
Fin qui la comunicazione sembra riconducibile alla dimensione orizzontale della politica.
In realtà, nello scambio di comunicazione con gli altri, definiamo e ridefiniamo la nostra relazione in
termini di potere.
Le interazioni e le comunicazioni politiche comportano sempre un agire strategico orientato al
successo (politico).
La comunicazione politica si pone l’obiettivo di persuadere i cittadini per conseguire fini di parte.
Pertanto, non può che riflettere l’ambivalenza caratteristica della politica: ora strumento di
integrazione e di trasparenza che aumenta la qualità della democrazia, ora arma nella lotta per il potere
e, in questo caso, tanto più soggetta a manipolazioni e distorsioni quanto più ci allontaniamo dai
contesti democratici.
La comunicazione politica si risolve nell’insieme di scambi o interazioni che si realizzano nel triangolo
costituito dagli attori politici, i mass media e il pubblico dei cittadini.
In astratto, tale modello di relazioni a più voci postula una situazione di parità ideale fra soggetti, che
sarebbero quindi dei “primi inter pares”.
In realtà, le ricerche sul campo hanno mostrato che il peso dei tre attori è di fatto sbilanciato, risultando
assai più forte quello dei mass media.
Tale evoluzione, prodotta dagli anni Sessanta con l’avvento della televisione, è ancor più evidente oggi
nel contesto delle trasformazioni tecnologiche che ha subito il sistema delle comunicazioni di massa e
della rivoluzione scaturita dall’avvento delle telefonia mobile e soprattutto da internet.
La politica trova sempre più espressione all’interno dell’arena dei mass media.
Questo modello, più realistico, e forse più preoccupante, è stato chiamato “modello mediatico della
comunicazione politica”.
Per capire la logica di funzionamento della mediatizzazione della politica è importante apprezzare la
centralità dei mass media e dei loro professionisti (primi fra tutti i giornalisti) alla luce di due
parametri: a) quello sistemico, che mira a cogliere il grado di subordinazione/autonomia dei media e
dei loro operatori dalla politica e b) quello massmediale, relativo all’orientamento professionale dei
mezzi di comunicazione di massa.
Il primo parametro, sistemico, è costruito sulla base di quattro dimensioni:
1. la struttura proprietaria del sistema dei media; il grado di controllo statale dei mass media (nomina
dei vertici dei vertici dei giornali, finanziamenti, linee editoriali), massimo nei sistemi autoritari ma
sensibile anche in alcune democrazie, come l’Italia;
2. il grado di partisanship dei mass media è tanto maggiore quanto i giornali e le televisioni sono di
proprietà delle forze politiche e dei loro leader;
3. il grado di integrazione delle élite politico-mediali: tra i due gruppi c’è separatezza – ed è bene che
ci sia – o c’è simbiosi (es. giornalisti che diventano politici e politici che fanno i giornalisti)?
4. Il grado in cui la professione di giornalista è percepita come indipendente da pressioni e viene
riconosciuta la sua funzione sociale che in democrazia si risolve principalmente nell’advocacy,
promozione e difesa dei diritti, e nel watchdog, controllo dei potenti.
Quest’ultima dimensione fa da ponte con il secondo parametro, massmediale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Ad un polo vi è l’orientamento pragmatico, “in questo caso, i newsmedia sono portati a dare
copertura informativa a quegli aspetti ed elementi della vita politica che essi ritengono corrispondere
innanzitutto alla domanda del loro pubblico”.
Al polo opposto troviamo l’orientamento sacerdotale tipico di un giornalismo sensibile alle esigenze
del sistema politico, “pronto a officiare il rito dell’informazione al servizio di parte, sia pure delle più
alte cariche di governo, mettendo in secondo piano le regole e le pratiche della logica mediale”.
Gli Stati Uniti rientrano nel primo caso, mentre paesi quali l’Italia, la Svezia e la Francia nel secondo.
Nel primo caso prevale il modello “avversariale”, fatto da un giornalismo eroico, cane da guardia
contro i potenti, negli altri casi si oscilla tra il modello del “collateralismo”, del giornalismo schierato
politicamente, e il modello “competitivo” nel quale il rapporto tra i due termini è di sfida.
Vi è una tendenza di lungo periodo all’americanizzazione della politica.
Tali sviluppi riguarderebbero una serie di caratteristiche strutturali e processuali della comunicazione
politica.
In primo luogo, la crescente importanza del marketing politico, volto a valorizzare le potenzialità
del candidato rispetto a un certo numero di elettori, e della sue evoluzione nelle campagne
comunicative negative, in cui si cerca di demolire la credibilità degli avversari e si ricorre a messaggi
che sollecitano reazioni emotive del pubblico, come la paura o l’identificazione con posizioni estreme.
In secondo luogo, l’evidente tendenza alla personalizzazione della politica, che può assumere due
forme distinte:
1. la leaderalizzazione dei vertici dei partiti; la centralità data nelle campagne elettorali all’immagine
dei candidati e dei leader, amplificate dai media;
2. la presidenzializzazione dei sistemi di governo con l’acquisita rilevanza (sia per le competenze
formali attribuite che per la legittimità sociale acquisita) dei vertici degli esecutivi, tanto più se eletti
direttamente dagli elettori.
4. Gli attori della politica orizzontale
4.1. I gruppi di interesse
I gruppi di interesse sono organizzazioni formali “di carattere permanente, dotate di personale a
tempo pieno, che si specializzano nell’opera di individuazione, promozione e difesa degli interessi,
influenzando e contestando le autorità e le politiche pubbliche”.
Da tale definizione si ricava, in primo luogo, che i tratti che li caratterizzano sono sia organizzativi (la
struttura) che attinenti alle modalità di azione (le funzioni).
In secondo luogo, risalta la distinzione tra “gruppo di interesse” e “gruppo di pressione”.
Se è vero che ogni gruppo di pressione è anche un gruppo di interesse, non vale il reciproco.
Il gruppo di interesse si qualifica come “attore del sistema sociale” volto alla tutela di specifici
interessi economici.
Il gruppo di pressione rimanda invece alle strategie adottate per il perseguimento dei fini
istituzionali, appunto la possibilità di influenzare anche grazie alla minaccia di sanzioni positive
(sostegno elettorale, economico, di expertise) o negative (ritiro del consenso, protesta, cambiare
referente politico) le autorità politiche.
Ad esempio, un’associazione di categoria o un sindacato, ma anche un gruppo che si pone l’obiettivo
di tutelare il paesaggio (es. Wwf, Italia Nostra) sono gruppi di interesse, in quanto aggregano individui
che condividono moventi o preferenze, si pongono obiettivi di tutela di certi interessi o di promozione
di specifici valori o diritti, comunque, agendo prevalentemente sul terreno della società civile.
Per contro, quando per le loro strategie li mettono in relazione con il sistema politico e li portano a
cercare di influenzarne le decisioni, agiscono quali gruppi di interesse.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Altri concetti da distinguere sono quelli di lobby e lobbying, con i quali ci si riferisce all’insieme di
attività o processi attraverso i quali i rappresentanti dei gruppi di interesse comunicano ai decision-
makers informazioni circa i desideri delle loro organizzazioni.
Almond e Powell classificano i gruppi di interesse nei seguenti tipi.
1. i gruppi anomici, strutture per lo più spontanee e non formalizzate che danno voce alla protesta,
talvolta anche violenta, nei confronti di ciò che le autorità e i governi fanno o non fanno;
2. i gruppi di interesse non associativi, si basano su legami tradizionali (razza, genere, discendenza,
religione, lingua, territorio) o su “interessi comunemente percepiti” di tipo moderno (es. i gruppi di
consumatori); mancano di un’organizzazione specializzata anche se la loro attività mostra una
maggiore continuità nel tempo;
3. i gruppi di interesse istituzionali, costituiti da istituzioni globali (la Chiesa, l’esercito, la
magistratura) o da sottogruppi intraistituzionali (dirigenti degli enti locali, pubblici ministeri,
dipendenti pubblici di una particolare regione), svolgono attività di pressione specializzate che
comunque non esauriscono le attività delle istituzioni;
4. i gruppi di interesse associativi, caratteristici delle democrazie pluraliste: sono strutture altamente
formalizzate e differenziate volte a rappresentare e tutelare gli interessi specifici di un gruppo
particolare (sindacati, associazioni di categoria, imprese, lobby).
La formazione dei gruppi di interesse non è un prodotto spontaneo della società.
Molti gruppi, addirittura, nascono in seguito a decisioni pubbliche.
Su questa scia, Offe distingue tra:
i gruppi di interesse economici, imprese, sindacati, associazioni padronali, che riflettono
l’organizzazione di classe e la divisione sociale del lavoro; il loro principale obiettivo è influenzare le
politiche pubbliche che incidono sulla posizione che i loro membri hanno sul sistema economico;
i gruppi fruitori delle politiche pubbliche nascono direttamente come conseguenza dell’intervento
statale e molto probabilmente non esisterebbero nemmeno senza tale intervento, si pensi alle diverse
categorie di pensionati, ai cassintegrati, ai lavoratori socialmente utili e, in genere, ai beneficiari di
qualche aiuto pubblico.
Una proposta sistematica di classificazione dei gruppi di interesse si deve a Salisbury, ripresa da
Mattina, che sulla base delle finalità istituzionali o “contenuto di interesse” distingue tra:
1. i gruppi sezionali o economici (sindacati, associazioni di categoria o professionali, singole imprese);
2. i gruppi promozionali o volti a una causa pubblica (Greenpeace, Medici Senza Frontiere);
3. i gruppi istituzionali (dirigenti pubblici, magistrati, forestali).
I rapporti tra interessi e istituzioni sono stati compendiati in alcune modalità specifiche che prevedono
una graduazione di controllo/autonomia degli interessi nei loro rapporti con le istituzioni e i partiti
(Morlino, Mattina):
1. il dominio partitico (o “occupazione”), ad esempio la Dc e la Coldiretti in Italia nel secondo
dopoguerra;
2. la simbiosi tra partiti e gruppi ideologicamente affini, ad esempio le relazioni tra sindacati e partiti
di sinistra in Europa;
3. la collaborazione (o “neutralità partitica”) volta alla tutela di interessi per lo più di natura
economica;
4. lo scambio tra consenso (ai partiti e ai candidati) e decisioni favorevoli (ai gruppi);
5. infine, con la subordinazione (o “egemonizzazione”) il gruppo di interesse sponsorizza la
formazione del partito politico, fornisce legittimazione, risorse organizzative e finanziarie talvolta
anche leadership, favorendone la sovrapposizione tra personale e strategie.
4.2. I movimenti sociali
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La nozione di movimento non è tra le più chiare delle scienze sociali.
Per la loro stessa natura, i movimenti sono fluidi e cangianti, non hanno confini certi.
Rappresentano un universo sociale più che un attore singolo.
Sono forme di azione collettiva “oppositive” rispetto ai tradizionali canali della politica istituzionale
(partiti, parlamenti) e del mercato (gruppi di interesse).
Inoltre, le caratteristiche che hanno assunto nella società postindustriale li rendono in gran parte nuovi
rispetto ai loro predecessori della società industriale a centralità del lavoro.
“I movimenti giovanili, femministi, ecologici, etnico-nazionali, pacifisti, non hanno solo portato sulla
scena attori conflittuali, forme di azione e problemi estranei alla tradizione di lotte del capitalismo
industriale; essi hanno messo in primo piano anche l’inadeguatezza delle forme tradizionali di
rappresentanza politica a raccogliere in maniera efficace le domande emergenti”.
I movimenti sono delle a) reti di relazioni prevalentemente informali, b) basate su credenze condivise e
solidarietà, c) che danno luogo a una mobilitazione di tipo conflittuale, d) attraverso il ricorso a varie
forme di protesta.
In primo luogo, perché nascono i movimenti?
Il semplice riferimento alla protesta è limitativo.
Per Charles Tilly i movimenti sono sempre il prodotto delle asimmetrie nella distribuzione del potere
(politico ed economico) e delle lotte tra gruppi per il riequilibrio che ne conseguono.
Per Alberto Melucci i movimenti sono il prodotto (indesiderato) del mutamento sociale e politico e,
soprattutto, del disagio prodotto dal contrasto tra i vincoli oggettivi e le aspettative (bisogni, desideri)
soggettivi.
Per Francesco Alberoni i movimenti nascono dalla delusione: “i membri delle classi minacciate di
declassamento e quelli delle classi in ascesa hanno in comune la delusione nei riguardi di un ordine in
cui avevano creduto per cui, nell’impossibilità di realizzarsi, sono trascinati a esplorare strade
alternative”.
In secondo luogo, le condizioni strutturali non sono tutto.
L’attivazione e l’efficacia dei movimenti sociali dipende anche da una serie di aspetti complementari –
veri e propri meccanismi di facilitazione dell’azione collettiva.
Il primo di questi si riferisce al fatto che i movimenti sono dei networks, delle reti di reti.
“I movimenti sono un intreccio di piccoli gruppi, reti di relazioni sociali e loro interconnessioni”.
Da questo loro carattere dispersivo deriva la centralità della mobilitazione delle risorse – umane,
conoscitive, relazionali – indispensabili per intraprendere con successo l’azione collettiva volta a
perseguire fini condivisi.
Così come deriva la necessità di dare ordine ai soggetti che popolano “l’universo sociale” dei
movimenti: si tratta del problema del coordinamento dell’azione collettiva.
In questa prospettiva, risalta l’importanza del leader e della leadership.
In terzo luogo, tali reticoli sono tenuti assieme – oltre che dal leader – dallo sviluppo di un sistema
di credenze condivise e dal senso di solidarietà che intercorre tra i partecipanti.
In quarto luogo, esistono molte forme di azione collettiva: volontariato, associazionismo, adesione a
un gruppo di interesse o a un partito.
Ciò che contraddistingue i movimenti sociali è la loro azione di tipo conflittuale.
“I movimenti avanzano rivendicazioni mediante un’azione di sfida diretta, rivolta contro élite,
autorità, altri gruppi o determinati codici culturali”.
Sidney Tarrow individua quattro tipi di movimenti sociali, sulla base del grado di opposizione (parziale
o totale) e delle interazioni (conflittuali o cooperative) che intrattengono con le istituzioni.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
I movimenti espressivi sono orientati all’affermazione di un’identità e a rapporti antagonisti con il
sistema di interessi e valori dominante (i tradizionali movimenti contadini e operai, così come
movimenti più recenti quali quello femminista e studentesco).
Di recente, tali movimenti di protesta hanno trovato nella crisi economica e finanziaria un terreno
fertile per attecchire (es. Indignados, Occupy Wall Street, ecc.).
I movimenti di riforma rivendicano libertà e diritti e, in genere, il conseguimento della cittadinanza
o di suoi particolari aspetti (dai movimenti antischiavisti negli Stati Uniti nell’Ottocento, ai movimenti
per i diritti politici delle classi popolari, fino ai più recenti movimenti ecologisti).
I movimenti integralisti mirano a sovvertire le istituzioni politiche e sociali moderne e per
raggiungere tale obiettivo ricorrono ad attività apertamente conflittuali (leninismo, nazionalismo
integralista, fondamentalismo religioso).
I movimenti comunitari rifiutano le istituzioni esistenti e cercano di creare comunità alternative e
autosufficienti sottratte alla loro influenza, senza con ciò avere l’intenzione di sovvertire l’ordine
sociale, ma piuttosto di convivere (gruppi controculturali, punk, comuni, sette e movimenti religiosi
come i mormoni).
Come conseguenza delle trasformazioni dei sistemi di rappresentanza, i movimenti evolvono verso
ulteriori e nuove forme che rendono il confine con i gruppi promozionali più sfumato, e che possiamo
indicare di seguito:
gruppo di interesse pubblico: caratterizzato da identità universalistiche e monotematico (o single
issue); struttura organizzativa e membership formale; strategie di intervento di lobbying e
concentrazione; vi rientrano anche i gruppi di pressione “promozionali” di certi valori (Italia Nostra,
Wwf, Amnesty International, ecc.) caratterizzati, rispetto ai gruppi di interesse tradizionali, per non
articolare interessi meramente economici e sezionali;
associazione di nuovo volontariato: caratterizzata da identità universalistiche; struttura
organizzativa permanente, partecipativa e reticolare; strategie di intervento di offerta di servizi;
circolo controculturale: caratterizzato da identità universalistiche; struttura organizzativa
partecipativa e reticolare; strategie di protesta anche radicale; sono, queste, forme che si avvicinano ai
gruppi di interesse anomici di Almond e Powell;
comitato: caratterizzato da identità localistiche; struttura organizzativa partecipativa, flessibile e con
bassi livelli di coordinamento; strategie di azione che privilegiano la protesta, seppure in forme
moderate.
Data la loro natura reticolare e discontinua, fluida e antagonista, la questione delle trasformazioni dei
movimenti dovuta al trascorrere del tempo e ai rapporti con le istituzioni pone sfide cruciali per la loro
identità e sopravvivenza.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Il tema è al centro di due contributi (Neveu, Kriesi) dai quali ricaviamo quattro tendenze evolutive.
L’istituzionalizzazione, che si registra quando il movimento cessa di essere un mezzo di
mobilitazione in vista di un fine condiviso per trasformarsi in un gruppo di pressione o, addirittura, in
un partito politico.
La commercializzazione, quando il movimento si trasforma in una specie di imprese sociale che
eroga servizi commerciali (es. cooperative sociali).
L’involuzione, quando l’azione mobilitante diretta a sostenere la sfida collettiva lascia il posto alle
attività espressive ed il movimento diventa uno spazio di socialità che fornisce servizi e attività ludiche
agli aderenti e simpatizzanti.
La radicalizzazione, quando il movimento si avvita su se stesso, esaspera i tratti conflittuali e
antisistemici. La sfida viene rivitalizzata e così anche la mobilitazione antagonista, talvolta fino ad
assumere forme violente.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
CAPITOLO 10 – Processi decisionali e politiche pubbliche
1. La politica in azione
La politica non è solo potere o lotta per influenzarlo, ma è anche un’attività o una sfera di azioni
finalizzate a risolvere problemi ritenuti di rilevanza collettiva.
La “politica”, intesa come attività finalizzata a individuare e cercare di risolvere problemi collettivi,
non è fatta solo di momenti topici (vittoria elettorale) o di singole decisioni (approvazione di una
legge), ma di una serie continuativa di azioni, discussioni, progettazioni, svolte a diversi livelli e in
diversi contesti.
La politica in azione è fatta di processi complessi e articolati in cui possono innescarsi dinamiche che,
di fatto, diluiscono le decisioni elettorali oppure gli impegni presi dai detentori del potere.
Non basta, quindi, avere potere formale o reputazionale per prendere decisioni efficaci.
Non basta chiedersi “chi comanda” o “chi ha il potere” per comprendere come funzionano i processi
decisionali e perché essi hanno alcuni esiti piuttosto che altri.
Così facendo, sarebbe impossibile spiegare, ad esempio, perché, in Italia, alcune opere pubbliche
strategiche non siano mai state costruite e altre lo siano state dopo decenni di discussione; oppure,
comprendere perché la sanità funziona in modi estremamente diversi nelle diverse aree del paese.
Insomma, i processi decisionali hanno bisogno di categorie concettuali ad hoc per essere compresi.
Per questo, per affrontare la politica in azione, è opportuno ricorrere al concetto di politica pubblica,
quindi a un modo di affrontare i processi decisionali per il quale “chi ha il potere” è solo uno degli
elementi costitutivi del processo mediante il quale si decide cosa fare e si attua la decisione presa.
Pertanto, è necessario adottare una prospettiva più articolata dei processi decisionali, capace di
focalizzare l’attenzione non solo su chi vuole cosa, ma anche su:
come i problemi collettivi vengano costruiti come tali; cioè, come un evento o una serie di eventi
vengano percepiti avere una rilevanza sociale e politica e quindi siano ritenuti meritevoli di attenzione
da parte dei decisori;
le modalità di interazione degli attori (che molto più spesso del previsto cooperano o comunque non
configgono);
la rilevanza di fattori spesso incontrollabili dai decisori stessi.
2. I processi decisionali come politiche pubbliche
Decidere deriva dal latino de-cadere, “tagliar via”.
La comprensione della formalizzazione di un atto di volontà che, “tagliando via”, sceglie una specifica
alternativa rispetto a un problema, deve essere inserita in uno specifico contesto.
Ad esempio, l’approvazione di una legge da parte del parlamento non è rilevante solo per il fatto in sé
(una maggioranza politica che prende una decisione per la collettività), ma anche per il processo che
ha condotto a quella specifica scelta.
Un processo che è fatto di tante decisioni e non decisioni, della scelta di come definire il problema da
risolvere, delle discussioni tra i portatori di interessi più rilevanti, ecc.
Senza contare, poi, che quella decisione parlamentare dovrà essere attuata e, quindi, affrontare un
ulteriore processo decisionale mediante il quale si cercherà di raggiungere gli obiettivi stabiliti.
La decisione in quanto tale è, pertanto, la punta di un iceberg che cela un complesso intreccio di azioni
e interazioni che necessita di essere ordinato, descritto e spiegato.
E qui viene in aiuto l’analisi delle politiche pubbliche che concettualizza la politica in azione come
politica pubblica.
Vi sono dei punti su cui vi è una sufficiente condivisione degli studiosi:
in primo luogo, il fatto che le politiche sono caratterizzate da un’intenzionalità perseguita dagli
attori coinvolti, che sono i veri protagonisti delle politiche;
in secondo luogo, le politiche sono un fenomeno dinamico e processuale, che si sviluppa nel tempo.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Questi tre elementi (attori, intenzionalità, dinamicità) sono stati variamente utilizzati nelle proposte di
definizione avanzate in letteratura.
Per ordinare questa varietà è utile dividere le definizioni in due tipi, a) quelle “ristrette”, che
focalizzano l’attenzione sul ruolo del governo o comunque su quello dell’autorità pubblica, e b) quelle
“ampie”, che mirano a includere maggiore variabilità di attori e venti.
Definizioni “ristrette” di politica pubblica
Ogni cosa che i governi scelgono di fare o non fare.
Deliberata coercizione, cioè un insieme di statuizioni finalizzate a fissare i propositi, i mezzi, i
soggetti e gli oggetti della coercizione.
Il prodotto dell’attività di un’autorità dotata di potere politico e legittimità a governare.
Le definizioni ristrette riconducono la politica pubblica ad una prospettiva tradizionale, intendendola
come un fenomeno molto simile alla decisione politica, all’atto di volizione degli attori pubblici o,
comunque, ad attività processuale degli stessi.
Si tratta di una prospettiva assolutamente legittima e utile che, però, non consente di cogliere alcuni
aspetti decisivi dei processi decisionali (quali altri attori partecipano, quali interazioni sussistono tra gli
attori, quali le poste in gioco).
Definizioni “ampie” di politica pubblica
Un corso di azione intenzionale di una persona, un gruppo o governo all’interno di un dato
ambiente che presenta opportunità e vincoli che la policy si ripromette di utilizzare e superare nello
sforzo di raggiungere un fine o realizzare un obiettivo o un’intenzione.
Un particolare oggetto o gamma di oggetti che sono intesi concernere un desiderato corso di eventi,
una selezionata linea di azione, una dichiarazione di intenti e una implementazione degli intenti.
L’insieme delle azioni compiute da un insieme di soggetti, che siano in qualche modo correlate alla
soluzione di un problema collettivo – e cioè, un bisogno, un’opportunità o una domanda insoddisfatta
– che sia generalmente considerato di interesse pubblico.
Le definizioni ampie di politica pubblica consentono di includere una pluralità di dimensioni e di
elementi rilevanti per un processo decisionale.
Si tratta di definizioni che non solo assumono una dinamica processuale delle decisioni di policy, ma
anche la presenza di una pluralità di attori che agiscono con il fine di risolvere problemi collettivi, o
percepiti come tali.
Le definizioni ampie di politica pubblica consentono una visione più realista dei processi decisionali
perché cercano di comprendere come si intersecano nella quotidianità della loro dinamica la ricerca del
potere con l’attività di decifrazione della realtà al fine di dare certezze alla collettività.
Traendo origine dalla proposta di Lasswell di ordinare funzionalmente le attività che si manifestano nel
corso dei processi di policy, gli studiosi delle politiche pubbliche sono andati via via disegnando e
perfezionando una modellistica finalizzata a ordinare, scomponendola, la complessità di tali processi.
Queste proposte suddividono le dinamiche processuali delle policies in alcune fasi: la costruzione
dell’agenda (che comprende l’emergere del problema, la sua definizione e il duo inserimento
nell’agenda); la formulazione del programma di policy (la fase in cui, dopo aver considerato le
alternative possibili, la decisione viene presa); l’implementazione del programma statuito; la
valutazione; infine, l’eventuale estinzione della politica stessa.
FORMULAZIONE FORMULAZIONE
IMPLEMENTAZIONE VALUTAZIONE
DELL’AGENDA E DECISIONE
Costruzione dell’agenda, formulazione, implementazione e valutazione sono intese non solo come fasi
ma come attività intrinsecamente costitutive dei processi decisionali.
Ciò significa che esse coesistono, continuativamente, nella realtà quotidiana dei processi decisionali,
costituendo più che delle fasi collocate linearmente nel tempo delle vere e proprie arene politiche al
tempo stesso autonome e interdipendenti con le altre.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Per arena politica si intende uno schema istituzionalizzato di comportamenti in cui determinati attori
perseguono un determinato obiettivo (mettere in agenda un problema, prendere una decisione, attuare
le decisioni, valutare gli effetti delle decisioni).
3. La formazione dell’agenda
3.1. La funzione strategica dell’agenda setting
Ogni processo decisionale si sviluppa in relazione a un problema, ritenuto avere una rilevanza per la
collettività, da risolvere.
La fase di formazione dell’agenda ha un ruolo centrale nell’analisi delle politiche pubbliche.
Infatti, è proprio nella costruzione dell’agenda che si struttura quella selezione delle alternative che è
lo strumento supremo per l’esercizio del potere; ed è sempre nel processo di individuazione dei
problemi collettivi che si manifesta la “seconda faccia del potere”, che consiste nella capacità di alcuni
attori elitari di far convergere l’attenzione pubblica su alcune questioni piuttosto che su altre.
La strategicità dell’agenda setting, pertanto, risiede proprio nel fatto che la posta in gioco delle
dinamiche che si manifestano in questa fase è costituita proprio dal decidere ciò su cui si deve
decidere.
3.2. La struttura dell’agenda setting
È opportuno distinguere tra agenda sistemica, agenda istituzionale e agenda decisionale.
L’agenda sistemica è l’insieme delle questioni che una comunità politica ritiene meritevoli, seppur
con diversa variabilità e variabile intensità, di una qualche attenzione.
L’agenda istituzionale è l’insieme dei problemi (chiaramente definiti) che vengono tenuti in
esplicita considerazione dagli attori decisionali.
L’agenda decisionale è l’insieme dei problemi sui quali gli attori preposti alle decisioni agiscono
attivamente al fine di prendere una decisione.
La fase di agenda è caratterizzata da una dinamica concentrica che, sulla base del comportamento degli
attori interessati, porta a una progressiva selezione delle questioni sulle quali i decisori si
applicheranno davvero.
Il movimento dall’agenda sistemica all’agenda decisionale, passando per quella istituzionale, è
fortemente influenzato dalle caratteristiche del sistema politico-istituzionale, dalla cultura politica di
un determinato paese, dalla contingenza storica, e dalle capacità degli attori di perseguire i propri
obiettivi pro o contro l’emergere di una questione rispetto a un’altra.
3.3. La dinamica dell’agenda setting
La dinamica di formazione dell’agenda è caratterizzata da due passaggi fondamentali: la “definizione
del problema” e la mobilitazione del supporto necessario per arrivare all’“iscrizione della questione
nell’agenda decisionale”.
La definizione del problema (o dei problemi)
Tale momento iniziale è assolutamente significativo.
Immaginiamo di trovarci in un’arena vuota, nella quale non esista alcun problema di cui discutere.
Immaginiamo che gli attori che gravitano in questa arena comincino a ragionare su un fatto (es. una
rilevazione statistica che quantifica nel 20% la disoccupazione della popolazione attiva).
Questo dato, per essere definito come problema, deve essere interpretato.
Cioè, deve essere inserito all’interno di una teoria causale.
Insomma: per dire che questo dato è un problema di rilevanza collettiva è necessario non solo mostrare
gli effetti negativi che esso causa alla collettività, ma anche “spiegare” perché il fenomeno si è
sviluppato in un dato modo, fino a raggiungere quella specifica percentuale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Questa operazione non è affatto neutra, ed è lecito ipotizzare che di fronte a questa necessità di
interpretazione/spiegazione causale si confrontino almeno due posizioni diverse.
Vi sarà, ad esempio, chi evidenzierà come l’alta disoccupazione sia il prodotto di una regolazione
impropria del mercato del lavoro oppure di un eccessivo costo dello stesso; vi sarà chi, invece,
evidenzierà come la causa primaria sia dovuta a una scarsa produttività o a scarsi investimenti.
Questo dibattito vedrà prevalere una definizione rispetto a un’altra.
E il problema, così definito, potrebbe trovare sufficiente sostegno per entrare nelle agende istituzionale
e governativa.
Ciò che conta in questa fase è, pertanto, il fatto che la definizione di un problema collettivo implica
che a esso venga imputata una specifica teoria causale che individua una gamma di possibili soluzioni,
escludendone altre.
Ed è proprio questa la natura intrinsecamente “politica” della definizione del problema: nel momento
stesso in cui si definisce qualcosa come un problema sul quale si deve decidere, si prestruttura l’ambito
delle soluzioni perseguibili.
Di questo carattere intrinseco della definizione prevalente sono perfettamente consapevoli gli attori in
gioco che, pertanto, agiranno in modo conseguente.
Giova osservare come una volta emersa una specifica definizione del problema, essa non deve essere
considerata definitiva.
Infatti, i “perdenti” cercheranno durante tutto il processo decisionale di far riemergere la propria
definizione del problema, quindi le proprie soluzioni.
In questo senso, la definizione del problema non è solo l’inizio della fase di agenda, ma caratterizza
tutto il decorso dei processi decisionali.
L’iscrizione del problema nell’agenda decisionale
Non basta che un problema venga rilevato e interpretato come un problema collettivo.
È necessario che esso venga sufficientemente condiviso per riuscire ad entrare nell’agenda decisionale.
Si tratta di un processo articolato e differenziato a seconda del tipo di problema e dell’arena
istituzionale nella quale esso viene trattato.
Cobb, Ross e Ross, puntando l’attenzione sul “chi” e sul “come”, hanno formulato una tipologia
dell’agenda setting che individua tre modelli di formazione dell’agenda:
nel primo tipo (outside iniziative model) un attore collettivo, esterno alle reti istituzionali, agisce al
fine di inserire una questione nell’agenda politica, auspicando che i decisori la inseriscano nell’agenda
costituzionale;
nel secondo tipo (mobilization model) sono gli attori politico-amministrativi che, intendendo
decidere su una data questione, agiscono per inserirla nell’agenda politica mirando a suscitare
l’interesse popolare al fine di costruire il supporto necessario alla decisione;
il terzo tipo (inside access model) assume che le questioni entrino in agenda per vie interne al
circuito politico-amministrativo, sulla base delle interazioni del sistema partitico, delle richieste degli
apparati amministrativi e dei gruppi di interesse privilegiati, delle scadenze istituzionalizzate prefissate
(es. legge di bilancio, rifinanziamento del debito pubblico).
Sul cambiamento del contenuto delle agende decisionali hanno focalizzato la propria attenzione altri
schemi interpretativi.
Prima di tutti, va ricordata la proposta di Kingdon che è basata sull’assunto che un nuova questione, o
una nuova soluzione, riescano a entrare nell’agenda istituzionale, ed eventualmente in quella
decisionale, solo se si crea una finestra di politica pubblica (policy window).
Secondo Baumgartner e Jones la dinamica di agenda è caratterizzata da periodi di stabilità, in cui
tende a persistere la medesima definizione del problema e quindi delle relative soluzioni, e momenti di
drastico cambiamento, concausato da cambiamenti nell’attenzione dell’opinione pubblica, dalla
modificazione dei rapporti di forza tra gli attori in gioco, dalla mobilitazione sociale.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4. La formulazione
4.1. La struttura della formulazione
La fase/arena della formulazione comprende una serie di attività in cui l’esito atteso è, appunto, la
decisione.
Per formulazione si intende quella fase del processo di policy in cui si cerca di approvare una
soluzione praticabile al problema di policy definito nell’agenda decisionale.
La fase di formulazione è molto più strutturata di quella di agenda, anche perché essa si svolge quasi
totalmente all’interno delle istituzioni politiche e amministrative, pur se in stretta interazione con il
sistema esterno.
Essa si focalizza sull’individuazione delle soluzione perseguibili data la definizione del problema che,
al momento, risulta prevalente.
È la fase nella quale si disegna il contenuto della decisione e si costruisce il consenso politico per
formalizzarla.
Tradizionalmente, la fase di formulazione è suddivisa in due sotto-fasi: a) l’elaborazione tecnica e b)
la decisione politica vera e propria.
L’elaborazione tecnica avviene all’interno degli apparati amministrativi (ministeri, assessorati), mentre
la costruzione del consenso politico avviene all’interno delle istituzioni politiche in senso stretto (il
consiglio dei ministri, le assemblee legislative).
Fermo restando che essa si svolge prevalentemente nelle sedi istituzionali preposte, la fase di
formulazione sembra essere l’arena in cui, più che in altre, si organizzano strutture relazionali
specifiche e tendenzialmente persistenti nel tempo.
Queste caratteristiche, portano necessariamente all’enfasi sui policy network come strutture relazionali
predominanti nei processi di formulazione.
Generalmente, con il concetto di policy network si intende “un reticolo di attori, pubblici e privati,
dotati di risorse quantitativamente e qualitativamente diverse, e operanti all’interno di uno spazio
definito dal problema di policy”.
I principali tipi di network sono: il triangolo di ferro, l’issue network, la policy community, l’advocacy
coalition.
Il triangolo di ferro rappresenta una struttura relazionale caratterizzata dalla presenza di rapporti
istituzionalizzati, anche se informali che, all’interno di uno specifico settore di politica pubblica,
legano in modo stringente gli apparati burocratici di riferimento, le commissioni parlamentari e i
gruppi di interesse più importanti del settore.
Si tratta di un sistema relazionale antipluralista, che focalizza l’attenzione sulla possibilità che questi
attori abbiano la massima convenienza a gestire la formulazione delle politiche in arene isolate
dall’influenza dell’opinione pubblica e degli altri attori politico-amministrativi.
L’issue network si presenta come l’opposto del triangolo di ferro.
Infatti, esso è caratterizzato dalla presenza di un numero potenzialmente elevato e comunque
imprevedibile di attori, da un’elevata instabilità, dall’improbabilità che una decisione venga presa.
Si tratta di reti relazionali che si formano sulla base di una spinta emotiva laddove l’unica cosa in
comune tra gli attori partecipanti è la condivisione del fatto che esiste un problema comune.
La difficoltà a definire una comune strategia e l’assenza di una condivisione di interessi e di
prospettive future, rende questo tipo di network decisamente poco efficace nel medio-lungo periodo.
Se una soluzione non viene trovata in tempi stretti, l’issue network tende a dissolversi così come si era
formato.
La policy community si caratterizza per rappresentare una vera e propria comunità.
I membri di questo tipo di struttura relazionale condividono non solo un comune interesse per un
settore di politica pubblica, ma anche il riconoscimento reciproco.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La policy community è composta da un numero stabile e non elevato di attori (sindacalisti, membri di
organizzazioni di rappresentanza, parlamentari, burocrati, esperti di settore) che tendono a negoziare
tutte le questioni relative a un determinato settore di policy con uno stile consensuale.
Questo tipo di network tende a conquistarsi un ruolo egemonico all’interno di un settore di politica
pubblica che ne fa il locus per la costruzione tecnica e sostantiva delle decisioni.
Si tratta di una struttura relazionale che è presente spesso nei processi decisionali anche perché essa,
con la sua stabilità nel tempo, può rappresentare una risorsa di riferimento e delle legittimazione delle
decisioni per i decisori.
La capacità di questi network di sopravvivere nel tempo è piuttosto elevata, grazie alla loro capacità di
adattarsi alle modificazioni ambientali.
Il cambiamento dell’arena può essere causato solo da un significativo shock esterno (elezioni
spartiacque, drastica mutazione dei convincimenti dell’opinione pubblica) che provochi la
delegittimazione della community.
Il concetto di advocacy coalition delinea il processo decisionale come un’arena in cui si
contrappongono almeno due network – coalizioni, appunto – che competono per imporre le proprie
soluzioni.
Questo tipo di struttura relazionale delinea un processo formulativo nel quale il network dominante
(grazie a una serie di condizioni esterne, in primis il tipo di coalizione al governo) impone le proprie
decisioni in un contesto in cui, però, viene continuamente sfidato da almeno un altro network.
4.2. La dinamica della decisione
Per cogliere le caratteristiche costitutive della dinamica decisionale e, quindi, del “come” si arriva a
prendere una decisione politica, si devono tenere insieme tre elementi essenziali: i modi mediante i
quali si può decidere; le caratteristiche del contesto politico-istituzionale nel quale si decide; le
caratteristiche della questione sulla quale si decide (la posta in gioco).
I modelli di decisione
L’analisi della decisione politica, cioè del processo di scelta tra più alternative è attività complessa che
necessita di una consistente razionalizzazione teorica.
In questo senso, sono disponibili quattro modelli di riferimento: il modello razionale, il modello
cognitivo (o della razionalità limitata), il modello incrementale e il modello del “bidone della
spazzatura” (garbage can). [v. tab. p. 308]
Il modello razionale assume che il decisore sia unitario e che abbia nelle proprie possibilità uno
stato di certezza cognitiva che consente di massimizzare l’utilità della decisione, avendo modo di
vagliare tutte le possibili alternative, simulando in modo realistico i possibili effetti.
Si tratta di un modello decisionale decisamente difficilmente utilizzabile nell’analisi dei processi
decisionali.
Neanche gli assunti di incertezza cognitiva (cioè che il decisore non possa disporre di tutte le
informazioni necessarie per decidere) e di sequenzialità nella definizione delle soluzioni (basata
sull’influenza delle routine, delle mappe cognitive preesistenti e delle soluzioni già in atto) proposti
dal modello cognitivo, riescono a risolvere il problema fondamentale dei modelli razionali: l’assunto
di unitarietà del decisore.
Si tratta di un problema teorico di non poco conto, laddove nei processi decisionali la differenza delle
preferenze degli attori, spesso configgenti tra loro, e le divergenze logiche di azione appaiono di
strutturale evidenza.
Proprio per risolvere questo strutturale problema dei processi decisionali sono stati proposti gli altri
due modelli decisionali.
Il modello incrementale si basa su un assunto tanto realistico quanto troppo spesso trascurato: il
fatto che i processi decisionali siano caratterizzati dall’interdipendenza di una pluralità di attori
partigiani (cioè portatori di specifici interessi).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La natura partigiana degli attori è fonte intrinseca di un potenziale di conflitto che in qualche modo
gli attori stessi devono risolvere mediante la negoziazione e la contrattazione.
Ovviamente, la possibile asimmetria delle risorse a disposizione rende la negoziazione più o meno
complessa o vantaggiosa per un attore rispetto a un altro.
Ciò non toglie che, in questo modello, la decisione origini necessariamente da un accordo tra logiche
di azione, interessi, valori diversificati tra loro (es. negoziazioni tra i partner di una coalizione di
governo; negoziazione tra governi a livello di Unione Europea).
Il modello incrementale coglie la natura fortemente politica dei processi decisionali e il suo intrinseco
pluralismo partigiano.
La decisione politica, in questa logica, non può che essere il prodotto del compromesso o della
contrattazione tra una pluralità di attori e, pertanto, non può che basarsi su un accordo partigiano.
Il modello del bidone della spazzatura offre una prospettiva radicalmente diversa dai tre
precedenti.
Esso, infatti, si basa sull’assunto di una sostanziale irrazionalità dei processi decisionali stessi.
Essi, secondo il garbage can model, sono caratterizzati da attori con preferenze mutevoli e niente
affatto date, da una significativa aleatorietà della partecipazione degli attori all’arena decisionale,
dalla rottura della logica “definisco il problema e trovo la soluzione”: le soluzioni preesistono ai
problemi e, anzi, aiutano a definirli.
Si tratta di un modello decisionale che assume la sostanziale “casualità” dei processi decisionali e del
contenuto della decisione politica.
In realtà, si tratta di un modello che enfatizza come l’azione e le preferenze degli attori decisionali
siano intrinsecamente fluttuanti e incerte se non ancorate a valori e pratiche istituzionalizzate.
Il contesto politico-istituzionale
Il processo formulativo che porta alla formalizzazione di una decisione politica non si svolge in un
vacuum, ma si dipana all’interno di uno specifico contesto politico-istituzionale che, pur non
determinando gli esiti, di certo ne influenza la dinamica.
Caratteristiche come la forma di Stato (unitario o federale), la forma di governo (parlamentare o
presidenziale), la struttura e la dinamica del sistema dei partiti (bipolare o multipolare), i cleavages
persistenti (socioeconomici, religiosi, linguistici), componendosi variamente a seconda delle tradizioni
storiche nazionali, costituiscono il contesto all’interno del quale la dinamica decisionale si sviluppa.
Due concetti possono catturare l’influenza aggregata dei fattori politico-istituzionali: quello di veto-
player e quello di policy style.
La teoria dei veto players individua le capacità di un attore di bloccare qualsiasi cambiamento
perseguito in un processo decisionale.
Ciò significa che, nella dinamica decisionale, quanto più numeroso sarà il novero degli attori capaci
di azioni efficaci di veto, tanto più probabile sarà che il processo si concluda o con un nulla di fatto o
con un incrementalismo minimo.
Il concetto di policy style cerca di cogliere l’influenza del contesto politico-istituzionale
costruendo una tipologia basata sull’attitudine dei governi ad avere una propensione ad anticipare i
problemi o a reagire a essi.
La posta in gioco
Le caratteristiche della posta in gioco influenzano fortemente la dinamica della formulazione della
decisione: è utile immaginare la dinamica decisionale come un’arena nella quale gli attori si muovono
perseguendo dei vantaggi.
Le caratteristiche dell’arena decisionale strutturano le caratteristiche della posta in gioco (il possibile
contenuto della decisione) e quindi il comportamento degli attori.
Gli attori decisionali sono ben consapevoli dei vincoli e degli incentivi che ogni situazione decisionale
offre per il perseguimento dei propri interessi (questo significa che, nel caso i propri interessi non siano
sufficientemente soddisfatti, possono cercare di cambiare la natura stessa dell’arena decisionale).
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
L’analisi della posta in gioco può essere sviluppata attraverso tre approcci teorici: l’approccio
tipologico, la teoria dei giochi e l’analisi razionale-istituzionale.
L’approccio tipologico risale ai contributi di Lowi, il quale assume che le caratteristiche della
policy in gioco determinino quali attori siano i protagonisti del processo decisionale, quali siano le
loro relazioni e, ovviamente, quale sia il contenuto della decisione.
La proposta tipologica di Lowi si basa sulla dicotomizzazione del criterio fondante la sua definizione
di “politica pubblica”, la coercizione.
Il prodotto di questo esercizio classificatorio è la quadripartizione delle politiche in “distributive”,
“redistributive”, “regolative” e “costituenti”. [v. fig. p. 312]
1. Le politiche distributive sono quelle in cui gli attori partecipanti ottengono tutti un qualche
vantaggio e, quindi, gli esiti decisionali sono, appunto, distributivi.
Se la posta in gioco è distributiva, molti attori partecipano al processo decisionale, ciascuno ottiene
un qualche vantaggio, in una interazione basata su un elevato consenso, anche perché i costi
possono essere occultati ovvero posticipati nel tempo (le elevate percentuali di debito pubblico sono
l’indicatore più eclatante di un modo di fare le politiche costantemente distributivo).
2. Le politiche redistributive spostano benefici e spettanze da un macrogruppo sociale a un altro
(es. politiche di welfare, politiche fiscali basate sulla progressività delle imposte sul reddito).
Esse vedono la partecipazione di attori fortemente rappresentativi delle classi sociali e un ruolo
attivo da parte dei governi; la loro natura implica che la decisione possa essere raggiunta solo se vi è
una condivisione da parte degli attori partecipanti.
3. Le politiche regolative mirano a modificare il comportamento degli individui o di specifici attori
collettivi o gruppi di interesse mediante obblighi e sanzioni (es. politiche monopolistiche, parte
delle politiche ambientali).
Si tratta di politiche altamente conflittuali, perché spesso i “regolati” non accettano di esserlo.
4. Le politiche costituenti sono quelle che stabiliscono le regole del gioco di un determinato settore
di politica pubblica (es. riforme organizzative degli apparati pubblici, riforme istituzionali).
Esse vedono come destinatari delle decisioni gli stessi decisori ed è per questo che raramente sono
efficaci.
Il secondo approccio è quello della teoria dei giochi.
Rileva sottolineare come i diversi possibili schemi di gioco decisionale si basino sulla percezione
degli attori, cioè a seconda che essi reputino che il gioco sia a somma positiva o a somma zero.
Nel primo caso gli attori tenderanno a collaborare (avendo la certezza di ottenere dei vantaggi), nel
secondo caso a confliggere (poiché per ottenere dei vantaggi dovranno arrecare degli svantaggi ad
altri attori).
Il terzo approccio è quello offerto dall’analisi razional-istituzionale.
In questo approccio le caratteristiche della posta in gioco (e quindi delle possibili logiche di azione
degli attori) sono strutturate da un complesso insieme di fattori (le decisioni prese precedentemente,
le caratteristiche del bene in gioco, le regole istituzionali, le caratteristiche culturali, sociali ed
economiche della comunità di riferimento).
Si tratta di un approccio molto articolato che, sostanzialmente, assume come la situazione decisionale
sia fortemente prestrutturata e, pertanto, vincoli gli attori decisionali in modo fortemente costrittivo
ad accettare la logica della posta in gioco.
4.3. Il contenuto della decisione
Ma cosa si decide quando si decide?
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Si decide come cercare di raggiungere degli obiettivi politici mediante l’individuazione di strategie di
politica pubblica.
Le strategie di politica pubblica sono costituite da un insieme di principi generali di azione di politica
pubblica accompagnati da specifici strumenti.
Uno strumento di policy è un metodo o un meccanismo mediante il quale viene indirizzata l’azione
collettiva al fine di raggiungere un effetto desiderato.
Hood ha individuato quattro tipi generali di strumenti:
a) la nodality (la capacità dei governi di svolgere un ruolo pivotale nei processi informativi);
b) l’authority (il potere legale e la legittimazione dei governi);
c) la treasury (le risorse finanziarie a disposizione dei governi);
d) l’organization (la capacità di azione diretta, almeno attraverso gli eserciti, la polizia e le
burocrazie).
La classificazione di Doern e Phidd, usando come principio classificatorio il livello di
legittimazione della coercizione, individua cinque tipi generali di strumenti:
a) l’autoregolazione;
b) l’esortazione;
c) la spesa pubblica;
d) la regolazione (includendovi anche la tassazione);
e) la proprietà pubblica.
La classificazione di Schneider e Ingram, incentrata sulle caratteristiche motivazionali del
comportamento individuale, presenta anch’essa cinque tipi di strumentazione:
a) gli strumenti autoritativi (presenza/assenza di disposizioni normative che indirizzino l’azione);
b) gli incentivi (presenza/assenza di stimoli premiali esterni all’azione);
c) gli strumenti che incidono sulle capacità di azione degli attori (presenza/assenza di risorse –
informazioni, educazione, organizzazione – necessarie all’azione);
d) gli strumenti esortativi (che cercano di incidere sui valori e le percezioni degli attori);
e) gli strumenti che cercano di incentivare l’apprendimento.
Infine, merita ricordare la distinzione analitica tra “strumenti sostantivi” e “strumenti procedurali”
proposta da Howlett.
1. Gli strumenti sostantivi sono quelli mediante i quali i governi determinano direttamente il tipo, la
quantità, la qualità e la distribuzione di determinati bene e servizi nella società.
2. Gli strumenti procedurali influenzano gli esiti delle politiche attraverso la manipolazione delle
caratteristiche dei processi di politica pubblica (es. contrattualizzazione delle politiche, creazione di
gruppi di interesse, regolazione dei meccanismi di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni,
riorganizzazioni amministrative, ecc.).
La dimensione procedurale di ogni tipo di strumento di politica pubblica è particolarmente rilevante
quando lo Stato limita il proprio intervento diretto (sostantivo) e costruisce strategie di policy in cui
governa a distanza le politiche utilizzando, appunto, strumenti procedurali.
La scelta degli strumenti e delle strategie da parte dei decisori è un’operazione complessa, spesso
dovuta a fattori contingenti, e fortemente influenzata dallo status quo e da pressioni esterne.
Questa dinamica ha condotto all’esistenza di strategie di politica pubblica caratterizzate
dall’assemblaggio di strumenti appartenenti a diverse tradizioni amministrative, a differenti teorie
causali.
È il trionfo dei policy mix, di decisioni politiche che sostanziano strategie di politica pubblica fondate
su un pluralismo incoerente nella scelta degli strumenti.
5. L’implementazione
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Spesso si ritiene che la decisione in sé quasi automaticamente produca degli effetti, ma in realtà non è
assolutamente così.
In realtà, qualsiasi decisione politica non produce alcun impatto sulla realtà se prima non viene trattata
attraverso una serie di azioni senza le quali la decisione non ha alcun effetto pratico.
Insomma, nonostante l’avvenuta presa delle decisioni, il processo decisionale non produce effetti sulla
realtà, se non attraverso l’avvio di un “nuovo” processo in cui esiste il concreto rischio che gli obiettivi
prefissati non vengano raggiunti o vengano distorti.
Questo processo decisionale viene definito “attuazione” o anche “implementazione” (dal latino impleo,
riempire).
L’implementazione è, pertanto, l’insieme delle “azioni dirette al raggiungimento di obiettivi posti da
precedenti decisioni di policy”.
In realtà, la fase di implementazione è una evoluzione, senza sostanziale soluzione di continuità, delle
fasi precedenti, ed essa ne presenta tutte le problematicità. In particolare:
1. coloro i quali hanno perso nelle fasi precedenti cercheranno di ribaltare la situazione con azioni
finalizzate ad annacquare le soluzioni statuite (cercando di catturare le strutture amministrative
preposte o di ottenere deroghe dal legislatore ovvero dalle autorità preposte all’implementazione);
2. la dinamica dell’implementazione difficilmente può essere di tipo autoritativo; pertanto, essa si
sviluppa sulla base di logiche negoziali tra gli attori partecipanti che strutturano anche
l’implementazione come un processo di mutuo aggiustamento partigiano; l’esito può essere, spesso,
quello di una ridefinizione dei fini della decisione politica;
3. spesso il contenuto delle decisioni è multiobiettivo, senza una chiara gerarchia tra le finalità da
raggiungere.
Inoltre, la fase di implementazione è fortemente influenzata da una serie di fattori, come le
caratteristiche economiche e socioculturali del territorio, le capacità tecniche delle burocrazie di
riferimento, le caratteristiche del sistema politico, le relazioni storiche tra amministrazioni pubbliche e
gruppi di interesse.
6. Valutare, apprendere, continuare a sbagliare
La valutazione è un’attività costitutiva dei processi decisionali. Essa non concerne solo l’esito del
processo decisionale ma si sviluppa durante tutta la dinamica dello stesso.
Innanzitutto, perché gli attori valutano continuativamente quello che stanno facendo per capire se la
loro azione è efficace sia in termini di policy sia in termini politici.
Ad esempio, gli attori politici sono ben consapevoli che riuscire a fare prevalere la loro definizione del
problema nella fase di agenda ha degli effetti diretti sulla loro legittimazione politica anche in termini
elettorali.
Merita concentrarsi sulla valutazione degli effetti delle politiche, quindi su quel tipo di attività
mediante il quale si cerca di determinare quali siano stati gli esiti effettivi dell’implementazione delle
decisioni politiche.
Si tratta di un’attività estremamente complessa e assolutamente problematica in relazione a due
questioni: come viene operata la valutazione e chi valuta.
La valutazione degli effetti di una politica pubblica non è un’attività “oggettiva” in senso stretto,
bensì un’attività soggettiva (in cui, cioè, i criteri di valutazione sono discrezionali) che viene resa
oggettiva dall’uso delle tecniche e di metodologie adeguate.
La valutazione delle politiche è un’attività intrinsecamente politica che spesso viene utilizzata dagli
attori politici come strumento si confronto e di conflitto politico piuttosto che come uno strumento
mediante il quale monitorare gli effetti delle decisioni e aggiustare ciò che sembra non andare.
Proprio questa caratteristica intrinseca della valutazione rende particolarmente rilevante la questione di
chi valuta.
I valutatori delle politiche possono essere sostanzialmente di tre tipi: attori indipendenti dal sistema
politico che ha prodotto le decisioni (es. Banca mondiale); attori interni al sistema a forte
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
legittimazione tecnica o politica (es. Istat, Banca d’Italia, commissione d’inchiesta parlamentare);
attori attivamente protagonisti del processo decisionale (i partiti politici, i gruppi di interesse).
È evidente che i primi due tipi appaiono in prima battuta più autorevoli e, quindi, più oggettivi degli
attori del terzo tipo.
7. Processi decisionali tra “government” e “governance”
L’analisi dei processi decisionali e delle politiche pubbliche è stata sottoposta negli ultimi vent’anni
alla sfida di una vasta letteratura che, traendo spunto da una certa percezione di crisi dello Stato e delle
capacità dei governi, ha enfatizzato come il ruolo dei governi nei processi decisionali sia diventato
meno significativo a vantaggio di una struttura di governo dei processi decisionali più orizzontale e
policentrica.
In questa prospettiva, le politiche pubbliche non sarebbero più governate in modo monolitico dallo
Stato e dalle istituzioni politico-amministrative, ma sarebbero coordinate mediante un intricato
intreccio relazionale tra più attori.
Il concetto utilizzato per cogliere questo presunto cambiamento è quello di governance.
CAPITOLO 11 – Dimensione sovranazionale e governance multilivello
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
1. Crisi dello Stato-nazione
1.1. Comunità immaginate
La vicenda dello Stato moderno descrive il processo di creazione e consolidamento, in Europa, di un
numero limitato di Stati-nazione a partire da un numero ben più ampio di realtà territoriali che, sotto la
guida di principi territoriali, tentavano di imporre il loro controllo su un determinato territorio.
Lo Stato territoriale si è imposto come forma dominante di regime grazie all’uso della forza.
Questa diventa metodo di controllo legittimo del territorio dai criminali, all’interno, e di difesa e
conquista dei territori fuori dai confini.
Il ricorso alla guerra come metodo di consolidamento dello Stato e strumento di regolazione dei
conflitti con gli altri Stati territoriali è fondamentale.
“Gli Stati fanno la guerra, la guerra fa gli Stati”, concludeva sinteticamente Tilly.
Il controllo del territorio e delle persone che in esso abitavano diventa quindi il principio fondante del
potere dello Stato europeo.
Nel corso del tempo si è cercato di creare negli abitanti degli Stati territoriali un’identità nazionale,
cioè un senso di appartenenza a una “comunità immaginata” con una storia e un destino comuni, così
che il rispetto delle leggi e l’estrazione delle risorse necessarie al mantenimento del controllo
diventassero più semplici.
Se la formazione degli Stati territoriali ha occupato almeno otto secoli, dal XII al XIX, la creazione di
comunità nazionali, partendo in ritardo rispetto al primo processo, si è prolungata fino al XX secolo.
La lotta fra nazioni – comunità di individui idealmente accomunati da una lingua, spesso una religione,
talvolta un’etnia e comunque un forte senso di appartenenza reciproca – ha raggiunto infatti il suo
apice nella prima metà del Novecento producendo due guerre mondiali.
Gli Stati nazionali non hanno però prodotto solo guerre e distruzioni, ma hanno anche costituito la
cornice istituzionale entro la quale la lotta per l’emancipazione delle masse e l’acquisizione dei diritti
politici, economici e sociali è stata combattuta e spesso vinta.
La democrazia, in tempi moderni, è pertanto concepita come democrazia nazionale.
Gli individui appartenenti a ciascuno Stato sperimentavano ogni giorno il significato profondissimo
dell’appartenenza alla stessa comunità statale e sviluppavano verso di essa un attaccamento e
un’identificazione che poteva apparire “originaria” mentre era stata costruita nel corso del tempo.
Cittadinanza e nazionalità andavano identificandosi: ancora alla metà del XX secolo, varcare i confini
di uno Stato significava contemporaneamente cambiare lingua, sistema politico e diritti sociali.
Ciò che rendeva lo Stato-nazione un costrutto particolarmente solido e vincente era il fatto che la
relativa chiusura dei confini statali – cioè la difficoltà oggettiva di cambiare cittadinanza – era
funzionale a garantire l’acquisizione e l’esercizio dei diritti a essa connessi.
Nonostante gli stranieri abbiano goduto da sempre di protezioni specifiche, talvolta anche molto
consistenti, la non appartenenza alla comunità nazionale comportava dei costi che, nel corso dei secoli,
sono andati sempre più crescendo.
La chiusura del sistema (impossibilità di exit) garantiva lo sviluppo del senso di appartenenza e
solidarietà (sviluppo di lealtà) sia la possibilità concreta di partecipare ai processi di
autodeterminazione democratica (esercizio della voice).
Ecco che il demos, detentore del kratos politico era la comunità nazionale: non si dava altra
democrazia che non fosse nazionale.
Questo connubio strettissimo raggiunse il suo apogeo negli anni immediatamente seguenti la Seconda
guerra mondiale ma, come spesso succede nel mondo naturale e sociale, la massima manifestazione di
un fenomeno avviene quando le determinazioni di questo fenomeno stanno già perdendo di forza.
In altre parole, gli Stati nazionali europei hanno raggiunto il massimo di consolidamento territoriale,
economico, sociale e politico proprio quando l’intensità delle forze che li avevano determinati veniva
messa in discussione da fenomeni inter-, trans- e sovranazionali.
1.2. Processi di integrazione regionale
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
La fine della Seconda guerra mondiale rappresenta l’“ora zero” non solo per la Germania sconfitta ma
per tutto il continente europeo dilaniato dai suoi nazionalismi ed egoismi economici.
L’idea stessa di nazione, dopo la guerra, pareva un concetto inutilizzabile per mobilitare quelle energie
positive che avrebbero potuto portare alla ricostruzione e alla rinascita.
La scelleratezza del progetto nazionalista – l’idea cioè di far coincidere anche con la forza Stato e
nazione imponendo un’identità culturale là dove essa urtava con altre identità locali ben radicate –
emergeva con forza in molti paesi europei.
L’artificiosità di suddivisioni territoriali imposte dalle potenze coloniali nei territori lontani conquistati
nel precedente periodo di colonizzazione iniziava a mostrare sintomi di disfacimento.
La volontà di autodeterminazione delle popolazioni colonizzate faceva nascere movimenti
indipendentisti proprio nel momento in cui anche nel continente europeo l’illusione di imporre unità e
solidarietà nazionali con la manipolazione culturale e con la forza mostrava tutti i suoi limiti.
Nel momento di maggiore debolezza e discredito del mito nazionalista si affaccia con prepotenza
l’idea, che il “governo del mondo” potesse essere garantito da agenzie funzionali, ciascuna incaricata
di gestire un funzione particolare, la cui giurisdizione attraversasse i confini nazionali.
Queste agenzie avrebbero dato origine a un working peace system, un sistema di pace che avrebbe
“funzionato” e avrebbe così creato una comunità di sicurezza.
I processi di integrazione regionale nascono così nel secondo dopoguerra, come tentativi di realizzare
su scala limitata e contigua quella gestione in comune di attività che, se perseguite su basi nazionali,
avrebbero probabilmente portato di nuovo gli Stati a farsi la guerra (v. Ceca / Cee).
La svolta “funzionalista” nelle relazioni internazionali non durò molto, e le leadership politiche del
dopoguerra si misero presto al lavoro per ricostruire economie e identità nazionali.
Già dall’attuazione del Piano Marshall si vide che la ricostruzione postbellica si sarebbe sviluppata
lungo tracciati nazionali e non avrebbe sortito quella stretta collaborazione fra paesi auspicata dagli
Stati Uniti.
1.3. Diffusione di regimi e organizzazioni internazionali
Il secondo dopoguerra vede anche la diffusione di una serie di accordi che vanno a costituire o
rafforzare organizzazioni internazionali e a creare regimi internazionali.
Il concetto di “regime” conosce una nuova primavera e si diffonde in campo politico, economico e
giuridico, insieme a quello di organizzazioni internazionali che dei regimi sono la manifestazione
formale e burocratica.
Un regime è un insieme di principi, norme, regole e procedure decisionali volte a raggiungere e
implementare scelte collettive.
Le organizzazioni internazionali sono entità formali create da tre o più Stati firmatari di un accordo
istitutivo che possiede una struttura permanente (un segretariato) che gestisce le attività
dell’organizzazione stessa.
Esempi di tali organizzazioni nel campo della pace e della sicurezza sono le Nazioni Unite, la Nato,
l’Opac (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) che promuove e verifica l’adesione
alla convenzione sulle armi chimiche che ne proibisce l’uso e ne chiede la distruzione, l’Aiea (Agenzia
internazionale per l’energia atomica) che sorveglia sul Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp).
In campo economico, il Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade), inaugurato nel 1948 e
sostituito nel 1995 dal Wto (World Trade Organization), per facilitare gli scambi commerciali
mondiali; la Banca mondiale, istituita nel 1944 allo scopo di aiutare la ricostruzione dei paesi usciti
dalla guerra e ora di combattere la povertà nel mondo, e il Fondo monetario internazionale, anch’esso
istituito nel 1944 allo scopo di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e garantire la
stabilità delle valute e l’ordine dei rapporti di cambio, entrambi risultanti dell’accordo di Bretton
Woods.
In campo umanitario, si diffondono le carte dei diritti fondamentali (Universal Declaration of Human
Rights, 1948) e le iniziative delle Nazioni Unite per i rifugiati (1951) e più tardi i trattati sulla
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
protezione delle lingue minoritarie (1992) sottoscritte dagli Stati nazionali soprattutto nell’ambito del
Consiglio d’Europa e gli accordi promossi dalle Nazioni Unite in ambito ambientale (1992).
Questi accordi, che pure limitano o regolano la sovranità degli Stati anche in modi nuovi e
significativi, rimangono però nell’alveo degli accordi fra gli Stati.
A questi occorre affiancare gli accordi che vanno proliferando fra attori provati che decidono di
autoregolare una serie di aspetti economici e professionali collegati alle loro attività.
Anche le organizzazioni non governative e non-profit si danno da fare per promuovere standard di
comportamento internazionali o per promuovere protocolli internazionali.
Sono queste tutte manifestazioni della presa di coscienza che i problemi dei giorni nostri non possono
più essere affrontati e risolti a livello nazionale ma necessitano di forme di cooperazione e regolamenti
internazionali.
Non si può non menzionare altri due fenomeni che confermano la volontà di prendere in seria
considerazione le esternalità causate dall’azione dei governi o attori economici nazionali sui cittadini
di altri Stati.
Da un lato, abbiamo l’adesione a codici di comportamento socialmente responsabili da parte di
imprese multinazionali.
Anche le imprese multinazionali, che grazie al fatto di operare in più contesti normativi possono
eludere le regole più ferree di questo o quel paese, capiscono in alcuni casi che la loro immagine
sociale e quindi anche la loro profittabilità possono risentire di questa elusione di responsabilità e
pertanto abbracciano volontariamente codici comportamentali più responsabili.
Un esempio famoso è quello della Nike che dopo le proteste ha rinunciato a utilizzare forza lavoro
minorile (in paesi in cui non vi è regolamentazione a riguardo) per abbracciare standard lavorativi
socialmente più accettabili.
Ciononostante la strategia di produrre le proprie scarpe unicamente in paesi a basso costo del lavoro
dove i seppur minimi standard di sicurezza e ambientali possono essere aggirati rimane una pratica
molto diffusa.
Dall’altro lato abbiamo imprese private che hanno acquisito uno straordinario potere regolativo
sugli Stati sovrani.
Le tre grandi aziende di rating finanziario – Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s, formalmente imprese
di diritto privato a scopo di lucro – svolgono il ruolo di “poliziotti” dei mercati finanziari sorvegliando
sulla solidità degli istituti di credito e sulla solvibilità dei debiti nazionali “sovrani”.
A farne le spese sono stati – in occasione della crisi economica iniziata nel 2007 – i risparmiatori di
mezzo mondo: di qui la decisione di creare l’Esma (European Securities Market Authority) perché
vigili a sua volta sulle agenzie di rating.
Esse non rappresentano solo la “voce del mercato” a cui anche i titoli sui debiti sovrani devono
sottostare, ma dalle loro valutazioni dipendono direttamente le azioni che altri organismi pubblici
possono o non possono intraprendere.
Questi sviluppi hanno indotto gli studiosi a dibattere se la sovranità degli Stati nazionali non fosse
ormai venuta meno, abbracciando la tesi dello svuotamento degli Stati sovrani.
2. Verso uno stato postnazionale
2.1. Sfide alla sovranità nazionale
Lo Stato westfaliano è un idealtipo. Esso incarna lo Stato pienamente sovrano, cioè completamente in
controllo del proprio territorio e totalmente autonomo nelle relazioni con gli altri Stati.
L’aggettivo “westfaliano” deriva dal Trattato di pace di Westfalia (1648) che sancì la formazione, sul
continente europeo, di un sistema di Stati, cioè di un numero limitato di Stati che non avrebbero potuto
espandersi senza intaccare il territorio di un altro Stato e, quindi, senza sconvolgere l’intero sistema.
All’espansione bellica si sostituivano pertanto la diplomazia e la politica come sistemi di regolazione
normali di questo delicato sistema.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Tuttavia, guerre anche molto più sanguinose continuarono a scoppiare nel continente europeo fino alla
metà del secolo scorso.
Ciò che venne acquisito una volta per tutte dopo la Seconda guerra mondiale fu proprio la coscienza
che la guerra non poteva essere considerata “la continuazione della politica con altri mezzi”, perché la
pretesa degli Stati di esercitare un controllo pieno e totale sul proprio territorio, sui possedimenti
coloniali e sulle popolazioni che in essi risiedevano era illusorio.
Nessuno Stato europeo era completamente omogeneo da un punto di vista delle etnie, delle tradizioni
culturali e della lingua, e ancor meno lo erano i possedimenti coloniali.
Ciò che invece succedeva e, purtroppo, succede ancora è che alcune etnie vengano discriminate, alcune
culture marginalizzate, alcune lingue ignorate – e si tratta di etnie, culture e lingue autoctone.
Le società moderne devono vedersela sempre più con gruppi minoritari che richiedono che le loro
identità vengano riconosciute e le loro differenze culturali vengano accolte e accettate.
Questa situazione è spesso resa con l’espressione “sfida del multiculturalismo”.
La crisi dello stato westfaliano, però, non è collegata solo alla “rinascita” delle minoranze
subnazionali, ma anche alla realizzazione che gli Stati nazionali europei non sono più padroni dei
propri destini. La sovranità degli Stati viene sfidata non solo dal basso – cioè dalla mobilitazione
subnazionale – ma anche dall’alto – dal processo di integrazione europea, a sua volta forse una
risposta alla sfida della globalizzazione.
2.2. Globalizzazione e democratizzazione
Le economie e le società nazionali sono sempre più interdipendenti.
Il termine che segnala questa tendenza è globalizzazione, un fenomeno che è stato in parte voluto e in
parte tollerato dagli Stati nazionali.
La globalizzazione è fenomeno di omologazione, di integrazione e di interdipendenza delle economie e
dei mercati internazionali e di uniformazione di modalità produttive e di prodotti su scala mondiale.
Democratizzazione e globalizzazione hanno causato una straordinaria mobilitazione di numerosi
soggetti economici e sociali su scala internazionale.
Il World Social Forum (2001) raggruppa Ong, advocacy groups e movimenti sociali che cercano di
proporre una “globalizzazione contro-egemonica”.
Questi gruppi si riuniscono annualmente soprattutto in paesi emergenti (es. Brasile, Kenya, India) per
promuovere uno spazio aperto di discussione e di proposta che cerchi di produrre idee in
contrapposizione alle dominanti idee neoliberiste (si contrappongono, infatti, al World Economic
Forum (1971) che raduna ogni anno i potentati economici in Svizzera).
Le global cities sono città che, per la loro straordinaria concentrazione di risorse economiche e
culturali, possono giocarsela alla pari con Stati sovrani.
Non si tratta solo di New York, Tokyo, Londra, ma anche di altre città che, seppur più piccole, riescono
ad avere un peso globale: ad esempio, Helsinki riesce a giocare un ruolo strategico maggiore della
stessa Finlandia di cui pure è capitale; Hong Kong e Dubai controllano risorse economiche e culturali
ormai equivalenti a quelle controllate da Stati ben più grandi di loro.
Dal lato della democratizzazione, due fenomeni apparentemente opposti si sono intrecciati negli anni
Sessanta e Settanta.
Da una parte, nelle democrazie più mature, spesso anche sedi delle economie più ricche, montava la
richiesta di maggiore partecipazione alle decisioni politiche e di minore ingerenza dello Stato nella vita
e nelle finanze dei cittadini.
Dall’altra parte, in quegli stessi anni, in Inghilterra, in Francia e Italia si andavano mobilitando le
minoranze etniche e linguistiche così come i lavoratori e gli studenti, anch’essi alla ricerca di maggiore
coinvolgimento nei processi decisionali.
Sono gli anni dei movimenti sociali contro il nucleare e la guerra e in difesa dell’ambiente e dei diritti
civili delle donne e degli omosessuali.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Lo Stato westfaliano si scopre improvvisamente né internazionalmente sovrano, né economicamente
indipendente, né socialmente in controllo.
2.3. Interdipendenza e integrazione economica
L’aspetto che oggi colpisce di più è certamente il grado di interdipendenza raggiunto dalle economie
nazionali.
L’ascesa delle multinazionali è iniziata negli anni Trenta per raggiungere il suo culmine negli anni
Settanta, ma dagli anni Ottanta in poi si parla di “impresa globalizzata”, non più meramente
multinazionale.
Le filiere di produzione si estendono dai paesi del Primo mondo a quelli del Terzo mondo sfruttando
sempre più i vantaggi comparati delle rispettive economie.
Decisioni prese in un paese, si ripercuotono sulle condizioni di vita di popolazioni di altri paesi, dove
si trovano i lavoratori di una fase di produzione o di un componente del prodotto di quell’impresa.
Se in molte zone del mondo la globalizzazione dell’economie viene sperimentata come dipendenza, in
Europa l’interdipendenza è stata voluta e ricercata dai governi degli Stati membri.
La Comunità, poi Unione, Europea è senz’altro il progetto più ambizioso che mira a riconoscere e
rafforzare l’interdipendenza fra Stati-nazione fino a trasformarli in Stati-membri.
Si ha interdipendenza quando decisioni prese da uno stato hanno ripercussioni anche sulle condizioni
di vita dei cittadini di un altro Stato, e viceversa; quando cioè queste ripercussioni non possono essere
facilmente ignorate, perché impongono costi significativi, e soprattutto quando sono reciproche.
Dopo la creazione della Ceca (1951) e della Cee (1957), negli anni Ottanta e Novanta gli Stati membri
si sono gettati a capofitto nella realizzazione del mercato comune europeo.
Dopo la stagflazione degli anni Settanta, gli imprenditori europei si convinsero che rimanere
intrappolati nei confini dei propri mercati nazionali, liberi solo di esportare negli Stati membri senza
pagare dazi doganali, non fosse più sufficiente e che occorresse avviarsi decisamente verso
l’abbattimento delle barriere non tariffarie.
Queste erano costituite dalle regole e dagli standard produttivi in vigore nei vari paesi nonché dalle
pratiche protezionistiche.
Inizialmente si credette di procedere attraverso la definizione di standard produttivi comuni per tutti i
prodotti scambiati; ma l’obiettivo di “armonizzare” le caratteristiche di tutti i prodotti scambiati
all’interno della Comunità economica europea era illusorio.
Occorreva piuttosto affermare il principio del mutuo riconoscimento e accettare come commerciabili
nel mercato comune tutti i prodotti in commercio in ciascuno degli Stati membri a meno che non fosse
provata indubitabilmente la dannosità del prodotto per la salute o per la società.
Sotto la spinta della Commissione e degli interessi economici, si arrivò nel 1986 alla firma del Trattato
di Lussemburgo, meglio noto come Atto unico europeo, che comportò l’abbattimento di molte barriere
non tariffarie relative alle specifiche tecniche dei prodotti.
Non si volle più che il mercato fosse solo comune, ma che fosse un vero e proprio mercato unico.
Altro ambito in cui una certa armonizzazione dei processi produttivi è avvenuta (o si è seriamente
tentata) è stata la politica ambientale, ma anche in questo caso da soluzioni rigide e comuni si è man
mano passati a soluzioni più flessibili e compatibili.
Si è comunque presa coscienza del fatto che creare un grande mercato unico comportava molto più
della libera circolazione delle merci e finiva per incidere su molti fattori che influiscono sulla
produzione di beni e servizi: la formazione professionale, gli orari e le condizioni di lavoro e, più in
generale, tutta la politica del lavoro dalla regolazione della sicurezza alla politica pensionistica.
Per facilitare ulteriormente gli scambi si decise pertanto di muovere verso tassi di cambio delle valute
sempre meno variabili.
Grosse oscillazioni nei tassi di cambio causavano infatti costi imprevisti a importatori ed esportatori,
specie in epoca di inflazione elevata e svalutazioni frequenti quali gli anni Settanta e Ottanta.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Si decise pertanto dapprima, nel 1979, di legare tra loro le valute in bande di oscillazione reciproche
limitate (il famoso “serpente monetario”) e poi, nel 1999, si arrivò a legare fra loro le monete di alcuni
paesi membri in cambi fissi al fine di adottare, dal 2002, una moneta comune, l’euro.
La creazione della moneta comune ha reso palese come mai prima la reciproca interdipendenza degli
Stati appartenenti all’area dell’euro.
3. Dal “government” alla “governance”
3.1. L’ascesa della società transnazionale
La globalizzazione economica e il processo di integrazione europea, la crescita della società civile
transnazionale e la rinascita delle identità regionali mettono in discussione la sovranità, l’autonomia e
la specificità dello Stato-nazione westfaliano.
I problemi che lo Stato deve affrontare non sono più risolvibili esclusivamente grazie all’azione
governativa delle burocrazie ministeriali ma grazie al concorso di molti altri livelli di governo e
organizzazioni non governative.
Insomma, non si può più parlare sono di government, ma occorre parlare di governance.
Una delle manifestazioni più rilevanti della globalizzazione è la mobilitazione della società civile
transnazionale. Vi sono varie tipologie di mobilitazione transnazionale:
Alcune di queste associazioni sono reti di associazioni nazionali o locali che si mobilitano in
particolari ambiti di policy creando un certo coordinamento tra le loro azioni.
Appartengono a questa categoria associazioni ambientaliste quali Greenpeace; di difesa dei diritti
umani quali Amensty International; di intervento umanitario quali la Croce rossa internazionale, Save
the Children, Medici senza frontiere; antirazziste quali Sos Racisme.
Vi sono poi movimenti che si sono formati su singole questioni per poi diffondersi per emulazione
da paese a paese – quali il movimento per i diritti civili, per la pace o contro il nucleare – sotto la
spinta di eventi particolari quali le lotte per i diritti civili negli Stati Uniti, o lo scoppio di alcune guerre
quali la guerra in Vietnam e la seconda guerra in Iraq o in seguito a disastri nucleari accidentali.
Vi sono ancora movimenti che, pur essendo partiti da singoli episodi, si sono progressivamente
organizzati a livello centralizzato e hanno saputo proporre momenti di controinformazione e
mobilitazione in occasione di importanti incontri internazionali quali il World Social Forum che si
mobilita periodicamente contro una visione esclusivamente economicista della globalizzazione che
trascura l’aspetto della solidarietà.
Vi sono infine organizzazioni la cui attività principale è fare lobbyng a favore di alcune categorie, e
che si mobilitano soprattutto là dove esistono organizzazioni internazionali che hanno il potere di
prendere decisioni rilevanti.
Appartengono a questa ultima e più tradizionale categoria, ad esempio, il Copa (Comitato delle
organizzazioni professionali agricole) e la Cogeca (Confederazione generale delle cooperative
agricole dell’Unione Europea) che raggruppano una quarantina di associazioni europee.
Ciò che contraddistingue queste associazioni è il loro carattere reticolare.
La loro attività principale è attirare l’attenzione su questioni che potrebbero sfuggire ai decisori o
all’attenzione pubblica e proporre controinformazione.
In alcuni casi si tratta di veri e propri movimenti di protesta (es. Indignados, Occupy Wall Street).
In altri casi si tratta invece di mobilitazioni trasgressive, promosse da subculture radicali, che
utilizzano modalità di protesta anche eclatanti di forte contenuto simbolico (es. Pussy Riot, Femen).
Pur trattandosi di movimenti talvolta limitati e locali, la loro strategia implica necessariamente la
mobilitazione della società civile e dell’opinione pubblica internazionale.
Senza la cassa di risonanza costituita dai mezzi di comunicazione di massa e soprattutto dai social
media, la loro protesta verrebbe rapidamente repressa senza alcuna conseguenza.
3.2. Governare con i cittadini (“co-governance”)
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
I soggetti che chiedono azioni di governo, spesso richiedono anche di essere coinvolti nella risoluzione
dei problemi che sollevano.
E, infatti, molte nuove azioni di governo non possono essere condotte senza il loro concorso.
Gli incrementi di produttività che una sfida come la globalizzazione richiede non possono essere
ottenuti se non grazie a uno sforzo condiviso e corale dei rappresentanti di lavoratori e imprenditori,
insegnanti e formatori, addetti ai servizi e amministratori.
La difesa della moneta comune non può avvenire senza il coordinamento tra Stati appartenenti alla
stessa area economica e monetaria.
La regolazione dei flussi migratori, l’accoglienza dei rifugiati, il contrasto al degrado ambientale, il
contenimento delle epidemie non possono essere messi in atto senza il supporto di organizzazioni
internazionali pubbliche e private.
La complessità e numerosità dei problemi affrontati dallo Stato contemporaneo sono tali che non è più
possibile pensare che esso se ne faccia carico in via esclusiva.
Il passaggio dal government alla governance riflette un cambiamento epocale nel modo di governare
avvenuto nel XX secolo all’interno degli stessi Stati nazionali.
Questo cambiamento è stato determinato da molti fattori, fra i quali il desiderio da parte dei cittadini
(la cosiddetta “società civile”) di un maggior coinvolgimento nelle decisioni.
In parte per arginare il crescente numero di domande poste al sistema politico (overload), in parte per
venire incontro alla domanda di maggior coinvolgimento e partecipazione, lo Stato ha
progressivamente rinunciato a comandare e prescrivere e si è sempre maggiormente predisposto a
orientare e regolare.
Anche questo regola il passaggio dal government alla governance: essersi resi conto che le decisioni
di policy non si attuano solo perché sono contenute in disposizioni legislative, ma perché una serie di
soggetti orientano il loro operato affinché si raggiungano risultati condivisi.
La politica di sviluppo regionale e di coesione forniscono un chiarissimo esempio.
Affinché un territorio si sviluppo occorre che lo Stato e l’Unione Europea mettano a disposizione dei
fondi; che vengano individuati gli obiettivi di sviluppo e identificato gli indicatori di successo o di
insuccesso; che gli operatori locali siano coinvolti e convinti della bontà delle strategie di sviluppo
(meglio ancora se individuate da loro); che i cittadini non si oppongano ai progetti di sviluppo.
Ma è davvero avvenuta la transizione dal government alla governance?
Quando assistiamo ad alcuni episodi di opposizione anche violenta a decisioni prese dallo Stato (es.
No Tav in Val di Susa), ci viene il dubbio che i cittadini non vengano ancora preventivamente coinvolti,
informati, ascoltati ed eventualmente convinti della bontà del progetto, ma che questo venga loro
imposto dall’alto.
Con il termine co-governance o interactive governance vengono indicati quei crescenti tentativi,
condotti soprattutto nei paesi del Nord Europa, di permettere ai cittadini di dettare l’agenda delle cose
da fare a livello locale se non anche a coinvolgerli personalmente nella loro realizzazione.
Il coinvolgimento dei cittadini nella definizione e risoluzione dei problemi configurerebbe un nuovo
tipo di democrazia più interattiva e partecipata e più rispondente sia alle esigenze delle
amministrazioni nazionali (desiderose di scaricarsi di un certo numero di ingombranti responsabilità)
sia dei cittadini (ansiosi di diventare protagonisti delle decisioni che incidono sulla loro vita).
3.3. La riscoperta della dimensione regionale
La messa in discussione della centralità dello Stato-nazione è dovuta anche alla rinascita delle identità
ed economie regionali avvenuta soprattutto a partire dagli anni Settanta.
La fine degli anni Sessanta marca una cesura storica di grande importanza: i sociologi collocano alla
fine degli anni Sessanta la fine dell’ideologia e l’affermarsi dei valori postmaterialistici.
Fra i valori che si vanno affermando negli anni Sessanta e Settanta vi sono quelli legati a questioni
identitarie e di espressione della propria individualità.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
Essendosi assicurati il diritto alla rappresentanza (right to vote), i cittadini delle società avanzate
reclamano il diritto alle radici (right to roots).
Fra le identità che si vanno riscoprendo in quegli anni sono pertanto anche le identità territoriali che lo
Stato presumeva di aver assorbito nell’identità nazionale.
Forse perché in quegli stessi anni iniziavano a scricchiolare le certezze dello stato del benessere
keynesiano, molti cittadini cercavano nelle economie e identità regionali le radici che sentivano di aver
perso nella società di massa.
In molti Stati, fino ad allora considerati esemplari dal punto di vista della coincidenza tra Stato e
nazione, si andavano riscoprendo lingue regionali.
A sostenere questa riscoperta delle identità regionali è anche la rinascita delle economie regionali.
Grazie a innovazioni tecnologiche che permettono di organizzare la produzione su scala più ridotta, si
affermano distretti produttivi costituiti da molte piccole imprese specializzate in produzioni flessibili.
Insomma, si scopre che il successo economico e commerciale non passa necessariamente per la grande
produzione di massa, ma attraverso la messa in rete di molte piccole aziende appartenenti alla stessa
filiera produttiva.
4. Le relazioni intergovernative
4.1. Alla ricerca del livello ottimale di governo
La scienza politica ha registrato fin dagli anni Sessanta e Settanta una tendenza diffusa alla creazione
di un terzo livello di governo – il livello “meso” – fra quello statale e quello comunale.
Su queste regioni amministrative si sono progressivamente innestate regioni politiche dotate di più o
meno ampi poteri decisionali.
Si viene a formare quindi una classe dirigente (amministrativa e politica) regionale che
progressivamente riempie di contenuto il contenitore regionale.
Ovviamente ciò accade tanto più rapidamente e con maggiore successo nelle regioni dotate di antiche
identità subnazionali, ma accade anche in regioni più decenti che però riescono a dotarsi di un’identità
più o meno “immaginata”.
Del resto, anche le comunità nazionali sono “comunità immaginate”.
Queste regioni trovano poi nel processo di integrazione europea e nel ruolo riservato dalla politica di
coesione ulteriori motivi per affermarsi.
Per molta scienza politica, lo Stato è ancora il punto di riferimento della mobilitazione politica e
dell’azione di governo: ciò che starebbe succedendo è il moltiplicarsi di problemi la cui soluzione
richiede interventi su scale territoriali differenti.
L’azione di governo, quindi, implicherebbe la creazione di ambiti di intervento sempre più
differenziati.
Che su un territorio nazionale insistano governi locali o funzionali di diversa “pezzatura” – si pensi,
nel caso dell’Italia, ai comuni, alle province e alle regioni ma anche alle Asl, ai distretti scolastici ecc.
– non è cosa nuova e non significherebbe che lo Stato centrale sia diventato meno rilevante.
Si tratterebbe, piuttosto di creare strutture per la gestione ottimale dei servizi che, per la loro stessa
natura, vengono prodotti e utilizzati su scale diverse.
Queste strutture di governo sono normalmente tarate su due parametri principali.
Il primo è l’efficienza produttiva: così come ha senso che gli asili e le scuole elementari siano gestiti
a livello comunale a seconda della distribuzione delle famiglie sul territorio comunale, così pure ha
senso che le università siano pianificate a livello nazionale a seconda della distribuzione delle
competenze e delle infrastrutture sul territorio nazionale.
Il secondo è la convenienza di utilizzo: guardie mediche e presidi ambulatoriali devono essere
distribuiti abbastanza capillarmente sul territorio, affinché siano facilmente raggiungibili da tutti i
cittadini, mentre gli ospedali specializzati possono essere concentrati in alcuni luoghi di più ampio e
facile accesso.
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
lOMoARcPSD|3189189
4.2. La riscoperta del federalismo
La ricerca dell’equilibrio tra offerta e domanda di servizi, ma ancor di più tra offerta di efficienza
governativa e domanda di legittimità democratica in tempi di accresciuta complessità e
interdipendenza, ha alimentato un grande interesse per la teoria del federalismo.
Il problema che il federalismo sembra essere in grado di risolvere sarebbe quello di trovare un
equilibrio fra un livello di governo sufficientemente ampio da garantire l’esecuzione delle funzioni
necessarie alla convivenza pacifica dei cittadini e la fornitura di servizi loro necessari e
sufficientemente ristretto da assicurare una certa omogeneità di preferenze politiche e quindi di
legittimità del governo.
In questa visione, il livello nazionale si farebbe carico delle funzioni essenziali alla difesa della
sovranità a autonomia della comunità nazionale (difesa, giustizia, commercio estero, moneta, fiscalità
centrale) mentre i livelli statali si farebbero carico delle politiche che determinano la vita dei cittadini e
che pertanto devono rispondere il più possibile alle loro preferenze (educazione, sanità, sviluppo,
polizia, sport ecc.).
Il federalismo prometterebbe, insomma, di risolvere sia i problemi di grandi Stati nazionali che, per
questioni di mera scala territoriale non possono essere governati da un solo centro – ad esempio, molti
grandi paesi (Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, India, Russia) sono federazioni – sia i
problemi di Stati più piccoli che, per la loro composizione culturale e sociale e la loro traiettoria
storica, risultano dall’unione di più Stati originariamente indipendenti (Germania, Svizzera, ex
Jugoslavia).
Eppure, proprio perché il federalismo comporta la congiunta sovranità dello Stato federale e degli Stati
federati, gli Stati membri dell’Unione Europea rifiutano ancora l’idea di dover accettare una sovranità
federale in aggiunta e potenzialmente in conflitto con la loro sovranità nazionale individuale.
A dimostrazione della non maturità dei tempi per una soluzione federale per l’Unione Europea si cita
normalmente l’assenza di un senso di appartenenza e un’identità comuni tra le popolazioni europee,
dimenticandosi che anche le comunità nazionali sono state a loro volta immaginate e create.
Vi sono vari tipi di federalismo, e nessuno di essi è immobile e definito una volta per tutte.
Vi è un federalismo duale, nel quale le competenze sono assegnate “una volta per tutte” a questo o
quel livello di governo, e un federalismo concorrente, nel quale le competenze sono per lo più
condivise fra più livelli di governo.
Si distingue inoltre un federalismo cooperativo, in cui i livelli di governo inferiori (statali) devono
necessariamente dare il proprio consenso affinché si prendano decisioni anche a livello federale (es.
Germania), e un federalismo competitivo, in cui il governo federale ha proprie strutture per intervenire
in aree decisionali di propria esclusiva competenza e in cui i vari governi statali sono in competizione
gli uni con gli altri per accaparrarsi le risorse federali e per convincere i cittadini a spostarsi nel loro
Stato (es. Stati Uniti).
4.3. La “governance” multilivello
La nozione di governance multilivello ci dice che il modo in cui i problemi e politiche sono decise e
gestite è fluido e comporta il coinvolgimento di più livelli di governo – sovranazionale, nazionale e
subnazionale – così come della società civile organizzata anch’essa a vari livelli – locale, nazionale,
transnazionale.
MANCA CAP 12
Descargado por Rosa Delosvientos (zgarayreyna@hotmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Storia della politica internazionale (1957-2017): Dalle conquiste spaziali al centenario della rivoluzione d’ottobreDa EverandStoria della politica internazionale (1957-2017): Dalle conquiste spaziali al centenario della rivoluzione d’ottobreValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Riassunto Manuale Di Scienza Politica Capano Piattoni Raniolo VerzichelliDocumento81 pagineRiassunto Manuale Di Scienza Politica Capano Piattoni Raniolo Verzichellifede100% (1)
- Il Linguaggio PoliticoDocumento19 pagineIl Linguaggio PoliticojoanamottaNessuna valutazione finora
- Sociologia Politica - Riassunto Manuale Di RushDocumento15 pagineSociologia Politica - Riassunto Manuale Di RushMariano CalòNessuna valutazione finora
- Darwinismo SocialeDocumento4 pagineDarwinismo SocialevitazzoNessuna valutazione finora
- Sociologia Del Lavoro - Tema PrincipaleDocumento20 pagineSociologia Del Lavoro - Tema PrincipaleGiuseppe Raciti100% (1)
- F Angeli Collana Sociologia PoliticaDocumento2 pagineF Angeli Collana Sociologia PoliticadanielpupiNessuna valutazione finora
- C Bocchini La Teoria Schmittiana Della Democrazia PDFDocumento477 pagineC Bocchini La Teoria Schmittiana Della Democrazia PDFMaurizio Falcone100% (2)
- Smelser-Manuale Di SociologiaDocumento54 pagineSmelser-Manuale Di Sociologiadarlenelilley100% (2)
- Teorie Ed Effetti Dei MediaDocumento139 pagineTeorie Ed Effetti Dei Mediaivan100% (1)
- Rawls e Sen - Teorie Della GiustiziaDocumento9 pagineRawls e Sen - Teorie Della GiustiziaGiacomo MauroNessuna valutazione finora
- Kelsen SchmittDocumento34 pagineKelsen Schmittmissanswer100% (1)
- Comunicazione Politica e Persuasione - Alessandro AmadoriDocumento19 pagineComunicazione Politica e Persuasione - Alessandro AmadoriasdfsgdjNessuna valutazione finora
- Manuale Di Sociologia SmeslerDocumento35 pagineManuale Di Sociologia SmeslerelandelNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Corso Di Diritto Pubblico Scienze PoliticheDocumento58 pagineRiassunto Libro Corso Di Diritto Pubblico Scienze PoliticheDavid Del Valli86% (14)
- Costituzione Maurizio FioravantiDocumento26 pagineCostituzione Maurizio FioravantiAlessandroFinottoNessuna valutazione finora
- Capire Il Copyright - Aliprandi (2012)Documento163 pagineCapire Il Copyright - Aliprandi (2012)Progetto Copyleft-Italia.itNessuna valutazione finora
- Appunti Di Storia Delle Istituzioni Politiche e SocialiDocumento46 pagineAppunti Di Storia Delle Istituzioni Politiche e Socializineb bakhta100% (1)
- Riassunto Il Gioco Della Cultura Di S. Piccone Stella e L. SalmieriDocumento55 pagineRiassunto Il Gioco Della Cultura Di S. Piccone Stella e L. SalmieriPaolaNessuna valutazione finora
- Retorica PoliticaDocumento27 pagineRetorica PoliticaIoana LuculescuNessuna valutazione finora
- Luciano Canfora: Le Ideologie Del Classicismo e L'uso Politico Del Paradigma ClassicoDocumento28 pagineLuciano Canfora: Le Ideologie Del Classicismo e L'uso Politico Del Paradigma ClassicoRoberto GozzoliNessuna valutazione finora
- Teorie Comunicazioni Di MassaDocumento20 pagineTeorie Comunicazioni Di MassaDaniela CoriNessuna valutazione finora
- Fabietti U. 2010, Elementi Di Antropologia Culturale, Mondadori (Parti I, V, VI, VII, IX)Documento33 pagineFabietti U. 2010, Elementi Di Antropologia Culturale, Mondadori (Parti I, V, VI, VII, IX)yqek5kl8Nessuna valutazione finora
- Storia Culturale FemminismoDocumento12 pagineStoria Culturale FemminismoEmily PierceNessuna valutazione finora
- Principi Di Scienza Politica Di Clark Riassunto Scienza Politica PDFDocumento46 paginePrincipi Di Scienza Politica Di Clark Riassunto Scienza Politica PDFMaria Amy Castelluccio100% (2)
- Comunicazione PubblicaDocumento34 pagineComunicazione PubblicaPescedargento100% (3)
- Elementi Di Economia Politica (2012)Documento76 pagineElementi Di Economia Politica (2012)NicoloNessuna valutazione finora
- Bobbio KelsenDocumento25 pagineBobbio KelsenAnonymous 4L7zuPcaLNessuna valutazione finora
- Cronologia Legislazione ScolasticaDocumento12 pagineCronologia Legislazione ScolasticaAntonio SgròNessuna valutazione finora
- La Politia AristotelicaDocumento33 pagineLa Politia Aristotelicaargentazzu100% (1)
- Il Pensiero Politico Di AristoteleDocumento5 pagineIl Pensiero Politico Di Aristotele65419Nessuna valutazione finora
- Riassunto - Storia Delle Dottrine Politiche PDFDocumento157 pagineRiassunto - Storia Delle Dottrine Politiche PDFAlberto AmorusoNessuna valutazione finora
- Diritto Costituzionale, MartinesDocumento28 pagineDiritto Costituzionale, MartinesPiersilvio VisioliNessuna valutazione finora
- CiceroneDocumento20 pagineCiceroneVincenzo TrittaNessuna valutazione finora
- Riassunti Storia Delle Dottrine PoliticheDocumento97 pagineRiassunti Storia Delle Dottrine PoliticheSalvatore CifaldiNessuna valutazione finora
- Partiti PoliticiDocumento52 paginePartiti PoliticiCaterina Fabbrini GalloriNessuna valutazione finora
- Psicologia Marketing Politico Catellani AmadoriDocumento3 paginePsicologia Marketing Politico Catellani AmadoriLuca AgostiNessuna valutazione finora
- Losurdo - Antonio Gramsci Dal Liberalismo Al 'Comunismo Critico'Documento260 pagineLosurdo - Antonio Gramsci Dal Liberalismo Al 'Comunismo Critico'ignacioar100% (3)
- Storia Della Ecologia e Dell'ambienteDocumento21 pagineStoria Della Ecologia e Dell'ambientegiorgionebbia100% (7)
- Storia Della Guerra Fredda BongiovanniDocumento8 pagineStoria Della Guerra Fredda Bongiovannicrepuscolarista67% (3)
- Fabio Dei - Antropologia CulturaleDocumento30 pagineFabio Dei - Antropologia CulturaleM. P.100% (1)
- La Rivoluzione IngleseDocumento146 pagineLa Rivoluzione IngleseEnrico Galavotti100% (1)
- SocrateDocumento1 paginaSocrateMariano De LucaNessuna valutazione finora
- Comunicazione e Propaganda. Il Ruolo Dei Media Nella Formazione Dell'Opinione PubblicaDocumento218 pagineComunicazione e Propaganda. Il Ruolo Dei Media Nella Formazione Dell'Opinione PubblicaMassimo Ragnedda100% (2)
- Diritto Allo Studio TannoDocumento128 pagineDiritto Allo Studio TannoMarco PaglioneNessuna valutazione finora
- Riassunto Sociologia EconomicaDocumento52 pagineRiassunto Sociologia EconomicaIsabel MazzoneNessuna valutazione finora
- Il Processo Di SocializzazioneDocumento25 pagineIl Processo Di Socializzazionemaria elena auxilia100% (1)
- Diritto Pubblico ComparatoDocumento71 pagineDiritto Pubblico Comparatoappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Mancini - Manuale Di Comunicazione PubblicaDocumento23 pagineMancini - Manuale Di Comunicazione PubblicaLarnè Marco100% (1)
- Riassunto Storia ContemporaneaDocumento43 pagineRiassunto Storia ContemporaneaGioia MaffucciNessuna valutazione finora
- Temi Di Geografia EconomicaDocumento86 pagineTemi Di Geografia EconomicarereNessuna valutazione finora
- Gramsci Et FolkloreDocumento6 pagineGramsci Et FolkloreEva RossetNessuna valutazione finora
- Umberto Eco - Il Mito Di SupermanDocumento13 pagineUmberto Eco - Il Mito Di SupermanGatbys100% (3)
- Principi di catalogazione e rappresentazione delle entità bibliograficheDa EverandPrincipi di catalogazione e rappresentazione delle entità bibliograficheNessuna valutazione finora
- Tutela del software e diritto d'autore. Convergenze e interferenzeDa EverandTutela del software e diritto d'autore. Convergenze e interferenzeNessuna valutazione finora
- Luoghi Migranti. Tra clandestinità e spazi pubbliciDa EverandLuoghi Migranti. Tra clandestinità e spazi pubbliciNessuna valutazione finora
- Vent'anni senza Muro: Dagli Imperi della Guerra Fredda agli Imperi del XXI secoloDa EverandVent'anni senza Muro: Dagli Imperi della Guerra Fredda agli Imperi del XXI secoloNessuna valutazione finora
- Storia della politica internazionale (1945-2013). Il tramonto degli imperi colonialiDa EverandStoria della politica internazionale (1945-2013). Il tramonto degli imperi colonialiNessuna valutazione finora
- Manuale Scienza Politica Capano PDFDocumento129 pagineManuale Scienza Politica Capano PDFZenaida Garay ReynaNessuna valutazione finora
- 14-11-21 Eurosocial Agenda Napoli ItaDocumento5 pagine14-11-21 Eurosocial Agenda Napoli ItaZenaida Garay ReynaNessuna valutazione finora
- Harcleroad Et Altri PDFDocumento25 pagineHarcleroad Et Altri PDFZenaida Garay ReynaNessuna valutazione finora
- Wolin Teoria PoliticaDocumento10 pagineWolin Teoria PoliticaZenaida Garay ReynaNessuna valutazione finora
- Appunti Sociologia Dei Processi Culturali 1Documento19 pagineAppunti Sociologia Dei Processi Culturali 1Miriana MirandaNessuna valutazione finora
- ORGANIZZAZIONI, Culture Modelli, Governance RiassuntoDocumento45 pagineORGANIZZAZIONI, Culture Modelli, Governance Riassuntolivia lucina ferrettiNessuna valutazione finora
- SHAHRAM KHOSRAVI - Io Sono ConfineDocumento11 pagineSHAHRAM KHOSRAVI - Io Sono ConfineAntonino Di SclafaniNessuna valutazione finora
- Sistemi Politici Comparati VassalloDocumento48 pagineSistemi Politici Comparati VassalloMiriam FuscoNessuna valutazione finora
- Al Cuore Della Terra e Ritorno - UnoDocumento270 pagineAl Cuore Della Terra e Ritorno - UnopinocabrasNessuna valutazione finora
- Riassunto Introduzione Alla SociologiaDocumento13 pagineRiassunto Introduzione Alla SociologiaAngelica MalliaNessuna valutazione finora
- Docsity Riassunti Corso Di Storia Medievale Testo Esame Medioevo I Caratteri Originali Di Un Etadi Transizione VitoloDocumento110 pagineDocsity Riassunti Corso Di Storia Medievale Testo Esame Medioevo I Caratteri Originali Di Un Etadi Transizione Vitolosveva vitaleNessuna valutazione finora
- Lez. 05 - Cap. 4 - Le Teorie Sulle Istituzioni PubblicheDocumento28 pagineLez. 05 - Cap. 4 - Le Teorie Sulle Istituzioni PubblicheMimi ZetaNessuna valutazione finora
- Testo Argomentativo, Analisi Personaggi Di Don AbbondioDocumento2 pagineTesto Argomentativo, Analisi Personaggi Di Don AbbondioGiorgia PelliciariNessuna valutazione finora
- GUENON Studi Sull'induismoDocumento188 pagineGUENON Studi Sull'induismoMarcoNessuna valutazione finora
- Francesco Varanini Un Certo Tipo Di LetteraturaDocumento13 pagineFrancesco Varanini Un Certo Tipo Di LetteraturaFrancesco VaraniniNessuna valutazione finora
- Potere Occulto MondialeDocumento17 paginePotere Occulto MondialeCarlo MagnaNessuna valutazione finora
- Articolo NeopsicheDocumento9 pagineArticolo NeopsichepaoluccioNessuna valutazione finora
- Le Basi Filosofiche Del CostituzionalismoDocumento18 pagineLe Basi Filosofiche Del CostituzionalismoDario MezzanzanicaNessuna valutazione finora
- Vampire The Masquerade - Guida Alla CamarillaDocumento233 pagineVampire The Masquerade - Guida Alla CamarillaBobDoeNessuna valutazione finora
- Riassunto OrientalismoDocumento11 pagineRiassunto OrientalismoElisa Martini50% (2)
- Stato Democratico e AutoritarioDocumento5 pagineStato Democratico e AutoritarioCinzia OcchipintiNessuna valutazione finora
- Relazioni BrutaliDocumento13 pagineRelazioni BrutaliSaraGNessuna valutazione finora
- ManoscrittoDocumento707 pagineManoscrittosimpliciusNessuna valutazione finora
- Ari ManeDocumento38 pagineAri ManeSilvia CalossoNessuna valutazione finora
- Marco Santoro - Il Sociologo e La Musica in ItaliaDocumento10 pagineMarco Santoro - Il Sociologo e La Musica in ItaliaFilippo LatellaNessuna valutazione finora
- Contropiano Rivista RecensioneDocumento23 pagineContropiano Rivista RecensionerobertoslNessuna valutazione finora
- Intervento Di Joyce Lussu PDFDocumento12 pagineIntervento Di Joyce Lussu PDFSonoria FirenzeNessuna valutazione finora