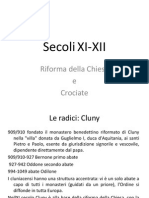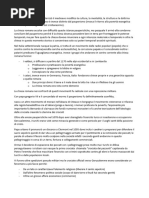Riforma Dell XI Secolo
Caricato da
Linas KondratasRiforma Dell XI Secolo
Caricato da
Linas KondratasRiforma dell'XI secolo
Riforma dell'XI secolo
La riforma dell'XI secolo consiste in una serie di riforme della Chiesa latina, attuate in Europa nel corso dell'XI
secolo. Quest'epoca, che pose fine al cosiddetto saeculum obscurum, inizi nel 1046 e si concluse con il Concordato
di Worms del 1122.
La cosiddetta riforma gregoriana, il cui nome deriva dal suo principale rappresentante e pi strenuo difensore, papa
Gregorio VII, fu soltanto una fase di questa pi ampia riforma. Il termine, tuttavia, viene spesso utilizzato per
designare tutti gli interventi di questa azione riformatrice dell'XI secolo, voluta e gestita soprattutto dal papato, che
volle affermare il primato della Sede apostolica sui vescovi e sul clero delle diverse diocesi (e di fatto creando spesso
tensioni con gli episcopati locali), nonch rivendicare le proprie prerogative nei confronti delle autorit civili, prima
di tutto l'imperatore romano-germanico.
L'iniziativa del papato e il conseguente scontro tra papato e Impero possono essere compresi soltanto se si tiene
conto che un'opera di riforma ecclesiastica era gi stata iniziata da altri protagonisti, soprattutto dagli imperatori
romano-germanici, e solo in un secondo tempo essa venne imposta al papato, che la assunse in prima persona e a sua
volta la impose al resto della Chiesa latina.
La riforma papale vera e propria pu essere suddivisa in quattro periodi:
1046-1057: inizi della riforma sotto i papi tedeschi,
1057-1073: intensificarsi della riforma sotto i papi tosco-lorenesi,
1073-1085: azione di papa Gregorio VII ("riforma gregoriana" propriamente detta, con il conseguente inizio della
lotta per le investiture),
1085-1122: attuazione e adattamento della riforma da papa Vittore III a papa Callisto II.
Premessa: la riforma imperiale (962-1046)
Con la svolta registratasi intorno all'anno Mille cominciarono a diffondersi nuovi fermenti sociali e religiosi, che
vennero a scontrarsi con la realt decadente della Chiesa cristiana.
Tra questi protagonisti del rinnovamento vanno citati:
i monaci: singoli monasteri cominciarono a rinnovarsi, aggregando a s altri cenobi. Questo avvenne in Germania,
Inghilterra e Italia. La pi importante e famosa fu la riforma di Cluny, in Borgogna: attorno a questo centro si cre
una solida organizzazione di monasteri, sparsi in tutta Europa.
il clero: nei primi secoli del Medioevo, al primo diffondersi del cristianesimo nelle campagne, il clero di una
pieve viveva insieme presso la chiesa battesimale (o "matrice"), dove si incentrava la vita liturgica di tuta la zona;
in seguito i signori locali avevano iniziato a far costruire delle "cappelle" anche nella campagna, assegnandole in
cura a preti loro sudditi, spesso dei servi che nell'ordinazione trovavano un modo per affrancarsi dalla schiavit ed
evitare i pesanti lavori della terra. Senza adeguata preparazione, isolati, abbandonati a s stessi, questi preti
conducevano frequentemente una vita indegna, dediti al gioco, alla caccia e al vino, e spesso a relazioni sessuali
del tutto disordinate (talvolta questi preti erano uomini sposati, altre volte solo formalmente celibi). La riforma del
clero favor la creazione di forme di vita comune tra i preti, in case chiamate canoniche dove i preti stessi
potevano trovare un'istruzione e una regola di vita.
i laici: la nuova situazione socioeconomica e il conseguente cambio di mentalit creatosi in tutta Europa intorno al
1000 port ad un risveglio e a un nuovo spirito di iniziativa dei laici. La loro reazione all'immoralit del clero e
alla concentrazione di grandi ricchezze intorno ad abbazie e vescovadi si espresse talora in modo violento, come
nella Pataria milanese.
i vescovi: si possono trovare qua e l singoli vescovi riformatori come, gi nel X secolo, Attone di Vercelli,
Raterio di Verona o Alberico di Como.
Riforma dell'XI secolo
Tutti questi sforzi di rinnovamento avevano il grande limite di essere isolati e senza continuit.[1] Mancava ancora,
infatti, una forza che desse coordinamento e continuit a questi tentativi frammentari, avviando una riforma su vasta
scala. Il papato, ancora immerso nel suo saeculum obscurum, non era in grado di assumersi questo ruolo. Non
restava che l'Impero. Una nuova dinastia, gli Ottoni, aveva avviato una riforma politica nel Regno di Germania: nel
962 Ottone I, unendo alla corona tedesca quella del Regno d'Italia, aveva rinnovato l'Impero, facendosi consacrare
imperatore da papa Giovanni XII. Non si poteva, per, attuare un rinnovamento dell'Impero senza risanare la Chiesa,
sulla quale poggiava, nella persona dei vescovi, gran parte dell'amministrazione pubblica. Pertanto gli Ottoni si
impegnarono a scegliere per le loro diocesi dei vescovi di grande valore. Questi stessi vescovi furono spesso riuniti
in sinodi riformatori.
Infine, Enrico III del Sacro Romano Impero, sceso in Italia per risolvere una delle tante lotte tra i partiti romani per
l'elezione del nuovo papa, impose una linea riformatrice alla sede romana stessa. Dal 1033 era papa Benedetto IX,
eletto dalla nobilt romana a soli dodici anni di et. Benedetto si era dimostrato immorale, arrogante e violento, e ci
provoc una insurrezione popolare.
L'imperatore intervenne nel 1046, e nel concilio di Sutri avoc a s il diritto di scelta del vescovo di Roma, e per sua
iniziativa furono eletti alcuni papi, di origine tedesca, assai attivi nella riforma della Chiesa
La riforma sotto i papi tedeschi (1046-1057)
Dopo l'intervento di Enrico III, i papi che si successero dal 1046 furono di nazionalit tedesca e scelti direttamente
da lui. I nomi che questi papi assunsero quando salivano al soglio pontificio furono particolarmente inconsueti, in
quanto presero il nome dei primi papi, a cui Enrico III stesso si rifaceva, come segno del recupero della realt
ecclesiale primitiva. Clemente II, Damaso II, Vittore II, anche se non riuscirono ad arrivare ad una azione concreta di
riforma (dato che morirono in fretta), vollero ritornare alla purezza primitiva.
Clemente II procedette contro la simonia, accompagn l'Imperatore in Sicilia ma, tornato a Roma, si ammal di
malaria (o probabilmente fu avvelenato) e mor il 9 agosto 1048. Gli successe Popone, vescovo di Bressanone, con il
nome di Damaso II, il cui pontificato dur soltanto 23 giorni. Un'attuazione concreta si ebbe con Brunone di Tull, ex
consigliere di Enrico III, uomo molto dotato che divent papa con il nome di Leone IX, regnando per cinque anni.
Egli, pur essendo stato designato dall'Imperatore, sottopose la sua nomina all'accettazione del popolo e del clero
romano.
In questi cinque anni di pontificato Leone IX inaugur un nuovo metodo di guida della Chiesa:
Si circond di un gruppo di validi collaboratori della Lorena ( in questo momento, probabilmente, che il collegio
dei cardinali passa dall'essere semplicemente l'assemblea dei parroci e dei diaconi della citt di Roma al ricoprire
la funzione di "gran consiglio" del papa): tra questi Alinardo, Umberto di Silvacandida (giurista e storico grazie al
quale ci sono giunte molte notizie), Federico figlio del duca di Lorena, Ildebrando di Soana (segretario di
Gregorio VI). Questa sua decisione fu gravida di conseguenze, in quanto fece partecipare questi suoi consiglieri,
alti dignitari, all'esercizio del potere pontificale, della riforma ecclesiale, liberandoli dagli impegni liturgici per
permettere loro un governo pi forte della Chiesa a loro assegnata.
Leone IX non risiedette a Roma, ma viaggi instancabilmente tra l'Italia, la Francia e la Germania, sull'esempio
dei sovrani secolari della sua epoca. Dal 1050 scese in Italia meridionale, attravers le Alpi, indicendo sinodi di
vescovi. Questi suoi viaggi portarono un grande vantaggio all'autorit pontificia: la mentalit/coscienza del potere
del papa nella Chiesa universale, oscurata dal secolo di ferro, venne rivitalizzata ed illuminata nel suo valore
universale.
Nel suo pontificato affront, principalmente, tre problemi.
Riforma dell'XI secolo
La riforma della Chiesa
Leone IX volle attuare una riforma di tipo morale e non ancora istituzionale. Il suo principale obiettivo fu la lotta
contro il concubinaggio e la simonia. Questo papa si rese conto della difficolt di questa impresa. Sapendo che la
legge era violata da buona parte del basso clero, difficilmente raggiungibile dalla riforma, decise di limitare la
riforma alla sola citt di Roma e dintorni, come esempio per altre citt. Egli proib ogni relazione di laici con i
presbiteri incontinenti, ospitando tutte le concubine in Laterano sotto il suo controllo. Lott poi contro la simonia che
intaccava preti e vescovi italiani e francesi. Essi sperimentarono la seriet dei decreti di Leone IX emanati nei diversi
sinodi (Reims, Magonza, ecc.), in conseguenza dei quali, di fronte l'accusa, il vescovo veniva subito deposto.
Secondo la mentalit del tempo, la simonia era l'eresia pi grave, quella che non permetteva, allo Spirito Santo di
agire liberamente: il vescovo non veniva legittimamente consacrato e, a sua volta, non trasmetteva l'ordine
all'ordinato. Questi metodi drastici tentavano, allora, di salvare la sostanza della fede e della vita sacramentale, ma
per questo furono anche fortemente osteggiati. Nacque, cos, anche il problema della differenza tra illeicit e
invalidit, pur nella non ancora chiara interpretazione, in quanto prevaleva ancora la visione del papa che riteneva
l'ordinazione invalida (tamquam non esse).
La lotta contro i Normanni insediatisi nell'Italia meridionale
Fu sicuramente il pi grave problema. Durante il secolo oscuro, i papi, nobili eletti dalle famiglie dei
Teofilatto e dei Tuscolani, e in particolare Benedetto VIII, avevano chiamato in aiuto a Meles, rappresentante
dell'Impero bizantino in Puglia (insorto contro la dominazione greco-bizantina), alcuni soldati Normanni. Essi
non si erano fatti ripetere l'invito e dalle Alpi, per mare e per terra, raggiunsero Meles e lo sostennero nella
battaglia. Questi "immigrati", che si erano insediati dopo il 1000 nell'Italia meridionale, nel giro di una
generazione erano diventati i padroni delle terre, maltrattando le popolazioni residenti, che, a causa di queste
ingiustizie, si appellarono al papa.
Per scacciarli, il papa fu costretto ad allearsi con i bizantini, che occupavano ancora gran parte dell'Italia Meridionale
e che erano guidati dal figlio di Meles. Chiese, poi, aiuto ad Enrico III, recandosi in Germania. Inizialmente
l'Imperatore approv i piani di papa Benedetto VIII, sostenendolo con un esercito, ma, dissuaso dal suo cancelliere, il
vescovo Gebehard di Eichstatt (che sar papa Vittore II), decise di rimanerne fuori.
Leone IX, succeduto a Benedetto VIII, decise di assoldare dalla nobilt tedesca un gruppo di giovani che unitisi ai
soldati italo-bizantini avrebbero sferrato l'attacco ai Normanni. Prima che i due eserciti si unissero, per, i Normanni
attaccarono l'esercito papale, infliggendogli una grave sconfitta il 16 giugno 1053 a Civitate, a sud del fiume Fortero,
facendo prigioniero il papa. Dopo sei mesi, i Normanni lo liberarono ma, colpito duramente e sfibrato dalla guerra,
Leone IX, il 19 aprile 1054, mor a Roma.
A Leone IX successe Gebehard di Eichstatt, con il nome di Vittore II, il quale si impegn fortemente nella riforma
ancora prettamente morale. Egli mantenne gli stessi collaboratori di Leone IX e indisse sinodi in Francia e in Italia.
La sua azione di riforma fu, per, condizionata dalla morte di Enrico III (5 ottobre 1056), il quale lasci la moglie
Agnese di Poitou reggente e il figlioletto (futuro Enrico IV) ancora minorenne. Essendo, quindi, vacante la sede
imperiale, il papa fu impegnato ancora pi direttamente nella politica imperiale, svolgendo magnificamente questo
suo compito. Vittore II, con abilit diplomatica, riusc ad assegnare il trono al figlio di Enrico III e alla moglie e a
indire un sinodo riformatore, durante la preparazione del quale mor, il 23 giugno 1057.
Con la sua morte fin il periodo della riforma voluta dai papi tedeschi.
Riforma dell'XI secolo
Lo scisma d'oriente (1054)
Per approfondire, vedi Scisma d'Oriente-Occidente.
I rapporti tra Chiesa occidentale e Chiesa orientale furono sempre particolarmente freddi. Alla morte di Alessio
Studita, divenne Patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario, che govern dal 1043 al 1058.
Un giudizio equo su questo protagonista della Storia del primo millennio non di certo facile. Egli ebbe una
personalit tempestosa e rivoltosa, molto autonomo persino dall'autorit dell'Imperatore bizantino. Gi da nobile si
dice che, aspirando alla corona, fece una rivolta per diventare Imperatore. Scoperto nei suoi intenti, fu mandato in
convento, dove ebbe grande influenza sulla politica e sullo stesso Imperatore Costantino IX, fino a che, nel 1043, fu
eletto patriarca di Costantinopoli.
Bisanzio e Roma erano gi di fatto divise, anche se non ancora formalmente, in quanto forte era la richiesta di
autonomia dalla Chiesa centrale.
A Bisanzio cresceva la consapevolezza e le convinzione che Roma andava degenerandosi a causa dell'alleanza con i
Normanni e con l'Impero Tedesco, mentre Bisanzio, nuova Roma, si fece depositaria delle vere e autentiche
tradizioni ecclesiastiche, della vita e della fede religiosa, conservatesi intatte.
Nella rottura dei rapporti tra Chiesa e Normanni (1053), nacque l'idea di realizzare un esercito formato dall'unione
militare tra tedeschi e bizantini in funzione anti - normanna. Questo esercito fu guidato da Argiro, figlio di Meles,
che nel 1009, con la protezione tedesca e papale, aveva combattuto contro l'esercito bizantino.
A Bisanzio Michele Cerulario non era disponibile ad aiutare Argiro in funzione anti normanna, per l'odio personale
che aveva nei suoi confronti, ricordando le vicende del padre. Per questo cominci a guidare una campagna anti
latina di dimensioni molto pi grandi di quella portata avanti da Fozio nell'863-869.
Nonostante questo, Argiro port avanti la sua campagna, sostenuto dall'Imperatore bizantino.
Michele Cerulario non si arrese e cominci una campagna di diffamazione contro Roma: rimise all'ordine del giorno
il problema del Filioque, del rito ecclesiastico, del celibato del clero, dell'uso del pane azimo, del digiuno del sabato.
Inoltre, fece chiudere le Chiese latine in Oriente e comp diversi atti vandalici anche contro le particole consacrate. Il
portavoce e il braccio del patriarca Michele era Leone di Okrid, il quale scrisse una lettera al vescovo di Trani (in
realt il vero destinatario era il papa), nella quale obbligava Roma ad adeguarsi a Bisanzio e ai suoi riti, ripudiando i
riti occidentali contrari a quelli greci. Questa lettera fu trasmessa nelle mani del tempestoso e sanguigno Umberto di
Silvacandida, consigliere del papa, che rispose a tono, accusando la Chiesa orientale di ben 90 eresie.
Mentre papa Leone IX era prigioniero dei Normanni e Costantino IX era consapevole della necessit dell'alleanza; la
curia romana, allora, per ristabilire la pace con Bisanzio, mand una delegazione all'Imperatore.
Umberto di Silvacandida e Federico di Lorena furono accolti con onore dall'Imperatore ma con indifferenza dal
patriarca Michele.
A questo atteggiamento, Umberto da Silvacandida rispose traducendo in greco le sue accuse di eresia, che
suscitarono una violenta reazione da parte del patriarca Michele.
Il dialogo si ruppe e la delegazione di pace si risolse in un nulla di fatto.
Umberto da Silvacandida il 16 luglio 1054 pose sull'altare di S. Sofia una bolla di scomunica contro Michele
Cerulario e i suoi collaboratori, designandoli come simoniaci, eretici, nicolaitici
Il 24 di quello stesso mese, Michele convoc un Concilio ed eman, in risposta, una scomunica ai legati del papa e ai
loro sostenitori. Lo scisma era ormai consumato!
Ai fatti concreti del 1054, per, dobbiamo accostare anche le valutazioni storiche a questi fatti che non coincidono
con la valutazione giuridica. Ne possiamo ricavare principalmente due:
1. Lo scisma, per cos dire, nacque nel 1054 ed in quest'anno avvennero i fatti pi determinanti. Esso, per, non fu
necessariamente avvertito nella sua gravit dagli stessi contemporanei, ma fu visibile soltanto una-due
Riforma dell'XI secolo
generazioni pi tardi.
2. Lo stesso aspetto giuridico, che ha un suo valore, sembra non essere cos chiaro. Infatti, papa Leone IX, quando
fu scritta e proclamata la bolla di scomunica da Umberto da Silvacandida, era gi morto. Noi sappiamo che, alla
morte di un papa, automaticamente vengono sospese tutte le deleghe che il papa stesso aveva concesso. La
delegazione, allora, aveva ancora lo stesso potere di agire? La scomunica non avrebbe, quindi, valore giuridico,
ma piuttosto una illegittima amplificazione del risentimento personale di Umberto verso il patriarca Michele,
sebbene, attraverso di essa, si colga il problema centrale della questione.
La veemenza con cui si parl durante questa discussione fu del tutto senza precedenti. Il repertorio di conoscenze e
di accuse di entrambi i contendenti fu sicuramente molto pi vasto di quello dello scisma foziano del 863.
Michele ed Umberto, in quel momento, non ebbero coscienza di quante conseguenze questa rottura avrebbe avuto
nel tempo. Nonostante il ritiro delle reciproche scomuniche da parte di Paolo VI e Atenagora, il problema tuttora
aperto, soprattutto riguardo all'autonomia sostanziale delle Chiese ortodosse tra loro e al rifiuto del primato papale.
La riforma sotto i papi tosco-lorenesi (1057-1073)
La morte di papa Vittore II fu inattesa ma la nobilt romana si risvegli. I vecchi riformatori e collaboratori di
Vittore II, ponendosi il problema di un eventuale ritorno dei Tuscolani, cercarono appoggio militare contro di essi,
chiamando in protezione l'esercito del margravio di Toscana e quello di Goffredo di Lorena e, in cambio del servizio,
elessero come papa Federico di Lorena, fratello dello stesso, Goffredo, con il nome di papa Stefano IX. Egli, formato
alla scuola di Leone IX, rafforz il gruppo dei suoi collaboratori, scegliendo tra di loro anche alcuni monaci, tra cui
Pier Damiani, successore di Romualdo, fondatore di Fonte Avellana, nominandolo cardinale di Ostia e valorizzando
cos il movimento eremitico dell'Italia centrale. Ma questo pontificato dur poco e non fu particolarmente
determinante; infatti, papa Stefano IX mor nel 1058.
Egli, prevedendo la sua imminente morte, fece giurare al popolo e alla nobilt romana che per la sua successione si
aspettasse Ildebrando da Soana, che stava tornando dalla Germania, dove era andato ad annunciare l'elezione di Papa
Stefano IX.
In questa situazione di attesa, i Tuscolani intervennero con una sommossa, eleggendo Giovanni di Velletri, con il
nome di Benedetto X. I collaboratori non riconobbero questa elezione e, a loro volta, elessero Gerardo di Firenze,
originario della Borgogna, che divenne papa con il nome di Niccol II. Accompagnato da Goffredo di Lorena, si
diresse verso Roma, scomunic l'anti papa e fu intronizzato il 24 gennaio 1059.
Con Niccol II si deline una nuova fase della riforma dell'XI secolo. Egli diede vita ad una riforma non soltanto
morale, ma anche istituzionale, seguendo il consiglio di Umberto di Silvacandida, secondo cui la Chiesa non sarebbe
mai stata riformata finch l'investitura del potere ecclesiale non fosse ritornata esclusivamente in mano della Chiesa.
Egli, quindi, non colp soltanto gli abusi simoniaci e di concubinaggio, ma cerc di combattere le stesse cause, le
radici di questi abusi che, a suo parere, stavano proprio nella concessione da parte dei laici dell'investitura delle
maggiori cariche ecclesiastiche.
Egli, perci, rivendic la libert della Chiesa e il diritto di conferimento delle cariche ecclesiastiche, liberandosi del
consuetudinario potere giuridico dei laici, lottando contro le loro investiture.
Nel settembre del 1059, quindi, Niccol II indisse un Sinodo romano, dove sottoscrisse un decreto, che, legalizzando
la sua elezione a papa, chiariva la procedura da seguire per l'elezione, dividendola in tre fasi:
1. I cardinali vescovi (termine che per la prima volta compare), consultati tra di loro sul candidato da eleggere,
decidono per un nome, avendo cos in mano l'elezione.
2. Alla decisione, i cardinali partecipano la loro decisione ai cardinali presbiteri e ai cardinali diaconi, con i quali,
raggiunto un accordo, presentano il candidato al popolo romano.
3. Presentato il candidato al clero e al popolo romano, esso deve dare la sua approvazione attraverso l'applauso, con
il quale lo conferma.
Riforma dell'XI secolo
Si fond cos un potere gerarchico dall'alto al basso, staccando l'elezione papale dal legame con il popolo romano e
dalla figura stessa dell'Imperatore.
In circa un decennio cambi radicalmente il sistema: dal 1046, quando Enrico III, dopo aver deposto tutti i papi,
pone l'elezione sotto la decisione dell'Imperatore, staccata dalle famiglie nobili romane e dallo stesso clero romano,
al 1059 quando la nomina non solo staccata dalla nobilt romana, ma anche da qualsiasi autorit, che non sia
ecclesiale.
Niccol II si rese conto della portata rivoluzionaria di questa sua decisione, che toglieva potere all'Imperatore. Cap
l'importanza di non limitarsi a una enunciazione di principio e di assicurare una forza politico-militare capace di farla
valere. Niccol II trov un valido alleato nel popolo normanno. Egli, messosi in viaggio verso l'Italia meridionale nel
settembre del 1059, stipul con essi il Patto di Melfi, secondo cui, nella logica del do ut des, i Normanni fecero
omaggio di sottomissione feudale e giuramento di fedelt, riconoscendosi sudditi del papa, mentre la Chiesa, nella
figura del papa, diede loro l'investitura su tutti i territori da loro conquistati. In tal modo i Normanni non furono pi
stranieri, ma ebbero il diritto di governare, promettendo di prestare fedelmente aiuto militare al papa.
Con una sola mossa papa Niccol II aveva conquistato la sovranit feudale su gran parte dell'Italia, ma, allo stesso
tempo, aveva violato il diritto imperiale di Enrico IV, con il quale, come preannunciato, cominciarono rapporti tesi e
difficili.
Alla morte di Niccol II, il gruppo dei riformatori, tra i quali Umberto di Silvacandida e Ildebrando, procedettero
all'elezione di Anselmo di Lucca, originario di Milano, il quale fu intronizzato con il nome di Alessandro II e
govern dal 1061 al 1073. La nobilt romana cerc di opporsi a questa elezione, sollecitando l'intervento
dell'Impero. A Basilea, quindi, fu eletto un antipapa (Onorio II), nella persona di Cadalo, vescovo di Parma. La sua
elezione ottenne ben pochi consensi e si rivel un passo falso per Agnese di Poitou, vedova di Enrico III e reggente.
Poco dopo, nel 1062, i principi tedeschi, guidati dal vescovo di Colonia Annone, sottrassero ad Agnese di Poitou il
principe ereditario, ancora minorenne, portandolo a Kaiserswerth ed affidandogli formalmente il potere imperiale col
nome di Enrico IV.
Uscita vittoriosa da questa prima lotta con l'impero, la Chiesa dal 1061 al 1073 continu l'attuazione della sua
riforma, la quale cominci a diffondersi raggiungendo l'Inghilterra e la Francia.
In Inghilterra
Papa Alessandro II intervenne per la successione del re d'Inghilterra, alla morte di Edoardo il Confessore. La Chiesa,
tra i due contendenti, Aroldo e Guglielmo di Normandia, appoggi quest'ultimo che, con la benevolenza del papa,
vinse Aroldo ad Hastings nel 1066. Da questo punto in poi la Chiesa inglese si leg intimamente al papato.
Nella Penisola Iberica
Anche nei diversi regni della Penisola Iberica l'influsso della riforma si fece sentire molto presto. Il re Sancio di
Aragona infatti, nel 1068 affid il proprio Paese al papa, sostituendo la liturgia ispanica con il rito romano. In questo
modo si riaprivano le relazioni tra il Papato e le Chiese della Penisola, rimaste abbastanza isolate dopo la caduta del
Regno visigoto. Proprio in questo periodo, anche su impulso dei papi oltre che dei diversi monarchi di Castiglia,
Aragona e Portogallo, nasceva quell'ideale di reconquista dei territori in cui i musulmani si erano insediati. Questo
fervore generale in campo militare, economico, sociale e anche religioso, port a grandi cambiamenti nella societ
ispanica del tempo.
Riforma dell'XI secolo
In Lombardia
In Italia settentrionale invece, la riforma ecclesiastica port ad una divisione del clero e del popolo. Il clero
ambrosiano, infatti, nonostante le imposizioni che giungevano da Roma, continuava nella sua propria tradizione di
permettere l'accesso al presbiterato anche a uomini sposati. I diversi predicatori giunti da Roma, tuttavia, favorirono
la nascita di un forte movimento tra i fedeli laici (la Pataria nella sua prima fase di esistenza), che cominci a
criticare pesantemente il proprio clero, bollando i preti sposati con il titolo di eretici "nicolaiti" (interpretando in
maniera de-contestualizzata alcuni passi delle cosiddette "lettere alle sette chiese" dell'Apocalisse di Giovanni) e
riducendo il matrimonio dei preti a semplice "concubinaggio". Di questo movimento erano membri sia alcuni laici,
sia alcuni chierici del partito riformatore, tra i quali spiccano i nomi di Arialdo da Cucciago e di Landolfo Cotta.[2]
I patarini diedero avvio a intense azioni di riforma ecclesiastica, a volte anche con mezzi violenti e obbligando i
preti, anche con la forza, a rispettare il celibato. Nell'estate del 1057, cominciarono a giungere al papa proteste e
accuse contro i patarini, tanto che Stefano IX fu costretto ad inviare una delegazione per chiarire e sistemare la
situazione. Pier Damiani e Anselmo di Lucca, giunti a Milano, decisero per di appoggiare apertamente la Pataria,
tentarono di stroncare le proteste e di ristabilire la pace, ingiungendo all'arcivescovo di Milano, Guido da Velate, di
sottomettersi al papa. Gli scontri successivi divennero ancora pi feroci, e una delle vittime fu lo stesso Arialdo, che
cominci ad essere considerato un martire della riforma romana.
L'arcivescovo Guido nel 1072 croll e accett di dimettersi, mandando il proprio anello e pastorale ad Enrico IV, il
quale invest il nobile Goffredo da Castiglione come nuovo arcivescovo. Questo intervento dell'imperatore, tuttavia,
ebbe come effetto quello di coinvolgere anche Milano nella lotta tra papato ed Impero.
Nonostante l'iniziale appoggio giunto da Roma, negli ultimi decenni dell'XI secolo la Pataria, abilmente sostenuta da
Roma nel progetto riformatore, venne in qualche modo "scaricata" dai papi, che cercavano una riconciliazione con
gli episcopati locali. I patarini radicali, delusi anche dai papi oltre che dal clero milanese, finirono per trasformare il
loro movimento in una specie di setta ereticale di contestazione all'autorit ecclesiastica, abbastanza vicina alle
istanze dei Catari.
La riforma gregoriana (1073-1085)
Per approfondire, vedi Lotta per le investiture.
Nel 1073 Ildebrando di Soana venne eletto papa per acclamazione della folla, cui fece seguito l'elezione canonica da
parte dei cardinali.
Ildebrando era un monaco cluniacense: aveva accompagnato in Germania l'ex-papa Gregorio VI, quando
quest'ultimo, deposto dall'imperatore Enrico III al Concilio di Sutri, era fuggito a nord delle Alpi. Ritornato a Roma
al seguito di papa Leone IX (Brunone di Toul), Ildebrando era entrato a far parte dei cardinali riformatori. Da
Alessandro II venne nominato arcidiacono, divenendo capo della Curia romana.
Appena eletto, Gregorio VII intraprese azioni contro la simonia e il concubinato del clero, promulgate soprattutto in
un sinodo romano convocato nella Quaresima del 1074.
Nel 1075 compose il Dictatus papae, una raccolta (o forse soltanto un indice) di varie affermazioni sul primato del
vescovo di Roma. Con questo documento Gregorio VII inaugurava una "nuova ecclesiologia" (come afferm il
teologo cattolico Yves Congar nella sua opera Sentire ecclesiam): il papa diventava "vescovo dei vescovi", Roma era
"caput ecclesiae" (centralismo romano) e ogni singolo credente diventava un suddito del vescovo di Roma.
Affermando il potere del papa al di sopra di ogni altra autorit (oggi si direbbe sia "laica" sia religiosa), Gregorio
provoc una profonda rottura proprio con l'imperatore romano-germanico (si ricordi che la riforma dell'XI secolo era
iniziata proprio per l'intervento degli imperatori, che avevano tentato di risanare il papato corrotto).
Riforma dell'XI secolo
Dotato di forte personalit e di una concezione altissima della dignit papale, Gregorio introdusse un elemento di forte
novit nel panorama del movimento di riforma, rivendicando il primato romano, cio la suprema autorit del papa all'interno
della Chiesa e nell'ambito della societ cristiana. Nelle sue lettere, infatti, pi che il concetto di "libertas Ecclesiae", che
costituiva pur sempre la bandiera del movimento riformatore, la contrapposizione tra "obbedienza" e "disobbedienza" a
ricorrere pi di frequente, identificandosi l'assoluta obbedienza a Dio con quella dovuta a lui in quanto papa, cio successore
dell'apostolo Pietro. Ne scatur una profonda e violenta spaccatura del movimento riformatore, che port ad un
rimescolamento generale delle forze in campo. Dalla parte dell'imperatore, infatti, vennero a trovarsi non solo i vescovi ostili
alla riforma, ma anche ecclesiastici di notevole levatura morale e non meno di Gregorio VII impegnati contro la simonia e il
concubinato del clero, quali - per restare in Italia - Dionigi di Piacenza, Guido d'Acqui, Guiberto di Ravenna (futuro antipapa
Clemente III), ma decisamente contrari alla concezione gregoriana del primato papale
(Vitolo, op. cit., p. 253)
Il giorno di Natale del 1075 Cencio, nobile e bandito romano, sequestr Gregorio a Roma, ma il papa venne liberato
da un tumulto popolare.
Nell'anno seguente l'imperatore Enrico IV convoc a Worms un sinodo dei vescovi del Sacro Romano Impero
Germanico (Dieta di Worms del 1076): i vescovi chiesero le dimissioni di Gregorio VII.
I vescovi tedeschi al fratello Ildebrando. (...) Ti dai cura di novit profane. Infatti ti sei preoccupato in tutti i modi di
togliere ogni autorit ai vescovi, autorit che - come si sa - stata loro concessa da Dio mediante la grazia dello Spirito
santo, il quale opera soprattutto nelle ordinazioni. Hai dato in mano al furore della plebe tutta l'amministrazione delle
faccende ecclesiastiche. Ora nessuno pu pi diventare vescovo o prete se non va a mendicare questa carica dalla tua altezza,
con una adulazione del tutto indegna. Hai sconvolto in una miserabile confusione tutto il rigore dell'istituzione di Cristo, e
soprattutto quella bellissima distribuzione delle membra di Cristo che il dottore delle genti
loda e difende. E cos, per i tuoi gloriosi decreti, lo stesso nome di Cristo - lo diciamo con le lacrime agli occhi! - perisce.
Chi infatti non si meraviglier di questo fatto indegno che tu ti arroghi ingiustamente una potenza indebita, distruggendo i
diritti dovuti alla fraternit universale? Affermi, infatti, che qualora giungesse a te anche solo il sospetto di qualche delitto di
uno qualsiasi dei membri delle nostre diocesi, nessuno di noi avrebbe pi l'autorit di "legarlo e scioglierlo", ma soltanto tu,
o qualcuno che tu avessi appositamente delegato a questo scopo. Non c' nessuno esperto delle sacre lettere che non veda
come questa pretesa superi ogni stoltezza
(J.M. Watterich, Vitae Romanorum Pontificum, vol. I, p. 373)
Poco dopo, Enrico IV invit i sudditi dell'Impero Romano alla disobbedienza nei confronti di Gregorio, e lo
proclam deposto. In reazione, nel febbraio del 1076 Gregorio VII scomunic Enrico. Dopo la scomunica Enrico
venne abbandonato dai principi tedeschi, che gli contrapposero Rodolfo di Svevia e minacciavano di non
riconoscerlo pi come imperatore se non si fosse liberato dalla scomunica. Gli stessi principi invitarono il papa ad
Augusta perch questi emettesse una sua decisione nella loro controversia con Enrico. Con mossa abilissima, mentre
Gregorio VII era gi in viaggio verso Augusta, Enrico lo anticip, incontrandolo a Canossa. In un primo momento
Gregorio, combattuto tra opportunit politica (istituire un processo contro Enrico in Germania, con grande prestigio
per il papato) e dovere pastorale (perdonare chi gli si presentava come peccatore pentito), scelse la seconda via e
assolse Enrico dalla scomunica.
Pochi anni pi tardi, per, Gregorio si mostr molto pi spregiudicato e nel 1080 dichiar pubblicamente il suo
appoggio per Rodolfo di Svevia, rinnovando la scomunica e deposizione di Enrico IV, il quale, a questo punto, fece
eleggere un nuovo papa nella persona dell'arcivescovo di Ravenna, Guiberto (noto come antipapa Clemente III). Nel
1081 Enrico marci su Roma e la conquist nel 1084: a Roma ricevette la solenne incoronazione imperiale da
Clemente III, mentre Gregorio fuggiva a Salerno, dove moriva nel 1085.
Gregorio VII aveva riaffermato vigorosamente l'autonomia della Chiesa e la suprema autorit di Roma su tutte le
Chiese locali. In particolare, come risaputo, Gregorio si oppose nettamente ad ogni ingerenza laica nella scelta dei
vescovi e degli abati. Questo, inevitabilmente, provoc uno scontro feroce con l'imperatore, perch di fatto i vescovi
e gli abati erano anche detentori di una autorit civile (non solo quando erano vescovi-conti, caso in realt non
frequentissimo, ma perch normalmente esercitavano una giurisdizione su coloro che risiedevano nelle loro diocesi e
amministravano patrimoni terrieri vastissimi), e ovviamente l'imperatore voleva intervenire nella selezione di questi
Riforma dell'XI secolo
suoi funzionari.
L'iniziativa riformatrice di Gregorio VII non fu, comunque, la prima mossa della riforma dell'XI secolo, bens
l'ultima. La riforma gregoriana fu generata dalla riforma imperiale la quale, a sua volta, aveva assunto e coordinato la
riforma che si era sviluppata dal basso (monaci, clero e laici). D'altro canto, lo scontro con l'Impero non fu il
contenuto centrale della riforma gregoriana, anche se ne costitu un passaggio obbligato: se la riforma dell'XI secolo
era stata caratterizzata soprattutto da una spinta unificatrice, chiaro che gi due centri unificatori (Papato e Impero)
erano troppi.[3]
La riforma da papa Vittore III a papa Callisto II (1085 - 1122)
La morte di Gregorio VII e la situazione difficilmente superabile venutasi a creare colp fortemente il partito
riformatore.
Pass infatti un anno prima che fosse eletto il successore di papa Gregorio VII. Desiderio di Montecassino, eletto nel
1086, diede il suo assenso l'anno successivo e fu intronizzato il 21 marzo 1087 con il nome di Vittore III. Accettata
la nomina gli manc il tempo per realizzare la riforma, infatti, il 16 settembre 1087 mor.
Dopo di lui venne eletto papa il cardinale di Ostia, Ottone di Lagery, con il nome di Urbano II (1088).
Egli si adatt alle circostanze, condividendo il programma riformatore di Gregorio VII ma utilizzando spesso la
dispensa papale per quei vescovi simoniaci che si dimostravano disposti a piegarsi alle linee imposte della Sede
romana (e spesso venivano nuovamente ordinati).
Durante il suo pontificato per era ancora in vita l'antipapa Clemente III (Viberto di Ravenna), il quale fu
neutralizzato, anche grazie al cambio di mentalit di molti vescovi prima favorevoli a Clemente III ed ora ad Urbano
II.
Enrico IV, pur avendo sconfitto il rivale Rodolfo di Svezia, fu quasi abbandonato dai suoi sostenitori e persino dal
figlio Enrico V, per cui fu costretto ad asserragliarsi nella regione di Padova e Verona.
Intanto papa Urbano II intraprese un viaggio per due anni che lo port in Francia, passando per la Toscana, dove
convoc concilii a Piacenza (1055), in cui decise l'invalidit delle investiture fatte dall'antipapa e dai suoi sostenitori,
e a Clermont Ferrant (1095), nel quale cerc di incitare i monaci perch imprimessero la riforma nel paese. Durante
questo concilio indisse la prima crociata, invitando i cavalieri cristiani a combattere per la liberazione della Terra
Santa.
Urbano II mor il 29 luglio 1099, due settimane dopo la presa di Gerusalemme da parte dei crociati (15 luglio 1099).
Alla sua morte gli succedette papa Pasquale II, del quale non abbiamo molte informazioni. Certamente italiano,
monaco anche se non cluniacense, fu descritto dagli storici come persona semplice e, a volte, ingenua. Sotto il suo
pontificato si continu a combattere contro le investiture, argomento maggiormente interessante e scottante in questo
periodo. Questa questione si risolse innanzi tutto in Inghilterra ed in Francia.
In Inghilterra il problema fu risolto giuridicamente alla presenza del re e di sant'Anselmo d'Aosta, nell'agosto del
1107, con la dieta di Londra. Enrico I d'Inghilterra, figlio di Guglielmo il Conquistatore, rinunci all'investitura dei
laici alle cariche ecclesiastiche con l'anello e lo scettro (segni dell'investitura spirituale e temporale), ma conserv il
diritto di ricevere dai vescovi, prima di essere consacrati, l'omaggio feudale. Prima di essere consacrato, infatti, il
vescovo eletto doveva fornire al re una truppa di uomini, di cavalieri gi armati che si mettesse al servizio del re.
Anche in Francia la situazione fu la stessa. Il re rinunci a dare l'investitura con l'anello e il pastorale ma si
accontent di chiedere al vescovo, a differenza dell'Inghilterra, soltanto un giuramento di fedelt.
Secondo gli storici canonisti, si giunse a queste soluzioni perch ci si rese conto in ambito politico che l'investitura
era duplice ed era necessaria, quindi, una distinzione: il potere spirituale (ordinazione episcopale) era un ufficio
ecclesiastico, mentre il potere temporale (dare i beni, le propriet) spettava al re. A questa distinzione contribu
fortemente anche Ivo di Chartre.
Riforma dell'XI secolo
Il problema, superato per Francia ed Inghilterra, rimase irrisolto per le regioni dell'Impero (Germania, Italia e
Lotaringia).
Pasquale II, accortosi del problema, tent una linea di soluzione nel 1111, invitando i vescovi a rinunciare
all'investitura temporale, alle propriet affidate loro dall'Imperatore. Questa soluzione non port alcun successo, anzi
cre ribellioni di molti vescovi all'autorit papale, sebbene fosse una soluzione che piaceva all'Imperatore, in quanto
vedeva tornare a s tutti i donativi e le propriet affidata ai vescovi dagli Ottoni (800). Pasquale II mor nel 1118. Gli
successe papa Gelasio I, il quale venne imprigionato e fugg a Gaeta dove mor nel 1119.
Alla sua morte gli successe Callisto II, un monaco cluniacense francese, con il quale si risolse il problema. Egli,
infatti, raggiunse un accordo con l'Imperatore Enrico V nel Concordato di Worms (1122), durante il quale fu
cambiata la modalit di elezione del vescovo.
Sviluppi della storiografia recente: messa in discussione del concetto di
"riforma gregoriana"
La categoria storiografica di "riforma gregoriana" fu sostenuta all'inizio del Novecento (soprattutto dallo storico del
cristianesimo Augustin Fliche). In questa prospettiva, che trov rapidamente un consenso unanime tra gli studiosi, la
"riforma gregoriana" sarebbe stata un vasto movimento unitario che partiva dal papato ed ebbe il suo culmine
nell'opera di Gregorio VII, vero ispiratore dell'opera dei papi suoi successori ma anche migliore incarnazione
dell'opera dei suoi predecessori, di alcuni dei quali era stato anche collaboratore attivo. Parlando di riforma
gregoriana, il punto di vista si focalizzava notevolmente sul papato: sintetizzando molto, si pu dire che la riforma
veniva comunque presentata come opera del papa, mentre il "nemico" contro cui opporsi era l'imperatore.
Questa stessa categoria, tuttavia, and presto in crisi, poco dopo la seconda guerra mondiale:
Jean Franois Lemarignier, studiando la riforma cluniacense, pot indicare nella centralizzazione operata da
Cluny il modello della riforma (che pure egli chiamava ancora gregoriana);
Cinzio Violante individu e studi un ampio movimento riformatore attivo a Milano quando ancora il papato non
aveva assunto alcuna opera di riforma.
Il culmine di questa revisione si ebbe, in Italia, con un famoso articolo di Ovidio Capitani del 1965.[4] Capitani
scriveva:
Esiste un'"et gregoriana"? O, per lo meno, pu giustificarsi, atteso i risultati pi significativi della storiografia in
questione, la scelta di un aggettivo cos importante, a qualificare una periodizzazione? ... Molto c'era da tempo in via di
realizzazione che trov una sua completa manifestazione nel tempo di Gregorio VII, ma non ad opera sua. ... Il pontificato
di Gregorio VII la vera ed unica "et gregoriana", e sembra inequivocabilmente indicare il momento di massima fluidit
polidirezionale della crisi. Da studiare, quindi, sempre: ma sempre meno nelle persone, sempre pi nei problemi e nella
dinamica delle forze
(Ibidem, p. 480)
Ci si rese sempre pi conto, in definitiva, che il termine "gregoriana" in qualche modo rimuoveva, o per lo meno
metteva in ombra, la riforma voluta proprio dagli imperatori romano-germanici, quella intrapresa da correnti
monastiche e laicali, o quella di vescovi di parte imperiale (si pensi a Viberto di Ravenna o al primo Rainaldo di
Como) che furono sicuramente dei riformatori, sebbene apertamente schierati contro Gregorio VII.
10
Riforma dell'XI secolo
Note
[1] La riforma episcopale, come era stata concepita ed attuata da Attone di Vercelli, da Raterio di Liegi e da altri prelati animati da medesimi
intenti, non ha dato e non poteva dare che risultati insignificanti. ... Il vescovo riformatore frutto di un caso felice che presto o tardi non si
rinnover; il pi delle volte il suo successore non gli somiglia affatto e l'opera abbozzata interrotta, compromessa, o anche completamente
distrutta. ... Il papato nel X secolo perse l'autorit il prestigio indispensabili per una azione efficace. Da qui risulta, in fin dei conti, che
l'iniziativa della riforma non pu venire che dall'imperatore. ()
[2] Gran parte del popolo ader alle idee patarine ... Essendo ormai penetrata nella cultura popolare l'idea della sessualit come colpa e
contaminazione, i preti sposati vennero con facilit fatti considerare peccatori pubblici e impuniti. Si cominci ad attuare uno sciopero
liturgico da parte dei fedeli, che si rifiutavano di assistere alle messe e di ricevere i sacramenti di questi sacerdoti, e si arriv poi
all'allontanamento forzato dalle chiese e all'aperta e violenta persecuzione. Il moto patarino si fondava sull'idea non cattolica dell'invalidit dei
sacramenti celebrati dai sacerdoti peccatori, che faceva apparire agli occhi del popolo la condanna del clero sposato e la conseguente
persecuzione come una legittima purificazione e liberazione della Chiesa. ()
[3] Se Gregorio VII pu essere assunto come simbolo di una riforma che, avviata per liberare la Chiesa dalla decadenza infiltratasi in essa a
motivo dei soffocanti legami con i poteri locali, e anche di uno slancio spirituale che, come tale, risulta politicamente sconfitto, egli va tuttavia
indicato anche come l'esponente massimo di una nuova concezione di Chiesa, non soltanto nei suoi rapporti con l'Impero, ma prima di tutto
nella relazione tra Chiesa romana e Chiese locali. Nel Dictatus papae ... si dichiara essenzialmente l'unicit della Chiesa di Roma (nel senso di
essere l'unica Chiesa propriamente tale) e, di conseguenza, la sua autorit immediata su tutte le Chiese locali; d'altra parte si d anche
un'immagine inedita della cristianit, come presieduta non pi da due autorit affiancate l'una all'altra - come era stato, pur con esiti alterni,
lungo i secoli precedenti - ma da una sola autorit, quella papale, alla quale quella imperiale risulter sempre pi nettamente subordinata, nei
secoli successivi, fino al tramonto del sistema medioevale. ()
Bibliografia
Ovidio Capitani (1965). Esiste un'et gregoriana? Considerazioni sulle tendenze di una storiografia medievistica.
Rivista di storia e letteratura religiosa (1): 454-481.
Ovidio Capitani, L'Italia medievale nei secoli di trapasso : La riforma della Chiesa (1012-1122), Bologna,
Ptron, 1984. ISBN 8855518887
Ovidio Capitani, L'et pregregoriana in La Storia : I grandi problemi dal Medioevo all'Et contemporanea,
Torino, 1988.
A. Fliche, La rforme grgorienne, Lovanio, Parigi, 1924-1937.
G. Fornasari (1983). Del nuovo su Gregorio VII? Riflessioni su un problema storiografico non esaurito. Studi
medioevali serie III, 24 (1): 315-353.
Hubert Jedin, Storia della Chiesa, Milano, Jaca Book, 1975, Vol. 4, pp. 267-280, 479-499.
Giovanni Miccoli, Chiesa gregoriana : Ricerche sulla riforma del secolo XI, Firenze, 1966.
Francesco Quaranta, Preti sposati nel Medioevo : Cinque apologie, Torino, Claudiana, 2000. ISBN 8870163350
G. Rossetti, Il matrimonio del clero nella societ altomedievale in Il matrimonio nella societ altomedievale,
XXIV Settimana di Studi del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 1977, Vol. 1, pp. 473-567.
Il dramma della Chiesa impegnata a fondo nel suo rinnovamento non fu la lotta dei buoni (la sede apostolica)
contro i reprobi (l'episcopato e il clero corrotto). ... Fu un dramma sociale e istituzionale che richiede da parte
nostra uno sforzo di comprensione globale della dinamica interna di quella societ. (p. 549).
Giovanni Vitolo, Il rinnovamento della vita religiosa e la riforma della Chiesa in Medioevo : I caratteri originali
di un'et di transizione, Milano, Sansoni, 2000, pp. 244-263. ISBN 8838318573
Saverio Xeres, La prima grande riforma nella storia della Chiesa; Le principali conseguenze di una riforma
irrigidita in La Chiesa, corpo inquieto : Duemila anni di storia sotto il segno della riforma, Milano, Ancora,
2003, pp. 63-86. ISBN 885140108X
11
Riforma dell'XI secolo
12
Voci correlate
Dictatus papae
Lotta per le investiture
Portale Cattolicesimo
Portale Cristianesimo
Portale Medioevo
Fonti e autori delle voci
Fonti e autori delle voci
Riforma dell'XI secolo Fonte: [Link] Autori:: .snoopy., Actarux, Antis, AttoRenato, Avemundi, Barone Birra, Bartleby08, Cazza, Croberto68,
Eumolpo, Federico di Svevia, Gervasi, Luccaro, Madaki, MapiVanPelt, Marco 27, Massimiliano Panu, Medan, Mickey83, Nicola Romani, Pequod76, Phantomas, Pinea, Pracchia-78, Rago, Rl89,
Rojelio, Rosa nero, Sailko, Sentruper, SolePensoso, Talmid3, Torsolo, Urumbamba, Vituzzu, 54 Modifiche anonime
Fonti, licenze e autori delle immagini
Immagine:[Link] Fonte: [Link] Licenza: GNU General Public License Autori:: Guppetto
File:Emblem of the Papacy [Link] Fonte: [Link] Licenza: Public Domain Autori:: Cronholm144 created this image
using a file by User:Hautala - File:Emblem of Vatican City [Link], who had created his file using PD art from Open Clip Art Library and uploaded on 13 July 2006. User talk:F l a n k e r
uploaded this version on 19 January 2007.
File:[Link] Fonte: [Link] Licenza: GNU Free Documentation License Autori:: Tinette.
File:Cross of the Knights [Link] Fonte: [Link] Licenza: Public domain Autori:: User:Kbolino
Licenza
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//[Link]/licenses/by-sa/3.0/
13
Potrebbero piacerti anche
- 14 La Lotta Per Le Investiture 14Nessuna valutazione finora14 La Lotta Per Le Investiture 1422 pagine
- Istituzioni Di Storia Medievale - I Mille Anni Del MedioevoNessuna valutazione finoraIstituzioni Di Storia Medievale - I Mille Anni Del Medioevo27 pagine
- Lezione Riforma Chiesa - Crociate - 0Nessuna valutazione finoraLezione Riforma Chiesa - Crociate - 039 pagine
- Evoluzione Chiesa e Cultura e ViaggioNessuna valutazione finoraEvoluzione Chiesa e Cultura e Viaggio4 pagine
- La Riforma Protestante e La ControriformaNessuna valutazione finoraLa Riforma Protestante e La Controriforma13 pagine
- 1 - Lotta Per Le Investiture - Chiesa e ImperoNessuna valutazione finora1 - Lotta Per Le Investiture - Chiesa e Impero29 pagine
- Riforma Protestante e ControriformaNessuna valutazione finoraRiforma Protestante e Controriforma4 pagine
- 12 Riforma Della Chiesa, Universalismi e Autonomia ComunaleNessuna valutazione finora12 Riforma Della Chiesa, Universalismi e Autonomia Comunale6 pagine
- Sviluppo Intellettuale Del Medioevo, BaraNessuna valutazione finoraSviluppo Intellettuale Del Medioevo, Bara10 pagine
- 12 Conseguenze Della Riforma ProtestanteNessuna valutazione finora12 Conseguenze Della Riforma Protestante18 pagine
- Storia 2m Riforma Protestante SchedaNessuna valutazione finoraStoria 2m Riforma Protestante Scheda1 pagina
- Lotta Per Le Investiture Tra Papato Ed ImperoNessuna valutazione finoraLotta Per Le Investiture Tra Papato Ed Impero5 pagine
- Riassunto La Reconquista e Le Crociate Federico BarbarossaNessuna valutazione finoraRiassunto La Reconquista e Le Crociate Federico Barbarossa6 pagine
- ndt2 Riforma e Controriforma FlattenedNessuna valutazione finorandt2 Riforma e Controriforma Flattened17 pagine
- Scontri Tra Chiesa e Impero Tra XII e XIII SecoloNessuna valutazione finoraScontri Tra Chiesa e Impero Tra XII e XIII Secolo6 pagine
- La Riforma Protestante e La ControriformaNessuna valutazione finoraLa Riforma Protestante e La Controriforma20 pagine
- Ludovico II Del Sacro Romano ImperoNessuna valutazione finoraLudovico II Del Sacro Romano Impero9 pagine
- Ora Santa Per Pregare Per I MalatiNessuna valutazione finoraOra Santa Per Pregare Per I Malati5 pagine
- Periodo 3 - Illuminismo - Giordano BrunoNessuna valutazione finoraPeriodo 3 - Illuminismo - Giordano Bruno3 pagine
- Riassunto Appunti Letteratura ItalianaNessuna valutazione finoraRiassunto Appunti Letteratura Italiana4 pagine
- Vangelo in Immagini IV Domenica Quaresima A PDFNessuna valutazione finoraVangelo in Immagini IV Domenica Quaresima A PDF1 pagina
- Riassunto Arte (Botticelli, Antonello, Mantegna, Bellini)Nessuna valutazione finoraRiassunto Arte (Botticelli, Antonello, Mantegna, Bellini)11 pagine
- Lorenzo de Medici, Poemetti in TerzineNessuna valutazione finoraLorenzo de Medici, Poemetti in Terzine110 pagine