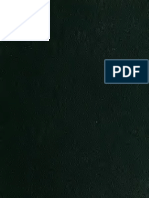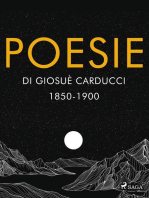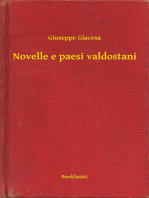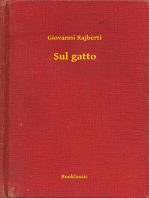Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Galiani Baretti Salza - I Cicisbei
Caricato da
dertoninoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Galiani Baretti Salza - I Cicisbei
Caricato da
dertoninoCopyright:
Formati disponibili
Creato: Creato: Creato: Creato: 10/08/2012 13:04
Cicisbei ill rosa vvv. bmp Cicisbei ill rosa vvv. bmp Cicisbei ill rosa vvv. bmp Cicisbei ill rosa vvv. bmp
I CICISBEI
Ferdinando Galiani
Orazione sul tirare a sorte i Cicisbei e le Cicisbee
Giuseppe Baretti
Gli Italiani - Relazione sugli usi e costumi d'Italia
Capitolo II Le persone maritate
Abd-El-Karam Salza
I cicisbei
Ancora dei cicisbei
Creato: Creato: Creato: Creato: 09/08/2012 22:54
FRONTESPIZIO DEFINITIVO. png FRONTESPIZIO DEFINITIVO. png FRONTESPIZIO DEFINITIVO. png FRONTESPIZIO DEFINITIVO. png
- \
..
OR ,AZIONE
llE C ITATA I N UNA A S S E MB L E A
}li E L C A P O D E L L ' A N N O
MD CCLlX.
IN OC C .ASIONE
Di tir are Cl forte
I
CICISBEI, E LE. CrCr5BEE.
i ,. ~
oC5 )o
L'E D I T O R E
.A c fil L E G G E .
I capitata cafualmente nelle ma-
ni la : prefente fpiritofa produzio-
ne dell' Abate Galiani , di cui re-
centemente fi fatta, perdita _ Ella un"
Orazione [ come fi vede dal titolo] re-
tirata in una fioritiffima Aflernblea nel
Capo d'anno del 1759- hl occafione di
ti rar fi a fort e j Cicisbei, e le Cicisbee ,
Lettala con rapidit, mi accertai fubiro
di efler parto fuo ; e chi per tale non
l a riconofcer allo flile , "ai penfieri, ed
alle grazie, che vi fono Iparfe? Per vie
j
A " pi
pil aflicur rmene ne dornan ai l' Avvo-
cato D. Fr tlafca A '{'{;1riri di l ui Nipo.
te, ch' 1'ercd-= delle Iue ' letterari e fati-
ghe. Egli mi dille di non ave rla pun..
t o ritrovata tra le fue carte; ma di co-
flargli beniflirno , che n' aveva molti an-
ni fa cfiemporaneamente compolla una
fu quello foggetto, e di non
potcrfi dubitare di efler appunto quella,
che . io gli moftrava , tanto pi ch' era
tutta fcritta di carattere del fuo Ama-
nuenfe a lui ben noto . Mi fembrato
un peccato privarne il Pubblico che ha
fernpre ben accolto le produzioni di qua-
l unque genere foflero , di queflo ill uflre
letterato, il quale e di fommo onore, e
gloria, e di piacere infieme fiato alla
Nazione . Credo adunque che Tu, o
'Lettore , me ne debbi efler grato . E fe
mi
r
oC5 )0
mi domandi, perch tra le opere, che
l' Abare Galialli ha lafciate manofcrirte ,
non ne abbia cercata un' altra di pi uri-
le, e pi inrereflante argomento, ti ri-
fpondo, che io non ne ho altra, n ho
i mezzi da poterne far l'acquiflo , Cerca
Tu , Ce hai amor per le lettere, fe ti
muove l' onor della patri a, chi le abbia,
convienlo innanzi al Tribunal della ra-
.
glOne, e fallo afiringere a pubblicarle ,
Quello quel , che poflo dirti , e vivi
felice .
o R A Z J o N E..
.
i I
: Q ,U EST lodevoliffimo Ifliruro', che la pre;
fente nobiliffima Atfemblea religiofa-
I I
mente offerva, e mantiene, febbene fia fiato gi3
parecchie .volt e da me meditato, e fecondo che
li iodato, ed ammirato ,; pure ella
jla de' fuoi pregi, la grandezza.
de' fuoi vanraggi , che ogni qual 'volt a , che io ri- .
torno a parlarne , trovo la matria non folamen-
.. 1"1 Jf
te. riflretta , ma incredi bilmente crefciuta ;
ed ayanzata. E non altrimenti, che l'Ernie
(che volgarmerne diconfi Palloni) coll'
andar degli anni fempre pi crefcono, ed ingi-
. . I ,
gandifconfi ; cos avviene in me, che. ogni anno
Fi mi crefce il campo, e l'argomento di ra-
,
gionare Pe"r la. qual cofa , io che non voglio
n
( 8
l'l man are Il' . ic ilr ut alla oflra
alpettazione , Udirori , a guifa di coloro , che
per fervire attentamente gli ammalati buttano
con ogni pre Ilezza gli urinali per le finefire ;
cos io per Iervirvi verfer aila , pegsio, e fen-
za alcuna ricercatezza nel dire queflo inlpidot e
malacconcio ragionamenro , E poicch a divi ....
fione de' , punti ..tanto , e prezio
fa agli Of"arori, .quanto la ere' pu ti
t1.tile a Cot1giategan}i; ecco io divider in quefla
t ' f . ,r r I .. ... t.' r
guifa Il mio dire, l ' collume d. tirar a forte
l .
nd primo d dell' anno: le Dame,
e nobile per la. fua orlzire : nella Co. '
. b . , / r rt ..
ftituzione; pio in teorica] meritorio' rn
. (
tica ,
EGLI abbailanza. l1oto, che il primo co.
minciamento della ufanza , di cui' favellta'mo, fi.t
nella Germania; e quantunque alcuni ignoranti
vogliono ripererne il principio O da' famof qava;
lieri della Tavola Ritonda, che l' Inghilrerra pro.
duffe, o dalle celebra e Corti' d'A.;nore dagli anti-
chi Conti di imagiaate (nelle 'quali ebbe
.;
( I) (J
l'onorato p()fi dr Portiere il Petrarca ),ed altri fio.
nalrn nte vi fiano che n 111 Corte di Carlo Ma
. ,
{no lo vogliorio i tl ituiro , e .Ioftengoa etfere
-to Monfig or Turp ina il primo Gran Cancelliere
dell' Ordine ; pure ti fatte opinioni non hanno fuf-
fifenz verua , fi ccorne ha dottamente dimofira-
te il nofro Ta./Jone- nel fuo li bro De Antefato,
Iaddove di tutt e le umane cof confufamenre ra-
giona . E quantunque ' il mio pr ivato
con gliarmi a. dihirarne Il' Re
pino, dall l cui generofa firp per diritta, .e P:l-
ozenira linea. io difcendo ; pure a. me non pia-
b "
ce tradire l verit per tirarne a cnn privato pro-
fitto L Refij a, nque decifo , che I' invenzi one' di
a gloriara. cofa rutr do r"ta alla Germania;
ella quale fecondo che io 'leggo i m,alte anri-
he Croniche, nella Citt d" Popp.:ring.:r co-
(s dal nafcervi, p pput le donne) fa la prima.
penfata 1 e meffa in pratica. Ora qual al-
tro argomento di bifogno abbia noi per dimo-
{trame la" obilt? Chi non sa , che. 1 Genes-
. QO'ifii. ogni qualun ue '3. fanno difcender
dalla.
o( 10 "
dalleGermania (vero, o falfo che 6a ) per render.;
la Nobile ? Quafi in niun altro paefe fi poteffe
efler nobile, fuorch in Germania. Olt racci
chi non sa , che la Germania la fame e la
,
fcaturigine di ogni cofa buona? D i Germania
venuto il taice ; il pi genti le incitamento dell'
.impuro Amore. . Di . Germania, e propriamente
dalla Svezia, vengono preziofi prefciurti , eccellen-
ti cafci , tele finiilime , butiri incomparabili, or..
timo pane'. J Ma quel che pi, tutte le fami-
gerate galanterie di Venezia dalla Germania ven-
gono '; non fi. lavorano in Venezia. Or fe l'amo-
re, e la galanteria fono una fefla cofa, chi
potr negarmi , che l'Amore per effer galan,
te, gentile, e nobile ha da venir dalla Ger-
mania ? Altrimenti egli far bf'ltale, e fuc-
-cido , giacch fenza il dono delle galanterie
non Cl pu fare generofarnenre , e con profitto
l'amore. Le Navi Inglefi , e Francefi per
.contrario portano a noi il baccal le arinzhe
, b'
le farache, .il tarantello , ed altre fimili porcherie.
Perlocch egli ficurc ., ed incontraflabile-, che
J quanto
<>( 11
quanto cede il baccal al prefciutto, le aring
al cafcio , il tarantello ai- butiri , tanto deve ce-
dere l' amor Francefe, e l' Inglefe al . Tedefco
nella polizia, e nel buon fapore ,
CHE fe nobiliffimo il nofro i fiit uto per
la Iua origine Germanica, utiliffimo nella fua.
coftituz.ione . Certa cofa , che il principio di
ogni umano piacere fia fondato nella Societ ~
fenza la quale gli uomini firnili ai bruti vivereb-
bero vita mifera , e fientata. Non parlo io di
quelle Societ, che i Mercanti formano per fo-
lo fine di lucro, nella quale ciafcuno poffiedc
qtialhe carata. E nemmeno parlo di quelle S o ~
det (volgarmente dette './/jJaciazioni) , colle q u a ~
li Cl truffano gli antecipati prezzi de' libri dagli
Sramparori ; n di quelle altre airociazioni, colle
quali lugubremente fi vanno ad aflociare , e fe-
pelli re i morti. lo intendo di quella Societ,
fecondo la quale l'uomo non per carate, ma. in-
rierarnente , e pacificamente . poffiede tutto log-
getto amato. E , certamente I fe vi c o f ~ in-
comoda , e nojofa , ella quella . di far l' amor
B per
1
oC u .
per earar t. flccorne per difgrazia avra qualcun.
di Noi qualche vol ta fperimenrato.. Quefia no-
biliflima t e sublime. Societ. ha. la fua fede. nell'
amore ; per la qual. cofa. tutte. le invenzioni, che
alla purificazione dell' amore conducono , t utte fo-
no daverfi. per ut ili, e gi ovevoliffime, E' 1' a
more. un. punto di mezzo, t r l ' amicizia , ' e la li-
bidine, Dovunque trabocchi diventa viziofc ,
E ficcarne. l'alino , . qualora. non fia equili brata).
e giuflamente, divifa in: eguali pefi la fua fama,
non. pu. innanzi andare " cos avviene nel carn-
mino et amore. a. tutti gl"infelicf viandanti ,
Iocch - eflendo il piacere.. fondato nella Soci r t
c: quefia. nell"amore" ed. effendo l'amore pe r cf.
fer lu ngo , e felice tutto fondato. nell' efattezza
de' contrapefi ,. chi. potr. nega re eflere uriliff,
ma, e perfetta 'quell a. ifiituzione, che equlii bra.
e conrrapefa gli oppofii ingredienti dell' amore
Tale per appunto la nofra, Ella non giova
ad incominciar le amicizie, ch'e fi fuppcngone gi
contratte. tra' coloro, che nell' Urna .fat ale efpon-
ono. i loro. nomi, Nemmeno, pu fervire acl
" ali--
3 )
la. concup,lfcenza, dipendendo dal ca-
fo J e non dalla libera [celta; e niuno , che
coucupifca acaro , e.cl al )puro azzardo; fuorch
.che ii trovano lenza quatrini , de' quali
ro 10n certo, che niuno tra di voi nobi-
liffimi Uditori. D unque quefo no/ho
manrenend quel perfett o mezzo , che 1 richiede.
al puro, e ' dure vole amore , far utiliflimo , ed
ammirabile, e fuperiore ad ogni maldicenza, e
fofpetto, Il che tantp ;v,ero ) che io.... non Jlxr
2lcuna difficolt. di \ pio l ' e virtuofo,
En in vero febbene, (che il Ciel non
pofl avvenire, che egli in pratica ii 'cor rompa'
. .
e dal ' l UO naturale principio efca e ii guafii
. . . t
pure non pqtr mai negarfi , che teoricamente
riguardato) egli non fia , come io diffi , pio, e
vrtuofo. , E di grazia qual , 'altra cofa, la pl(i.
t. , che la ram gnaaione Del che :fe alcuno ar-
dubitare confideri 11 Sacro Monte della Pie...
t, e vedr in ciro primieramente r aflegnare tan-
t e te tante: robe, che ,11 pu dire e(fer quel
iO e fondato a farvi paflare la ,
B
( if )0
generale di tutti i migliori gal antucml aj ,
In fecondo luogo non folarnente la gen e 11a raf;
fegnata alla' fedelt di quei, che cuflodifcono le
loro . robe, ma fa ancora raffegnatiflima al Di-
vino volere ful quanto, e ful come, e con quai
mezzi potr finalmente una volta ancorch rofe
,
c tarlate farle ufcir di l. Piet, e rafegna-
eione fono dunque la medefima cofa ; e la virt che
alt ra cofa- ; fuorch la coflanza contro gli avvert
o incerti cafi della Fortuna? A chi dunque raffe-
gnando' le Iue generali inclinazioni s'e fpone al dub..
biofo evento della cieca forte, non dovr. com-
peterli il titolo di pio, e virtuofo
MA perch molti faranno, che ardiranno
forse 'chiamare foltezza , e temerit quefta, a
creder mi ,vera virt, referanno effi- certa..
mente confufi, quando riguarderanno, quanto la
noflra nobile, w ut e, e pia coflhmanza -fi a me-
ritoria in' pratica. O voi , anime grandi , e ge-
nerofe di coloro, che brutte, o vecchie mogli
avete fpof-Jte, voi foflenere :il mio 'dire- e ' narra,
eci voi, re la b av ra di 4fqvo/a, cheJ tenne-fer-
ma.
o( 15 )0
ma la mano Iul fuoco, f e l' eroi fmo di
che prevenne colla fua morte il fato infelice di
Roma; fia paragonabile al voftro , o f a , come ' io
credo, di "gran lunga minore. lo fon ficuro , he
il tormento di quel Tiranno, che il corpo di ' un
cadavere leg a quello .d' uomo vivo, poffa Ialo
darci una imperfetta idea dell' afprezza del tor-
mento che foffre un Giovine nell' avere un'an-
,
rica , e Iquallida Donna vicino; o che [offre una.
Giovine, e fanguigna Donna nell' aver accanto
un vecchio, e bavofo o amante, o marito. Irn-
perfena idea, io dilli, perch la pena di quel
, Tiranno era dalla profIima morte allegerito; ma.
quefta, dapoich l'ufo giovevole di certe acquette
non fi trova pi via , n modo da.
farla finire. Ma lafciarno querte molefie imma-
gini; lafciarno parimenti quelli argomenti, che
dall' aver dirnoflrata noi utile, e pia la prefente
cofiumanza fervirebbero del pari a dlmofirarla
meritoria ; ed andiamo solo a quell' ineluttabile,
iuvincibile A',"hilleo argomento, che solo ' pu ba-
tiare a render vano' ogni sforzo 'de' nofr] Avver-
. fa-
c(J4 )0,
_rj. Dicamifi di grazia, l'opera meritoria
che con !ile? ell' abnegaaione della propria ve-
lont 'e rd' I querfta, I abbafanza ragiona,
t .) , e nella perfetta 'mort ifi cazione , e di quefla
vengo a parlare , Il ooftroperfenlmo iftiruto
richiede per legge fondamentAle ' ed efige che
'alla forruitarnenre eletta, Cicisbea faccianfi fre-
quenti, e copiof regali. E quale ( lasciatemi escla,
mare anzi dir meglio ) lasci aremi urlare ) qual . ,
pi perfetta , p; pura , pi diffi cile., pi mira-
colo a mort if caz.ione, che quefia del regalare
La disciplina mortificaaicne, ma toglie un san-
gue impuro , tal volta 'soprabbondanre , e necefla-
rio a cavarfi, e sempre facile '! rigenerarfi .: ma
il regalare toglie 'il sangue puriffimo dell'oro, che
non mai bafievole a niuno , e che mai, e poi
mai fi pu riacqui fare , Il digiunare morrifi,:
cazione , ma potrebbe eiTe effetto di lefina ; o
almeno certo) che ch' f mortifica digiunando',
fi consola pensando ) che non ha da firmar la lifla
della-spesa del Coco per quel giorno. Ma il re.
&alare tutto tormento Chi fa .la penitenza
d'ano:
I f
I
0C 17 )0.
d'andar scalzo, almeno. non firugge le scarpe'; ed
a. parer mio, minore mortificazione andare a
piedi scalzi , cIre. andar' senza. scarpe , ma' con
le. calzette; perch cos yanno a. malora i peda-
lini . In. fine. chi va nudo non fl:rugge vefliti; ch
dorme in terra, risparmia la lana di T unifi Ma
nel regalare. qual risparmio." qual consolazione 1-
qual cornpenso ? O puriffima-, e sublimiflirna mor-
tificaz:one ,. mal conosciuta. dagli uomini, e niente
esercitata ,. Deh. poffa il Mondo, riempirfi, di que.
Ila. santa. morti ficazione r io la. defider. di vero
Cuore, e n'avrei fingolare. bisogno .
VlA su dunque', dilettiffimi miei ,. nobilitare-
vi coll': iniziarvi alla. noflra. famofa. cofumanzar
rendetevi utili alla. Societ coll' incircoscritto, e.
casuale amore: vi fi accenda la piet: colla. me-
dirazione. raffegnaaione i . morti fi carevi. col
regalare ,. ma. morrificatevi uJquc ad
eifu./ionem , se volete. acquifarne. merito.. , E
yete. felici .
1.. L, F 1. N E ..
6'. IV, 230
G L' I T A L I AN r
o s u.
RELAZIONE
DEGLI IJSI E COSTUMI D' ITALIA
DI
GIUSEPPE BARETTI
DALt..' I N G L E SE
CO N tio'T); UF.L T lI A.DtlTTOI\.I>.
MIL ANO
T' Jm G J OV AN:n l 'I l\OTT A
in Sapla
'!Ii . pece. xvrt r,
./ !
. 1 .
,
. 'd
I L TRADUTT OR.E.
I l )' a d(1 (rftu n 'Iu'il f atit r{fIl1i!r s irim semcnl ,
J I!'$ tJbsuniit.'.sdal' l ilftUd ril'e ; eI MS ",e,O$UIl5"$
'Iu'il faut !'t/wU$,,!:r alJu force-
La presente venionl!' vi..n" l"'sta IOIt" lo lul..l'*
delle le;;;;; . e$Hudoii adtmpito a qua ntI>
esn
S Al'tIUELLO Sbar p (I ), ch iru rgo inglese ri nu-
mari ssiruo , dopo avere rapidamente scor sa
l' Italia ritornato in Inghilt erra, vi pubbli c
cer t e sue lettere irineraric in titol a te : Lettere
,SI' r Italia , descriventi i costumi c le usanze di
quella contrarla negli anni 1765-66 . con un
awiso a' gentiluomini che vogliono passare le
d/pi ; opera pi eua di ridicole e infami ingiu-
rie contro gli usi d'Italia e cont ro i rili
della Chiesa Romana. - Le Lett ere di Shar p
cap ita rono alt e mani III Giuseppe Baretti ,
c.) T.or m zo Sr erne , uomo di ingt!' gno acullUlmo.
parl ando ili She ep , al quale egli aMl'gna il nome ili.
M tl l'lP UIliGUS i cosi i i esprime : .. J\ h .r!l Ol,lIliGOS e la sua
steemiuara opulenta per corser o t uuc i l gran gi ru ,
.. endando da Roma a Napoli _ da Napoli a V..neaia e-
Ol da Venezia a vi eene , a Dresda , a Berl ino . e non
., r iporlo ne la rilllt lnbr anza il' una sole gener osa uurl-
.. cizia ne un solo piacll!Tole aneddoto da r aceonter e
l' sorr idendo : cor re va sempr e dir itto senza guerdere
Ol ne a si nistra . n a destr e , temendo non la ecmp as-
l' O l' amore l' adescassero fuor di strada - .
T.Ti nce, sento , cap. X Y I Il.
X PREFAZIONE DEL TRADUTTORE.
(Ii Appendi ce . due note dd benemerit o tra-
utt or e (Iella Drammat urgia di Schlegel nelle
quali vengono gi udiziosa mente espost i &1 i
p iceioli dift:t1 i, che i grandi p regi (lei mag-
gior Comico it aliano.
Il t imore di esse re biasimato per aver \'0-
Imo Ilare una traduzione italiana di un'Opera
del Bar eui. eenz' essere capace di mante-
neni lo st ile b rillauti esimo e tutt o propr io
di quell' i ll g r.gn0 50 autore , i cui ecr irt i 50110
le delizie C! t" gli uomini di gusto , me ne ave va
quasi fatto abbandonare il peueier o ; ma la
brama IIi far cou oecere agl' I tali ani qu est' Ope-
r a , la qu ale appena nota pel 8 110 ti tolo in
Italia . mi ha animate 3 mandare ad effetto
il mio divi eamcnto , e oso Jusingar mi che
quc' lettori i quali proveranno q ualche .fi-
lett o vedendo co me il Bare tti st" ppc dipi n-
gerci agl' I n g l ~ t i , vorr anno perdonar e al mio
stile , e mi lf ap ranuo buon grado di aver reso
Ilota in I talia questo suo scritto.
G J&oLAUO P OZZOLI.
PREFAZ IONE
DEL I: AUTORE.
LApresente Opera non fn intrapresa al
solo scopo di confut are le osservazioni
fatte dal sig. Sh:lrp p. ,la quegli altri
scrittori inglesi, che dopo aver fatto u n
breve giro, si sono avventurati a descri-
vere l' It alia e gr I taliani. Molto meno
sono per darla a' miei lettori come una.
compiut a e soddisfacente relazione in-
torno quel celebre paese, preso in tutti
quegli aspetti sott o i quali pu essere
considerato, e spero che nessuno vorr
appcrmi U11 simile disegno.
l' REr AZIONE
l o 3Ve\?3 gi da lunga pezza osservato
Con qualche sdeg no ~ che i pi degl i
scrittori di viaggi possono dirigere la
r iflessione di que' giovani che viaggiano:
ad oggetti frivoli C di nissun vantuaaic
0 0 ,
avvezzandoli a dare giudizj premat uri e
inconsidemn s u t utte le Cose che vee-
e
gan a. Ho quindi pigl iato occasione ,
massime dal libro del sig. Sharp , per
farli accorti , se posso , degli errori in
cui sono indotti ~ c in dicar loro degli
ogge tti di ricerche pih merit evoli dell a
cur iosit delle persone seusate , reuden-,
doli pi cauti nel oondannara tutto che
non hanno veduto nel loro paese. Un a
cieca ammi razione dell e usan ze e dei
Costumi stranieri mostra indizio di stol-
tezza; ma una censura che non fa distin-
zione , pal.l.a e maliziosa.
Nel 1700 ritornai in I talia ~ dopo avere
soggiornato di eci anni in questo regno
( l' Inghilterra ) , e trovai col che i miei
fratelli avevano ri unito in alcuni volumi
DELL' AUTORE. XIII
tutte le lettere ch' io aveva scritte a loro -
in quel lungo spazio di tempo. Un n ~ a - .
turale impulso mc li Ie' scorrerc : Ula.J.i
t rovai ( il primo specialmente cd il ~ e ..
condo) cos ripieni di st rambi giudizi
su gli uomini e le cose , desunti da
primitive e superficiali impressioni, che
mi credetti ben fortunato di paterne
stracciare ciaschedun foglio, procedendo
nella l ettura di una tale serie di osser-
vazioni.
l o domando perdono per questo insi-
gnificante aneddoto, che sente forse
Iroppo di parzialit , Ma quello che
avvenuto a me, sarebbe avvenuto in si-
mil e circostanza al sig. Sharp , e a quasi
tutt i gli scritto ri di \"iaggi cb' io lessi in
vira mia. - Dall a lettura tic' susseguent i
fogli sar tenuto parziale verso il mio
paese , n saprei se potessi interamente
giustificarmi d'una tale taccia : ma spero
che la mia predilezione non si rite rr
disgiunta da qual che cognizione ed espe-
XIV PREFAZI ONE DELL' AUTORE.
rienza degli argomenti che tratto. Il
lettore avr almeno dalle seguenLi di-
SCUSSlOUl il vantaggio di aver pi ah-
bendanti materie per dirigere il suo pr o-
prio giudizio.
e --
G L' I T A L I AN I,
o SIA
RELAZION E
D f; GL I
USI E COSTU:m D' ITALIA.
- -
CAPITOLO r.
Dei - Grande variet nel: carattere
dei divIn i popoli u Italia. _ . .41/ezione degli
Ita liani pc' f orestieri. - Loro condotta .
riguardo agli attori. nei teatri. - Il popolo
fr ugale c laborioso.
POCRE sono le opere !il favor evolmente ac-
colte dal pllbbl ico, come quelle in cui do-
minano la maldiccnza e le ingiurie
furono tanto in voga tutte le re lazi oni di
viaggi pubblicate ;l' miei giorni : \' engOlI() e-se
r icercate c lette con la maesima avidir, almeno
per qualche t empo, perch sono la censura
anzi cb la storia dei p opoli che si pretende
)
d an e ; e quando partite, non fanno come I
cont ad ini e gli alt ri operai cl' Iughiherra che
chit'do no q ualc he coea pe[' bere. - L' Ira-
Iiauo non chiede mai nulla, r ifiuta anzi ci
che gli i i vuol dar e , e brama che non lo
p r endiate pe r un uomo cii mendicare.
Il sig. Sh aep Oli SCJ'\'3 che il ter ritorio di
('oper to di poderi e .li villaggi le
CIII non sono farre di terra e di stoppia
come In Francia ed in Ingh ilterra , ma che
sono Iabb ri cete di pierr e e di man oni , e che
i vi sono agiati e assai beu vei l i ti. -
Se Il sig. Sha r p avee..e voluto pigliarei l' inco-
modo cii baderci , avrebbe veduto Ja ereeea
cosa nell e alite part i d' It alia, senza ecce r-
t uam e i. di Napol i e dr! Papa, - Il
no.st ro " lagglator e si dA. molta briga pe r iseo-
p rue q uale pOl ed eseere la r agione di questo
stat o florido dei contadi ni de lla Toscana e
. .
la loro opulenza come effetto
benefiz.] che hanno ricevuti dalla casa dei. AIe-
dic , anzich attr ibui rl o all a sua vera causa
voglio dire all a loro sobriet ed al loro
a more pel rravaglio ; e se queste non sono
l e ver e ca ule del loro aspetto opulento , bi -
segua crcdr-re che ciascun contadin o t oscano
abbia eredltaro un pod er e dal suo ant enato
il .quale ne :l' ..eese fa tt o I' ac q uist o so no i
rr gllo della famiglia de! Medici: 8UP-
che un po' IrOppOassurda,
S(" I nell a Toscana godono di lilla
cert a giatceaa , e se quel li del terri to rio de lla
Rt" pubblica di Genova banno dell e abuazioul
che li prender ebbero p er case di geut il uo..
, o GL ITALl A1.'il.
,
'::: APITOLO J. ! !
rollII, non debbo no questi vantaggi "che alla
Joro sobri et ed al loro amo re (Id la voro t
qualit che da eeel &011 0 ad ,un
incredibile. Arrivano a l!C' gno (li ta.ghar e 9
t1z
-
z.onrallht'lIle un maeev vi vo, coprirlu di ter ra,
portat a ral volra da luoghi assai lon talJi, e
pi antar vi "' iti , a fichi , o lcguml , il che ha
dato l uogo al pro\"Crbio che in India i con-
tadini m.angiano sassi. loro q ualche
vol ta di d ov er lavorare anche di nott e al
chiarore de lla Juua , nell e , iglle e ne' campi ,
mentre le loro do nne e i loro fi gl i sono i m-
mersi Del 500no. - La eteua COla bo io
veduta nel reano d' Aragona e nella Cara-
Ja Gna , e no:: per tauro Spagnuoli pas-
generalmente per intio ger di e dormi.
gliooi, almeno a (Iella dell a .. ,aggior parre
dei viaggiatori , eenza dubbio iuslrun i ed esa n i
cseer vato r al pari del sig. Sha rp,
CAPITOLO Il.
Dift:. UO f1' cseC'Uz.innr. detlc leggi.
P ell e per.slJnc maritate.
La tardir con la quale ne i tri bu nal i d' Ir a-
ha si or dinano i prol lS"j de' r ei , dic/IC' oc-
cee.one al llg:. Shar!, ci i fnre le pi odiose
t ifi . e-ioni sul gb\ e rno i rat iauo. Egli l'CI
v. ra ('hl' in It alia la puui zionr - nou 8('gUt' &1
tc-u. il d t>li tt u , C' c he, l u ll ClIlt' il Prcu.out e, O\"G
la gi ueuzia in caso di omici dio p iurtoeto.
CL' IULl .-na .
spcdi riva , pare che in ogll i altra parte si
n'Si troppa len tezza nell' esecuzione delle It' ggi :
in Venezia e in Roma un aeeasaino 110 11 viene
giudicare dcfuirivamente ee non dopo pifi
mesi <li prigionia.
Ma v' in ltaha un' invinci bile causa che
p u sottrar re alle volte un omi cida dal
p lizic ed la facil it <l i fugg.i re dal ter ri-
tor io ave ba com-nesso il deli rro.
Ognuno S3 che l'Italia di visa in pi princi-
p ati ; pn la qual cosa se un r eo trovasi in qual.
che di st anaa flal cent ro d'uno di essi ilei 010
... ment o ch e commette un delitto. pu preto giu-
gnere alle front iere e pa ssa re nello stato vicino,
Tutta la vi gil anza d e! magi!lt ra to pr r arrestare
il del inquente debb'ees-re in 3110r3 infrutt uosa,
D' alt ro nde un It aliano non si laeeia e
facilmente ar restare come un l ngl esf' ; tosto
ch' egli l' crm a!o che cadendo nelle mani
della giust izia sar impi ccat o o mandato in
ga lera, si lascia uccidere anzi. che renderai ,
e si d ifende d ill !H>rataml'n te fino alla mone. _
Si ebbe uh ima meut e in Inghilt erra un esempio
del furore it al iano. - I nolt re il popolo d' It alia,
per nn falso l'unto d' onore o per I1n mal int ese
principi o di umal,lit" , non darebbe il minimo
8 () CC0f80 agli uffi ciali della e ius tizia od agli
sbirri, I mag ist rali fono llunque obbligat i di
far i1I1If'SlIire i coll't' voli da una numerosa e
!len armata compagnia cii guardie a cava llo ,
11 che ri ch iede del tempo, e il malfa ttore
pa ssa le Iruntiere dello Srato a vanti l'be si
I l,os,sa . rnggi u
9
nerl o. Vr o che molti prin -
ell'l In I talia Ili rendono scambievol mente
cn n OLv Il.
. Ielinqucuti quando po ssono ar reetarl i . e
, , , l ' .funci l
i l conte Nogarola , il qua c craer n
l' I(>llIout e dopo ave re commesso omicidio
in Verona , fu a rrest ato presso ('
dato li Venezia ove venne glU&UZUHO. l\I a
l iflcllemlo\l i , uu uomo giudizi oso co nqacer
c he Ull tale espediente 110n pu essere molt o
eflcace contro queeto male in un pae se
come l'Italia costituito.
. l\ ('cadde una vol ta in Venezia che si ' t r o\' b
nn forua]o pre!lW un uomo che era stato
eriletrato ; il coltello era ancora Il,,1 eadavere ,
e il forua]o aveva in tasca nn fodero che
parna tatto lJer quel coltello : al
egli fu arrestato , ,npllIccato
beuch innocente in quell OUl ICldIO , I l
scoperllC roseo dopo. QUCjl O
di ede Iuc zo ad un uso che UUTO 111 ' CU(' ZI.3
pi e che arato belle il
coueervarlo s q uando 1 glull lC' erano per p,ro-
nunziare una sentenza d mor te , uu officiale
{Z,I idava loro: Riconku eci del , )Ol iera Fomoi o,
Da indi in poi , i gilldi ci in Venez.ia e n elle
a lt re parti , I("W Itali a sono difficilissimi sull e
p ro\'e che dcbbouc far co ndanuure qualcuno
a morte ; e fii qui WI!lCOnO le lunghe forma-
li l che si udoprano 1H' lIa fon naaione dc' pro-
cceai criminal i. - i for eerler! ordina-
ria mente sono fal"' ilissimi a cene urare t non
Il i C'urano d'ill foTmarsi delle cause che p ro
llu lI!lerO certe usanze , delle qual i heu ai co-
l JO l: CUIiO gl' iucouvenie uti . Il sig. Shurp vuole
rifl' I'ir ruuo ag li usi del I UO t"ssi sono
J;J norma di run e le sue decielcni, Tutto che
GL' ITALf.Ua .
non viene fatt o altrove come i n Inghilterra '
(laIla !l L13 r ara r; aga cit gi ud icato etol ro
e de teerabil e. Quest o modo di r agionare
proprio fii 1111 Inglese affezionato alla sua
patria : ma 11 0 n gli lU il dir itt o di pretendere
i l t ito lo di oeee r varore imparziale delle alt re
nazioni ; f> sebbene alcuni I taliani aieno ca-
p aci di tiare una pu gnalata Ol i loro r ivali od
a lle 10 m hel le , per un eccesso di gel osia , ci
non lo .1II luri zza 3 presentare i l minu to po-
p olo d'I talia come una t urba di uomini malvagi
e per verei , ,c-mpre pronti ad ammazzarsi .
Un' i nd lll31.IOlle coel lIullifei t d farebbe Sl1p-
por re 11 1;" 1 pop lOl o un ca ra t tere natural mente
cr ud ele I1I d , . allegr ia e la compassioue ,
q ' lalll domi uauu negl' It aliani, IIOli Ili accor-
p Uli to con questa pret esa crudelt,
Dietro la logica olt raggiosa del eig, Shar p ,
UII It al iano potrebbe a buon dritt o r iguar -
dar e il popolo inglese come un a t urba di
In- eud ar] , perch vede all e vol te ne' foglj
pubblici delle prome6se di ri compensa a
chiunqu e scol, ri r ..Ii a ut ori di lett ere ano...
. o
Olmi: scr itt e da ince udiarj. Qu aure amare ri fles-
sioni non avrebb' ..gli fatte su noi , se gli fosse
stato dett o in It a lia , che uua figlia aveva ,
come accadde in l ughiherra , avvelenato SIl O
uua nipot e 11110 zio , una moglie suo
mant o ? Se gl i avesser o raccont at o che q uauro
guardre clelia gius tizia avevano formato r or-
r ibile n-aura d. far giust iziare cinquanta o
sven tu ra ti per la lusinga fii ili) me-
echino guallllf7 11o, e che niunc di questi eeel...
lcra ti fu f'ltto mori r e da lla giustizia pubbl ica
CAPITOLO Il .
per mancan za d i lilla Icgge che
q uest o caso Con I Uft?
delitt i c mohl altri non meno or ri bil i SI co m-
mettono l' res..o le p i pul ite uaaion i ; f':
scr itt ori che att r ilmi"con o quest i fat ti
colar! al cara tt e re di. un a na1;i pn c",
debbou essere couside ran sto lti o c3lun lllaton.
II f!.ig. Sharp .. dopo .''''ere fi cng!iato
il comun po po lo i pi pungentt dardi di
maldicenza , non r iiparmia le per sone di stint e:
eee-ri ece clic iu It alia i costumi sono 3550 "'1
l urnmente co rro t t i , e che i due seu i eone i n'
p reda alla pi l or r ibile efcenatez za.
Il metodo del quale egli si ser ve per dar e
alle eue i mpoerure UII' appar enza di verl t , l'
assai malizioso. Egli cominci a ad a\' vertire i
"no i lett ori che per lo pa!l!lato in It alia le
donne era no Ir re prcnsi bi li ne lla condot ta e
nei costumi , e che i marit i erano gelc ei ;
ma che oggidl non ci sono donn e l una terrn
pi i mpud iche e pi di ssolute \Idlc It aliane ,
e che in Ita lia la parola gclo.sia di ventata
fuor i d' lISO.
l o lascicr ari nIt ri la cur a di esaminare
fine a qual punt o quest o bel prel ud io !li
accordi con le id ee de i filosofi 8 U l' or igine..
eui progrt'ssi e su gli effett i ddlf! nostre pali-
aioui : c 1I 0 1t cercht"l" di provare che l' a-
more e la gclol:l ia, a! pari di tutte le alt re
umane affezioni , eone ugu al ment e s p'lTl.\i fra i
mortali , c ch e Sii eflcr ri che Ile ri sultano,
so no unifonuemenre gli stceei U\'Ullll ue n-o-
vuuai uo mini. Vorrei pi uttost o dimostrare che
i lioni cd i ecrci non sono ll lioni, u scrci
.
IO GL' IHLUNl.
c he in certi paesi , e che In altri paesi SOIl O
gatt i o pipieuvlli ,
Secondo il llig. Shar p m Italia ncn c
donna moriuua che non abbia il suo cici-
.( 1) ,. [l dire C' h' ella ba un gi1uiue,
d CUI p ri ncipale impiego di disonorare suo
marito ; . e la signora ha (i i poco ri g. u.mlo ,
che a ness uno ignota la per sona ch' l' ssa
onora della lill a eceha e della s ua co rteeia.
.. I l cicisbeo. oltre a qucsta nobile uccu/Ja.
li. zione , obbligato di accompagnarla al-
F o pe ra, di se lle re con es..a tl3 eo!o il
Il sole nel palchett o , '" dev e i1l' pt-.ua
Ol. vetl.ut o dagli spett ato ri , perch i re.nri in
.. Italia eone male illuminat i. Dopo l' -opt'ca,
.. la conduce al caeiuo di lei , e vi r uunn-
.. gall o volte rutt a la notte soli, 1I0n
.. tralasciand o alla manina (Ii recars i alla
fl; mes sa pri ma (li srpararsi. )I l ' 3il110 U l l ol
sta nza (..I ) presa ili affitto Jlcr 1.111 intero
I
CAPITOLO II. 1"
I
ann o (il si gnor Shar p si -d i
a: di rci se dal cicisbeo o dalla elgno ra ).;
Il: in l uogo d ist ant e dall' abitazione .delle
signora , ed per C 81i1a e r ei suo .e ci-
sbeo un asilo inviolabile : lo ' p080 non
vi si a vvicina gia mmai , Un mari t a che
foss e abbas tanza mala ccorto Ili voler t ur-
e: ba re i nostri amanti , passerebbe gencral-
mente per un uomo senza esperi enza di
mondo, c ili (u n i i crocchj dove compa-
a: risse, sa rebbe l"uggett o delle pi ll pungen ti
a: beffe. In Italia cosa ta nto r i ticola per
. gli sposi il trovarsi insieme , che non vi
Il: esempio di simile fenomeno. Se una gen-
<l rildonna volesse proporsi di conservare :1
.. suo la fedel t conjugale, e stare
.. c!clsbeo , ella sarebbe obbligata di
vrvc re II) casa sila come i n una solit udine ;.
uiuu' altra gentildo lUu vorrebbe moet rnrei
in pubblico con lei. -- La re pubblica dl
Venezia una secon da Cipro, ave ambi i
sessi di ogni stato si co nsacrano a Vcnere,
a: Quivl i parenti hanno pochissi mo affetto
pc' loro figli : i maschi vengono coneide-
a: rar i .come 6glil1oli della repubbl ica , e le
a: fanci ulle rucch iudonai di bonieehu' ora nei
dove i lor o gc niwr i li visitano
III o . mai. -- I . cici sbei sono in part e
schiavi e III par te tiranni dell e loro ei-
GI: g!l?re! e le signore so uo gelOllC de' loro
qU,anto in altri paesi de'l oro s posi.
Gt No n 61 puo a meno di r idere vedendo an-
a: dare <1.\ nomini Ilei pii'! grave ca -
rr. r attere , e tah che pctrehbono ca dere in
B areu,
18 CLlTALU J:<; I.
tt sospetto l,i cl ' ipocri sia, fIi eupcretizioue
CI; e di fanati smo , che di galanteria )l .
Pare che un au rore dopo una s ecanda-
le sa descri zione (Ielle usanze e dei costumi
d i un paese, do vrebbe cessar e per tema di
essere tenuto per un calunniat ore ubbr iaco ,
anche i pi creduli ; ma il sig. Shcr p
ben lourcno di avere eiffat ro timore, troppo
vile per lui , e continua COli una
assa i pi l'l sfacciata, Egli ha al t res l' a udacia
di protes tare nel solenne modo che le
flu e asserzioni sono da tener si per vere ,
slllt onor suo J poic!l t'gli parla sopra buoni
f ondamenti J c 11M mosso da UIl O spirito di
maldicenza .
Un affetto tenero e- scamb ievole gli
te 'posi nel clima d' Italia una p assione
.: igno ta. Gli uo mini e le donne si uniscon o
c i n mat rimonio senza la minima pa et ioipa-
c zione per loro parte , e di rado eaiandi o
Cl int er viene che le p ar ti interessate si co-
c noscauo p rima di epoears i. La fanciulla
e: in lUI convento , ove il pi delle vol te non
Cl vede il suo futu ro SpOl>O , e da dove c11.1
o: non es ce se non che il giorno della cc-
o: Ichruzione de l rnatr itnonio. L' uso abbomi...
t'( nevole e infernale di prendere al 5 UO ser-
e: vlelo , par tendo dali' al ta re , un cici sbeo
Cl: (s' intende per tutta r Italia ) , estingue fra
li: gli sposi ogni t enero sent i mento. I figli
c Ilen ' oli o poco a mantenere l'amicizia e
li'. l' a rmonia ilei matrimoni o, perch lo spos o,
o: inti mamente per suaso dell' att accamento
Go J clla S UI' sposa p er un amante , non p u
,
CAPITOLO U. 1 9
ave r amo l'e p er essa pc' Ggli .
o: Le fanciu lle non compaJono mal ali alcun
c; eon vlro , giacche ili la loro inno-
l( ce ns a e viva cit un pIacer e rotalmeu te
O( sconosciuto o negletto. Un mari to ce r to
Cl, che i l primogenito appaeriene a l ui "5 01 0 ,
nasca nel pri mo 0311110 suo
4: matrimoni o. Se la met delle gentl ldo lllle
marit ate non volesse cicisbei o vives se con
.. essi in modo innocent e. l' altra mcd le
o: disp rezzerebbe. Ho vell uto io stesso a Na-
Il poli (dove egli non mai casa
,( ct alcun gentiluom? . o prioatc }
l( e du chesse col CICI..beo a l fianco vrsuare
a; i loro amici se nza dars i il mini mo pensiero,
<I Se i nvi ta te cinque gentililonne a pranzo ,
bisogna far mettere dicci pOMte .,
ot ciascuna genti ldonna mena ecco I l SIlO CI_
I,( cisbeo. La natura ci el cli ma r ende gli uo-
l( mini s naturalmente vol ubili ( questo glielo
.. avr detto qualche autorCi-'Ole uapoetano, f orse
lIt gran macreoogista }, che pochi mesi di ma-
Il trimonio ba st ano per cstine ucre le Gamme
o .
l( del l' imeneo. Egli dunque neceeaano pcr
Cl: le po"ere do nne d i ave re de' cicisbei al
.. lor o eerviaio. La distinzion e del bene e
<;( del male 1 le idee di innocenza , di de-
coro . di castit 8 011 0 appena not e in I talia.
In Fi r enze le ge ntildo nne huun o genera l-
" mente t re cicis bei p er ciascuna : il primo
il cicisbeo d' onore; il secondo quell o
({ incat i.t:at o Ili raccogliere i guanti Il a " Cl1:
" t a nlio, se nvvie ue che cadano da lle mam
" cl elIa signora ; i l t er zo il cicisbeo so-
" sU1IJ1.i,l!e ,
2.0 Ct.'l TALU Ni ,
\Ii sa r ei gr:lIl delllcnte
temer it di Cj ueMt:" o5sen'37. IOOl se UOII
stato infor mato della sorge nte nell a quale Il
sig. Sb arp aveva attinto eiffartc
che l' oracolo cii' egli consul ta va 5 111 coetunu
e f ll le usanze d' Jtalin , era nn gahnue scr-
vitore per nome Anto nio, ch' egli ave va
:\1 suo eer vixio in Napoli. 1\13 come os mar
llrcsulllcrc Il sig. eh" egl,i
derebbe t utta l' Illgluhcrra che v III Eu-
r op a un ,"35tO j
cbc le loro mogli , subito Il matri mo-
nio li disonorino nel pi infame mod o ?
che 'convinti del loro disonore, ma
rentl su q u('st o punt o , cont i nui no n
sotto lo steeeo l etto con le loro dorme e COI
lor o figli , senza amore per le uue , n af-
fetto per gli altri ? .
Gli sposi in Italia non hanno Ietti
rat i , nuc he nei. pi caldi mes i dell ' :
ci not o ad ognuno, Come dunque Il s Ig.
Sha rp p Ol spera re di far credere i ID3:
ric i ri CC\' IUl O nei loro letti le propn e mogl i
uscit e (bile mani della proarituaionc ? che le
donne , t osto dopo il matrimonio , s i abban-
donino a tutti gli eccessi (Iell a dissolutezza ?
e ci in Ull paese ave le ment i 6011 0, se.
condo lui, ,wggiogate dalla superstizione , e
110\'c le fan ciulle, mceee ne' conventi nell a
. 01"0 pi tenera gio vi uez za , vengo no
in tutte le prat iche c con tutt i i sent iment i
c he pu "inepirnre la religione? Come ! dopo
una simi le cducazio ne , uscendo da l con-
vento, non s i troverebbe pl in esse verun
C.UITOLO II.
pri ncipio el i r eligi one ? in es..e .che dai
I
li tene ri a nni fino alla maturi t mnrrun o-
.
niale no u hanno ':l p p l' l' 11 0 n
Non vi sarebbe n ti more , Il(l .H' rgogna ,
n modest ia u eontiuenaa in uu sesso
per natu ra . tim.illo , modesto
c conti ucnte ? e non ' "I 81 ved rebbe n
u collera, n il minimo r isen:
rimemo IIcgli uomi ni la ha. fatti
tanto audaci ir,a seiLtl l , COIlUI CI , IInpe-
tuosi ? D..1 t;n lato il pill sfrenato Jlber ri-
naggio , e alt ro una int iera e perfetta
itpatia ? e CIO III un paese Canto not o pe!
carattere focoso e per l' ardente fanr aela
suoi abi rauri ? E il sig. Sharp r-it iene che. e
un fen omeno il cedervi due epos!
ineierne in pubblco ? e quelle fenuniue (tu:
sol ute c redcrehbon ai dieouorate rrovandosl
i n compagnia di una Se
q uceri nou sono i vaueggramen u (11 no ser ve
o i l . r "
di pi azza, a ch i deeei d u,ulue arm Hm I
"' la oser dimaudare al sig. Sbarp se cale
,.
l' or dine comune c1c1 b nat ur a , o Ile S,I
nomini e le donne in It alia 50no di specie
differente (Ii q uelli degl i alt l"i pat'lli? S' egli
vuole servirsi Il ella sua r agione , mi r iepou-
dcr certament e che l a natura dappel"lutt o
uniforme e che in Italia gli uomi ni non
sono div;rsi di quelli degli alcri .c1 imi. 1\l a
se sono di eguale spec ie, perch Iill conducon
essi tutt' alr ti me nti ilei matr imonio , che
il pi i mpo rtante affar e della vita? i n Ull
affare che pi di ogni alt ro int eressa alla
gener alit degli eeeer t uma ui ? Oser
il sig. Sba rp l'Ile il clima rende i ma-
J ili meostauti ? l' la non vede ella . sig. filo-
sofo bri tauuicc , che 11011 v' cosa p il'l
surda Il i att rib uir e al clima il poter e"(li r en-
dccc st upi di gli uomini? ch e lo stesso 8UO
servo el i piazza arrossirebbe di essere accu-
lato <l i UII sI st ol te n1g,io na mcllt o SII bila.
tura umana ? Ma se il cl ima fa degl' I taliani
tanti eutomat l , e se le loro affezion i cd
azion i sa n regolate dal clima, e non da loro
etcesi , pecchi: dipi osu li sot to un el odioso
aspetto, e tentare ogni mezzo di fende rli
sprl"gf'\' oli agli occhi de' comparriorrl di lei ?
Se 1I 0n pe r elezio ne , ma irresis t ibi lmente ,
che (Ii.. dissolut i e lDalvagi, qual r im-
! JfOHfO 81 pu far loro ?
lo faci lmen te che in I nghil terra
la generali t delle donne si conduce COli
ci rco.spezione e r itenntezzn che quelle
cl [ tulia r vogli o crede re che n i l teat ro del-
l' Opern , n quello della comme dia , I l il
Rcnclagh , n i l Vauxbal l n l' assemblea
(l' Almak, n q uelle clelia 's i17llora Corncl y
non il minimo pregiudizio alla virt
p ura e lIIll'gra delle geurildo nne ing!t'si ; con.
verr Ilurc che Venezia , in parti colar e ,
un". citt multo pi l corrotta, in punto di
cest it che Lond ra ; e che in Venez.ia (lei
P?ri che in al cune alt re grandi ci tt dell'I talia ,
VI sono d elle do uue I q ualit le quali non
fanno alc un con to del ln decenza , e si ab-
bandonnuo alla pi vergognosa !H' lle. t;mzionc,
nemmen o pl' t1l'11UI' a copri r e la lo r o
disoucsr col velo dei mi erer o ; ma facendo
CAPi ToLO II. 25
questa eoufessione al Shar p , dcc anche
esso con cedermi che lJleSSC donne le
q uali in si sono rese . c c-
C'Il i della ragione e <I ella r cli gioue-, pou ono
esser e facilmente nominate; c che q uesta
pceeibilit di uominarle most ra e" identelucllte
che la classe di queste donne noli Il,ume-
r osa. Egli dcc eai andio confessare che Il ?u-
mero di quelle le quali in quest c ci u
con ser vano una ripll tazione Inconeau nn ata ,
bastantement e consi der abile per far Suar .
l' are le sue ac cus e generali come UII am-
masso di spregevoli calunnie. E cl' altronde
per .ll uanto eicn c corrotti i ccsuuni di un
picciol numer o di donne ( o di molt e , se
vuole il sig. Sha rp ) iII alcune delle gralH.h
ciu d'Italia, egli almeno cosa ce r ta che
nell e citt A piccole esse non sono u migli ori,
n peggiori che nelle altre pi ccole citt dci-
l'Europa , a ve la mancan za di occaaic ui
" iziose , la rarir de' ca tti vi es empj , il
ti more della maldi cenza, e cento alt r i mc-
ti vi d i maggior con side ra zione teo gollo i n
dove re le donne.
Se il eig. Sharp fosse stato capace Ili fare
queste r iflession i , si sarebbe accor te che il
carattere di. una numerosa nazione n oli di-
pende da alcune per son e spa rlic in ci nque o
sei grandi citt , ma che se ne dee giudicare
sop ra molti mi lioni d'uomini spt"\rsi in du-
gellto o trecento piccole cirr e ne" loro
territori . S' egli avesse detto che la mie
tildouua in Venezic , la tal princi pcsea in Na-
poli disringuonei gener almente per la loro
";'L' I TALIA NI .
malu condo tt a , o pcr Ja di eeolurczza de' loro
mi a\"rt"bbc tr ovato d' accordo ecu
l ui. Ala Cj l1un.! o fa \I l:'O d i ter mini colletti vi;
quando dic e : le gentildonne veneziane le gen-
tiktonne napoletane, le gentildonne {wrmtine. c
ci che pcggio , L E GE2\' T UDONNE I T,A-
Ll A N E , egli mi p ermetter di dir gli che
un i mpostore c l UI cal unniatore.
lo vor rei saper e chi sono i rnallevadori
.sig. Sharp quauri' egli che gl' h a-
liani 1I0n portano affezione a loro figli Que-
8t' accusa . ch' egli 1I0n si cu ra (Ii pro'"ar e,
COlitra natura , e non ei combiua coi
cost umi fii un popolo il CIIi cara ttere, do-
minante l' umore c la sensibilit. _ E Bur-
ner ( I) el ice che gl' It aliani hanno pc' 101"0
.fi gli un ' affezione che ign ota ali' altre na-
. . ossCf.vazione certa ureute gi u-
J1 ZI Olll &5IUl3, perci occh se gl' It aliani mer i-
t ane qualche r illlprovl'fO a qu esto ri ... uardo ,
s i di a vere un eccceeivo affetto loro
figli. III Ycneei e , che la ci tt la pi cor-
r otta di t utt a It alia , i padri c le madri ,
le eteeeo p ersone pil' dis tinte fanno pas- "
( I ) Gilbcr lo Bl.lr?et , veseovc di Il prt'-
ce rtcre del duca d i Clocesrer , nel 1643 in
};dimbur.go. Egli. ua considerato in Inghilterra come
Bouu et In Fr anCI a ; ma lo Sccer ese aVl':va meno genio
del francese . meno condona e meno DlOderazi"ne e
saviezza.. - Burnet nel 1715, lasciando ruelte
op ere d. storia l'i (li ccrurover sia e la tel azi,",.e el
suo 'tiaggio uell a Svieeera e nell' Itali
i l
JI SIIO odio
contro fa chiesa r omana ha di sono..aeo l a r l"rma e le
opere di. lui. ( Nota del T rad. )
,
CAPITOLO U.
if"p;gi are sulla p iazza di Sa n Marco lo'l?
figli , estili (la useari , (fa euh aue , da Pihtofl.
da pasLOrell e , c ne din-c st rnno COl1lpw,t'nza:
il ehe il sig. Sharp sa , e 11 011 ,\ Ia
realasciare (li farne Ct'1I 1l0; ma era sua uuen-
aioue di render e odiosi gl' I taliani. Ed- con
questa il1 r,CIIZi? l1 e cl..' <'gli
(li asser ire che m I talia gh 6 1' 0 10 1 non 9 1 sono
veduti dUI" volt e ava nti le loro lIozze. lllCII
trecb nella ste ssa Vt'llI'zia v' l' 11S0 gc nc-
r nl urer ne sra bil u o , anche Ira i pri ncipal i no-
b ili , di differire di pi mes i , e qualche
d i un iut iero a nno UII ma trimonio 8t311111tO,
affiucb i giovani amanti possano concepir.c
amore r uno prr l' altro. poco pr!.
ma dt'"1I' a rr ivo dci sig. S hurp In Ye nezin Il
manimonio progt'uaw della daOl igd t t Bai ba-
r igo e del tl cI procuralOl"e Zco , . due
delle p i cos p icue f.lmiglie (Ii (l'Ie lla rc pu b-
b hc a , e rasi r otto ; hencb le par l i fosse ro
p romesse gil da pi di un cu uc e
gi farri i preparativi (Ielle nozzc ; e (luesta
r ott ura 1I 0n ebbe alt r a ca usa se IIllII l' avve r-
sione che concep la damigella pel giovine il
q ual e aveva ce ssato di fasl e la corre con la
solita regolar it gioi naliera. fatt o c
cent' altri eimili avrebbero dovuto meegnare
al 6ig. Sharp c he i mar itaggi ccnrraeva uel iII
Iralu come nel le altre pani Europa : nella
nobilt per fare una s plendida alleanza \ o per
mir e d' interesse, e nel popolo . come m In -
ghiltcern , per ben accompagnar si.
^
ABD-EL-KADEK
SBALZA
.^
I
CICISBEI
ESTRATTO DAL FASCICOLO DI SETTEMBRE I9IO
Rivista d'Italia
ROMA
PIAZZA CAVOUR
Roma
Tipoftrafia dell' Uniotie Kdltrice. via Federico Cesi 45-
I CICISBEI
NELLA. VITA E NELIA LETTERATURA DEL SETTECENTO
(NUOVI CONTRIBUTI).
Il Settecento fu in tutta Europa, e in Italia pi che altrove,
il secolo della galanteria. Il costume leggero di quella societ
incipriata, la quale sulla china dei facili amori e degli spassi
geniali si avvicinava inconscia a quella terribile catastrofe che fu
la Rivoluzione, ci rivelato, oltre che dalle numerose testimo-
nianze storiche, dalle pi varie manifestazioni dell'arte e della
letteratura. La poesia che meglio fiori in quel tempo, e vi trov
pi sicuro favore e pi intimo consenso, fu quella erotica: pro-
cedendo dal platonismo non sincero della rinata imitazione pe-
trarchesca, dall'apparente ingenuit del costume pastorale, dalla
prima espressione dell'Arcadia
canzoni e sonetti e madrigali
a centinaia, a migliaia
essa va sdrucciolando per la via galante
e licenziosa bene spesso, che le dischiude con gli altri anacreontici
il Frugoni, e di cui non proprio una deviazione quella, a capo
della quale sta, maestro di lubricit, l'abate che di casto ebbe
solo il nome. Le scene del costume settecentesco ci sorridono
anche oggi nei vivaci colori delle ceramiche di Sassonia, nelle
pitture di scuola francese, che le stampe incise riprodussero a
migliaia per tutta Europa. Il Watteau col suo capolavoro VEm-
barquement pour Cythre ci dava la pi idealmente vera figura-
zione del suo secolo, e negli altri suoi quadri erotici egli ne
compiva il ritratto. Il Boucher, mentre dipingeva, nell'et della
Marchesa di Pompadour, l'idillio pastorale, dando alle sue pasto-
relle i tratti gentili e le pose molli delle dame e ai pastori i
lineamenti fini dei cavalieri, dalla mitologia traeva soggetti di
pi ardente sensualit; e il Fragonard, spesso licenzioso, denu-
dava la bellezza muliebre, la collocava audacemente in mezzo al
lusso voluttuoso dell'alcova, le offriva gli atteggiamenti pi pro-
vocanti. L'amore, di cui quella societ parve pi d'ogni altra
sentir il fascino sottile e tonace, la tirannia forte e soave, si
I CICISBEI
185
esprimeva
simbolicamente in quegl' infiniti Amorini, paffuti bam-
binelli dallo sguardo ridente e leggermente malizioso, che scher-
zano nelle poesie, e sciamano dalla fantasia degli artisti nei
quadri,
negli affreschi delle camere, nelle soprapporte, nelle de-
corazioni dei mobili, sui paraventi, sui parafochi, nei ventagli,
nelle incisioni dei libri
;
e si ripetono, trasmutandosi in angeli,
negli stucchi delle chiese. La musica, con la dolce armonia delle
sue arie, accompagnava in molle ritmo le tenui favole sentimen-
tali che s'intrecciavano cos frequenti in quella societ innamo-
rata, essendone attori le giovani dame e gli attillati cici.sbei.
Alla storia, del costume italiano del Settecento, per quel che
riguarda i cicisbei, il miglior contributo fu dato, son gi molti
anni, da Achille Neri,
i
ricercatore diligente di quelle che ai
facili improvvisatori sembrano minuterie erudite, mentre sono,
nel loro complesso, parte integrante della storia, tanto pi no-
tevoli, quando illustrino il costume d'un* et tosi importante,
come il secolo dell'Arcadia e della Rivoluzione. Dopo il Neri,
che non volle, e poteva, darci la f^toria compiuta dei cicisbei,
si ebbero altri contributi, pi o meno importanti, per opera di
diversi ricercatori; ma in realt, dopo il Cant e dopo il Neri.
molto pi ricco d'informazioni, e il Malamani che s'occup par-
ticolarmente di Venezia, non possiam dire che si sian rintrac-
ciate molte testimonianze nuove intorno al cicisbeismo: si sono
invece ripetute senza troppe aggiunte le notizie raccolte dai primi
indagatori.
2
'
Achille Neri. / Cicisbei a Genova (in Costumanze e sollazzi, Ge-
nova, 18S8, pag. 117 e segg
'. Il nome cicisbeo, d'etimologia incerta, si trova
usato la prima volta da Cesare Caporali
1531-ltiOl), in un'apostrofe citata
dal Neri (pag. 125):
cicisbei ! Di quanto mal cagione
In ogni etade foste, in ogni loco!
>.
(Caporali, liime, Perugia, iTTo, j.ag. UH . Nel Settecento a questo particolar
costume della nostra vita, di cui eran protagonisti i cavalieri serventi
o
cicisbei, e le cicisbea, i patiti e le patiti-, le pariades de pigeons > lome le
diceva l'arguto presidente De Brosses, si diedero i nomi poco armoniosi
di
cicisbeato e galanteo.
'
C. Canti-, L'ab. Panni e la Lombardia nel secolo passato,
Milano, I80J.
pag. 119 e segg.; E. De Mmuhi, Lettere e letterati italiani nel secolo
xvin.
186
I CICISBEI
Eppure la letteratura del secolo xviii oiFre in gran numero
altri documenti intorno ai cicisbei, che nella societ d'allora
ebbero un'importanza ed esercitarono un influsso quale noi pos-
siamo appena intravvedere nelle opere che mirarono a satireg-
giarli e a combatterli. Se essi non sono una degenerazione dei
cavalieri antiqui
, come fu detto, certo li sostituiscono nella
servit verso la donna
;
ed il galanteo pu dirsi l'istituzione
che succedette alla cavalleria, quand'essa decadde nel traviamento
del Seicento, che anche nelle relazioni tra uomini e donne so-
stitu la smanceria alla cortesia, l'umiliazione servile alla devo-
zione signorilmente dignitosa.
Se la galanteria fu nel 700 propria di quasi tutta
1'
Europa,
'
il cicisbeismo costumanza propria dell'Italia: troppi stranieri,
venuti da noi in quel secolo, l'aifermarono, perch possiamo so-
stenere il contrario. Il cicisbeismo fu pur troppo italiano, seb-
Milano, 1882, pag. 815-21
;
G. Carducci, Storia del (riorno (nelle sue Opere, XIW
pag 43 segg
i
;
V. Malamani, // Settecento a Venezia : I, Satira del costume,
2"
ediz., Tt)rino, Roux e G., 1891, pag. 89 segg.
;
G. B. Gerini, // cicisheiftmo
ritratto da Paolo Mattia Doria (nel Giornale stor. di letter. italiana, XXXIV,
460-3), con alcuni particolari tratti dall'opera del Doria, flettere e ragiona-
menti varii, Perugia, 1741 (voi. II, P. I.'
;
C. Zacchetti, // Ricx^iardetto
di N. Forteguerri, P. II, Torino, Paravia, 1899, pag. 33-39. Nessun valore
hii un opuscoletto di C. Ronconi, Il Parini e la societ incipriata, Torino,
Scioldo, 1903; scarsa novit, se ne togli alcuni passi curiosi tratti ilalle
Ijettere critiche, giocose e morali del co. Agostino Costantini (Venezia, Bas-
saglia, 1751), contiene un articolo di Antonio Marenduzzo, / cicisbei nel
Settecento inella Rivista d' Italia, agosto 1905, pag. H71
82), che si giova spe-
cialmente dello studio del Neri e di un articoletto di Pompeo Moi.menti,
/ cicisbei a Venezia inella Passegna Nazionale, IH gennaio 1901, pag. 19S-201I.
Mantiene poco le promesse del titolo lo studio di Antonio Fortina, // cici-
stmsmo con riguardo speciale ni <i
Giorno di G. Parini e alla satira con-
temporanea al Parini, Arona, Brusa, 1906. Qualche notizia sui cicisbei d
anche Adolfo Sassi, // <
degno amore di V. Alfieri (nella Nuox^a Antologia,
1 settembre
19<^3
. Ricordinsi amora Moroni, Minnetti, Roma, Voghera. 1880,
e RoGOERit, // 1<I0 galante, Milano, dalli Oniodei e Guindani, 189(5. Altri
scritti sul nostro argomento saranno ricordati pi avanti.
'
Cfr. per la sola societ francese E. et .1. de Goncourt, IjU f'etnme mi
dir huitime siede, Nouv. dition, Paris, Charpentier, 1882, dov' un capitolo
sulPamore; e anche l'altra splendida opera degli stessi su Madame de Pom-
padour, Nouv. dition, Paris, Firmin Didot et C.ie, 1888. (guanti soggetti
la vita galante effeminata e amorosa offrisse in quel tempo all'arte francese
pu vedere chiunque sfogli un catalogo delle stampe che essa is])ir a cen-
tinaia (cfr. Gustave Bourc^ard, Dessins, gouaches, estampes et tableaux du
di.r- fi nitienw sii'cle, Paris, Damascne Morgand, lH93i: in esse assai spesso
la galanteria sdruc-.cicla nella liiliricit.
1 CICISBEI
187
bene avesse stretta parentela con la galanteria francese e inglese
e austriaca del secolo xviii: e per schiettamente italiano il
Giorno del Parini, come schiettamente inglese il Riccio rapito
del Pope, che tanta fortuna di traduzioni ebbe in Italia, sebbene
una indiscutibile affinit d' inspirazione li ravvicini, nonostante
la diversa virt degl'intenti. 11 cicisbeismo invase tutta la nostra
vita del 700,
oltre che sul serio, anche per burla. Ferdinando (ia-
liani, il quale defin l'amore un punto di mezzo tra l'amicizia e
la libidine , e scrisse, in francese, un dialogo poco notevole sulle
donne, nel 1750 fece un'orazione sui cicisbei, per lodare un giuoco
che in quel secolo si usava il primo d'ogni anno nelle societ
galanti
.i
Ecco come ce lo descrive l'editore degli Opuscoli del
Galiani (1825). Si sorteggiavano i cicisbei e le cicisbee, che il
capriccio della sorte, e spesso la malizia di chi dirigeva il giuoco,
obbligava a curiosi appaiamenti.
Si riponevano a tale oggetto
in un'urna egual numero di nomi di persone d'ambo i sessi, che
trovavansi presenti, apponendo ad ogni cartella un analogo motto
talvolta derisorio, e tal'altra atto a seminare amorose discordie; n
siometteva di porre in opra ogni frode per far s che le coppie
si componessero da persone comunemente conosciute per reci-
proca antipatia. Dovendo quindi per obbligo il cicisbeo danzare
con la dama che gli era toccata in sorte, corteggiarla durante
la serata, e presentarle un qualche donativo, mille intrighi e mille
gelosie vi avevan luogo, soggetti di riso e d'allegria . Chi abbia
sfogliato le curiose raccolte di giuochi senesi del secolo xvi, ri-
conoscer con noi che questo giuoco settecentesco del sorteggio
de' cicisbei ha parentela d'invenzione con alcuni di quelli ele-
ganti e vari del nostro squisito Rinascimento.
Il cavalier servente fu proprio di tutta Italia, sebbene nelle
varie citt cambiasse un po' aspetto e costume, secondo il di-
verso modo di vita de' vari centri italiani. Teneva il primato
del cicisbeismo Genova,
-
tra le citt italiane ritenuta, a torto
'
Ferdinando Gauani, Opuscoli, Napoli, 182
>,
4"
0;^ i^c .lo.
-
Per il cicisbeismo a Genova in particolare, vedi Neri, Op. cit., cap. II
e IV. 11 Neri nel cap. II tratta diffusamente della corruzione a Genova nel 5<X),
donde la citt Ligur.' ritrasse quella fama non buona che le rimase anche
dopo; ma torse le testimonianze, a cui si attiene, di comici e trattatisti del
secolo XVI, sono esagerate: e ad ogni modo gli studiosi del costume sanno
che Venezia e Roma, in quel secolo, erano anche pi corrotte di Genova.
Per il Settecento ricordo che mons. Nicol Forte.t;uerri. in Arcadia Nidalmo
Tiseo, lod le belle dame genovesi in una lunga anacreontica poliiiietra
j^gg
I
CICISBEI
o a
ragione,
la pi
proclive
agli amori, come
Venezia era il
centro
internazionale
degli
amori
venali. Facciamo
un rapido
giro per le
principali
citt
d'Italia,
alla ricerca dei nostri eroi.
Ci
accompagner,
amabilissima
guida, il piccolo
presidente
Charles
De
Brosses
(1709-1777,
che
viaggi
l'Italia negli anni
1739-40.
e dei
nostri
costumi
fu
osservatore
argutissimo e acuto, e te cui
Lettres
famiUres
non
sono
ancora
state messe a
profitto inte-
ramente
per ci che
riguarda
i cicisbei.
Veramente
curiose
sono
le
informazioni
che egli ci d sui
cicisbei
genovesi:
Que
penser
des
abbs
et des
petits-matres,
cent fois plus
agrables
et plus
papillons
auprs
des
femmes
qu'en
FranceV
Nous voyons ici une
chose
singulire
a nos
yeux;
une
femme
tete
tte avec un
homme
aux
spectacles,
aux
promenades,
en chaise. La
premiere
fois que l'aliai
la
comdie, j'y
vis,
ma grande
surprise.
un
jeune
homme
et une
jeune
femme
fort jolie
entrer
ensemble
dans une loge
;
ils v
coutrent
un acte ou deux en
caquetant
avec assez de
vivacit ;
aprs quoi ils se
drobrent
la vue du
spectacle et des
spectateurs,
entirant
sur eux des
rideaux
de
taffetas
vert
qui
fermaient
le
devant de la loge; ce n'est pas
qu'ils
voulussent
prendre ici leur camp de
bataiUe
pour rien de
secret,
qu'ils ne
faisaient
peut-tre pas
mme chez eux;
aussi
personne
que moi ne fut-il choqu
de cette
aventure.
A
Paris,
la
dcence est aussi
grande dans les
usages
que
Tindcence
1
est
dans les
moeurs.
Ici c'est
peut-tre
le
contraire
.i
Quest'ultimo
contronto
torna in eerto
modo ad onore
degl'Italiani,
per quanto
il
peut-tre
del
piccolo
presidente
nasconda il veleno
del suo
mondano
scetticismo.
Il
cicisbeismo
era in fiore
anche a Milano,
sebbene il De
Brosses ce ne lasci
soltanto
breve
memoria
:
Les
femmes ne vont
gure
avec les
femmes
;
mais on
voit
souvent
une femme
avec un ou
plusiem-s
hommes, du
nombre
desquels
le mari
n'est jamais
.-^
Ognun sa che
specialmente
contro i ci-
cisbei
milanesi
il Parini
avvent
gli strali del Giorno, ^ e noi ve-
, nelle Rime degli
Arcadi,
Roma, De Rossi. 1718, II, pag. 314 e segg. e che il
Frugoni in una
canzonetta
si trattenne a
parlare delle
conversazimn
degli
abbigliamenti e dei
divertimenti
delle sue
concittadine
genovesi (v. C. 1.
t ri
-
GONI, Poesie,
Parma,
Bodoni,
ITTU. VI. 454 e segg. .
^
.
Ch De
Bkosses,
Lettres
familires,
Paris, 18-08, 1,
pag.
Hb. Citiamo
sempre da questa
edizione, non
avendo
avuto agio di vedere
l'ultima la o :
Paris,
Perrin,
1904. Per
l'aneddoto
narrato dal De
Brosses. ctr.
Parisi, Mat-
tino, V. 877 e segg).
-
T>K Brosses,
Lettres faviiiH'.res,
I, l'>8.
=>
Non sar inutile
richiamar i versi del Parini, in cui si
accenna
ai
I CICISBEI 189
dremo pi oltre che gi sul finir del Seicento lo spirito timorato
di Carlo Maria Maggi insorgeva contro il costume dei cavalieri
serventi.
A Venezia le cose procedevano anche peggio. Il De Brosses
ci d una ben strana narrazione del costume delle famiglie pa-
trizie, e del modo con cui esse si assicuravano la discendenza
del sangue attraverso i magnanimi lombi . Ds qu'une fille,
entre nobles, esi: promise, elle met une masque, et personne ne
la voit plus que son futur, ou ceux qui il le permet, ce qui est
fort rare. En se mariant, elle devient un meubl de communaut
pour tonte la famille, chose assez bien imagine, puisque cela
supprime l'embarras de la prcaution, et que l'on est sur d'avoir
des hritiers du sang. C'est souvent l'apanage du cadet de porter
le nom de mari; mais, outre cela, il est de regie qu'il 3' ait n_
amant
;
ce serait mme une espce de dshonneur une femme
si elle n'avait pas un homme publiquement sur son compte.^
Quest'ultimo doveva esser naturalmente un nobile. Non bastava
adunque il concorso di tutto l'elemento virile della casa
;
ma si
richiedeva anche l'amante, o meglio il cicisbeo, quello di cui si
faceva spesso il nome nel contratto nuziale. Del resto il De Brosses,
dopo quelle piccole accuse contro le dame veneziane, mitigava
i sospetti, che la presenza d'un cavalier servente potrebbe far
sorgere, con quest'altra informazione che ha valore per la fonte
da cui gli proveniva: Il faut cependant rendre justice la verit;
notre ambassadeur me disait, l'autre jour, qu'il ne connaissait
pas plus d'une cinquantaine de femmes de qualit qui couchassent
avec leurs amants. Le reste est retenu par la dvotion. Les
confesseurs ont trait avec elles, qu'elles s'abstiendraient de l'ar-
ticle essentiel
;
moyennant quoi, ils leur font bon marche du reste
tout aussi loin qu'il puisse s'tendre .
legami stabilitisi fra il giovin signore e la sua cicisbea ^ Mattino,
vv. B9 e segg.):
< Tu volgi intanto
A' versi miei l'orecchio, et odi or quale
Cura al mattin tu debbi aver di lei,
Che spontanea o pregata a te donossi
Per tua Dama quel di lieto che a fida
Carta, non senza testimonj, furo
A vicenda commessi i patti santi,
E le condizion del caro nodo.
'
Dk Brosses, I, pag. 175.
-
De Brosses, I, pag. 176. Il De Brosses dice che a Venezia, dove il
numero delle cortigiane era il doppio di quelle di Parigi, sulla piazza di
190
I CICISBEI
N gl'intrighi veneziani si ordivano solo nei palazzi e nelle gon-
dole, a teatro o nei ridotti
;
ma anche nei monasteri. Le monache
veneziane del Settecento non diiFerivan molto da quelle del Cin-
quecento e del Seicento, che tante mormorazioni avevan provocato,
e deliberazioni dei governanti, coi loro liberi costumi. Mentre le
dame facevano grande uso di maschera e bautta, esse invece
rinunziavano ai veli religiosi. Il De Brosses ce le descrive cosi:
Elles ont une petite coiffure charmante, un habit simple, mais
bien entendu, presque toujours blanc. qui leur dcouvre les paules
et la gorge, ni plus ni moins que les habits la romaine de nos
comdiennes
. 1
Delle monache che rassomigliavano alle donne
di teatro ! E non basta. Questo stesso presidente De Brosses,
reporter della maldicenza e della cronaca galante, in servigio
(sia detto a scusa delle dame italiane d'allora) delle signore
francesi sue amiche, ci parla anche di dissidi sorti fra tre mo-
nasteri veneziani pour savoir lequel aura Tavantage de donner
une maitresse au nouveau uonce qui vient d'arriver . Avevano
ben diritto gli abati di corteggiare a loro agio le gentildonne,
e spesso senza conseguenze, quando gli alti prelati variavano
la monotonia della nunziatura con gli amori monastici. Il libero
San Marco v'eran mezzani, courtiers d'amour , che oftVivano anche donne
di elevata condizione datesi al meretricio (I, 177). Anche il Lalaxde [Voyage
d'un franrois en Italie, I7t>r)-H. Venise [Paris], Desaint, 1769, Vili, 175 esegg.
parla dei cicisbei veneziani, e dice, d'accordo col De Brosses, e contro lo
Sharp {Letters front Itali/, 1767), che essi eran per lo pi di convenienza.
'
De Brosses, I, pag. 177. Sulla vita monastica femminile del Settecento
V. r incompleto articolo di E. Rudocaxachi, Le nonnes en Italie dii xiv au xviii
Mde nel Bnllettin italien, V. 1''), a cui sono da aggiungere, tra i contri-
buti pi recenti, i curiosi ragguagli offerti da Antonio Pilot in Una capa-
tina in alcuni monasteri veneziani del ,500 {neUa. /divista d'Italia, luglio I910i.
E sulle monache veneziane soprattutto da vedere P. Molmenti, che stu-
diando nella sua opei-a monumentale La storia di Venezia nella vita privata
dalle origini alla caduta della repubblica (Bergamo, Arti grafiche, lW5-9i,
ha dedicato un capitolo interessantissimo al costume femminile del Sette-
cento (voi. Ili, cap. 12), in cui illustra assai bene anche la vita e le usanze
mondane delle monache di Venezia (pag. 414 e seggi. Il Molmenti iIII, pa-
gina 418; non crede che il Patriarca di Venezia avesse un'amasia, ci che
noi invece vediamf) affermato dal De Brosses. L'ambasciatore francese, che
il De Bross"s ci dimostra cosi addentro nella conoscenza dei costumi vene-
ziani, era il FrouUay, di cui giusto in quel tempo furono scandalosi gli
amori con la monaca patrizia Maria Da Riva (cfr. Molmenti, III, 11?'.
Nell'opera del Molmenti sono anche illustrate con belle incisioni le con-
versazioni nei parlatori veneti.
1 CICISBEI 191
costume dei monasteri veneziani, 'li cui veiremo pi oltre la
satira, era gi stato osservato da altri viaggiatori, anteriori la
De Brosses. Nel 1664 l'abate Pizzichi, parlando del monastero
delle Benedettine, che accoglieva pi di cento suore gentildonne,
aveva detto di esse: Vestono leggiadrissimamente con abito
bianco come alla francese, il busto di bisso a piegoline ...
;
velo
piccolo cinge loro la fronte, sotto la quale {fficj escono i capelli
arricciati e lindamente accomodati: seno mezzo scoperto, e tutto
insieme abito pi da ninfe che da monache . E il barone
Ch. Louis Poellnitz (lOlJ'i-lTTi, celebre avventuriero, nei suoi
Minolrex, stampate dal 17.'i4 al 1747 aveva fatto delle monache
veneziane questo ritratto : L'habillement des Religieuses est
plus galant que modeste: elles portent leurs chevaux tresss,
comrae les flles de Strasbourg: leurs jupes sont assez courtes
pourqu'on leur voye la cheville du pied : pour corps de jupes
elles portent des casaques basques courtes, qui sont trs-avan-
tageuses aux belles tailles : leur gorge est dcouverte . . .
'>.
'
A Bologna trioni'ava il genio francese, anche nel salotto del
conte e della contessa Rossi, dove il De Brosses si rec, e tra le
dame che vi convenivano, graziosissime et beaucoup plus que
coquettes.^ Dame, che riunite in circoli, mentre facevano
della causerie con gli amanti, parlavano quasi tutte francese,
ma conoscevano anche i poeti italiani: inoltre elles citent Ra-
cine et Molire, chantent le mirliton et la bquille, jurent le diable
et n'y croyent gnre . E al disopra di tante testine piene di
grilli e di tante parrucche incipriate, l'arcivescovo di Bologna,
il Cardinale Lambertini, il futuro Benedetto XI\'. < bonhomme
sans facon
,
pieno di spirito, gaio, colto, di ottimi costumi, fa-
ceva sentire la sua arguta conversazione, nella quale si serviva
de certaines particules expltives peu cardinaliques : egli fece
al De Brosses de bien bons contes de flles, ou de la coui' de
Rome, e gli chiese delle avventure del Reggente e del sm>
confidente il Cardinale Dubois.
^
L'opera in musica era a Bologna.
"
Sull'ai). Pizziilii e sul Pollnitz e su queste loro testimonianze, vedasi
A D'Ancona, L'Ifalia alla
fine
del secolo xvi. Giornale del viaggio di Micini
de Montaigne in Italia nel J^SO e 15S1,
Citt di Castello, Lapi,
188i>.
pag. G75 e seg.
"
De Brosses, I, 249 e seg.
'
Dk Bkossrs, I, 250 e seg. Della nobilt bolognese, potili anni juinia
del De Brosses, Etienne de Silhouette, di cui riparleremo, scriveva: elle
s'amuse le plus noblement et le plus utilement il, 172i.
I
CICISBEI
19'^
'^.... P delle
pefites-
,,.......
""""'*,.
B,ote'
non
accenni
a -P^^
^^Jf
\, 'f^ma
di
nemici
delle
f::^
conservavano
^^a^aU^^^^
^^^_^
^^-f
^
^^
t
donne.
e
d'uom^nx P^-^^^^^;^^^^^.
,,,
convenga
nsahre
ala
te
i.vo
Quella
fama
non
so,
^e
pi
^^^^^^i e
agh
altri
che
loio
quella
intorno
a
Brunetto
,.
,,ga
oscena
stimomanza
di
UauL
^^^^^.
^^^^
^qO
1
accus
^ r-on
lui
sotto
le
tawe
u
gl'italiani,
ed
ancne
vanno
con
lui
.^itanto,
ma
a
tutti g
^dunavan
nnu
fu
lanciata
a
loro
^i^uori
fiorentini
bi
raaui
non
lu
Settecento
i
signoi
Brosses
vide
co-li
stranieri-
Jsei ^^
.
-i
-^yesidentc
u
oiuo
leutieri
nelle
^^^^^. '^Jj.o
di
.-ente
d.e^-
q,v.
riccissime
ed
-
*^^.
to
uonun.
sun.uo.amente
tiUant,
di
d.a,nant,,
e
, ,
,, e
nser-
-txapoU
ii
De
B.osses
.evo
^
^^
ST^ie
p.even-
4.^ fl'\lessandro
viu,
, .
^.^ ^i; niemente
Xl,
toboni.
nipote
d
Alessa
^^^^^i,
nipote
di^^^u
lire
trte
d
collge
et
le
plu^
-^
^^
^^,^^^^
g,,
,pet
Tdedicava
^^
jf
ZS:^^^-^^
S^
^l
.
grand
d^rideu^-
d^
le^^ ^P^^
^
3^
''^*"^"';^r
a
bX
^Pr'''^roXerX
cannella..
^--X^Cin^rcento,
che
-ttri:rrecclesia.icanona
e.^
-
De
Brossks,
1,
-^J-
,ochi
cicisbei
a
Napoli
.
De
Brosses,
H,
22H
I CICISBEI
103
se non uomini; ma in compenso abbondavano le riunioni e le
belle dame:
^
la principessa Borghese, la duchessa di Caserta, la
baronessa Piccolomini, e le signore Petroni, Ricci, Falconieri,
Sampieri, Bolognetti, Patrizi. Nei salotti e nelle conversazioni
v'eran numerose coppie cicisbee, che s' incontravan dovunque,
sempre insieme, e facevano a lor posta la petite jaserie finche
non si mettevano a giocare a carte. Il De Brosses, a proposito
della societ romana, ci regala alcune riflessioni sul cicisbeismo,
che era stimato sans consequences ,
mentre in Italia sarebbe
stata scandalosa la coquetterie delle signore francesi dai molti
amanti e corteggiatori. Al De Brosses pareva significativo il fatto
che delle donne eran solo disponibili le brutte, mentre le belle
eran tutte . . . occu])ate: la Ricci, jolie et mignonne au possible
,
era eternamente accompagnata dal bello don Paolo Borghese
(il De Brosses dice che gli uomini di casa Borghese eran bella
gente, come i De Rohans francesi); l'amabile e gaia Bentivoglio
sempre dal cugino, un marchese Bevilacqua ( on ne les voit
jamais l'un sans rautre)^; e cosi sappiamo che il Cardinale
Alessandro Albani assisteva madama Grimaldi, la quale fece di-
vorzio dal marito (uu Cozzadini di Bologna), accusato d'incapa-
cit alle funzioni maritali
;
^
e pochi anni prima Roma vide
l'abate Lorenzini, custode d'Arcadia, che pure ci vien descritto
poco pulito e sordido nel vestire, fare da cavalier servente alla
bella Valdambrjni. Vero che i galanti (certe coppie duravan
fedeli anche venti anni) con la loro assiduit divenivano altret-
tanti Arghi, peggio che i mariti. Cette odieuse race de sigisbs
pouse les femmes dix fois plus que les poux , conclude a
questo proposito il De Brosses,
*
riferendosi, speriamo, alla sor-
veglianza che il cicisbeo esercitava sulla cicisbea.
11 pi frequentato dei salotti romani era quello della princi-
'
Sui costumi romani nel Settecento vedi De Brosses, II, 2(Jt) e segg.
Cfr. un articoletto di Pietro Tommasini Mattiucci, Pagine romane: Il Pre-
sidente De Brosses i nella Pivista di Roma, XIV, 2, 25 gennaio 191U). Tra le
dame romane ricordate dal De Brosses una Marianna Cenci Bolognetti,
amata o almeno ammirata molto da mons. Nicol Forteguerri. che la lod
nel Ricciardetto, XXIII, 4H-7. Su questo tardivo atetto del Forteguerri. e su
due lettere di lui alla dama, v. Guido Zaccagnixi, Un'avventura amorosa
di Niccol Forteguerri (nel Bullettino storico pistoiese, V, 1908, pag. 99-103).
Sulla societ romana vedi anche Lalande, Voi,age cit., V. 142 segg.
-
De Brosses. IL 217 segg.
"
De Brosses, II, 223 segg.
*
Db Brosses, II, 217.
VA Hivistd d'Itiilu. anno XIII. voi. II, tasf. Vili (Agosto 1910\
194 I CICISBEI
pessa Borghese, nata Colonna, che anche soleva ricever gl'intimi
o
quelli
cui si dava per deferenza lo stesso diritto, nella sua ca-
mera da letto, essendo essa ancora coricata, a discorrer d'intrighi
e di belle donne.
^
Nella sua casa, frequentata da ricchi inglesi,
c'era banco da giuocare, e vi si giocava disperatamente : la prin-
cipessa, sul conto della quale correvano delle maldicenze, accet-
tava la corte dell'ambasciatore veneto, il cav. Marco Foscarini,
fra qualche anno erudito storico della patria letteratura e Doge,
per allora spasimante d'amore, uomo di spirito e giocatore acca-
nito di faraone.
La ricchissima letteratura dei viaggi del Settecento oifre
molte conferme alle osservazioni del De Brosses e nuovi rag-
guagli. Cominciamo dalle informazioni che ci offre l'epistolario
d'una celebre gentildonna inglese, briosa scrittrice e arguta os-
servatrice, della quale torneremo a discorrere. Lady Montagu.
Tornando dall'Oriente essa travers l'Italia, e scrivendo da Gi-e-
nova ad un'amica (28 agosto 1718) parlava delle signore di quella
citt, dicendole belle e abbigliate alla moda francese, e ricono-
sceva la singolarit dei cicisbei, che secondo il suo parere, si
videro primamente a Genova, donde se ne diffuse il costume
per tutta Italia:- n credeva al platonismo delle coppie cici-
sbee. Due anni innanzi, passando da Vienna, aveva dato un
giudizio ben severo dei costumi di quella capitale,
^
dove tutte
*
Sull'uso delle donne, di tener conversazione essendo in letto, vedasi
anrhe l'opera cit. dei De Goncourt. La femme an xviii siede, pag. 1.57.
Anche l'inglese Brooke ufr. D'Ancona, Op. cit., pag. 58<ie segg
i
nel 1794
a Roma fece visita ad una dama che era ancor in letto: seppe da lei che le
signore costumavan dormire senza camicia, e su ci ebbe con essa una di-
scussione. Su questo particolare del costume passato hanno scritto parecchi :
M. ScHERiLLO {L'uso della camicia nei secoli xiv e \v a proposito di uno
similitudine dantesca, in La Lettura, II, 4, anno 1902), Fkdele Romani
I Noterella sull'uso della camicia nel Medioevo, nella Miscellanea per nozze
Scherillo-Negri, Milano, Hoepli,
1904i e V. Gian (Sull'uso della camicia, nel
Giornale stor. d. letter. italiana, XX.VI, 2.57 seg.).
'
Lettres de Miladji Wortlay Montagute \sic) etc, traduites de l'an-
glais etc, Londres (Paris, Duchesne), 17<>4, li, 179-81.
'
IMtres cit., I, 60 sgg. Solo in parte contrasta con la testimonianza
della Montagu (e ad ogni modo non esclude che le dame viennesi avessero
in buon numero degli amanti) il Metastasio, che nel 1747 scriveva a Garlo
Broschi il Farinello, allora idolo delle ardenti dame madrilene: Qui gli
odii e gli amori non tolgono mai il sonno: qui l'anima s'impaccia pochis-
simo degli affari del corjx): la sera siete il favorito, la mattina l'incognito.
Le premure, le agitazioni, le sollecitudini, le piccole guerre, le frH<]iienti
I CICISBEI 195
le dame avevano un amante . .
.,
anche le vecchie. E i mariti
viennesi gareggiavano con gl'italiani per la mansuetudine: " Ils
ont autant d'attentions pour les amans de leurs femmes, que
pour un commis qui les dcharge de la partie la plus emVjar-
rassante de leurs affaires ; e alla loro volta l'anno lo stesso
ufficio presso un'altra dama.
<'
En un mot. c'est la coutume
Vienne, que chaque l'emme ait deux maris, l'un qui en port le
nom, l'autre qui en fait les fonctions ; talch chi invitava a una
fesra una dama doveva invitar anche l'amante di lei: tali coppie
eran notissime, e duravano talvolta anche vent'anni, e spesso
l'amante passava una pensione alla dama. Fra i tanti riscontri
che si son cercati ai cicisbei italiani presso le altre nazioni, nes-
.suno, mi pare, j)i calzante di questo viennese.
'
Ed ecco la testimonianza curiosa di altri viaggiatori: TAr-
chenholz descrive i cicisbei di Genova :
^
Etienne de Silhouette
paci, le gratitudini, le vendette, il parlar degli occhi, l'eloquenza del si-
lenzio, in somma tutto ci che pu dar di piacevole o di tormentoso il
commercio delicato delle anime, paese non conosciuto, se non che come
ridicolo ornamento de' romanzi. E cosa incredibile a qual segno arrivi l'in-
dolenza di queste placidissime ninfe. Io dispererei di trovarvi una sola ca-
pace di trascurare un giuoco di piquet per la perdita o per la morte d'un
carissimo amante; ve ne troverei ben quante mai ne volessi di quelle che
non interromperanno l'insipido lavoro de' lor nodetti fra gli eccessi dell'estro
pi imperioso >. Metastasi*), Lettere disperse e inedite a cura di 6. Carducci,
Bologna, Zanichelli, 1883, I, pag. 20B sg.
'
Il Neri [Op. cit., pag. 121 sg.j ritiene che il cicisbeo italiano fosse af-
fine al galanteos e al cortejos spagnuolo, all'ami de la maison e a.]Valcoriste.,
per quanto innocuo, di Parigi. L'affinit non pu negarsi, ma il cicisbeo
italiano si distingueva per caratteri suoi specialissimi, rilevati chiaramente
da tutti gli stranieri, dei quali uno o due soltanto attermarono le somiglianze
del costume italiano con quello dei loro paesi. A me non occorre trattar
l'intricata questione dell'origine dei cicisbei. Il Muratori citato dal Neri
{Annali, 1707) disse il cicisbeato eredit del dominio francese; ma non si
appose, perch esso era gi nel costume italiano dalla fine del
'6<M, come
ci attester fra poco il Maggi, di cui non si rilevato il va'ore a questo
proposito. Il Neri (pag. i;-58 sg.), citando anche da autori del Cinquecento,
dimostra quanto sul costume dei cicisbei inHuissero le idee del secolo "xvi
sull'amor platonico. A nostro avviso si tratta d'un fenomeno che ebbe varie
cause: la galanteria secentesca, il rifiorire dell'amor platonico con le nuove
accademie letterarie e specialmente con r.\rcadia, in cui la galanteria e il
corteggiamento penetrarono con molta fortuna, e gli ultimi resti traviati
della protezione cavalleresca verso la donna.
-
Cfr. D'Ancona, Op. cit., pag. "HS.
196
1 CICISBEI
uot poco di speciale a Milano,
'
ma a Venezia, con grande ri-
lassatezza di costumi e amore del piacere, donne con des fa-
(.ons lascive et attraj^antes . .
.,
ardentes dans leurs amours et
vindicatives
:
"^
il Dupaty nel 1785 lamentava la corruzione di
Genova e la sopravvivenza dei cicisbei, pur osservando che le
.sygisb reprsente -peu prs Gnes Vami de la maison Paris
>^.
^
E dei cicisbei tornano a parlare l'inglese Brooke nel 1794* e
l'abate Co3-er.5
Del Piemonte finora poco o nulla ci hanno discorso gli au-
tori veduti; in realt lady Montagu nel 1718 a Torino trov
una Corte molto devota, e osservava che la galanterie
y
est
regarde comme un crime irrraissible
>.^
E anche pi tardi, nel
Voi/aye en Piemont del Breton de la Martiniere e del Brion. ci
si dice che a Torino i costumi eran migliori che altrove e i ci-
cisbei vi eran quasi sconosciuti.
^
Che i costumi torinesi, per
questo riguardo, fossero pi lodevoli che in altre citt italiane,
oltre questa testimonianza,
dimostra anche un curioso aneddoto
narrato dal conte di Blondel, ministro di Francia alla Corte di
Torino sotto Vittorio Amedeo III e Carlo Emanuele IH. Do-
vendo la regina, moglie di Carlo Emanuele III, andare alla fiera
di Alessandria nel 1730,
il re elesse sei dame che l'accompa-
gnassero, e poich ad Alessandria sarebbero convenute anche
dame genovesi, milanesi, fiorentine e d'altre citt, nomin alle
sei dame altrettanti cicisbei pour se conformer la mode ita-
'
Voyage de France, d' Espagne, de Porhtgal et d'Italie par M. ,S'***
(Etienne de Silhouette! du 22 avril 1729 au 6 tevrier 1730, Paris, Merlin, 1770,
I, 83. La nobilt milanese soleva passeggiare sulla piazza del Duomo: Les
hommes mettent pied terre et vont causer avec les Daiiies qui restent
dans leurs carosses .
-
Voyage cit., I, Kjo.
'
Cfr. D'Ancona, Op. cit., pag. (>11.
*
Cfr. D'Ancona, pag. 58<J sg.
"
D'Ancona, pag. 591 sg.
"
MoNTAGi', Letirea cit., II, 189.
''
Il Voi/age en Piemont fu stampato a Parigi nei primi anni del se-
colo xix {cA'r. D'Ancona, Op. cit., pag. 578 sg.). Contiene un interesuante
capitolo sul cicisbeismo, di cui vede una delle cause pi probabili: Catte
coutume a pour Vjase la manie de l'amour ])latonique et pastoral, que l'en-
thousiasme pour les ouvrages de Ptrarque a introduit en Italie. Tous
les gens d'esprit furent obligs, sous peine de pasaer pour insensibles,
d'adorT une chaste Laure, mais en tout bien et tout honneur . (Cfr. D'An-
cona, pag. 579).
I CICISBEI
197
Henne", dalla <[uale differiva quella piemontese.' Al Blondel
tocc far da < avalier servente alla contessa Innocenza Cristina
Provana di Frossasco, nata contessa della Trinit.
<'
ag^e de
18 ans et trs-belle. Ma l'ufficio era faticosissimo, attesta il
conte, per quanto bella fosse la dama servita: il cicisbeo doveva
dar la mano alla signora mentre saliva in carrozza, levarle i
guanti, metterglieli, danzare con lei quando essa desiderava e
non aveva altri ballerini, e fare altri simili favori; e poi ricon-
durla a notte avanzata a casa: < et pour tonte rcompense de
mes peines
conclude l'arguto cicisbeo improvvisato
elle me
donnait sa main baiser et je retournais chez moi-.-
II costume della Corte e della societ torinese non era stato
sempre cos severo: a tutti son noti gli amori e gli scandali del
tempo delle due Madame reali e di alcune dame, tra le quali
famosa la Verrua, l'amante di Vittorio Amedeo li.'' Non v'erano
i cicisbei, ma una specie di cavalier servente avevano quasi
tutte le dame e damigelle della seconda Madama reale, Gio-
vanna Battista.* V'era anche in Turino un particolare costume,
che non ha riscontro, ch'io sappia, in altre citt. Il Millin
(1759-1818) parlando del castello del Valentino che sorge nel
bellissimo parco sulle rive del Po. dice: <
Un donnoit autrefois
dans ce chteau une fte le jour de S. Valentin, le 14 de f-
vrier. Chaque dame appeloit le chevalier qui la servoit, son Va-
lentin. C'est de la qu'est venu le nom de eette demeiu-e >>.Ma
la notizia del Millin poco particolareggiata. Pi preciso
quel che scrisse il
p.
.J.-B. Labat (1B63-1738),
che viaggi l'Italia
'
Il Neri, a cui nota questa testimonianza, crede che essa provi l'esi-
stenza del cicisbeato a Torino; ma a noi pare che dimostri invece il con-
trario, e che dia ragione all'affermazione che abbiamo trovato nelle Leftres
della Montagu. Cfr. Neri, Op. cif., pag. IS'd sg
,
in nota.
*
11 documento fu edito da Vincenzo Promis nella Miscellanea di .storia
italiana della li. Deputazione di .storia patria, voi. XIll. Torino. ISTI, pa-
gina 522 sg.
*
Gaudenzio Cl.\|{etta. La corte e la societ torinese dalla met del
secolo XVII al principio del XVIII (nella Rassegna Nazionale, voi. LXXIII
e LXXIV, 18!J3i: la lunga, interessante monogra6a fondata sulle memorie
di N. de Grandchamp [La (/ue'ro d'Italie, memoires dii conte..., Colo-
nia, 1710).
*
Claketta, La corte e la socitt torinese, ecc., pag. 66 delTestratto.
"
Millin Aihin Louis (17.5W-1818), Voi/age en Pimont, Xice et Gnes.
Paris, Wassermann, 1816, I, H40. (Cito dal D'Ancona, Op. cit., pag. 642).
Vedi anche D'Ancona, pag. ^i^( sg.
198
I CICISBEI
al principio del "700, sebbene egli riferisca in generale all'Italia
il costume dei valentini , clie ritengo vedesse solo a Torino:
Je n'ai janiais
p
scavoir assez au juste la raison de ceb
usage, mais il est tabli il
y
a bien des annes. Les lilles choi-
sissent des gareons, qu'elles envoyent avertir qu'elles les ont
pris pour leurs Valentins. Les gareons
y
rpondent d'abord par
un bouquet, qu'ils envoyent leurs Valentines et les mariages
suivent assez souvent ces petites unions dont personne n'est
scandalis, parce qu'elles sont innocentes. et que les titres de
Valentin et Valentine ne dispensent pas les parens de veiller
l'ordinaire sur la conduite de celles dont ils sont chargz.
()n se fait de prsens pendant le cours de l'anne, on se visite,
on se trouve, aux assembles et aux promenades: et lanne
finie sans engagement, on songe a faire de nouveaux Valentins
et de nouvelles Valentines. car il est juste qu'ou recommence
un nouveau bail. Les religieux mmes ne sont pas dispensez
d'tre choisis pour Valentins, et comme tout se passe dans cette
petite union selon toutes le rgles de la biensance la plus se-
vere, on n"3' trouve point redire .
'
Anche pi interessante
una testimonianza fatta conoscere pi recentemente, che fa ri-
salire il costume dei valentini alla seconda met del secolo xvii.
Nel Ceremoniale ancor inedito del conte 8caravello, maestro di
cerimonie della Corte piemontese, alla data 14 febbraio 1677.
si legge:
<>
^Madama Reale ha comandato che si rinnovasse la
funzione di fare li Valentini alle dame; s che, la sera, nel
(gabinetto di M. R., ov'era S. A. R., la Ser.'"* Principessa e
Ser.*"' prencipi con tutte le dame e cavalieri della Corte, se ne
fece l'estrazione nelFinfrascritta forma: fu fatta una lista di
tutte le dame d'honore e figlie d'honore della Corte, e fatti
altrettanti pollicini {polizze) col nome dei cavalieri, e messi
in un vaso d'argento dorato, qual tenevo io come mastro delle
cerimonie, e m.'' De l'Echeraine,
1
secretano di G-abinetto di
S. A. R., leggeva ad alta voce i descritti nella detta lista, co-
minciando da M. R., Ser.""* principessa e tutte le altre dame e
figlie d'honore, senza distintione di precedenza
;
quali conforme
erano nominate, si presentavano avanti Madama Reale, e tira-
vano a sorte uno de' pollicini, e subito aperto si nominava il
cavaliere flescritto, qual doveva restar
<'
Valentino della dama
chn l'avf-va estratto, alla quale detto cavaliere doveva far qualche
'
Il passo riterito dal D'Ancona, pag.
i>41
sj;g.
I CICISBEI 199
regalo di fiori e nastri
'>.i
A Maria Giovanna Battista di Sa-
voja-Nmoiirs spetta adunque il merito d'aver ripristinato questa
istituzione di galanteria: a noi non dato spiegarci l'origine
(li essa, sebbene vi si possa veder la derivazione di una consi-
mile usanza dalla Corte di Francia. Nei Vaentini qualche
somiglianza indiscutibile coi cavalieri serventi del secolo suc-
cessivo: ma noi non riteniamo che questi abbiano avuto origine
da quelli, come ad altri sembrato, e perch i Valentiui servi-
vano anche le fanciulle, e non solo le maritate, e perch essi
sopravvissero, come le testimonianze vedute ci dicono, al trion-
fare dei cicisbei. I quali nella seconda met del secolo xviii non
eran pi a Torino una rarit, come abbiam veduto nel 1730: il
Millin riteneva perci erronea l'opinione che il cicisbeismo fosse
nato a Genova, mentre per lui cominciava appunto a Torino,
e offriva i pi perfetti tipi di cavalieri serventi a Venezia e in
Toscana;
2
nel 1795 lo storico Gibbon, parlando delle conversa-
zioni torinesi, affermava che ogni dama bada solo al proprio
cicisbeo, e un povero inglese che non sappia parlare piemontese
e non conosca il giuoco dei tarocchi rimane nel suo cantuccio
senza un cane che gli rivolga la parola ; e nel medesimo anno
il marchese Enrico Costa osservava: Non mai fu veduta simile
fiera di cicisbei; le dame che ne sono gi provviste e vogliono
assicurarsene uno per sempre, accordano mezze pensioni e no-
minano coadiutori con futura successione.'^
A compiere la geografia italiana dei cicisbei manca ancora
la Sicilia. In essa, come gi diceva di Napoli il De Brosses,
le donne non eran cosi libere come nel continente. Questo ci
'
11 brano riferito in ano ftei curiosi articoli su Torino e i Torine.'<i
che av All)erto Virigli i venuto pubblicando sulla quotidiana Gazzetta
del Popolo di Torino numero del IT novembre
19o5:
Esposizioni del pas-
sato . Il nume di Vaentini, che il Viriglio non sa donde provenisse, deri-
vava probabilmente dal giorno in cui si taceva quella festa, che era annuale,
il 14 febbraio, giorno di S. Valentino. Se poi il castello, che era stato rie-
dificato dalla prima Madama Reale, Cristina di Francia sorella di Luigi XIII,
prendesse il nome dalla festa dei valentiui. come asserisce il Mallin, non
saprei affermare. (Questa costumanza dei patentini ricorda il giuoco di societ
fattoci conoscere da Ferdinando Galiani.
Ctr. D'Ancona, (tp. cit., pag. GtU.
'
Costa de Beaurrgard C. A., Un homme d'aut-efois, Paris, Plon. 1891.
pag. 271 sg., e per la testimonianza del Gibbon, pag. 272. Abbiamo citato
da una versione di questo libro ^Uii uojuo d'altri tempi. Torino, tip. Arti-
gianelli, 1.S79. pag. 208 sgg. 1.
200
I CICISBEI
attesta il viaggiatore inglese Brydone. il quale \'isit la Sicilia
nel 1770. e lodava il costume, seguito in molte famiglie, di educar
le fanciulle presso la madre, anzich nei conventi. La galan-
teria, sempre secondo lo stesso autore, era per simile a quella
del resto d'Italia : i cicisbei erano abbastanza numerosi, ma non
quanto nelle altre regioni italiane,
i
II.
La galanteria della vita privata non poteva non riflettersi
nella letteratura. Nella prima met del secolo xviii sono quasi
unicamente i religiosi e i moralisti, che scrivono trattati pieni
d'ammaestramenti morali, accumulando autorit sacre per di-
mo-strare il pericolo delle troppo assidue e libere conversazioni
che il secolo consentiva tra individui dei due sessi. Ma a poco
valero i loro sermoni, che la societ non solo accettava, ma
favoriva le coppie cicisbee, e il cicisbeismo divenne uua squi-
sitezza caratteristica del ceto aritocratico dapprima, poi delle
classi meno elevate, e col tempo di tutte, eccettuata la plebea.
La poesia si compiacque d'ispirarsi alla gaia costumanza e con
fervido sentimento erotico espresse lo spirito galante e delica-
tamente corrottp di quel mondo di spigliate e capricciose da-
mine, di effeminati cavalieri serventi: molte delle Dori e delle
Filli, che s'atteggiano a ingenue pastorelle nelle anacreontiche
della prima met del Settecento e nelle canzonette e nei sonetti
arcadici, sono appunto graziose cicisbee, per le quali l'amore e
il corteggiamento costituiscono una bella creanza. Fra le troppe
liriche del Frugoni, che serv tante vivaci e garbate signore,
sarebbe agevole fare una raccolta di poe.sie da cicisbei: la li-
bert che spesso confina con l'indecenza, la malvelata sensualit
di esse sono proprie, vero, di quello sboccato epicureo che fu
Cornante; ma egli uno dei pi caratteristici uomini del suo
secolo spensierato e amante del piacere.
^
'
Sul Brydone cfr. D'Ancona, Op. cj7., pag. 582 sg. E sul costume sici-
liano in {genere e pel nostro tema v. Isidoro La Limia, I.a Sicilia di nn
secolo addietro secondo i viaggiatori stranieri (nella Nvova Antologia, aprile
1H7*)).
*
Per questo aspetto delle poesie del Frugoni mi si conceda di riman-
dare a quel che ne ho scritto nel mio volume in corso di pubblicazione su
/m lirica italiana dall'Arcadia ai tempi moderni, pag. 21} sgg. (nella iSYor/a
dei generi letterari italiani edita dalla casa Francesco Vallardi di Milano .
I CICISBEI 201
Anohe ali infuori della lirica eroti< a del l-'rugoni e dei suoi
imitatori, la vita di quel secolo, e il libero costume ci sono rap-
presentati in altre forme e maniere di- poesia, senza intenzione
alcuna di ridicolo e di censura. Kfco un altro uomo del 'TOJ,
diverso in gran parte dal Frugoni, l'Algarotti, Ahjarottuliis
nosfer, come gli amici bolognesi lo chiamavano, il compagno
d'avventure del grande Federico di Prussia, che ad un'amica
discreta, a Lesbia, in un'epistola in versi, parla d'un suo amore
giovanile, troncato bruscamente e poi ridesto, quando purtroppo
l'amata era gi sposa d'altri. Purtroppo? Chi sa? Certo non
mancavano speranze al eonte veneziano:
I dolci sdej^ni, e le pi dolci paci,
II parlare, e il tacer gi d'una volta
Si risvegliare al cuor; ne centra lei
Fresca immago di Londra o di Parigi.
N valse lunga ussenzia. o mille leghe.
Nel letto il mezzogiorno, e il cioccolatte
In leggiadro atto assisa ella attendea
D'un gentil zamberlucco il seno involta
Che un sol ago tenea dinanzi chiuso.
Languidamente ella girava gli occhi
De' notturni piacer segnati ancora.
Che troppo mi diceano: altri felice.
Il mio sguardo vagava or sul confuso
Crin dalle Grazie, or sulle due pozzette.
Or sul vario disordine del letto.
Che Imeneo, non Amor turbato avea...'
la solita contesa tra Amore e Imeneo, cos opportuna
qualunque sia il giudizio che altri ne reca
nel (Giorno del
Parini, di cui costituisce l'invenzione intorno a cui s'aggira
tutta la varia favola del poema, in quanto mira a rappresentarci,
con l'ornamento dei vivaci colori mitologici graditi a quel se-
colo, come sorgesse l'uso del cavaliere servente, spesso tanto
caro al cuore della dama gentile, quanto tollerato era il marito,
che si rifaceva a sua volta nel nido altrui. E questa sposina,
descrittaci dall' Algarotti, certo una cicisbea in formazione,
essa che riceve l'innamorato della prima giovent in camera,
essendo ancora in letto (come faceva in Roma la principessa
Borghese con la folla de' suoi ammiratori e conoscenti), e non
teme che l'antica fiamma si ridesti, a provar se i baci d'amore
'
Algarotti F., Epistole in verni, Venezia. Novelli. lT>o. pag. tT sg.
202 I CICISBEI
sian pi dolci di quelli d'Imeneo. Anche Durante Duranti, uno
dei molti imitatori che s'ebbe subito il Parini, in un episodio
del suo poemetto L'Uso, parl di parecchi vagheggini, o Nar-
cisi come li dice, novelli Proci che vanno a far visita ad una
dama che ancora in letto:
Ognuno a gara
S'accosta ardito, e chi vicin s'asside,
Chi l'una man le stringe, e chi dell'altra
O delle molli ritondette braccia
Sugge i candidi avori; e chi sdraiarsi
Gode persin sullo scomposto letto...
L' USO permetteva libert di gusto assai discutibile, come
ognun vede. Che se la dama levata e attende alla sua toe-
letta, non mancher qualche innamorato, poeta o no, che l'aiuti
nel delicato lavoro. Il barone Antonio Caraccio di Nardo, in
Arcadia Lacone Croraizio, celebratore di Cristina di Svezia, in
una canzone ci si ritrae tutto intento a pettinar la sua Dorinda,
adattandole sui capelli nastri e legami, e tessendo nodi e anella:
vero che non dimenticher di paragonarsi classicamente ad
Ercole debellato da (.)nfale.
i
Ad un'altra costumanza del Settecento, ai lunghi viaggi nelle
pesanti e monumentali diligenze, si riferiscono alcuni altri cu-
riosi poemetti. Eccone intanto uno del medico Lodovico Bian-
coni (1
717-1 7B1), intitolato Viaggio d'Amore e Dori a Roma,
pubblicato la prima volta, credo, nel 1766.- Che questi viaggi
avevano pure la loro poesia, e non eran niente aifatto spiace-
voli se venivano intrapresi per tener compagnia ad una gentile
signora: a tutti noto che uno appunto di questi viaggi favor,
mezzo secolo dopo quello descrittoci dal Bianconi, e il divam-
pare dell'amore di Lord Byron e della Guiccioli. Ma torniamo
al medico settecentista. La Dori, che egli ci presenta, una
dama veronese a cui egli compagno di viaggio fino a Roma.
I versi del Bianconi non sono brutti, anzi s'atteggiano alla ner-
vosa e succosa precisione degli sciolti pariniani, di cui da pochi
anni l'Italia aveva sentito il sapore, soave })er gli uni, agro per
'
Nelle Rime deijli Arcadi, \ul. IV, paj;-. 15:5 sgg.
-
Viaggio di Amore o Dori a Uoma, Venezia, Sansoni, iTdtJ. Senza nome
d'autore. Troviamo poi questo poemetto nel Parnaso italiano dello Zatta,
Venezia, voi. ")1, pag. l'M sgg.
I CICISBEI 203
gli altri. Il nostro verseggiatore e medico va a destar Dori per
la partenza:
Dalle t'elici sue notturne piume
Il giovin fianco e il rilevato seno
A che pi tardi a trar. leggiadra Dori?
Tu dormi ancor tranquilla e non t'accorgi.
Che alta rosseggia in Oriente e splende,
Quasi rinfacci a te le tue dimore.
La rugiadosa moglie di Titone.
La carrozza gi pronta ad aspettarla:
Odi il cocchier, che a le tue soglie assorda
Col rauco corno, e col flagel nodoso
I sonnacchiosi abitator vicini.
E intanto i destrier fervidi inquieti
Battendo van col pie ferrato il suolo.
Il nostro autore entra liberamente nella camera della pigra
signora, che sta giusto allora svegliandosi; ed ecco anche la
vigile cameriera. E una scenetta che merita d'essere letta nei
versi del Bianconi, di schietto stile settecentesco:
Ah Lisetta gentile, entra: te pure
B-iveggio volentier; depon sul letto
I bianchi lini profumati e molli,
Ch'entro fragrante e gallico canestro
Vigile ancella a la tua donna apporti,
E in segno d'amist dammi la destra.
Calza a Dori il bel pie, rivesti il fianco,
E mentre che a l'argenteo, e mattutino
Desco d'Amor ministra le alimenti
Col pingue nardo, con la bianca polve
II lungo ondoso crin iisciolto e sparso,
E in viril treccia lo componi e annodi.
Io qui mi assido. ..
Bevi, o Dori, frattanto, e al caldo latte
Mesci la fervid'onda, che al tuo lato
Sopra l'inglese e bel tripode bolle
Con l'odorosa foglia giapponese,
Grato conforto al cor. grato a la bocca,
E una tazza a me pur ne porgi ...
Non ci meravigliamo che il nostro medico poeta assista al
levarsi della gentile Dori, di cui ci si rivela invaghito: eran
costumanze che il secolo gradiva. Ormai i nostri due eroi sono
204
I CICISBEI
in viaggio: un viaggio turbato dalla polvere che le ruote pesanti
sollevano
;
e la signora costretta a difendersi da essa, per con-
siglio anche del suo compagno :
Ma, oh Dio, che fai? Col bianco lin deh copri,
Copri quella venusta e corallina
Bocca gentile, acciocch'essa non beva
Questa che innalzan le ferventi ruote
Nube di polve da l'adusta strada:
Se tu noi sai, quella tua bocca, o Dori,
A tutt'altro, che a polve amor destina.
N qui si fermano le attenzioni del compagno di Dori. Egli,
appena il sole appare e penetra nella carrozza, cos dice alla
bella viaggiatrice:
Lascia ch'io chiuda col sottile e verde
Serico velo, al destro lato il cocchio,
Perch non entri de l'adulto sole
Il ca,ldo raggio ad imbrunirti il volto.
Giunti sull'Appennino, i due viaggiatori si fermano ad un
albergo, e si ristorano : la dama si fa dar la cioccolata, e sor-
bendola
Tinge di brun le la])bra di corallo.
Noi auguriamo loro il buon viaggio.
Al Bianconi possiamo unire l'abate Clemente Bondi, che ci
d una Descrizione d'un breve viaggio da l'adova a Milano.^ Egli
si mette in viaggio in cocchio con Nice, e le fa da cicerone :
questo era tra gli uffici dei cicisbei uno dei meno sgraditi, quando
la compagna era leggiadra e briosa. Il Bondi ci offre con minu-
ziosa compiacenza la descrizione dell'abbigliamento da viaggio
di Nice :
E pria succinta Amazzone l'usata
Vest semi virile, orlata intorno
D'un aureo giro, al rilevato fianco
Stringi adattando e agli omeri gentili,
Che il sen chiuda affibbiata: e come l'uso.
Al liscio eburneo collo avvolgi intorno
Della gallica benda il lungo ingombro,
'
B()Ni>i, Poesie, Vienna, 1H08, II, pag 254 e segg. D'un altro viaggio da
Padova a Ferrara, ma non pi con una dama, tratta un' altra poesia ilei
Bondi, intitolata II sogno, pag. 276 e segg.
I CICISBEI 205
N l'indica sottil pieghevol canna
Non obliar, dell'oziosa mano
Lieve trastullo; e il Vjiondo crin sul dorso
Negletto ad arte in lunga treccia copri
Dell'anglico cappel, cui l'ala estesa
Serico fil circonda, e d'augel raro
Oman le fosclie tremolanti piume.
Di questa forma di poesia parrebbe talvolta aver voluto far la
parodia il Parini nella sua satira poderosa, sebbene anch'egli,
figlio del secolo, sapesse a suo tempo esser galante con le belle
signore; ma lo stesso Bondi, messosi sulle orme del grande poeta
brianzuolo, non fu degli ultimi tra quelli che volsero la loro Musa
a ritrarre i difetti della loro et per correggerli. Nel poemetto
La Moda egli si ride della schiavit a cui la societ si sottopone
per seguire i capricci della volubile dea, e ci trattiene nella de-
scrizione (iella toeletta a cui le dame dedicano tanta parte della,
loro giornata.! Nell'altro poemetto La Felicit, paragonando il
costume dell'et aurea a quello del suo tempo, dice che ben di-
versi erano allora i giovani:
Che non del tardo di spendevan l'ore
Inanellando il crin, pingendo il viso;
Js fra l'occulto amante, e quel di onore
Ai varj ufficj era il mattin diviso.
Con libero candor era ogni core
A un solo aifetto, a un volto sol deciso.
E il gentil sesso, che fra noi si onora.
Non si serviva, ma si amava allora.
-
Di quella societ mondana del Settecento, il Bondi che la
frequent e conobbe ci descrive il costume e i trastulli, e i mezzi
con cui essa va alla ricerca della felicit: il giuoco, i passeggi,
i convegni nei giardini fiorenti. Citiamo alcuni versi, in cui
par di leggere la spiegazione di una delle scene campestri del
Watteau :
Molti su le fiorite ei'be novelle
Traggono all'ombra le piacevoli ore.
Di ninfe al fianco lusinghiere e belle.
Di reciproca fiamma accesi il core.
*
'
BoNoi, Poesie, Padova, Penada, 1778. I. pag. 1S6 e 198 e segg.
'^
Bondi, Poesie, Vienna, 1808, I, pag. 123.
*
Bondi, Poe.s?>, Padova, Penada. 1778,
1,
pag. 172. Sui poemetti del Bondi.
cfr. anche G. Agnelli, Precursori e imitatori del 'Giorno^ di G. Porini.
Bologna, Zanichelli, 1888. pag. 68 e segg.
206 I CICISBEI
Pi. varia e riuscita la caricatura contenuta nel poemetto
La Conversazione^ in cui il Bondi ci descrive argutamente tutti
i tipi che pi frequenti si trovavano in quelle riunioni, ove di
preferenza facevano la loro apparizione le coppie cicisbee.
Con questi poemetti del Bondi abbiam fatto una digressione
nel campo della satira, che ci riserbiamo di percorrere pi oltre.
Torniamo quindi alla letteratura che s'inspir seriamente al co-
stume galante del secolo xviii. Ognun sa la passione che le dame
d'allora ebbero per i cagnolini : non v' in quel tempo poeta in
voga, il quale non abbia una poesia per qualche cagnolina, o
vergine cuccia . Il famoso episodio pariniano pose un freno
a tutta quella poesia canina a cui il Frugoni contribu larga-
mente, a cui l'abate Casti diede il suo epicedio ben noto. Ma le
sensibili signore non amavan meno i canarini, e non manc chi,
in un poemetto didascalico, naturalmente in isciolti, cantasse di
proposito :
Quell'augellin da i si soavi carmi
E dalle verdi e candidette piume.
Fu uno di quei veronesi, che nel Settecento ebbero la spe-
cialit della poesia didascalica, il conte Ignazio da Persico, e
l'opera sua ebbe, con due edizioni, le lodi di parecchi benevoli,
tra' quali Giulio Cesare Becelli.
i
Fiori e cagnolini porsero al Bettinelli l'occasione di scrivere
un supposto carteggio tra due amiche, le quali concludono la
loro conversazione epistolare in modo poco lusinghiero per i
cavalieri serventi, esaltando e fiori e cani al disopra degli uomini:
tanto le avevan seccate i cicisbei! L'operetta del Bettinelli gir
anonima, pubblicata per nozze, ed ha una blanda intonazione
satirica.
-
'
/ canarini, V-erona, Tumermani, 1728. Un'altra edizione con note fu
fatta a Torino, Stamperia reale, 1765, e ad essa va unita l'anacreontica del
Frugoni sul canarino di Crinatea: / pi bei numeri Casfalia Dea, ecc. (pa-
gina XLV e segg.i
"
/ fiori, e i cagnolini: carteggio tra due amiche dedicato agli illustri, e
nobilissimi signori conte D. Gius. Schinchinelli, e contessa Donna Maria
Borromeo in occasione delle loro faustissime nozze, Cremona, Manini, 1793.
Che l'autore sia il Bettinelli affermato nella liihlioteca oltremontana ili
Torino, 17HH, voi. I, pag. 251-1)0. Sui cani, delizia delle dame nel sec. xviii
e piima e dopo, vedi Marchksi G. B., op. cit. pi oltre, pag. 317 segg e 3t)2
segg., a proposito delle satiriche Avvent^ire di Lillo cagnuolo folognese (Ve-
nezia, Zatta, 1760'.
L
I CICISBEI 207
Ma ben seriamente il conte Antonio Cerati tratt dei giuochi
di societ e di fortuna: biribisso, tric-trac, tressette, scacchi, ecc.
^
Il Settecento era il secolo dei pi arrabbiati giuocatori. La du-
chessa di Modena, Carlotta Aglae d'Orlans, che era venuta in
Italia preceduta dalla fama non bella de' suoi amori <ol duca di
Richelieu, poteva vantarsi di avervi importati, nella prima met del
secolo, i giuochi d'azzardo, dei quali era tanto appassionata che
faceva della notte giorno : giuocava a biribi tutta la notte,
cessava alle 6 del mattino, si coricava alle 8 per levansi alle
5 pomeridiane."'^ Sale da giuoco abbiam gi veduto a Roma presso
la principessa Borghese : giocatrici impenitenti erano non poch^^
delle belle signore parmigiane cantate dal Frugoni, e tra esse
la spiritosa e leggiadra marchesa Anna Malaspina. Non a vuoto
flunque colpiva il Parini quando in pi episodi del Giorno^ e
specialmente in quello dell'invenzione del tric-trac^ denunziava
il vizio del giuoco come uno dei pi gravi della societ del suo
tempo.
^
Non pare che dai cicisbei traessero materia abbondante i ro
manzi del Settecento, tra i quali baster citare i V'iagyi di Enrico
Wanton del veneziano Zaccaria Sceriman (Venezia, 1749).* Invece
a mettere in caricatura e ad esporre al ridicolo i cavalieri ser-
venti contribu certo con efficacia il teatro comico, del quale ci
sarebbe materia da far un lungo discorso
;
ma a noi baster ac-
*
Jj'isola del giuoco, in Cerati. (JpuscoU, Parma, 1797, pag.
'2ti
e segg.
-
Ct'r. Dr Brosses, Lettres famlires, Paris, 1858, I, pag. 45H e segg
^
Sui vari giuochi del 700 non sarebbe difficile trovar una letteratui-a
poetica abbastanza ricca Al Parini e al Cerati aggiungiamo il Bettinelli,
che scrisse un poemetto sul Giuoco delle carte e il Bondi, che descrisse il
Biribisso nel poemetto La Felicit (e. II). Cfr. le sue Poesie, Vienna, 1808,
I, 160 e seg. Dal Molmenti (La storia di Venezia nella vita prirafa. ecc.,
ni, 242, n. Il tolgo la seguente indicazione bibliografica: Il trionfo del
tresette poema in versi sciolti di un patrizio veneto [Lodovico Morelli], Ve-
nezia, Zatta, 1756; e ad essa aggiungo quest'altra: // Faraone. Poemetto
giocoso. In Modena mdccl.\xix. Presso la societ tipografica. Il Faraone
un breve poemetto ipagg. 12) in distici ottonari di valore assai scarso. Sui
ridotti e sul giuoco a Venezia nel Settecento, vedi Molmenti, op. cit., III.
241 e seg. Il Parini, noto, espose argutamente l'invenzione del tric-trac
nel Mezzogiorno^ vv 1112 e segg. Su d'uno sconcio equivoco si svolge la
poesia veneziana Una partia a la bassta (vedila in Malamani, op. cit.. II.
pag. 191 e segg).
*
Cfr. G. B. Marchesi, Studi e ricerche intorno ai nostri romanzi e m-
manzieri del Settecento, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, UXDi,
pag. 229 segg. e pagg. 2H2 specialmente.
208 I CICISBEI
cennare quanto ci giovi a colorir meglio il quadro che stiamo
rapidamente delineando. Tra le commedie del Fagiuoli troviamo
// cibisheo sconsolato, che nel 1732 si rappresentava a Vienna
;i
l'Albergati dei cicisbei rise in pi commedie, specialmente nei
Pregiudizi del falso onore, e nelle due che s' intitolano il Saggio
amico.^ In questa serie van messe anche talune del Chiari, La con-
cersazione e La galanteria, e quella pi aspra e forte di tutte,
opera dell'Alfieri. // divorzio
^. Delle commedie del Goldoni, la
parte che riguarda i cicisbei stata di recente studiata in modo
lodevole:
^
le commedie dell'avvocato veneziano, che per questo
rispetto c'interessano, non son poche,^ e in -esse l'autore non ha
voluto esser mai aspro, come forse avrebbe dovuto. I mariti che
egli ci ritrae sono di solito deboli, o trascurati, o svogliati, o
servono un'altra dama, e rarissimi sono i gelosi
;
i cicisbei sono
gli esseri pi innocui di questo mondo, nella rappresentazione che
ce ne d il Goldoni; le dame poi armonizzano coi mariti e coi
cicisbei: svogliate coi primi, fatue coi secondi, e della infedelt
vera o apparente dei mariti rarissimamente gelose.
Anche l'opera in musica fece posto, com'era dovere, ai cicisbei,
per esporli allo scherno e al dileggio : nella sola Bologna, per
non ricercar di altri luoghi, nel 1747 si recitavano / tre cici'ibe?
con musica di Natale Resta; nel 1749 La rirfuosa corteggiata
da tre cicisbei ridicoli, un dramma giocoso di Carlo Antonio
Vasini musicato da Matteo Buini
;
nel 1759 La conversazione,
musica di Giuseppe Scolari; nel 1761 / tre amanti ridicoli, opera
(Ji Baldassarre Galuppi, e nel 1764 // cicisbeo burlato, messo in
musica da Tommaso Porta.^
'
Cos scriveva il Metastasio alla sua Romaniiia (Mktasi'Asio. Opere
postume date alla luce dall'ab. conte D'Ayala, Vienna, Alberti, 175*5, 1, 146).
Questa commedia ha anche il titolo Ci che pare non .
Vedi E. Masi, Francesco Albergati^ Bologna, Zanichelli, 1H78, cap VII.
"
Su <|uesta commedia dell'Alfieri, vedi F. Novati, Studi critici e let-
terari, Torino, Loescher, 18Hi>, pag. 78 segg. Non ho creduto necessario fer-
iiianui sulla nota satira alhsriana, intitolata II cavalier servente rcteraiio,
di cui tutti sanno le vigorose terzine.
*
Maria Mp:ri.ato, Mariti e cavalier sermnti nelle commedie del (O/doni,
Firenze, Carnesecchi, 1906. Dei cicisbei in particolare, pag. ;{1 e segg.
'
Sono H cavaliere e la dama (che avrebbe d(jvuto aver il titolo: / cici-
sbei), Im donna prudente, Ixt famiglia dell'antiquario, IjC femmiui' j)iin/i-
gliosf. Il festino, ecc.
'
Vedi Corrado Ri(( i, / fcatridi Bologna, Bologna, Monti, 1888, pag. 46;{,
461, 475, 478, 484. Non so se l'ultimo melodramma sia una cosa sola con
// cicisbeo burlati), dramma giocoso per musica di Angelo Anelli, musica di
I CICISBEI
209
Nemmeno in quella feconda e curiosa letteratura degli alma-
nacchi, che da noi ha tradizioni molto lontane, nei l'ronoxfici
del Rinascimento (famosi quelli di Pietro Aretino), e che era
molto in voga sul finire del
'700
e nei primi dell'HOO, non man-
cano allusioni al cicisbeato.
Ne ha dato un saggio curioso il Neri,* e tra i molti ch'egli
fece conoscere, alcuni sono satirici h galanti, come II gran parco
di Londra (1794) e // giardino d' Armida (1795). Nel secondo dei
quali si mettono in caricatura quelle pseudoletterate che allora
avevano ammiratori e di cui diremo, le dame di spirito e i loro
cavalieri serventi, che non erano spariti del tutto, sebbene fos-
sero scemati di numero : le seducenti Armide e i molti Rinaldi,
che a somiglianza di quello dell'immortale poeta, si perdono
nell'ozio e negli amori
.'^
Altri calendari passavano in rassegna
il costume in genere, come // mondo alla moda ossia galanterie
di ultimo gusto; ed altri eran bene indiscreti, poich, come quello
intitolato La toletta del bel senso, dei principi del secolo xix,
parlavano della toeletta delle dame, e non solo di quella palese
che esse facevano spesso avanti al cicisbeo e ai loro ammiratori,
ma anche di quella intima, cui sperabile non assistesse nem-
meno il cavalier servente.' Affini agli almanacchi erano le Pre-
dizioni, che si pubblicaron certo in buon numero : noi citeremo
quella del 1 756,
nella quale si prende di mira specialmente il
sesso maschile etferainato.* La profezia, che fa l'autore, questa :
Si cambieranno gli uomini in donne, e le donne in uomini
(pag. V); e ad essa lo induce il veder gli uomini del suo tempo.
Ferdinando Orland (Milano, Classicii, che fu recitato alla Scala nel lsi-2.
Sul melodramma del Oaluppi v. A. Wotql'ennk nella I/ivista musicali^ ita-
liana, VI. 5(>7.
'
A Neri, Veccfii almaaaccfii milanesi, ne' suoi Studi bibliografici e let-
terari. Genova, Sordomuti, 185)0, pag 2()1 e segg.
-
Neri, loc. cit., pag. 274.
'
Neri. loc. cit., pag. 2S4. Della toeletta, di cui tratteremo pi oltre, si
occupano molt'altri almanacchi segnalati dal Nei'i. Ricordiamo ancora, tra
gli almanacchi attrihniti a Isidoro Bianchi cremonese, i seguenti che per i
loro titoli si riferiscono ai vari argomenti da noi studiati: La conversazione
(Cremona, 1779i, Tm donna di talento (Cremona,
1783), Idee d'un orientai*-
sul giuoco del Faraone i Cremona, 1705), Idee d'un Egiziano sul giuoco del
Tarocco iX'reniona. 17!><)). Ct'r. Melzi, Dizionario di opere anonime ^
jtseu-
tlonimr di scrittori italiani, ecc., I, pag. B7.
'
L'anno niaroriglioso. Predizione del 1748. Col compimento di essa
del Jl.'td. E una lettef^a inforno all'acconciare i capelli, Yenezia. Occhi. 17.^H.
La lettera sui ca])elli tratta dell'acconciatura delle signore.
14 h'ifisto tritatili, anno MH. voi. II. tHs.-. Vili, ^Agosto IHIO).
210
I CICISBEI
sempre pi effeminati, dare altrui udienza a letto fino a mez-
zogiorno
;
rompere a mezzo un discorso grave per far conver-
sazione ad un cane, parlare con l'effigie loro ad uno specchio,
accarezzare i merletti de' loro manicottoli, dar nelle smanie,
se si spezza loro qualche galanteria da nulla, cadere svenuti
sopra un pappagallo o un canarino malato, e insomma rubare
all'altro sesso tutte le sue gentilezze (pag. IX). Il quale altro
sesso
s' dato agli studi prima riserbati agli uomini, sicch la
concorrenza reciproca : Anch'esse compongono libri. La gen-
tile Poesia divenuta un passatempo de' loro freschi anni, e non
pi. S' hanno posto alla bocca fino la tromba del Milton, agli
uomini lasciano le fabbriche de' romanzi ... e son fino a viva
forza entrate ne" pi occulti gabinetti delle scienze (pag. xii).
E veniamo alla satira propriamente detta.
III.
Essa cominci a sferzare il costume, di cui ci stiamo occu-
pando, verso la met del secolo, e lo fece con varia violenza e
con maggior frec^uenza che prima non avessero fatto i moralisti
e i trattatisti. La satira milanese contro il cicisbeismo ha per
suo principal campione Giuseppe Parini, il quale, col Giorno,
mirava appunto a mettere in ridicolo un & giovin signore
, di
quelli che l'usanza della casta a cui appartenevano destinava a
servir la donna d'altri, e la societ frivola nella quale egli s'ag-
girava e di cui era l'eroe infrollito,
i
Ma noi, dopo la ritorta che
'
Abbiamo gi citato il passo del Mattino, in cui il Parini accenna pri-
mamente alla cicisbea. In qualche altro luogo delle sue poesie minori, con
meno lindezza di poesia, e pi aspro vigor di satira, il Parini castig il
ricisbeismo. Citiamo il sermone II teatro (Parini, Opere, ed. Reina, III.
pag. I<i5 e segg.), in cui il poeta entra in teatro con quella sua Musa non
pari a putta , e cosi le dice :
Entriam dopo costui che tanto a uscire
Sta di carrozza, e seco al fianco valli
L'altrui moglie ch'egli ha tolto a servire.
Il marito aspettando a casa stalli:
E de la melonaggin del marito
Ridono i consapevoli cavalli.
Stimasi oggi un error d'esser punito.
Non che da tinger per rotisor le guance,
Veder lo sposo a la sua uoglie unito.
E finita la gelosia, prosegue, e non si teme pi il cimiero
Ch'ebbe a tempi pi rei si mala voce.
Altre coppie ugualmente curiose entrano a teatro, e noi le vedremo pi oltre.
Si ricordi il bellissimo passo della gelosia nel Mezzogiorno, vv. 1<2 segg.
1 CICISBEI 21 1
del (Homo ci ha dato il Carducci, non discorreremo del Parini.
se non. per richiamar le somiglianze che le satire di cui ci occu-
peremo hanno con alcuni tratti della sua opera.
Quel che fossero i costumi veneziani abbiamo in parte ve-
duto nella narrazione del De Brosses
;
^
solo in parte, perch
molte cose sfuggirono all'acuto e arguto francese, come ci di-
mostrano le notizie abbondanti e curiose raccolte dal Malamani.
Dai cicisbei veneziani tolse argomento per (jualche caricatura
anche la musa popolareggiante, che in quel secolo fu cos feconda
nella citt della laguna. Tra i molti canti popolari, che ci son
noti,'* uno ha appunto il titolo Et servente: il cavaliere ci
rappresentato mentre assiste alla toeletta serale della dama, ed
esprime la sua ammirazione col ritornello:
La xe pur bela.
Signora s,
Quanto una stela,
Pofar de mi I
Pi che la vardo
Pi la xe bela,
Signora si.
Di lei loda i capelli, il tup, la fronte, gli occhi, e non
guarda oltre, e di quel che, se fosse pi indiscreto, gli reste-
rebbe da ammirare, d im giudizio encomiastico complessivo:
Mi no m' inoltro,
Ma ben l'aderto
Che se pi abasso
Per a(,i dente
Con l'occhio passo,
De megio certo
No se poi dar.
'
Sul costume veneziano, oltre l'opera citata del Molmenti, e gli altri
scritti minori gi indicati, si vedano E. Masi, La vita, i tevipi, gli amici
di Francesco Albergati, ecc., Bologna, Zanichelli, 1878, pag. 2Sb e segg., ma
in particolare il bel volume di Philippe Monnier, Venise aie A'TV//' siede,
Paris, Perrin, 1907 : quivi specialmente quel che detto delle donne (pa-
gina 81 e segg). Non molto di nuovo il Monnier dice a proposito dei cici-
sbei ipag. 10(1 e segg.) Caratteristiche pitture del costume femminile vene-
ziano sono le leggiadre Stagioni, di Antonio Lamberti i l7.57-18o2, che puoi
vedere tra le Poesie veneziane scelte e illustrate da Rataello Barbiera. Fi-
renze, Barbra, 188G, pag. 146 e segg.
^
Ci furon fatti conoscere da V. Mai, amasi, // Settecento a Venezia, II : Iai
Mnsa popolare, Torino, Roax, 1892. Oltre El servente i pag. 269 e segg. , vedasi
un'altra canzonetta intitolata / morosi in rasa, e un'altra (pag. 271 n,> in
cui detto che anche i fanciulli giocavano alla dama e al cavalier servente.
212
I CICISBEI
La satira vera e propria, mentre Venezia continuava a di-
vertirsi, si diffondeva a berteggiarne e sferzarne il costume. Cos
faceva G-a spare Grozzi, ne' suoi belli ma un po' freddi sermoni,
in cui traccia bravamente dei quadretti riuscitissimi di tipi vari
e curiosi di quella societ a lui ben nota : nel sermone Del pas-
seggiare la sera in piazza, cosi egli ci descrive in pochi tratti
una dama:
Quella procede anzi veleggia intorno
Qual caravella, con immenso grembo
Di guardinfante, pettoruta e gonfia;
e cos
ci rappresenta le signore che passeggiano :
Ha ciascheduna passeggiando intanto
Due maschi a lato, e men felice turba
Che indietro segue. La beata coppia
Confitta a' fianchi, ad ogni muover d'anca
Della signora sua, misura i passi . . .
'
Altrove descrive argutamente ad una dama la passeggiata
fatta con lei in maschera sul Listone,^ a quel modo che l'abate
Frugoni aveva sognato di ritrovarvisi con la sua Aurisbe , la
bella Cornelia Barbaro Gritti
;
3
e in altro luogo, delineando il
notissimo Ritratto degl' innamorati moderni, sorride dei tanti
gingilli di cui il bel costume li costringeva ad andar forniti.
*
L'ab. Angelo Maria Labia (1709-1775) descriveva pi severamente
le donne veneziane :
.
Concier da furie, mate spiritae,
Cavei sul muso mezzi sparpagnai,
Colo nuo afato e in colo ben spalae
E do peti mostrar sempre spacai . .
.
Cotole e veste curte, e curte assae,
E stamesanti veli sui cendai.
Calza bianca e mulete e gran cordale,
Puzae con languidezza sul servente...
Occhio lascivo in ziro e seducente.
Sedizioso el parlar...''
Certo queste dame non eran modelli di seriet, e se ne videro
di quelle, accompagnate dai cavalier servente, che si picchiavano
'
(jr. G(i/j7A, (Jpere, Padova, Minerva. 1S-J((, XI, Hhi^ ^egg.
'
Gozzi, op. cit., XIII, no5 segg.
"
Sul Frugoni cfr. ancora il mio cit. voi. .su /jn Urica, ecc., pag.
2'2'2
e seg-
'
Gozzi, op. cit., XI, 339 e segg. Cfr Paki.m, Mattino, vv. KVJ e segg.
"
MaIvA-MANI, // Settecento a Venezia, 1: l,a satira del costume, ediz. cit.,
pag. 2!' (^
seg.
I cicisBKi 21:;
plebeamente sotto le Procuratie vecchie. Di .scandali, noto, fu
piena la vita delle due cognate, Caterina Dolfin Tron e Cecilia
Tron, che erano, specialmente la seconda a cui tocc la ven-
tura d'esser esaltata dal Parini) (jualcosa di peggio che .semplici
cicisbee: amante la prima di Carlo Grezzi e d'altri e causa della
famosa questione del gentiluomo Gratarol, amante la seconda di
Cagliostro e d'altri assai.' Sicch i loro salotti erano assai poco
reputati, sebbene sappiamo che poco oneste erano anche in ge-
nerale le conversazioni che si facevano dopo il teatro:
2
quest'ul-
timo pregio non era proprio soltanto di Venezia, jjoich a Roma
sul finire del Seicento il teatro di Tor di Nona fu demolito per
porre fine alle oscenit che si commettevano nei camerini e nei
palchi.
La rilassatezza del costume era anche nel clero : quante ca-
ricature sono toccate per questo agli abatini del secolo xviirl
Che l'abate in quel tempo fa il paio col cicisbeo, e spesso, come
vedremo, una sola persona con esso. Di un abate zerbinotto,
dalle scarpine sempre lucide, il Frugoni chiamandolo < abate
Tulipano immagina che Venere stessa gli mandi un messo per
avere una di quelle sue scarpine di cui essa s' invaghita, e che
gliene scriva proprio cosi :
Abate, anilina mia. datemi {uella
Cosi rara scarpetta, e mi vedrete
Pisciarvi dentro, e poi cangiai la in stella."
In una poesia satirica veneziana si lamenta qualcosa di peggio:
Vedo pi de un abate a dar el brazz<
A Ninfe che frequenta vie remote.
*
'
Su Caterina Uolfiu Tron v. Ph. Monxibr, op. cit., pag. 18 e seg. e Ma-
LA.MANI. op. cit., I, pag. l'29 segg. Su ambedue, ma in particolare su Caterina,
vedi Enrico Ca.stelni;()vo, Una dama reneziana del spcoIo XVIII (nella
Nuova Antologia, 15 giugno 188*2i.'che ne ha tentato una difesa.
-
Maij\.mani, I, 86 e segg.
''
Frugoni, Poesie, Lucca, Bonsignori, l78o, XV', pag. 120. Degli abati
cicisbei si rideva anche il Borsetti icfr. E. Rertaxa in (iiornole stnr. di'llo
letter. ital., Supplemento 1, pag. 25, n. ;>
.
*
Mai.amani, 1, pag. 107.
214 I CICISBEI
E agli abati non la cedono in questo i preti :
A. prender el frescheto su la bruna
Anch'eli va co la so ninfa al fianco,
E el viazo va a finir su qualche banco
Per contemplar i quarti de la luna.'
Pi discreta la satira veneziana nel parlare del costume
delle monache,
^
di cui abbiam gi veduto quel che dicono altre
testimonianze, tuttavia un satirico fa una riserva che conferma
in parte quel che gi ne sappiamo :
S ben che se averave assae da dir
Sui vizi che le porta, e sul vestir
Che le ha introdoto ancuo per parer bele.
Compendiava i vizi del sesso femminile veneziano una satira
efficace, la quale si rivolgeva alle donne perch mutassero vita . .
.
in occasione del giubileo del 1777:
Licenzi afato el cavalier servente
Che v'ha fato ogni di da belo e scaltro.
Diseghe pur che za no vol altro
Far de pi mormorar tuta la zente.
Lascino i
casini ; allontanino i parrucchieri, zerbini in-
fami e ganimedi impuri ; non faccian pi maldicenze nelle con-
versazioni, al caff. Si correggano anche da altri difetti e usanze
non belle:
Quel andar in remorchio o pur al corao
Butae zo in trasto in atto lussurioso,
'
Malamani, I. pag. l'J8. A questo lamento dei satirici veneziani ta
riscontro quello del Parini nel sermone 11 teatro, che abbiamo gi ricordato:
il fiero poeta ci dice che a teatro andavano anche frati mascherati (e ne
traccia una figura comica e laida), e abati:
Debl' io tacer per che spesso misti
Anzi allacciati in un con Clori e Filli
I vezzosi abatin giunger ci ho visti?
E grondar tutti di odorose stille
Co' manichetti candidi d'Ohinda,
E i ricci in su la testa a mille a mille?
''
Mai.amani,
1,
pag. Il; e seg.
k
I CICISBEI 215
Col servente viciri o col moroso,
Perch d'of^ni riguardo el rompa el UK^rso;
Quel permetter che el busto lu ghe impira
Senza pi incomodar la camariera.
Far che in camera el staga anca la sera
Fin che in letto spogiae le se destira;
Le xe al mio creder cosse disoneste
Che fa scandalizzar i servi in casa,
E che no gh' pericolo die i tasa...'
Fj passiamo alla Toscana. Quivi non sar senza curiosit
cominciare da una cantata
<'
a una voce composta dall'improv-
visatore Bernardino Perfetti, celeberrimo a' suoi d, intitolata
'ericoli del cicisheato.
''
Una nuvola leggera
L'altro giorno s' inalz,
Ma dal Sol ])0 riscaldata
E cresciuta e condensata,
Ad un tratto si f nera,
E con grandine e con lampi
Le capanne e i nostri campi
Quella nube rovin.
Questo racconto fa ad un saggio pastore un'arcadica Glori, e
quello spiega moraleggiando che anche l'affetto per il cicisbeo,
che nasce nel cuore della bella Glori, pu mutarsi in nera e
torbida passione . Pi vivace intenzione satirica si prefisse Lo-
renzo Pignotti in quel suo poema La treccia donata di dieci canti
in sestine, inspiratogli dal Riccio rapito del Pope. Il secondo
canto ha per titolo Origine del cavalier servente, e in esso il
Pignotti immagina che Amore, inorridito per le tante atroci
tragedie coniugali, provocate in Italia nei secoli scorsi dalla
gelosia, abbia impetrato da Venere che i mariti divenissero di
cuore pi mite:
Regnar le donne allora, e con industri
Arti cercar per celebri avventuie
Di rendere i lor nomi al mondo illustri."
^
Malamani, I, pag. 152 e segg.
^
B. Perfetti, Saggio d poesie, Firenze, stamperia Bonducciana. 1774.
pag. HH()
e seg.
''
L. Pignotti, Poesie, Firenze, Molini, 1820, pag. 5GG. Su questo poema
del Pignotti, vedi L. Rossi, La freccia donata, poemetto eroiconico di L. P..
Padova, tip. (Jallina. U(t(i.
216 I CICISBEI
Allora esse pretesero l'omaggio e la servit d' un cicisbeo
;
anzi alcune non contente di quello del cuore, ne ebbero pi
d' uno d'etichetta :
Al molle braccio altri sostegno eletto :
Dell'angle cagnolin quello custode:
All'argenteo scaldino questo addetto:
Tutti lian merc : con dolce nome s'ode
Quegli appellar, questi un sorriso, ed have
Un guardo o un tocco della man soave.
Anzi i cicisbei piacquero anche alle vedove. Il Frugoni, che
in un sonetto (// moderno cicisbeato)^ aveva denunciato come
assai pericolosi i cavalieri serventi, egli che non fu mai stanco
di cicisbeare e di corteggiare le belle donne, in un'altra sua
poesia consigliava alle vedove di non rimaritarsi, ma di sce-
gliersi un cicisbeo discreto
.-
Ora una novella di U. De Cou-
reil
*
ci offre la storia d'una vedova, che alla morte del con-
sorte parve e tu creduta inconsolabile :
[1 cicisbeo medesimo
Che del consorte in vita
L'avea costante e assiduo
Di braccio ognor servita.
Invan quel pianto a tergere
Adopra ogni ragione.
Usa invano artiHzio,
Lusinghe, adulazione.
Ma che ella si fosse consolata, rinnovando ancor una volta
la storia della matrona d' Efeso rinarrata nel Settecento da Eu-
stachio Manfredi, dimostr il fatto che dopo parecchi mesi le
nacque un figlio, che era . . . troppo postumo : il cicisbeo aveva
certo saputo mettere in pace il cuore della vedova desolata.
Ahbiam veduto quanta parte alla vita mondana prendessero
*
Frugoni, Poesie, Lucca, 1780, voi. XV, pag. -JUti.
-
Fku<ON1. Poesie, Parma, Bodoni, l77!t, TX, ISS e segg.
'
Opere poetiche det co. Giov. De CointEiL, Firenze, I7f>'i, Grazioli, tomo I.
pag. 144 e segg.: Novella IIL II Dio Courkii,, lop. cit.. I, pag. 54 e seg.i in
una sua tavola ilib. I, fav. 20*: L'anatra, la gallina e i pulcini), nell'anitra
che d le uova da covare alla gallina, e nei pulcini che poi non riconoscono
pili per madre l'anitra, volle satireggiare, come non pochi altri autori del
Settecento, tra cui il Parini, il costume di lar i tigli da nutrire e allevare
ad estranei (ctV. 1'.\rini, .\fezzogiorno, vv. 70 e segg).
L
I CICISBEI 217
in Roma cardinali e altri prelati: (;hi sa (luariti intrighi non
arcadici n platonici si avviarono tra le compiacenti ombre del
Bosco Parrasio, e quanti pastori e quante pastorelle provarono
nella realt sentimenti vivaci e turbamenti di passione che ve-
larono poi di platonismo j)etrarchevole e rinverdirono di fronde
pastorali nei sonetti che noi oggi accusiamo di pochissima sin-
cerit! Da due ecclesiastici muove nel primo trentennio del Set-
tecento la satira romana contro le r-oppie cicisbea : di mons. Ni-
col Forteguerri abbiamo un capitolo in derisione de' cicisbei,
al padre Ijiborio Venerosi pisano
;i
ed a mons. Lodovico Ser-
gardi dobbiamo la curiosissima satira intitolata: La con Kernazione
delle dame di Roma, dialogo
fra
Pasquino e
Marforio.
2
Quivi
l'arguto Quinto Settano {La convei-Hazione una delle satire pi
gustose del secolo xviri) immagina che i due rappresentanti
dello spirito satirico romanesco sian divenuti nobili, e discu
tano fra loro sulla convenienza d'accettare, con gli altri privi-
legi del loro nuovo stato, anche l'uso del cicisbeismo. Marforio
esalta questa istituzione, che ha fatte pi discrete le riunioni,
pi mite il costume, pi placidi i mariti e i parenti delle belle
signore; ed tutto per il nuovo galateo, in virt del quale una
dama
Gli ossequi pu d' un cavalier gradire
Sotto nome gentil di cicisbeo.
Ma non vi si pu adattar Pasquino, nel quale rimasto pi vivo
il buon senso plebeo. Dalla parte sua Marforio combatte la ge-
'
in alcune edizioni ha il titolo di Critica della cicixheatura. Comincia
Odi, Liborio mio, e Fautore toglie occasione a criticar fieramente i cic3l>ei
dall'invito che una hella signora gli fa invano di divenir suo cavalier ser-
vente. Contro le dame cicisbee sono anche talune terzine del capitolo pre-
messo al Ricciardetto :
Consumau la lor vita e i lor talenti
Maneggiando le carte od a lo specchio
O in dire e far co i cavalier serventi.
-
La con oersazione delle Dame di Roma, dialogo fra l'asquino e Mar-
forio Di fresco venuti alla nobilt, in cui Martorio persuade Pasquino ad
accomodarsi alla moda della conversazione provandogli ad evidenza, che tra
Dama e Cavaliere, stante la nobilt, non pu esservi punto di male, n da
fare inombrire alcuno, bench premurosissimo dell'onore . iln Giulio Cer-
cano, Raccolta di poeti satirici italiani. Torino, Biblioteca d. comuni ita-
liani, 185;i, voi. II, pag. 677-701). Ne conosciamo un esemplare manoscritto
nella comunale di Perugia icod. M. 15, ce. UH-UJiH. in cui gl'interlocutori
sono ribattezzati in Fabio e Persico.
218 I CICISBEI
losia, inutile ed oltraggiosa, se eleva sospetti sui diportamenti
d' una dama e d' un cavaliere, entrambi nobili. Pasquino trase-
cola: non riesce a capire come mai possano un giovane signore
e una giovine signora, star da solo a sola per ore ed ore senza
far del male. Virt soltanto, virt esclusiva, rincalza Marforio,
della nobilt di sangue,
Che gli aifetti volgar tenendo a freno,
Opera che la parte intellettiva
Del sensuale amor sprezzi il veleno:
E da questo disprezzo ancor deriva
Un magnanimo sdegno ad ogni eccesso,
Che offender pu la nobilt nativa.
Tutto ci riesce incomprensibile a Pasquino, il quale obbietta
un argomento che gli pare formidabile:
Dimmi, non la carne di costoro
Carne come la tua, come la mia?
Allora Marforio fa una lunga, imbrogliata spiegazione sulla
nobilt di sangue e un parallelo tra nobile e plebeo, dove l' ironia
s' affacci a qua e l tra verso e verso. Ma Pasquino ha l'obbie-
zione anche a questa spiegazione gentilizia : o come va, chiede
all'amico, che soltanto le dame belle e giovani hanno il servente,
mentre le brutte invecchiano imbronciate e solitarie ? Allora Mar-
forio, da personaggio del suo tempo, sfodera una sua teoria pla-
tonica del bello, la stessa del resto in cento sonetti proclamata
dall'accademia di Arcadia in quegli anni di ridesto petrarchismo ;
ed al suo compagno, che ragiona ancora materialmente, spiega
la belt divina infusa nella donna, sicch chi ama il bello mu-
liebre, ama il riflesso della bellezza celeste; e conclude trion-
falmente che hanno mille ragioni i cavalieri, ad amar le belle,
essendo la belt dono di Dio . Pasquino per ora vinto.
Quindi Marforio comincia a parlargli dei trattenimenti signorili,
delle conversazioni, cos animate
('he tu sempre veiirai, che corteggiate
Sono le dame, e in stretta confidenza
con il cavaliere, o con il frate.
Come? anche i frati? interrompe quel buon uomo di Pa-
squino, a cui tutte codeste diavolerie di costumi aristocratici
non vali gi.
Frati, sicuro, risponde l'altro; n la cocolla ci
fi.
I CICISBEI 219
perde : vedrai frati che giuocano a carte, frati che vanno in giro
in maschera con la dama
Travestiti da Zanni o da Cuviello;
'
persino i gesuiti stanno al giuoco. E prosegue: immaginiamo di
trovarci in una casa nell'ora della conversazione : ad un balcone
vedi la dama che ascolta le dichiarazioni del cicisbeo :
Si, ma questo non causa, ombra di male;
Scherzan fra lor con innocente amore,
E non entrano mai nel criminale.
Si fa all'amore per ispasso, senz'ombra di male : vedi pre-
senti, testimoni compiacenti, mariti, fratelli, padri, senza che
alcun d'essi s' ingelosisca. Poi vien portato il tavolino della bas-
setta e si giucca. E poi si fa il giuoco dei pegni, quello predi-
letto dalle coppie cicisbee, che mettendo in esecuzione mille in-
gegnose invenzioni, una pi ardita e pericolosa dell'altra, danno
prova di valore e di sangue freddo che invano cercheresti in un
plebeo:
Mira col quel che contento e senza
Toccar le labbra, toglie dalla bocca
Della Dama lo spillo loh che avvertenza!
;
Mira quell'altro dee spuntar la rocca
Tra il petto e
'1
busto di colei confitta,
Ed destro cos, che non la tocca.
Quell'altro deve della gamba dritta
Di quella Dama (osserva il gi-an cimento i
Senza scoprirla, sciogliergli la vitta.
insomma il trionfo dei cicisbei e dei milordi >. che si equi-
valgono, e di cui Marforio sa tracciarci due arguti ritratti. Dopo
tutto questo Marforio termina con un evviva all' uso nuovo che
Accorda fra l'amore ed il decoro
L" innocente armonia, e fa tornare
Al mondo il gi perduto secol d'oro.
Pasquino ormai arciconvinto della bont del cicisbeismo.
Da Roma risaliamo a Bologna, donde il
p.
Appiano Buona-
fede, a tutti noto per l'acre polemica ohe sostenne col Baretti.
ma di cui non tutti sanno ch'egli fu uomo di sodissima coltura
'
Si ricordi la testimonianza, gi veduta, del Tariui // teatri' .
220 I CICISBEI
e uno de' primissimi banditori d'un nuovo verbo filosofico e poe-
tico in Italia, e' invia i suoi Versi liberi, e ad essi manda in-
nanzi un'interessante prefazione, ricca d'idee moderne e ardite
per quei tempi.
'
Di molte cose egli tratta in questi versi, che
s'armano spesso degli strali satirici, n gli sfuggono i vizi del
suo secolo
;
e mentre esprime idee coraggiosamente democratiche,
critica aspramente il costume muliebre : come l dove descrive
Licori, tardi uscita di letto, dopo un sonno agitato, la quale
perde gran tempo
A quella tavoletta che d' inganni
E di compre bellezze la custode,
per restam'are la compromessa belt del viso
;
e che poi esce a
braccio dell'amante per divertirsi.
-
Ma ecco uu bozzetto, in cui
'
Versi liberi di Ayatopisto Cronaziano il Buonafede) messi in luce da
Timoleonte Corintio con una epistola della libert poetica, Cesena, Bia-
sini, 176B.
'
Versi liberi cit., pag. M e segg Quanti autori nel Settecento trattaroim
di quel sacrario della bellezza che fu in ogni tempo la toeletta! Il Bondi
nel suo poemetto su La Moda [Poesie,Yieiina.,
1803,1, pag. 205 e segg.) descrisse
il gabinetto di toeletta delle dame alla moda
;
per un'ode ne prese argomento
il genovese F. Gastaldi (cfr. V. A. Arullani, Lirica e lirici nel Settecento,
Torino, Clausen, 1893, pag. 121 1. Garbato un ditirambo, che prende occa-
sione dalla toeletta, di Tommaso Gargallu ili Poeta e la Toletta, ditirambi,
Palermo, Lorenzo Date, 1822) : una dama matura, mentre sta a rinfronzirsi
allo specchio, ha la sventui'a di scoprire un biglietto galante che il suo
cicisbeo ha scritto alla sua stessa cameriera, meno nobile certo ma e pi
giovane e pi appetitosu. Interessante specialmente una relazione in
prosa, del 1795, di G. Gherardo De' Rossi, il quale assiste alla toeletta d'una
signora e del suo cicisbeo icfr. Do-MENICO Gxoli, La Toletta d'una signora
di G. G. De Rossi, ne' suoi Studi letterari, Bologna, Zanichelli, 1883, pa-
gina 341 e segg.). Un altro poeta ci rappresent una dama alla toeletta,
mentre s'incipiiava ((tIov. Ant. Vor.i'i, Rime,
2-'
ediz., Padova, Cornino, 1741,
pag. 189):
Quella che fa ne' cor piaghe profonde,
E scema i pregi a Palla e a Citerea,
Bianca polve trattava, e ne spargea
L'oro forbito delle trecce bionde.
Ma l'autore disapprova l'uso della polvere, di cui fra (jaHlclie anno il grande'
Pariui doveva ironicamente esaltare l'invenzione:
Non dee chioma si ricca, o si lel viso
Vani ornamenti ricercar dall'arte.
Una poesia intitolata Ixi Toeletta tra quelle di (Juskim'k Passkki
{Saggio di poesie, Napoli,
17<if)i,
diretta ^ donna Vittoria Giievar diKjhessa Ca-
L
I CICISBEI 221
la satira del si volge ad intento nociale, e ci fa sentire gli stessi
principi che in quegli anni, o poco dopo, l'abate di Bosisio faceva
rafa di Maddaloni. 11 Parini descrisse, noto, largamente la toeletta del giovine
signore {Mattino, vv. 469 e segg.), e vi incluse la favola dell'invenzione della
cipria (Afrt//mo, vv. 750 e segg.); e poi accenn pi lirevemente alla toeletta
della cicisbea { Mezzo;fiorno, vv. 30 e segg
j.
Ne pochi poeti cantarono altre cose relative all'acconciatura muliebre
nel Settecento. Si ha un poemetto / nei (Venezia, Graziosi, IT'JHi, forse di-
verso da un altro del Vittorelli (cfr. Agnelli, Precursori e imitatori del
Parmi, pag. 58 59). Il Tape fu cantato dal Vittorelli; (cfr. Agnbli>i, Precur-
sori e imitatori del Parini, pag. 66 sgg.); e Gaspare Gozzi scrisse In lode del
tiip un capitolo di scarso valore (Gozzi, Opere, Padova, Minerva, 1820, XIV,
pag
12r) sgg ). Delle pettinature .si occup l'autore di quella predizione del 174H,
Jj''anno meraviglioso, che abbiam gi veduto: < Vedevansi capelli leggeri, on-
deggianti, che leggiadri cascavano di qua e di l sulle guance, facendo al viso
come un (jontorno, o gentilissima frangia, che l'orlava con un vistoso garbo,
e con una pittoresca delicatezza; standosi quasi tutto coperto l'orecchio,
salvo quella poca polpa vermigliuzza dove gli orecchini si sospendono.
Og-
gid aH'inconti'o. tutti i capelli tiraiisi all'ins, se ne fa una massa solida,
che lascia tutti gli orecchi scoperti, e non solo gli orecchi, ma tutto il collo
per lungo e per largo (pag- LIV sg.). Altri si occ iparono dei vestiti : e lo
stesso autore di questa predizione trattava del vestire d'amazzone,...
molto somigliante a quello de' maschi ipag. XXIV sg.). Il Frugoni ci de-
scrive la perfetta acconciatura del capo fatta da un industre parrucchiere
francese alla marchesa Fiordcspina Zavaglia di Ferrara, che venuta a Parma
brill all'Opera e alla Corte (Frugoni, Poesie, ediz. di Parma, X. 184 sg. .
Come poteva il Frugoni, ammiratore impenitente delle belle signore, non
ammirarne anche e cantarne le vesti che davano risalto alla loro leggiadria ?
Quando la contessa Giusti Boni, una sua fiamma parmense, indoss una
andrienne di tela bianca ricamata a fiori di seta, venutale da Parigi ( Senna
maestra del vestir gentile
,
come diceva il Frugoni, ne esalt la perfe-
zione in un sonetto (Poesie, ed. di Parma, II. 213. Di quella foggia sette-
centesca, che fu Vandrienne, sci-issero anche il Roberti e il Baruffaldi (vedi
Vandrienne nel Volume primo de' Baccanali, di Girolamo Bariffalpi,
2'
ediz.. Bologna, della Volpe, 1758). Il petanler, leggiadro vestito, fu can-
tato dal Frugoni stesso in una vivace canzonetta {Il petanler color di rosa.
in Poesie, ediz. di Parma, VI, 148 sgg.i, ed ricordato anche nelle satire
veneziane (Malamani, Op. cit., II. pag. 251 sg.). Che dire dei manicotti/
Alla fine del
'500
Angelo Ingegneri scrisse una canzone Per una maniza
donadagfie da la so' morosa {Poesie veneziane, scelte ecc. da R. Barbiera.
citate, pag. 12 sgg.)
;
e il Frugoni [Poesie, ed. di Parma. II, 28!M ne cant
un'altra d'una contessa parmigiana. Nel
'500
il ventaglio era stato argo-
mento di versi per Francesco Sansovino (Sopra i ventai de le donile, nella
raccolta Dell'opere burlesche di m. F. Berni, ecc., Usecht, 1726, III, pag. 50 sgg.
i;
e quanti se ne scrissero nel '7(X)! E basti di questa nota, che potrebbe as-
sumere ben altre proporzioni, se volessimo trattar con la necessaria accu-
ratezza il tema attraente, in cui rientra, con ben diversa intonazione ed
222 I CICISBEI
squillare ne" suoi versi sciolti bruniti suil* incudine e martellati
con muscoli plebei :
Era scorso il meriggio e Fille avea
Compiuto a stento il pigro sacrifizio
A Venere marina. Adorna e pinta
D'infinite lascivie era Timmago.
Era ogni parte in lei fulgida e colta
Fuor che il celabro sol che in lei non era.
Tirsi sollievo de' donneschi affanni
E della maritai noia ristoro,
Tirsi per vanit di capo eguale
Alla sua vaga belva in volto umane
Seco dolcezze e favole mescea.
Quando col dove teneano insieme
I due novellatori il parlamento.
Un villanel di polve e di sudore
-asperso venne e l'ode rosa Fille
Gravemente fer d'ettuvio ingrato,
Tal che impedite al respirar le vie,
Chiuse i begli occhi e svenne: e Tirsi vinto
Da pi etate e da sdegno, aperto in prima
II cristal colmo d'odorifer'onda
Sacro arnese de' molli, i spirti erranti
Chiam all'uffizio usato, e Fille visse.
Indi tal f' del villanel vendetta
Che il campo suo ne senti lungo il danno.
*
Poesia scadente davvero, se ne togli il concetto. Dozzinale
anche quella che ci viene da Napoli in un poemetto di metro
anacreontico, che s'intitola Amore disarmato, e di cui ci ri-
masto ignoto l'autore.
1
Ma quante verit messe bravamente a
nudo in que' sei canti di sestine ottonarie, quanti colpi bene
aggiustati al secolo corrotto e crollante, quante invenzioni sa-
tiriche degne di miglior poesia! In fine al poemetto, un nobi-
elevatezza, l'ode pariniana A Silvia Rimandiamo pertanto i lettori ad al-
cuni articoli, curiosi anche per le illustrazioni che li adornano, relativi a
questa parte del costume muliebre settecentesco: A. Bisconti, /m dama e
la sua toletta nel Settecento lin Natui-a e arte, 1895, n.
19),
P. Nuhra, Una
pagina di storia del costume femminile lin Emporium, marzo 19<X>, pagg.
*214-
231),
AcHiLLK FiMiMMNi Fantoni, // ventaglio e la SUO storia {\n Eviporium,
luglio 1895, pagg. 52-70), Jacopo Gelli, Vn po'* di storia del busto e della
fascetta (in Emporium,, giugno 1903, pag. 459 sgg).
'
Versi liberi, di Aoatopisto Cro.maziano, gi cit
,
pag. 24 sgg.
'
Amore disarmato. Poemetto. Napoli, nella stamperia Poraatelli al segno
del disinganno, 1768.
L
I CICISBEI
22.'5
lissimo motto di Erasmo : Admoiiere voliiimus, non mordere :
prodesse, non laedere: oonsulere moribus hominura, non officere .
In effetto l'intenzione dell'anonimo poeta elevatissima: egli
deplora lo sfacelo della famiglia, causa del deperimento della
nazione italiana, e la decadenza intellettuale di essa:
Da ciascun veggo adorata
La pi vii fatuit,
l'erch' d'oro, e d'ostro ornata,
E di mille vanit;
Pure ascoi tan suoi precetti
Vecchi stolti e i giovinetti (pag. 9).
Il poemetto ha il titolo dalle strane avventure d'Amore,
esautorato da una Nice
;
ma il poeta ne prende occasione per
mettere in satira tutti i difetti e le classi de' suoi tempi. Tocca
motivi ormai frequenti nella poesia satirica e burlesca di quel
secolo, quando si scaglia (;ontro i poeti :
Si i'ecida un l)iond crine.
Od un secco allor si doni.
Si mariti Fabio, o Frine,
dal pulpito un ragioni.
Da costoro pur s'aspetti
Un profluvio di sonetti (pag. S):
contro la moda e il lusso (pag. 61); contro il punto d'onore
che pone la ragione sul filo d'una spada, ma poi non vieta tante
e tante azioni disoneste:
Chi ripien d' un Dio si forte,
L'altrui ben ruba, e smantella.
Pu sedur l'altrui consorte.
Violare una donzella,
Esser empio, e traditore.
Senza mai perder l'onore
ipag.
5Si.
Il nostro anonimo ci d pi oltre il ritratto d'una dama, che
amava gli studi degli uomini, compresa la profonda matema-
tica (pag. 74 e segg.), e mette in caricatura le donne scienziate
del suo tempo, come gi il Martelli nelle sue satire aveva sma-
scherate tante pastorelle d'Arcadia, che passavano per poetesse
petrarcheggianti con dei sonetti che si facevan fare da poeti di
224 I CICISBEI
professione pagandoli con delle concessioni di genere non pla-
tonico :
Tutte san la teoria
Sin de' moti della Luna.
E ineguale perch sia.
Noto
'1
metodo a ciascuna
Delle linee curve, e quale
Calcol sia diifei-enziale (pag. Hi).
E si domanda con finta ingenuit:
Pure a voi, t'emminiiiei spirti,
Imparare or si permette
Tante scienze alla Toilette?
Ma il nostro satirico T ha a morte specialmente contro i
cicisbei :
Peste rea dell' uman genere.
6ozzi osceni Cicisbei,
Sagri a vile infame Venere.
Mentre io scrivo i versi miei
collo .stil ferreo, venite
Ch'io vi guati, e poi fuggite.
Al color pallido e fosco,
Ch' di moi'te il reo colore,
Infelici io vi conosco.
Il piacere insidiatore
Nuovo morbo a quel vi apprese,
(Jhe lai lombi aviti scese (pag. 81).
Noi tutti italiani, che altro siamo, grida, se non una razza di
cicisbei, smidollata e scervellata, buona a nulla?
Da una schiatta tosi frale,
Cosi stupida, e leggiera,
E vii serva <iel su( male.
Or la Patria indai-no spera
La difesa, o])re, o consigli
;
Ma essa ])ur langue coi tigli pag. H2i.
r)r non hanno dunque ragione i] negli oltramontani (il La-
niartine ebbe in (|uesto, chi noi sapesse, dei j)re(ursori), i (juali
dicono
Fatta gi l'Italia al fine
Vun ti>ml)a alta li polve,
I CICISBEI 225
Urne, scheletri, e rovine,
E corrosi marmi involve,
N altro pi presenta a noi
Ch'ombre vane, e vecchi eroi pag. 84 1.
C' bens un letteratone, di cui il poeta ci fa il ritratto, che
pubblic assai libri, e li regal per divulgarli '^pag. 89j:
(Mille tomi ei cacci fuori,
E ognun sa che dotti sono);
egli ora, forte della propria grandezza, s' presa la briga di
difender l'Italia contro gli attacchi degli stranieri, che la ve-
dono estranea al movimento intellettuale che si va maturando
in Europa; ma a che varr la sua dottrina? A chi si possa al-
ludere in questo tratto non sapremmo. Il nostro anonimo, da
uomo moderno, non vuol tanti poeti n tanti dotti, e per con-
siglia i genitori a dare i figli al commercio :
Quel raestier che d dell'oro,
No, per Dio, no un disdoro ipag. 91 1.
Egli penetra anche nei monasteri, dove per varie testimo-
nianze abbiam veduto che la castit aveva gettato alcuni dei
suoi veli. Che fanno esse nel chiostro
Molte belle monachine
Giovinette tenerineV
Mettono in pratica del loro meglio una ricetta che Amore ha
loro lasciato, per cacciar la malinconia :
Recipe: nel dormitorio
Libbre sei di libert,
Ore tre di parlatorio
Con virile societ,
E si chiuda a un tempo istesso
Agli scrupoli l'ingresso (pag. 100).
Le allusioni e le caricature satiriche s' inseguono rapidissime:
ora contro il teatro, dove la folla ha il suo seggio :
Sul Teatro quindi lian corso
Uomin, bestie, e vaghi suoni :
Correli tutti a veder l'Orso,
E il confuso ordin d'azioni ipag. 103i;
15 _ liicisUi dlUtUa, anuo XIII. voi. Il, taso. Vili, (Agosto 1910).
226
I CICISBEI
ora contro i nobili, die fanno far anticamere lunghissime a chi
non di nascita aristocratica :
Eppur quanti servidori
Hanno un'aria signorile.
Perch figli de' Signori?
Quanti poi d'aspetto vile
V'ha signor, perch'essi afte
Son figliuoli di Lacch V
Qui la satira sibila come una frusta agitata con violenza. Se-
guono altre macchiette: ecco un predicatore che provvide a
farsi un uditorio di donne famose per nobilt e leggiadria, e
che sarebbe stato ugualmente buon commediante :
Non mai l'alme egli cont,
Che compunse e converti.
Ma ben sempre numer
Le carrozze, ch'ogni d
V'eran per lunga distesa
Alla porta di sua Chiesa ipag. 109 segg.);
ecco un marchese che soifre di consumazione dorsale per
stravizi
;
ecco una dama, Erina, che soffre di fantasia : ha
preso caff, legge distratta, piglia tabacco, sbadiglia, e lo specchio
dinanzi al quale si sta pettinando la spaventa perch vi si vede
ammalata. Mentre le cameriere l'acconciano.
L'adorata diva, e bella
Bacia intanto un canarino;
Stride e sgrida una donzella,
vezzeggia un cagnolino.
Oppur chiacchiera, o tempesta
Contro quella cosa o questa.
Se talor le siede a lato,
Come l'uso oggi fa legge,
Scaltro abate effeminato.
Sorridendo ella corregge
Lenta col ventaglio i diti
Lascivetti, avidi, arditi ipag. 114).
Negli ultimi due canti il poeta si occupa in particolare della
vita coniugale: ahim! Imeneo pericolante, percli il vero amore
non unisce pi gli sposi, e le donne, liberali j)iii che in ogni
I CICISBEI 22.7
altra et^ vogliono ai fianchi
uno stuol d'innamorati " pag- 131 ..
E il nostro satirico tocca dei tasti, che diremmo pariniani, lamen-
tando che i cicisbei guastino l'animo delle donne e If- rendano
ribelli ai loro mariti:
L'altrui sposa negli amori
Oggi serve del bel niornlo
Agli oziosi abitatori.
Della moglie intanto il pondo
Hanno i docili mariti
;
E alla mensa i parassiti,
Coi cascanti cicisbei
L'altrui sposa il giorno spende;
Se la notte star con lei
Il marito poi pretende,
Increspando allora il ciglio,
Va fingendo alcun periglio <pag.
13-2 .
E poco pi oltre, un altro particolare prezioso per conoscere le
relazioni coniugali della cicisbea :
Sposa tenera innocente
Se trovar nel letto crede
Quinci
'1
sonno e Imene sente.
Presto il gomito, ed il piede
Via ritraggo, e si s'offende
Che l'anelito sospende (pag. 133 1.
'
Che le sante ironie del Parini fossero ripetute era cosa ne-
cessaria e provvida, anche a costo di esser guaste come nella
strofa precedente che ritrae il ribrezzo della cicisbea di fronte ai
diritti d'Imeneo. Conseguenza di queste relazioni tra i coniugi
*
Si confrontino rjuesti versi con quelli bellissimi del Parini (Mezzo-
giorno, vv. 41B sgg ] :
Oh come spesso
La Dama dilicata invoca il Sonno
Che al talamo presieda, e seco invece
Trova Imeneo; e stupida rimane
Quasi al meriggio stanca villanella
Che tra l'erbe innocenti adagia il fianco
Queta e sicura; e d'improvviso vede
L"'^n serpe . .
.
228
I CICISBEI
il poco amore delle madri per i figli concepiti in amplessi
svogliati e sonnacchiosi:
Nascon simili ai parenti
Con un'indole infelice
Empi i figli ed indolenti.
Per poter la genitrice
Vezzeggiar poi cani e gatti,
Solft-e ch'altra i figli allatti pag 1351.
(Quindi anche i matrimoni son divenuti meno frequenti, mentre
A capire i naturali
Sparsi figli della sorte
Pi non bastau gli spedali pag. 146 1.
Cosi amore ha cangiato natura, dopo che i cicisbei han so-
stituito i mariti. Eppure quanta felicit in quelle coppie che
l'amore ha congiunte e rende felici ! In esse vede il nostro buon
autore l'avvenire della nazione:
Ecco gi ne" tgli Amore
Versar sue grazie leggiadre,
La virt del genitore,
La bellezza della madre ip. 154).
Con questo augurio si chiude il satirico poemetto, cos no-
bilmente ispirato pur nella sua disadorna veste poetica, nel quale
da Napoli una voce onesta faceva eco a quella del Parini.
Questa letteratura, che metteva in parodia o satireggiava
aspramente il mondo dei cicisbei, ebbe ditlusione appimto dopo
il Parini, e noi ci intratterremo ancora intorno ad alcuni minori
prodotti di questa imitazione pariniana, che altri hanno gi
studiata. Una Scuola degli amanti del 1779, danonimo,
i
imita
volgarmente il Parini insegnando ai giovani inesperti l'arte di
vincere e tradir le donne. Vi si dice quali doti deve possedere
il giovane galante: sia sempre provvisto di notizie delle quali
si pasca la curiosit mondana delle signore; sappia
Qual di Temi seguace, o Guerrier duce
NaiT avvolto la fama in nuovo aifanno
Per la vezzosa danzatrice, a cui
Il parterre profonde i plausi suoi ip. JO);
'
Scuola degli cinaufi, Venezia, Palese, 177!>: sono due canti in ot-
tava rima.
L
I
CICISBEI
^'^^
sappia
anche
descrivere
minutamente
e da
buon
intenditore
eguale
all'esterno
vespt-rtin
passeggio
iNuova
brillasse
ed avveduta
Frine,
e di (luali
vesti fosse
adorna,
i
Inoltre,
secondo
gli
avvertimenti
gi dati dal
Parmi e dal Gozzi,
possegga
un
astuccio
inglese
con
pinzette,
forbicine,
spilli; e
Colmo
cristal
di spiriti e licori,
Quando il finge una donna,
oppur vien meno.
Abbi, che
all'uopo i pali)iti e i vapori
Sedi, o
qual altro mal le serpe in seno.
Il
galante
cavaliere
compir
i suoi
pregi
parlando
francese e
sapendo a tempo
offrire alla
dama una
poesia, o sua o. che
fa lo stesso,
scritta da
qualche
rimatore
affamato
per lui
(p.
B4).
A
proposito
degli
svenimenti e dei
deliquii,
in cui
facilmente
ca-
devano
le sensibili
dame del '7(X),
vi fu chi dedic
ai cicisbei,
damerini e amatori
languenti,
una sua
predica
morale, m forma
scherzosa,
su Le
convulsioni
delle signore di beilo
spinto.
-'
Come c'era
stato
un maestro
dei
cicisbei,
cosi si ebbe chi
scrisse
nello
stesso
anno La scuola
delle dame,
dedicandola
alle
'
Questi versi ne richiamano
ad ognuno altri ben noti del Parini I Mattino,
vv
208-216). Anche
Clemente
Bondi,
nelle
Conversazioui
iBondi. Poesie,
Padova, Penada, 1778, I. pag. 38) fa
intervenir
l'avventuriero
che sa tutte
le
informazioni
mondane:
Chiedasi a lai, se hai di saper desio
Qual su le scene
giunger tra poco
Musica Frine, o
Danzator
Narciso,
Questo
all'itale spose, e cara
quella
Agl'itali
mariti.
=
Le
convulsioni
delle signore di bello spirito, di quelle che affettan
let-
teratura e deWaltre
attaccate
dalla dolce
passione
d'amore
vudattia d,
questo
secolo
Con
l'anatomia
di alcuni cuori e
cervelli di esse. Del signor
dott. Gio-
VANN-i
PiRANi di Cento,
Venezia.
Graziosi, 1789. Il canto V del poema La
treccia
donata del
Pignotti ha il titolo
Eurilla in
convulsioni
Pignotti,
Poee,
ediz. cit., pag.
594 sgg.) ;
una
commedia
dell'Albergati e
intitolata
appunto Le
convulsioni
(1784. E degli
svenimenti
femminili,
come di ot-
timo
espediente
comico, si giov
naturalmente
il Goldoni in pi
commedie
(cfr lo studio gi cit. della
Merlato, pag 21). Il Parini. che e.
descrisse
le
convulsioni
della cicisbea
nell'episodio
della
vergine
cuccia^
iMezz^y-
giorno vv.
5B4 sgg.),
e
specialmente
in un
meraviglioso
passo del I espro
230 I CICISBEI
signore fiorentine.
^
Le cicisbee vagheggiate da questo rimatore
nelle sue divagazioni debbono possedere una certa coltura : La
Bruj^re, Molire, la Zaira : e non siano trascurate le scienze :
sulla toeletta della dama sia un mappamondo e un atlante, s
ch'ella sappia di geografa, e conosca la storia. Sappia discor-
rere della teoria newtoniana sulla luce i^non l'aveva adattata al-
l'ingegno femminile il famoso Algarotti?); e d'astronomia parli
con la guida di Fontenelle, che non solo l'autore di pasto-
rali e di lettere galanti e piccanti, ma anche di quella Pluralit
des mondes, che in quegli anni si traduceva in Italia con le altre
sue opere. Ma il poeta educatore insiste perch le dame fuggano
la lettura di altre opere perniciosissime
;
e se v'insiste, segno
che molte di quelle signore del
'700
le leggevano e forse se le
facevano interpretare e commentare dall'abate o dal cavalier
servente: respingano adunque l'Aretino (vedi fortuna settecentesca
di questo lubricissimo tra i pornografi del cinquecento!) e tante
altre sconce opere, di cui la paternit del secolo xvii e del xviii:
// portiero certosino, Margherita acconciatrice, La Teresa, La
Fuicella, e l' Accademia delle dame, empia e infame . Che
cosa siano alcune di queste opere fangose, che pervertivano le
dame in andrienne e in guardinfante, non sappiamo, n la loro
(vv. 189-213), ne accenn un'altra causa in uno de' suoi scherzi sul para-
foco {Opere, ed. Reina, III, pag. 4):
Le convulsion vi assalgono,
Allor che andate in collera
Col perfido amator.
Allora spezzano parafochi e ventagli, quei parat'ochi che altra volta servi-
rono con arguto inganno a coprir agli occhi del marito un piccolo furto,
un bacio desiato , che col discreto riparo del parafoco fu dato e rido-
nato (Opere del Parini, ed. Reina, III, pag. 8 sg.j. Vedi anche un canto
popolare veneziano, Le comndsion (in Malamani, Op. cit., II, pag. 93 sgg.).
*
La scuola delle dome, versi di Francesco ZACCnniOLi, Firenze, 1779.
Sono versi di vario metro, per lo pi distici ottonari (pagg. Ifi). Insegna-
menti pi seri dava e a uomini e a donne del suo tempo il canonico par-
mense Aldighiero Fontana, in due opere sue: La donna maritata d'ogni
grado instriiita per santamente vivere, Ancona, Mancinelli e Ramini, 1719,
e 11 cavaliere espresso in ogni stato, di giovine, di ammogliato, di vedovo, ecc.,
Venezia, Poletti, 1720 (cfr. Akf-Pkz/ana, Scrittori e letterati ptirmigiai,
VII, pag. .SI I. Del poemetto dello Zacchiroii la parte che riguarda le letture
delle dame pu esser confrontata con un passo noto ilei Parini 'Mattino,
vv. 598-019 .
L
I CICISBEI 231
indole merita che si ricerchi
;
Fai Pulcella forse il noto poema
flel Voltaire^
i
IV.
Ormai siamo sul declinare del Settecento, quando al cicisbeo
che non moriva mai d'amore, corteggiatore leggero, fatuo, in
un secolo frivolo, dove la colpa prendeva i veli della lecita ga-
lanteria, sta per succedere Jacopo Ortis, che ama disperatamente
e porta la sua passione alla tragica fine, perch non pu aver
tutta sua la donna amata. Tuttavia, prima che il sentimenta-
lismo settecentesco divenga tragico, e il romanticismo nordico
spinga nei cieli sereni che ridono ai boschetti d'Arcadia le nu-
vole malinconiche e le tetraggini notturne, abbiamo l'et delle
dame erudite,
-
che dividono il loro cuore tra la filosofia,
come allora dicevano, e il galante
;
e come prima la servit e
la devozione cavalleresca avevan fatto da maschera alla non
sempre innocente schermaglia amorosa, cosi l'entusiasmo per la
'
Nella Bibliographie des ouvrages relatifs l'amour aux femmes, au
mariage (Tarin-Londres, 1871) c' l'indicazione bibliogratica de VAcadmie
ds dam.es (Venezia, verso il 1680) e del Portier des Chartreux ou Mmoires
de Satuniin (Roma, verso il 1745).
^
Degli studi muliebri ognun sa che il Parini si dimostr fautore nel-
l'ode La laurea. Tra le donne illustri per studi e per ingegno, che il Set-
tecento ebbe numerose, una delle pi celebri, la Agnesi, appena novenne,
aveva detto una Orato qua ostenditur artium liberalium studia a femineo
sexi neutiquam abhorrere (1727), che fu pubblicata con rime di vari autori,
alcune delle quali scherzose, sullo stesso tema (Mediolani, in Curia Regia,
per Joseph Richinum Malatestam, 1727). Questo tema provoc nel 1723 un
lungo e noto dibattito nell'Accademia dei Ricovrati di Padova, da cui usci
il volume dei Discorsi accademici di vari autori intorno agli studi delle
donne, ecc., Padova, stamp. del Seminario, presso Giovanni Manfr, 1729 .
Cfr. su questa discussione G. B. Gerini, Una discussione siigli studi della
donna in Italia nella prima met del sec. XVIII (nel suo voi. Gli scrittori
pedagogici italiani del sec. XVIII, Torino, Paravia, 19(1, pag. 77 sgg.
,
su
cui cfr. E. Bkrtana (nel Giani, stor. d. lett. ital , voi. XL, pag. 235i, e
Luigi Bonfigli, Una vittoria femminista nel primo Settecento [leWa livista
d'Italia, gennaio 1905). La questione per fu agitata anche pi tardi, dal
P. Bandiera, e dal senese abate Melani : quest'ultimo verso il 1758 stamp
un'opera che non abbiamo veduta,
<<
Il libro per le donne. Tomo primo, che
contiene otto dialoghi intorno allo spirito delle donne, al lor valore ed abi-
lit nelle scienze, ecc. >, di cui tratt il
p.
F. A. Z.\cc.\ria, che si dichiarava
contrario all'istruzione femminile superiore (V. Annali letterari d^Italia,
Modena, 17G4, III, pag. 414 sgg.
23 J I CICISBEI
cultura e la scienza tenta spesso di nascondere ed onestare l'in-
trigo d'amore. Il Bettinelli nel poemetto su Le raccolte rilev
con molt'altri questo capriccio intellettuale delle signore del suo
secolo :
nel cocchio, o nella gondoletta
La pi giovane sposa cicisbea
Legge pnr franca, s'ella mai soletta,
Tradotta, intesa no, la Teodicea;
Tien pur tra i nastri e i nei su la toletta
Di Loke il saggio (Canto I, st. 49).
Ma alle dottrine di Leibniz, di Locke e degli altri intelletti
migliori di quella et, a diflPerenza di quel che dice il Bettinelli,
le signore s'accostarono non sempre sole, anzi pi spesso in com-
pagnia ben gradita. Intermediari tra la scienza e il
docile ce-
rebro delle dame furon bene spesso gli abati, contro i quali
si appuntarono tanti strali satirici e tanti rabbuffi di moralit.
Clementine Vannetti, uomo che ai buoni studi uni una co-
noscenza non iscarsa del costume de' suoi tempi, cos ci dipin-
geva uno di questi abatini, a cui non era sembrato sconveniente
anche l'ufficio di cicisbei: Un abatino di naso profilato, che
va leggero per la via collo zazzerino ben liscio, che dalla sua
iniqua stella stato condannato all'istituzione di nobili ragazzi,
e dalla sua poca scienza costretto a contenersi entro i limiti della
grammatica, ma che per un genio superiore si sdegna della pro-
pria fortuna, e tenta sovente innalzarsi
,
che si coltiva il fa-
vore d'una giovane, che legge opere di spirito, che sa recitare
con della grazia e del gesto i madrigali e le anacreontiche, che
compone egli stesso de' martelliani, o qualche sonettino, in cui
non manchi ne il mormorio del ruscello, ne il garrire de' pinti
augelli, per farsi merito presso alla sua letterata .
^
Lo stesso
Vannetti, in un arguto dialogo,
-
mette in caricatura una dama,
che sfoggia letteratura, si tiene in relazione con molti letterati,
ama avere alla sua mensa degl'improvvisatori (ai quali non manchi
bella presenza e bella voce), e ai suoi ospiti fa sentir per forza
le sue poesie, centoni di versi altrui e di versi suoi zoppicanti.
Consigliere e correttore dei carmi le un giovane abate, che
.sa far versi h commenta le parole di lei con strofette metasta-
siane, nelle quali esala l'amore languido che prova per la bella
'
C. Vannetti, Opere, Venezia, Alvisopoli, 1827-;U. voi. II. pag. l'.'.
'
Vannktti, Opere cit., I, pag. 2! sgg.
L
I CICISBEI 33
indotta. E certo ne f^ode anche favori meno intellettuali, comt-
suppone un cavaliere viaggiatore (un altro tipo settecentesco,
che il Goldoni non manc di prender sotto braccio e condurre
sulla sua scena), il quale della brigata e parla un linguaggio
misto di francese e d'italiano imbarbarito. La dama divisa
dal marito, ed ha un figlio, che fortunatamente ha da da passar
ancora degli anni in un collegio
;
sicch ella ha tutto l'agio di
farsi correggere i versi dall'abatino intraprendente. A questa
signora descrittaci dal Vannetti noi saremmo tentati, se non
fosse malignit indiscreta, di mettere il nome di pi d'una dama,
che nel settecento s'atteggi a donna superiore in qualche sa-
lotto, e di qualche altra che fece accogliere il suo nome nella
storia della nostra letteratura.
Un altro scrittore, di non molto merito, vissuto tra la fine
del settecento e l'ottocento, Matteo Borsa, nipote del Bettinelli,
in un suo Elogio di se .sfesso,
^
autobiografia bizzarra e fanta-
stica, di gustoso e interessante spirito satirico, ])unse molte abi-
tudini e caratteristiche del secolo che finiva. In un curioso ca-
pitolo
-
son messi a confronto due salotti di due dame difi*erenti.
Il primo era un salotto serio, dove si radunavan letterati seri,
dove si facevan pochi discorsi ma seri, e si prendeva la letteratura
sul serio: un fastidio! Il secondo invece era popolato d'una folla
multiforme e multiloqua, un quadro da fiammingo per la va-
riet che vi regnava: gruppi or di giovani spose coi primi
amanti nelle penombre delle anticamere, or di gente da traffico
e da maneggio negli angoli pi trasandati : or di novellisti, di
musici, di maldicenti seduti al fuoco, o veramente sdraiati su
diversi soff . Per tutti aveva uno sguardo e una parola la pa-
drona di casa, che aveva finito d'esser giovane e non avea
grand'ingegno
;
ma il compensava colla dissipazione continua
del divertimento e colla inesauribilit della stravaganza . In
questo secondo salotto, oltre che d'amore (quest'era l'argomento
proprio delle coppie novelline, che preferivano starsene in di.
sparte), si parlava di politica, di filosofia, di morale, e vi si
recitavano poesie strazianti.
Il protagonista di t[uesto Elogio di se stesso ci confida che
s'innamor di una Zelinda e la corteggiava visitandola in casa.
Questa Zelinda non era una cicisbea al modo delle antiche:
'
M. Borsa, Opere. Mantova, Agazzi. 1817. voi. V, pag. ISi' sgg.
^
Il V, pag. 259 sgg.
234 I CICISBEI
aveva una predilezione particolare per il Voltaire : Sulla ca-
miniera aveva un tometto del Dizionario filosofico ;
sul tavolino-
la Pulcella d' Orlans^ ed in mano le Lettere d' Eugenio. Vita
mia, che mano ! Come ne risaltava il candore al contrapposto
di qualche macchietta d'inchiostro che accortamente ne ingem-
mava le dita, superbe di queste insegne studiose ! Com'era rapitor
quel sorriso nel condirsi di lodi cosi fine! Come animavansi
d'una parca virilit quei suoi tratti, quando stavam disputando
su la religion naturale, su la degradazione dell'uomo, su la so-
vranit della ragione! (pag. '281).
In molte critiche fatte alla classe privilegiata dalla fortuna
consentiva un patrizio torinese, il conte Benvenuto Rebbio di
S.
Raffaele, autore di parecchi romanzi e d'altre opere d'intento
educativo: e scrivendo Del gran mondo (1786)
^
voleva persua-
dere i nobili che non vero che i grandi sono nati a godere,
siccome il popolo a lavorare . Pur non ricorrendo alla violenza
satirica, censurava la istituzione del cavalier servente, che sta
le tante ore testa testa con una gentildonna, di cui si dichiara
fedelissimo, ed talora seccatissimo servidore (pag. 1-1); disap-
provava la lettura dei libri nuovi e cosidetti geniali, dai quali
appena si pu attendere una coltura superficiale trarre idee sba-
gliate, e le conversazioni, dove si fa la satira e la maldicenza, e
dove spesso il linguaggio ofiende gli orecchi delicati e gentili
delle dame ingenue con l' equivoco licenziosetto e con qualche
motto arditello
.^
Disapprovava il lusso e le danze, specialmente
queste, delle quali diceva: l^e danze gravi e maestose, se non
esprimono passioni accesissime, come il fandango spagnuolo, non
recan diletto, n a chi l'eseguisce, perch sono difficili e faticose,
n a chi vi assiste, perch non han brio, n prestezza. Perci il
minuetto e gli altri balli serj e contegnosi fan poca fortuna
;
ed
aver sogliono miglior incontro le contraddanze, dove il saltellare.
'
Del gran Mondo. In Milano, per Cesare Orena nella stamperia Mala-
latesta, MDCCLXXXVI. Al costume <iel Settecento si riferiscono per la
maggior parte anche le altre opere che il conte di S. Raffaele scrisse con
intenti religiosi e morali.
"
Noiosa e pedantesca opei-a quella del gesuita Dome.nico Maria An-
TiNORi. Le veglie d'oggid, overo Discorsi .ut l'uso delle veglie, Venezia, Occhi,
1757; se ne biasimano tra l'altre cose la libert del parlare, (Disc. XII), i
giuochi e le danze che vi si fanno (Disc. XIV). Sulla elegante Licenza
>
e sul 'gentil Motteggio delle conversazioni richiamiamo il Paui.ni iMcz-
zogiryrno, vv. :3(;4-:iH2|.
k
I CICISBEI
235
il
v(.lteggiare,
l'incrocicchiar
le braccia, il batter di mano, e fin gli
stessi errori, che si commettono
dai ballerini,
producono
allegria,
vivezza
d'occhi,
obblivion di contegno,
alcune
volte maggior di
quella, che al matronal
decoro pu
convenire
>. (pag. 46).
Ognun
sa quanto
aveva
apprezzato la
zighediylia e il fandango,
appas-
sionate
danze, Giuseppe
Baretti,
quando le vide
ballate
dalla
bella
Catalina e dalla sorella di lei dagli occhi
ardenti, le due
venustissime
spagnuole di Badajoz, che gli
rallegrarono,
special-
mente la seconda, la
monotonia
del viaggio
attraverso
la peni-
sola iberica.
^
A
meglio illustrare
questo
caratteristico
costume
della societ
settecentesca,
che il cicisbeismo,
ci giover una rapida scorsa
attraverso i trattati, che furono
scritti per
combatterlo.
La serie
di essi ben lunga, e noi di sicuro non ne ricorderemo
se non
una parte. Nel
penultimo
decennio del secolo xvii, Carlo Maria
Maggi, il poeta milanese,
che occupa un posto
notevole nella
storia
dei principi
dell'accademia
d'Arcadia,
tradusse
un'opera
ascetica
dal francese e la fece seguire da una sua scrittura di
non lieve
importanza,
im
Trattenimento
intorno ai diversi sog-
getti della vanit
delle donne.-
Il Maggi,
uomo di gran devo-
zione,
specialmente
negli ultimi suoi anni, amico dei gesuiti, tra
cui il celebre
padre Segneri,
precorse,
come altri not, col suo
Trattenimento,
il Giorno del Parini:
modestamente,
s'intende.
E mir ad esporre i
disordini della vita della dama
milanese
:
la
differenza tra i due moralisti sta nel fatto che la riforma con-
sigliata dal Maggi tutta fondata su principi
mistici e religiosi.
Il Maggi fa rilevare la brevit fugace dei piaceri, e
rimprovera
alle dame del suo tempa
esagerata cura del corpo e del viso, il
lusso delle vesti e quello delle
suppellettili.
Lamenta l'abuso
che
nelle cae si fa di affreschi e di quadri atti a stimolare la concu-
piscenza con nudit
vergognose... Si
veggono appi del letto e ai
lati del letto, nelle pareti, nel soffitto, con mille
vaghezze di n-
Baretti, Opere, Milano, Mussi, ISU, voi. V. pag. 'iin e seg. Sul mi-
nuetto ctV. Cant, Parini, cit., pag.
3in e seg.
2
L'opera tradotta dal francese la seguente:
Ritiramento
per le Dame
con gli esercizi da farsi in mo del li. Padre
Francesco
Guiulior ^sic,,
Milano 1687. La Retraite pour les dames
del Giillor
(1615-ir,m) tu stam-
pata per la prima volta a Parigi nel US4.
236 I CICISBEI
tratti . Biasima ancora i pregiudizi della societ, la conversa-
zione, il giuoco, a cui le donne prendon parte con trasporto, l'as-
sistere alle commedie, il ballo moderno e le mode, tra cui egli
giudica una delle peggiori quella che fa le dame amantissime di
un cagnolino, s che una bestia ruba ai figlioletti di esse le ca-
rezze materne. Ed ha un capitolo intero, l'XI, Intorno ai galanteo^
che egli definisce quel particolare corteggio, e quella servit che
un cavaliere prende a fare ad una dama procurando ad ogni suo
potere di conseguirne la grazia e di sostenerne ed accrescerne la
gloria, con dichiarazione di non volere cosa alcuna che punto si
opponga all'onest della medesima. E le dame giurano che
queste loro relazioni sono pure ed innocenti : ma il Maggi le
mette in guardia contro la effeminatezza e le arti seduttrici dei
damerini , che ad altro non tendono che a vincere l'onest
delle dame : aspirano a profanare e ad imbrattare delle loro
lascivie il sacrario del vostro decoro e a rapirvi il pregio sublime
del vostro sesso e della vostra condizione . Curiosa veramente
questa lezione di morale, che un nobile milanese dava ai suoi
pari ottant'anni prima che con altro stile ad essi ne apprestasse
una pi efficace e vigorosa un poeta plebeo.
Chi crederebbe che la seconda opera contro le conversazioni
contro i damerini e gli abati vagheggini, ci venga dal Belgio V
Giustamente considerando il cicisbeismo come un frutto di ga-
lanteria maturato sotto questo bel sole italico, che accende gli
estri e i cuori, noi dimentichiamo troppo spesso che la galan-
teria, la bella creanza d'amore, fu propria di tutte le societ
europee del Settecento, da Londra a Vienna, da Roma a Parigi,
sebbene assumesse particolari aspetti nelle varie nazioni. Abatini
anelanti a godimenti mondani se ne videro dovunque, e di loro
parlava appunto copli che scrisse Le commerce dangereu.r entrc
le.s deii.r se.res, stampato nel 1715 a Bruxelles,
^
e quaranta anni
dopo tradotto in italiano da un sacerdote.- Nel trattato origi-
'
Trait moial et liistorique , Bruxelles, Rodolphe, 1715. L'autore
G. B. Drouet de Maupertuy, secondo il Melzi, Dizionario di opere anonivf
e pseudonime ecc., 1,
22(1.
"Venezia, Tavernini, 175(). Questa traduzione non ral)l)iani veduta; il
Malam.wi (Op. cit
,
I, iiH
.) cita // cominercio pericoloso fra li due sessi
fuori del matrimonio, Venezia, Rosa, 175H (^ma stampato sulla fine del 1755:
traduzione dal francese i,
e deve essere la stessa versione del trattate che
esaminiamo. Autore di questa traduzione, che ebbe la prima edizione a Lu-
gano, 1755, fu (secondo il Mblzi, Op. cit., loc. cit., il P. Gio. Battista Negri
teatino.
k.
I CICISBEI 237
naie, sebbene non si parli esplicitamente di cavalieri serventi,
si biasima ogni specie di (conversazione che provochi relazioni
assidue di uomini e donne, e specialmente si muove rimprovero
agli ecclesiastici, che praticano la compagnia di donne, se anche
non abbiano cattive intenzioni. E all'autore giovava, come poi
ad altri che ripeterono le sue lagnanze, citar le parole di S. Gi-
rolamo contro gli ecclesiastiii mondani, e censurava aspramente
quelli che dice
abbez de ruelle i quali sembrano sposi no-
velli, cosi lindi e ricciuti come sono, dopo molte ore di specchio,
quando vanno a far visita alle signore :
<'
Vous les voyez marcher
le chapeau sous le bras, de crainte che son poids, quoique leger,
ne vint dranger la simtrie de leur frisure. A peine touchent-ils
le pav, tant ils ont peur que leur galante chaussure ne se sa-
lisse . Del resto in Francia gi La Bruyre aveva consigliato i
direttori spirituali a fuggir le donne, anche a rischio di non
curarne la salute dell'anima, per non perdere la propria,
i
Nemmeno in Italia mancaron moralisti, che protestassero
e non pare con molto risultato
contro la facilit con cui
gli ecclesiastici frequentavan le signore. JNon sempre innocente
era l'intento di quel prete o frate che s'insinuava nelle case. Un
autore, un abate,
2
.scriveva a questo proposito ch'egli detestava
i tanti raggiri, con i quali gli ecclesiastici, e i regolari in specie,
s'insinuano nelle nostre case, quando in esse abiti qualche fem-
mina di non disprezzabile aspetto. Vi compariscono essi a pren-
dere la cioccolata ed il latte, ora se ne vengono portando i libri
in prestito... (pag. 5): le arti insomma che l'ipocrisia us sempre,
e che nel Settecento non era solo il Parini a smascherare neV Im-
postura. Ma poi il nostro autore prosegue la discussione rivol-
gendosi a quegli ecclesiastici che avvicinan le donne in buona
fede e senza fine cattivo : il pericolo non meno grave per questo
;
non sanno essi che l'amore verso il bel sesso naturale ed ir-
resistibile? e che non se ne ottiene vittoria nemmeno allonta-
nandosi atatto dal mondo ? Credon seriamente di poter aste-
nersi da ogni idea non casta coU'assiduo sedere al fianco di
una tenera giovinetta, o per insegnargli {sic) scioglier la lingua
'
Cfr. Le Commerce dangereu.r, pag. 2G1.
"
Discorso accademico sopra Vahuso di (nielli ecclesiastici che insegnano
alle donne leggere, scrivere, il canto, il suono, il disegno, la poesia, le scienze,
le lingue, scritto dall'abate O. G., scolare pisano, Livorno, MDCCLXI. Per
Gio. Paolo Fanteclii all'insegna della Verit.
2S8
I CICISBEI
a,l canto, o per istruire le sue morvide mani alla pratica di ar-
monioso strumento r*
i
(pag. 13 e segg.).
Le leggi sacre, di cui l'autore cita molti passi, proibiscono
<iuesti congressus mu/erum, che possono screditare intere comu-
nit di religiosi, e gettare lo scandalo su famiglie onorate, poi-
ch il popolo ne giudica per lo pi sfavorevolmente, anche se si
tratti di relazioni non colpevoli. Ad ogni modo temibile e pi
facile il danno personale, perch quei congressus turbano la
coscienza e i sensi dei precettori, e spesso nella china dei di-
scorsi confidenti e tentatori minano le anime delle pi inno-
centi colombe (pag. 21): infatti, afferma l'autore (pag.
35),
la
alunna di solito non donna attempata, ma bens bizzarra
giovinetta, e di non spiacevole aspetto , e pu porre al precet-
tore un affetto pi profondo e pericoloso di quello che le loro
relazioni potrebbero giustificare.'^
Ma torniamo al Commerce dangereux, di cui parlavamo. Pa-
gine interessanti di esso, pi di quelle dove spesseggiano le ci-
tazioni dei Santi Padri, son le altre in cui l'autore discorre delle
donne maritate del suo tempo, affermando che per la grande li-
bert che godono elles prenent du mariage ce qnil a d'agrable,
t rejettent ce qu'il a de penible. L'habitude qu'elles ont de vivre
avec un homme, fait, qu'elles ne peuvent plus s'en passer. Mais
elles veulent un ami au lieu d'un poux . Questo era il male, e
L'Alfieri nella notissima satira su VEducazionc, tra le occupazioni
che in casa del nobil conte toccheranno all'abate D. Raglia da Baatiero,
pone anche quella di esercitare la contessina a canticchiare Metast6sio, le
ariette. . .
.
*
Accadeva spesso che questa famigliarit tra uomini e donne si strin-
gesse sotto aspetto di relazione tutt'affatto spirituale. Il Parini immagi-
nando che una Elisa, signora un tempo dedita alla galanteria, voglia darisi
alla devozione, eleggendo come suo direttore spirituale un certo conte N.
N.,
fa scrivere da costui tre lettere alla convertita, in un tono di arguta ironia.
Il conte dice alla dama ch'ella ormai in un'et propizia al suo proponi-
mento : I giovani amici cominciano a poter vivei'e senza di voi
;
la vostra
et principia a lagnarsi di qualche lustro superfluo. Oh bella cosa ch' la
divozione quando si giugne ad un certo numero d'anni! (P.vkini, Opere..
ed. Reina, IV, pag. 206). E nella prima lettera il <> consigliei'e spirituale
si mostra poco tranquillo e sicuro della sua resistenza alle tentazioni : Oh!
la sarebbe poi bella, che il diavolo facesse che col nostro lungo commerzio
di lettere io mi innamorassi di voi, come accade spesse volte a' direttori,
che prendono a guidare sul cammino della divozione qualche ancor fresca
e spiritosa penitente > Pakini. (>/>ere, IV, 204'. L'al)ate di Bosisio conosceva
il suo mondo.
I CICISBEI 239
per (juante cagioni si cadeva in esso I L'arguto autore distingue
le donne che si fanno l'amante per vendicarsi del marito infe-
dele, o per sensualit, o per vanit, o per lusso, o per la moda,
o per passatempo sentimentale, e cosi via. Come meravigliarsi,
che fossero rarissime quelle signore che potevano fare a meno
corteggiatore, fosse o no sollevato all'ufficio di amante
?!
Un buon numero di trattati sul costume dei cicisbei .si ebbe
in Italia. Ma coloro che s'occuparono del nostro tema hanno solo
citato quello di Costantino Roncaglia, venuto in luce a Lucca
nel 1720 e ristampato nel 1736.
-
Dopo aver lamentati tutti i
danni morali del cicisbeismo, e aver messo in/ guardia contro i
pericoli di esso, enumerando tutti i peccati (quanti!) mortali e ve-
niali, in cui si cade nella conversazione, il Roncaglia lamenta la
diversit del costume del tempo suo da quello di mezzo secolo
prima, allorquando se ritrovata si fosse una giovane maritata
in camera solitaria con persona di sesso diverso, e di sua con-
fidenza, sarebbesi ci reputato bastevol cagione di sanguinosi
duelli ed irreconciliabili inimicizie: e rileva il decadimento e la
rovina della compagine domestica, dove la donna, amante del
marito, educatrice dei figli, viene a mancare. Egli vorrebbe che
le madri non dessero ai figli e alle figlie il cattivo esempio del
cicisbeato, che i mariti proibissero il cicisbeo alle mogli, e queste
non disubbidissero
;
ma soprattutto vorrebbe che gli ecclesiastici
non cadessero nella colpa di farsi cicisbei. Sono al solito gli
abati quelli presi di mira, e non sar inutile riferire il ritratto
*
Poich abbiamo accennato ad un trattato straniei-o sul costume sette-
centesco, ricoidiamo che prima del Commerce dangereit.r a Bruxelles s'era
pubblicato nel 1G75 un altro curioso trattateilo De Vabus des nuditez de
gorge, di cui alcuni (secondo il Brunet, Manuel) fanno autore Jacques Boi-
leau, ed altri un Mr. de Neuilly, cure de Beauvais, e che in cinque anni
ebbe altre due edizioni a Parigi (nel l<iT7 e nel 1680). L'editore dice che il
libro fu scritto da un gentiluomo scandalizzato nel veder le donne fiam-
minghe andar mostrando la gola e le spalle e il seno nudo: il timorato
gentiluomo francese non si lasci prendere all'incanto di cosi bella nudit,
sebbene riconoscesse che la veu d'un beau sein n'est pas moins dange-
reuse pour nous que celle d'un basilic ^
*pag. 12). Ricorderemo anche un
lungo trattato di pi di quattrocento pagine scritto da Jean Fraix or Tkem-
MLAY col titolo Conversofioiis moroles sur les jeu.r et les divertissements i Paris,
Pralard, lH85i.
*
Le moderne conversazioni volgarmente dette dei cicisbei, esaminate da
Costantino Roncaglia della Congregazione della Madre di Dio, ri* ed. ac-
cresciuta), Lucca, Venturini, 173G. Del Roncaglia s" giovato particolarmente
il Carducci, trattando del cavalier servente.
240
I CICISBEI
(he u traccia il Roncaglia, per confrontarlo con quelli veduti
innanzi : Voi dunque li vedrete primieramente con una zazzera,
che ognun giudicher, che sia stata ben disposta per pi tempo
allo specchio ... Le loro vesti, a riserva del colore, sono quali
le desidera un cicisheo secolare
;
e procurano talvolta ancora di-
scostarsi quanto possono dal color nero, quasi vergognandosi
dell'abito che vien dalla Chiesa loro prescritto (pag. 228).
E prosegue : Arrivano finalmente a cos disonorare il loro stato,
che vedonsi ne' carnevali con una abominevol maschera .servire
con ogni libert la cicisbea. Se poi niente niente le loro azioni
osserverete, reste^jete ammirato vedendole leggiere, scomposte,
e che danno manifesti indizi di vanit, camminando eziandio
per la citt con tutto quel brio, con cui un giovinetto secolare
etfeminatissimo, innamorato, d scioccamente ad intendersi di
farsi credere qualche cosa (pag. 229).
Ma prima del Roncaglia altri avevano trattato la stessa ma-
teria. Un anonimo, religioso della Congregazione della Madre
di Dio, come il Roncaglia, nel
1711,
pubblicava a Ferrara un
opuscolo su Alcune conrersazioni e loro difese esaminate coi prin-
cipj delia Teologia,^ in cui diceva doversi stimare materia di
erubescenza et un mancare al proprio decoro, se una donna li-
bera, e molto pi congiunta, ammessa una continua, libera e
confidente conversazione con qualche persona particolare, d
fondamento di sospettare, ecc. , e si lagnava che a siffatte con-
versazioni si desse in alcune citt il titolo di lecito diverti-
mento, o di ossequiosa servit dovuta alle dame, bench legate di
fede col santo vincolo del sacramento del matrimonio
. Per non
lasciar equivoci l'autore determinava, come il Roncaglia, di qual
conversare egli intendesse far censura : Io per questo conver-
sare intendo quella familiare conversazione, che determinata
per lo pi ad un solo, n determinata ad ore, ed a giorni, ma
si suole prolungare per pi mesi et ancora anni; quell'assistenza
continua a quella cui si dice servire nella conversazione, nel
giuoco, nel passeggio; quella libert di parlare in segreto al-
l'orecchio, e talvolta ancora d'introdursi in casa, sebbene l'ora
impropria possa far sospettare, che il vestito non sar in tutto
decente; luel
pretendere i di lei sguardi fino nel Santuario,
'
Ferrara, Barbieri, 1711: dubito clie sia la prima edizionf. Tra questo
opuscolo e l'opera del Roncaglia ho notato alcune relazioni : il Roncaglia
cono)be certamente il libretto ferrarese del 1711.
L
I CICISBEI 241
e avanti l'istesso Altissimo " (pag. 5 e segg.;. A Ferrara stessa
nel 1 714 si divulgava la RHpoxta d'un teologo ad un amico sopra
diclini casi di coscienza concernenti al vivere d'oggid. L'autore
non si svelava, ma pare che le donne e i cicisbei ferraresi riu-
scissero a scoprirlo e se ne vendicassero : difatti una nota ma-
noscritta, posta da un contemporaneo sopra un esemplare di
questo trattatello,
^
lo dice opera di D. (Giandomenico Barile
C. R. Teatino, contro del quale si suscit una fierissima perse-
cuzione de' Ferraresi, per cui da quella citt dov partire ,
Dei resto non si pu dire che il Barile adoperasse espres-
sioni pi gravi degli altri che combattevano il cicisbeismo: egli
denominava diabolico ritrovamento quello delle conversazioni
tra donne e uomini, e sosteneva che gli amori iniziati e prose-
guiti nelle veglie non sono innocenti, mentre veggonsi chia-
ramente li tali e le tali or fare scherzi assieme, da pi che offi-
ciosi, or parlarsi all'orecchio, e sovente l'uno all'altra in ginocchio.
Che scherzi e che giuochi fossero leciti in quelle veglie di cicisbei,
ci ha detto gi monsignor Lodovico Sergardi.
Nonostante la persecuzione, che lo allontan da Ferrara, anzi
forse appunto per essa, il Barile, due anni dopo, ristampava ac-
cresciuto il suo trattato, a Roma, col proprio nome e col titolo :
Le moderne conversazioni giudicate nel tribunale della coscienza.'^
Contro il cicisbeismo si continu a predicare e a teorizzare
durante tutto il Settecento, e nell'ultimo ventennio del secolo
un anonimo scrisse certe Riflessioni filosofiche e poetiche sul genio
e carattere dei cavalieri detti serventi secondo le massime del se-
colo XVIII (1783),'^ e un anno dopo uscivano altre Riflessioni,
con lo stesso titolo, ma sul carattere delle dame dette servite
.
Era come una ricapitolazione storica : il regno dei cicisbei stava
per terminare. In una lettera di Lorenzo Mascheroni ad un amico
(Pavia, 9 novembre,
1796), ricorre ancora questa testimonianza:
Sento dire che la cittadina Teresina Diletti Barbieri sia dive-
nuta poetessa, ed servita dal comandante francese di questa
piazza;
4 e nel 1805 il De Rmusat trovava ancora Tuso del
cavalier servente. Ma non va dimenticato, che Ugo Foscolo,
'
Ferrara, Barbieri, 1714. L'esemplare da noi veduto, che attribuisce la
h'i.sposta al Barile nella R. Bibl. di Parma (Miscellanee in-8, n. 261;.
^
Roma, Bernab, 1716.
^
Venezia, Zatta, 178:^.
*
Cfr. i Coniribiti alla biografia ili Lorenzo Mascheroni, Bergamo, Arti
Gi-afiche. 1!>04, pag. 114. E v. M.^: De Rbmusat, Mmoires, Parigi, II, 139.
Hi Riiistii dlUiUa, anno XIll, voi. II. taso. Vili, (Agosto ItUO).
242
I CICISBEI
esperto conoscitore di quel mondo di cittadine e d'altre signore
facili alla capitolazione in quell'era napoleonica, nel saggio su
Le donne italiane^
^
parlando del cavalier servente e della sua
dannosa efficacia, ci attestava il tempo in cui un atto di onesta
sovranit ne segnava ufficialmente la decadenza in Milano : Il
sistema dei cavalieri serventi, sebbene a prima vista possa sem-
brare degno unicamente di ridicolo e di disprezzo, agiva come le
potenze negative nelle matematiche, condannando le potenze at-
tive all'inerzia. L'uso era frutto della condizione religiosa degli
Italiani,
2
e le condizioni politiche lo perpetuavano. Questo per-
sonaggio anomalo disparve quasi istantaneamente nel setten-
trione della penisola, appena l'amabile figlia del Re di Baviera
vi comparve moglie di Eugenio Beuharnais, e modello di tutte
le virt domestiche
.^
La vice regina non ammise a Corte le
signore non accompagnate dal marito: e allora i cicisbei si ri-
trassero e le signore comparvero in pubblico e agli inviti della
gentile principessa dando il braccio al proprio marito senza pi
temere di esporsi al ridicolo.
Giunti a questo punto, dopo tante testimonianze nelle quali
and malamente compromessa la buona fama delle donne ita-
liane del Settecento, non sar un danno n una contraddizione
che noi concludiamo il nostro discorso con alcune altre infor-
mazioni che tornano a loro onore : che se il costume frivolo por-
tava in quell'et la donna verso i rischi del galanteo e del
cicisbeato
come allora dicevano, sarebbe ingiusto dar valore
generale alle prove che possediamo in proposito, e tacere di
quelle altre, che parrebbero eccezioni, e forse non erano cos
'
U. F0.SCOLO, Opere, Firenze, Le Monnier, 1882, voi. II, pag. 35 e segg.
Il Foscolo sostiene che una delle cause, anzi la pi profonda e velenosa
,
della decadenza politica d'Italia fosse l'abitudine di certe classi di profanare,
come per privilegio, la santit del matrimonio (pag. Ho). Per lo stesso Fo-
scolo {Opere, XI, 60 e seg.) trovava ancora vestigia di cicisbeismo nel 182H
(Cfr. Parini, Le Odi, Il Giorno, ecc., con note di Guido Mazzoni, Firenze,
Barbra, 19fX), pag. 170 1.
-
Il Foscolo reputa causa principale di quest'uso il celibato dei preti.
Noi .sappiamo ormai che questa affermazione non corrisponde al vero, se non
in parte.
^
Fu.scoLO, loc. cit., pag. 3iJ.
I CICISBEI
243
rare come potrebbe credersi, e sono certamente molto lu*!n-
ghiere. Non tutte le donne del Settecento furono fatue, leggiere
e amanti della corte dei ridicoli cicisbei: il Goldoni, dipintore me-
raviglioso della societ dei suoi tempi, ritrasse s le dame piene
di capricci e di smorfie, ma non trascur quelle migliori
;
e le
donne amanti del marito e della casa meglio che dei cicisbei e
delle conversazioni mondane sono pi numerose, nelle sue com-
medie, di quelle che alla famiglia concedevano la minor parte
dei loro affetti. E la letteratura che satireggi il non lodevole
costume muliebre, fu ricca ed ebbe fortuna,i non manc chi del-
l'indolee del carattere femminile tratt con maggior benevolenza
e cortese deferenza. A noi baster dar saggio delle opere e degli
autori che del sesso gentile ebbero pi rispettoso concetto/'' E
citiamo prima il padovano abate Antonio Conti, noto come tra-
gico e come filosofo, uomo di vastissima cultura e di grande
ingegno, ricco di idee moderne accolte nel suo lungo soggiorno
all'estero. Una lettera da lui scritta su tal soggetto, in francese,
e inserita fra le sue opere, fu nel 1773 aggiunta ad una tradu-
zione del Saggio Hopra il carattere i costumi e lo spirito delle
donne ne' varj .secoli del sig. Thomas dell' Accademia francese^"^
opera gi prima tradotta in italiano, favorevole al bel sesso, e
particolarmente interessante l dove considera il costume fem-
minile da Luigi XIII a Luigi XV e alla Reggenza, in quei tempi
in cui la decenza onde s'era velata la galanteria, anche se li-
cenziosa, fu posta del tutto in bando.
Qualche testimonianza pi leggiadra ci porger la poesia, e
noi ci fermeremo a due esempi, che si compiono l'un Taltro, e
ci mostrano la donna del Settecento in mezzo alla vita dome-
'
A quella fin qui ricordata aggiungiamo : Le donne. Quadro poetico mo-
rale di Evandro Aminta, Torino, Stamperia reale, 1791 : due brevi canti in
versi sciolti.
^
Non sarebbe difficile nella poesia, e in genere nella letteratura del
Settecento, raccogliere materia per uno studio sui sentimenti e sugli addetti
coniugali e famigliari. Ci accontentiamo di citare un breve stadio, che
anche un buon saggio intorno a questo tema, di B. Chiurlo, Gli affetti fa-
migliari di un poeta friulano (nel periodico La patria del Friuli, di Udine,
28 dicembre 1908): il poeta il co. Daniele Florio, che fu in relazione col
Metastasio.
''
Traduzione italiana corredata di annotazioni storico-critiche: ed ac-
cresciuta di una lettera dell'abate Conti P. V. intorno lo stesso argomento .
Venezia, Vitto, 1778. Ricordiamo Ancora a questo punto il trattato di Al-
dighiero Fontana su Fm donna, gi citato il719).
244 I CICISBEI
stica. uou pi. fastidiosa e tediosa per lei, come le appariva nelle
opere fin qui vedute, ma gradita e soave.
Ecco una raccolta di versi (si ricordi che il Settecento fu il
secolo delle raccolte, per tutte le solenni circostanze pubbliche
e private) fatta per le nozze del conte Gian Fioravante Nicelli,
piacentino, e della marchesa Isabella de' Franceschi, genovese.
Un buon numero di verseggiatori si proposero di descrivere e
quasi formare alla nuova sposa (si era nel 1792) il suo salottino
di toeletta, e alla raccolta diedero nome l gabinetto.
^
Giampaolo
Maggi cominci a tracciarne Le dipinture^ che lo dovevano ador-
nare. La pittura pastorale e mitologica francese del secolo xviii
aveva sparse dovunque, con la grande imitazione fattasi delle
scene del Watteau, del Boucher, del Fragonard e dei loro se-
guaci, scene d'amore e di passione, tutte pervase da un molle
carattere di sensualit. Un altro Maggi, da noi, Carlo Maria,
aveva gi lamentato, come vedemmo, l'abuso di pitture d'argo-
mento lascivo
;
Giampaolo Maggi non vuole nel gabinetto della
sposa le disoneste figure, che
Ornar di Cloe, e di Lalage
Le insidiose mura
Poter, e l'altrui rendere
Procacit secura:
l'artista tlipinga invece le sorti dell'amore grande ed eroica-
mente virtuoso di Alceste per Admeto, e la morte di lei, e lei
restituita al marito dalle divinit pietose di s grande affetto
coniugale. Il conte Federico Scotti della Scala cant La toeletta^
il piccolo altare della bellezza, a cui si assider la giovane donna
appena uscita dal talamo nuziale,
Se il pie succinto e tepido
Un solo passo avanza
Oltre l'amica soglia
De la notturna stanza.
"
Un tema pi delicato tocc al marchese Francesco Appiani
d'Aragona di Piombino, arciconsole dell'Accademia piacentina
'
Il Gabinetto. Versi per le t'austissinie nozze dt-l n()l)il uomo il signor
conte Don Gian-Fioravante Nicelli Piacentino con la nubil donna la signora
marcliesa Donna Isabella de' Franceschi Genovese, 1792, [Piacenza], presso
Giuseppe Tedeschi.
*
Richiamiamo qui la letteratura gi citata sulla toeletta.
I CICISBEI
i45
degli Ortolani, alla quale apparteugouo tutti i poeti della rac-
coltina che esaminiamo : egli cant //
sof^
i
Piacevol ospite
D'ogni aureo tetto,
GradevoI emulo
D'ogni ampio letto.
"
N per esso sar posta a dura j)rova la modestia della sposa :
Tema il cor gelida
Per non stringa,
Le gote ingenue
Rossor non tinga
Di lei che ascoltami
Sposa gentile:
l'autore sa che vi son divani ove l' ignobile volutt elegge il
suo campo, ma questo ch'egli canta accoglier una giovine
donna, di cui la bellezza maggiore la virt, e ad esso rivol-
gendosi cos gli dice :
Mentrella a placido
Sonno tranquille
Ama concedere
Le sue pupille.
Le membra languide
Tu accoglierai :
Il volto roseo
Ne sosterrai,
Ov'ella togliers"!
A troppo gravi
Cure domestiche
Ed insoavi
;
Ov'ella pascere
In dolce calma
Di saper aureo
L'ingegno e l'alma:
'
Anche il sof ebbe una sua letteratura nel Settecento. Ricordiamo //
Sof,
del veneziano Lamberti, in dialetto, ristampato dal Mal.\maxi lOp.
cit., II, pag. 133e seg.), e l'episodio notissimo del Parini su l'invenzione del
caiop {Notte, v. 275 e segg.)
-
Anche il Parini aveva detto del canap Xofte. vv.
819-32o)
:
E fama che talor invidia mosse
Anco a i talami stessi.
24t I CICISBEI
Ov'ella piacciasi
Fuggir di cento
Languenti il tedio
O l'ardimento.
In sen dell'ampio
Molle tuo piano,
Ora all' industrie
Dell'agii mano
Far suo genio
Contento e pago,
Alternand'opere
Di maglia o d'ago;
Ora su pagine
Dotte, ingegnose
Cui franca od itala
Penna compose,
Intenta ed avida
Corr le idee
Native ed utili,
Cui saggio hee{sic).
Versi non belli: ma a noi importa il concetto che il poco apol-
lineo arciconsole ha voluto esporre alla sposa, attorno alla quale
egli vede fra non molto, su quello stesso divano, i figliuoletti
avidi del suo bacio e delle molli carezze materne.
Scienza in versi, secondo l'uso non pi nuovo della poesia
d'allora, offre alla sposa Luigi Bramieri, nome non ignoto agli
studiosi del Parini^ descrivendo L'orinolo a pendolo: comincia
dal discorrere del Sofo maggior de l'Arno , Galileo, e poi del
batavo Ugenio, Huygens,
(Il pondo egli vibratile
A l'oriuolo appose
E al navigar si dubbio
Legge novella impose);
e seguita con tali leggiadrie poetiche, finch si ravvede :
E che varra, di vertice
Se a Te, di base e d'osse,
Di generante circolo
Parlar mio labbro osasse?
A si severo studio,
A l'aspre voci astruse
Mal l'armonia maritano
Del plettro lor le Muse.
I CICISBEI
247
Male davvero, e l'autore poteva essersene avveduto prima. Sog-
getto meno scientifico, / casi da serbare i fiori, tocc all'ab. Bar-
tolomeo Boccaccio. Questo abate dal celebre cognome parla dei
fiori, che nel tempietto adorno '>, nel segreto gabinetto della
sposa, emergono
Dal sen capace e diafano
Di pechinese argilla:
(^uei fiori anelano l'onore d'ornarle il petto, sebben temano di
esser vinti
(
facile indovinarlo) al confronto delle nevi del seno
e delle rosee guancie di lei : essi parlano alla giovane donna il
loro simbolico linguaggio, ricco di gentili e amorosi pensieri. E
il dottore Vincenzo Devoti svolse l'ultimo tema, caratteristico
del tempo, su / libri^ che avrebbero dato una nota intellettuale
al gabinetto di toeletta della nuova dama. Il poeta non vuole
ch'essa gravi la mente e la parola d' inameni concetti scientifici
e filosofici :
Dolci, non gravi sorgano
Voci sa roseo labro:
E Sota no, ma Venere
Parli da bel cinabro.
Donna gentil coll'occhio
Cerchi le vie de' cori,
E non armata d'anglica
Lente le stelle esplori.
In questo luogo, ove domina la Moda co' suoi riti, non manche-
ranno tuttavia aurei volumi (sentasi curiosa miscellanea d'opere
discordi), la Bibbia, Molire, la iJidone del Metastasio, e Cla-
rissa,
la bella Inglese
Che per le vinte insidie
A maggior gloria ascese.
Quanti begli occhi di donne s' inumidirono di lagrime pietose,
nel Settecento, leggendo la storia dell'eroina del Richardson I
Qua! ninfa d'alma tenera,
D' ingenui modi ha il vanto,
Che di Clarissa ai miseri
Casi non sacri il pianto?'
*
Cfr. l'opera citata di G. B. Marchesi sui romanzi del "TiK,). pag.
2'i
e passim.
248 I CICISBEI
Nella raccoltina su cui ci siamo indugiati non abbiamo pi
la dama cicisbea, ma nel signorile e civettuolo gabinetto che i
verseggiatori piacentini preparavano all'aristocratica sposina,
rimane ancora come diffusa un'aura di leggerezza e di frivo-
lezza.
i
Per altre nozze, della N. D. Lucrezia Nani col N. U. Lorenzo
Sangiantoifetti, a Venezia, si pubblic nello stesso anno La vita
coniugale^ da prosa inglese di Mi/lady Montaigne, recata in
verso italiano dall' Abate Antonio Conti P. V.'- Il Conti ebbe
lode dal Foscolo per la vigoria e maestria con cui tratt l'ende-
casillabo : un altro dei pregi di questo tragico padovano, del
quale abbiam gi discorso. Il trattatello della dama inglese, seb-
bene scritto in prosa, ricco di poesia, e in esso passa un soffio
di squisita femminilit, come in molte delle cose scritte da questa
donna di mente superiore. La Montagu vuole che nella vita co-
niugale amore suggerisca la scelta, la fedelt e la costanza la
mantengano. E per provare quanto la societ e gli usi suoi tol-
gano delle cure muliebri al marito, essa, che stette alcun tempo
a Costantinopoli (dal 171(3 al
1718),
essendo moglie dell'amba-
sciatore inglese, ricorda le parole dette a lei dall' amabile Sul-
tana , che si scandalizzava della libert delle donne europee,
le quali conversavano con tanta frequenza con gli uomini. N
la risposta della gentildonna inglese appag la Sultana, perch
essa ribatt:
Oh gran bont degli Europei mariti.
Se fedelt si limitata e scarsa
Gli appaga! Non son forse a pubblic'uso
Le vostre mani, il vostro volto, e il core,
E le parole? E che mai pretendete
Riservare a gli sposi ?
A questa prima versione, nella elegantissima pubblicazione
nuziale segue la traduzione d'una lettera della stessa Montagu
ad una sua amica. Ed una cosa deliziosa, questa lettera, una
'
La biblioteca era ornamento ambito dei gabinetti di toeletta. Una ricca
raccolta di novelle del '7CX) ha appunto questo titolo: La toelette ossia rar-
colta galante di prose e versi toscani dedicata alle dame italiane (Firenze.
Allegrini, Pisoni e C, 1770-1771j.
''
Venezia, Zatta, 1792. Le due traduzioni del Conti .si trovavano gi
nella raccolta delle sue Prose e poesie (Venezia, Pasquali, voi. I, 173!>, e
voi. II, 175G), nel voi. II, parte 2, pag. ii e segg. e pag. xm e segg.
I CICISBEI 249
amabile fantasia giovanile, in cui la scrittrice traccia il ritratto
dell'uomo ideale a cui darebbe il suo amore, e pregusta con la
immaginazione le gioie che con esso vorrebbe godere. L'uomo
che essa desidera dovrebbe accoppiare l'onest al senno, non
esser troppo severo, e nemmeno scioccamente baldanzoso :
Giusto decoro in publilico con8er%'i;
In me confidi, e ne' suoi sguardi il mostri.
Mi si appressi di rado e con rispetto;
Ma senza sciocca languidezza, e senza
Dimestichezza ardita ei mi saluti.
Allora poi che delle pubbliche ore
Sia passata la noia, ed a secreta
Mensa concesso di gustar ne sia
Vin di Sciampagna e dilicati ])o]li,
Possan le pi piacevoli pazzie
Lusinghiera recarci ora felice
Da lunge ogni timor ci stia, da lunge
Ogni discreto e timido contegno;
E l'arti dispregiando e le sembianze
Tra la folla affettate alfin scordiamci
Ei d'esser rispettoso, io d'esser fiera.
A lui sia dato il dimostrarsi audace;
Ne disconvenga a me eh' io gli perdoni.
una scena d' intimit spensierata e birichina
;
anzi le pa-
role della Montagu ci lascerebbero dubbiosi che essa avesse vo-
luto parlare di un amore non consacrato dal rito nuziale, se non
dovessimo pensare ch'ella desiderasse di trovare nel marito, nel
compagno da lei scelto, l'amante : cos appunto interpret la
leggiadra descrizione della scrittrice inglese ehi la offerse, pub-
blicandola, ad una sposa novella.
^
Lady Montagu
'-
aveva spo-
'
Si noti che nella Vita coniugale la Montagu ha parole roventi contro
i zerbini e i seduttori e contro il loro amore disonorante, mentre esalta
quello coniugale.
-
Lady Mary Wortley Montagu (KjltO-lTti, nata Pieirepont, figlia del
Duca di Kingston, rimasta orfana di madre, ebbe un'educazione libera e
audace, ma irreprensibile. Brill fin da fanciulla per la sua grazia e viva-
cit d'ingegno nella s )ciet di (-iorgio I: aml)iziosa e desiderosa d'essere
ammirata. Tenne una corrispondenza, troppo spregiudicata per una fanciulla,
con Anna Wortley, sorella di Edward, che Mary am riamata, e ohe spos
di nascosto, per vincere l'opposizione poco giustificata del padre suo. Dopo
il soggiorno in Oriente, torn a Londra, e il suo temperamento le procur
noie e dispiaceri, in cui entr anche il Pope, divenutole, pare, nemico, perch
la dama spiritosa aveva respinto una dichiarazione del poeta. Per notizie
250 I CICISBEI
sato nel 17 L2 un uomo ch'essa amava assai, e dopo aver bril-
lato qualche anno nella miglior societ londinese dei tempi di
Giorgio T, ammirata e corteggiata, lo segui in Turchia; di qui
torn in patria nel 1718, e vi stette fino al 1739, dopo il quale
anno si stabil in Italia, lasciando la famiglia, in cui aveva
avuto gravi dolori, per opera specialmente del figlio Edward,
i
A questo figlio essa, essendo in Turchia, fece innestare il vac-
cino, secondo l'uso veduto fra gU orientai, dando coi, prima
fra le madri europee, un esempio che dopo di lei fu imitato e
diffuso : e ad ognuno nota la menzione gloriosa che del nobi-
lissimo e pietoso ardimento della Montagu, suggerito dall'amor
materno, fece Giuseppe Parini nell'ode famosa.
-
Questa donna
onora il suo secolo
;
e non senza ragione il fiero poeta, che
espose al ridicolo e s.'erz con la sua ironia le coppie cicisbee,
ma pi volte rappresent il lieto ed onesto affetto consacrato
dalle nozze, e seppe, nell'ode Alla Musa, descrivere una cosi
gentile scena d'amore coniugale, volle, fra le migliori donne
dell'et sua, esaltata questa dama inglese, che col suo esempio
tante giovani esistenze sottrasse al terribile morbo, e con senti-
mento cosi squisito di donna seppe rappresentare l' intimit do-
mestica allietata dall'amore,-'' Che se poi la storia fa le sue
sulla Montagu rimando ad un articolo di Camille Skldex [Vie et lettres
de Lady Mary Wortley Moyitaym, nella Bevue des deux Mondes, 15 ot-
tobre 1869).
'
Nel 174() la Montagu. dop'> di aver soggiornato ad .Avignone e a
Brescia, si stabil a Lovere, sul lago d'Iseo. Una testimonianza contempo-
ranea dice che e^sa era allora servita da Ugolino Palazzi, un conte bre-
sciano. E da notare che la maldicenza perseguit la Montagu anche in
Italia. Uno studioso, che s' occupato con qualche diligenza della dimora
della dama a Lovere, non crede che la fierrif del Palazzi alla Montagu
nasconda un intrigo: e noi facciamo rilevare che la gentildonna famosa
aveva allora 56 anni. Cfi-. C. P. L. Marinoni, Lady Montagu Wortley e la
sua decennale dimora alle rive del lago d'Iseo, Lovere, tip. editrice Luigi
Filippi, irKj4, pag. 11. Dello stesso Marinoni un altro lavoro, \\\\ difet-
toso, su Lady Montagu Wortley prima della sita venuta alle rive del Sebiiio
(Lovere, tip. Filippi, 1903i.
"
Ode su L'innesto del vainolo (vv. KMJ-IOS:
<) Monteg, fiual peregrina nave...
Port si gran tesauro
Che a pareggiare non che a vincer basti
Quel che tu dall' Eussino a noi recasti V
'
Si ricordi la canzonetta Per nozze, che contiene nella prima parte una
cosi leggiadra descrizione della sposa dormiente ancora al mattino e dtl
I CICISBKI
251
prudenti riserve su qualche atto dell'et pi matura della Mon-
tagu, riesce forse per questo a cancellare le benemerenze, per le
quali ebbe il plauso dell'austero poeta, che fu cosi parco tes-
sitore di lodi?
Abd-el-Kader Salza.
suo destarsi, e il frammento Per nozze .Era gioconda immagine). Ricor-
deremo anche il capitolo nuziale del Parisi, Signora Rusa mia saggia e
dabbene {Opere, ediz. Reina, III, 133 segg.), in cui il poeta in torma scher-
zosa d consigli pieni di saviezza, e questo prima d'ogni altro:
Voi vi dovete, o sposi, sempre amare,
Non gi voltarvi in capo a pochi mesi
L'una al servente, e l'altro a la comare
Gi E. Bp]RTANA Studi parhiiani, Spezia, Zappa,
1893, pag.
i^i
segg.i not
clie al Parini, prete e derisore della vita domestica priva d'affetti virtuosi,
e sferzatore de' cicisbei, tocc il nobile ufficio di elevar il concetto della
famiglia, nelle Nozze e nell'ode Alla Musa,
<
non coi rigidi precetti della
morale e con le solenni sentenze della sapienza, ma con le grazie scavi
e calde del sentimento .
AHD-EL-T\: A BA LZA
I
ANCORA DEI CICISBEI
ESTRATTO DAL FASCICOLO DI 1910
DELlA
Rivista d'Italia
ROMA
PIAZZA CAVO UH
Roma - ripoJ,:rafi:l dell' l t uion e Elllll ic('. vb Fcdcrico Cesi 45.
ANCORA DEl CICISBEI
L'articolo intorno ai Cicisbei nella cita e nella lett eratura
del Set tecento, da me inserit o nel fas cicolo dell'agost o scor so di
questa Ricista, fu pubblicato con le sol e correzioni fatte sulle
prime bozze; della seconda revisione , che comprend eva l'ag-
giunta di qualche testimonianza e cii qualche utile ind icazione
bibliografica, non si pot pi, per varie ragioni, t enere alcun
conto. Alle scorrettezze tipografiche avr provveduto l' accor-
tezza del lettore; l alle omissioni intendo qui riparare io me-
desimo, giovandomi ancora de lla cortese ospitalit de ll a Iii-
cista.
Dar il primo luogo ad un documento, che ebbi il t ort o di
tra-curare, per un tiro giocatomi dalla memoria. Parlando dell a
satira settecentesca rivolta a sfe rzare e cast igare i cicisbei, io
tralasciai deliberatamente di riferire quasi t ut te le testimonianze
note gi per gli studi di Achille Neri e di alt ri benemeri ti e
misi in rilievo solo quelle del t utto nu ove o imperfettamente
conosciute. :'.l a nella non breve enumer azione lasciai fuori un a
satira, che pur conoscevo e su cui m'ero promesso di soffer-
marmi. Xe dobbiamo la conoscenza al chiarissimo prof. Luigi
Valmaggi del]' Uni versit di 'l'orino, che' la pubbl ic i n un oJlu-
scolo nuziale 2 e gentilmente me ne offerse un a copia: la Xa
, Ecco tuttavia le pi necessarie: A p. li nea I l in luogo di sta111-
pale corregg] stampati; p. 19(; lino 3, {ascice corro iuscir rs; p. 19!J n. l li n. H,
Jfallin corro Jfillin; p. I. W, calero corro ral sero: p. :!Ul li n. HO, di CIIi
C. perrh: p. :W:! liu. e il dicampare corro il d ioumpa rc; p. li u, :1, su e
corro tue: P: 210 lin. 11;, la met corro !/ili nell a prima met ; p. 2:!1
Iin, 1, la satira del corro {a satira; p. 2:28 lino 15, [ctic! corro (t'de/ i : p. 2;1:2
lino Ili, di moralit corro di moralisti; p. 2:l l l i n. :2 1, s/lpcl'/il'ia{e t I'W ' I'(' corro
sllJII'/'/cial" o trarre: p. lino :2tl, t empa co rro l rm po la, o li n. :\0, ('II"
corro N/SI'; p. lin. :IU, COIJli corr. eolui ; l'. :2R!1 lin. 5, a mello con, Il
11/1'1/0 "'/111" p. lin. I,; {a curr. ....e {II : p. 2:iIJ li no H, col corr. (,IIS.
, SOZZI' Fontuna-lticaidour, 'l'orino, nprilo
DEI CICI S BEI 51 U
di dodi ci sat ire l scritt d a un sc t t -o - ut istn fiorent i no. ( rir)va n ni
Paxzi, del quale c' i uforrn eru l' f'gr r>gio professor Luig i
Fass, e iII essa l' aut ore esagera il cost ume chr- u'ngono i no-
bili giovani ci cisbei nel se r vire a lle loro d amo .
da vve r o un co rn poni meut o di sca rxiss irno valnr e
iufarcito d'idi oti smi e di vo caboli rir -r-r cat i : ma vi -ono qua
Jil aooenni curiosi, par t icol ari non inutil i a di i f:v'(,ia la storia.
del ci cisb eismo i a d ogni modo un nuovo non trascurabile do-
cume nto de-lla sat ire toscana co n t r o i cavalieri "Crvent i ,
T cic is be i offerse ro a rgomen to di riso, olt n-c h/: a lla satira e
alla commed ia, anc he all a nost ra opera buffa. Ai m-I od ra rn rni
da me segnala ti nella.rti col o citat o (p. conv ienr- aggiungere
quelli indi cati nel recentissi mo vo lum e, in cui Pir-t ro Toldo di-
scorre con tanta do t trin a, f.' reuere de .1foli re et sa [ort uue n
Italie. Essi sono i seguenti: Il cicisbeo schernito tlallortolana
scalt ritu , int ermezzi pelo musica (F err ar a 17:20) ; Lo cic isbeo co/ -
[eato, commedia p el' musica di 'I'ounnaso Mar ia ui , romano, 11/11-
sico di Costante Iioberto, rappres entata al t eatro dei Fi orentini
di Xapol i , l'WIlIO 172.9,. Il cicisbeo ridicolo, inter mezzi d'ano-
nimo (Gen ova, t eatro Falcon e, car ncva lo 17..J-B.I ; Il cic i...beo con -
solato oc oero i casteli'Ln aria di /Jon Vela-co, [ursetta ({ quat t ro
caci in 2 parti di Claudio .l[azzwel1i, musi ca di Ant onio Auri-
si cchio (Roma, t eatro della P a ce, carnevale 17-lS) ; Lo cici sbeo,
commedia pel' musica di Pietro 'I'r in c1te1'11, musi ca di Nicola Lo-
gl'ascino (Na,poli , 'l' entro Nuovo, 17,)] ) ; Jl ci cisbeo discacci at o,
commedia per musica, musi ca eli Gaetano }[onti , r a ppress entat a
al Teatro Nuovo di Xapoli , la prima vera 1777 ; J cici sbei de-
lusi, opel'a giocosa il/ .'l atti , d ' anoni mo (Livor no, t eatro San
Sebastiano, primavera La cedora scaltra e il cicisbeo /' i-
dicolo, intermezzo, d'ano n imo (F ir enze, tentro Cocomer o, cu rne-
vale 17aG).
Una fortuna veramente not evole bbero adunque i cici sbei
sul teatro, e chi prendesse in es.u ue c omplessiva me nte i me lo-
drammi p le commedi e, in cui fur ono o dr-r isi o mc-si in cui-i-
catura, ne trurrebbe parti colari assa i curios i per Lt st or iu <Id
cost ume sett ecentesco.
I Sono conse r vate nel cod. :\lagli abech i:lIw, " H,
Turin, Loescher, Ut Ili . p. ! :?n. n. 1. Vedi nuch e l'. 1:\l. n. I e 151 Il. l.
.-\.1 Told o so no an ch e noti al cu ni dei mel odrammi da me in dicat i. Egli inolt re
si occupa della co mme dia Il cici./o scolI .ot ato di G. n. e dI,il e
relaz ioni COli l' opera de l :\Iuli re I p. =-gl-: . .
520 DEI CICISBEI
Sia da ul ti mo rico rdata, a pr oposit o delle letture gradite alle
dume del / 00: l la t estimoni anza che ci vi ene dal car te ggio eli
Alessandro e Piet r o Verri , di cui s' da po co intrapresa la pub-
bl i caxione. ?
n futuro a utore dell e No tt i rOIiUlII e) nel 17GB, essendo a
R oma, f requentava la marchesa D. )Iargherita Gentili-Boccup .i-
dul e, nata marc hesa Sparapani di Came r ino, e ue era ninamo-
ratissimo.
Si tratteneva presso di lei a co nve rsare, a fa re un pl)' di
musi ca (essa sapeva suonare o cant a re, ed anch ' egli ca nt a va
come poteva) e a leggero. Rilevo dal Cmt eggio due tratti che
si l'i feriscono a qu est' ultima occupazione del Verri e della su a
dama. Xel primo, in una let t era del 28 agosto 17G8, Alessaudro
scrivendo a l fratello Pi etro, co me fa in quasi tutte le su e let -
tere, ri corda la donna amata: Ell a logge attualment e' il Mie
Clarlssu l Iorl ou:e [cio la or Horl ou:e del Ri-
chardsou], o lo g usta i nfinitamente. sta t a in cantata dall' /11-
gl;n ll cd ama assai La Pri ncesse de lJabyloll(, (II, p. 18) ; e nel
secondo passo (de l 7 settemb re 1/li8) aggiunge altri part icoluri
sull e letture pi gradite a lla gentil e marchesa: Leggiamo il
l 'ri ucipe di Nicol Machiuvclli , avendo la marchesa desid erato
eli aver id ea di questo famoso libro ... Leggo unc ho C11I -
r issa l Iorl oice, e ne in cantata. Ha let t o CO li piacer e il /'01;/11('
dI' (Ien ce; ma trova ca ust ico il ri trat t o di Ronsscau.
Xel 1/( !/'/ Il /III' l i l ' i nt ertlit t rova Emire ue un a pettegola
cr udel e" cd il nunzio tro ppo caricato. Cos] ella giudi ca i libri "
( 11, p. sg. ). Accanto al fu rbuna t issi mo ro manzo de l Hirhard
son, a veva singolur favo rr-, presso i tIUI" in na mo rnti, il Voltuir e.
e trova va un posti ciuo an ch e il Machia ve lli.
P iet ro Yerri non t'm meno i nna mor at o el i .\ l"SSltlll lro: e a
:Jlilallo s pasi mava per uu 'a.ltra uui rchesa, D. :\larl dal e na I sim-
bardi nat a Beccari a BIIlll'sa II<t i ma go.1eva nH' Il0 liher t dI'l fra
t-Ilo, p-rch il mari to .lolln siguoru, designato dal Yerri l'o i
graziosi app-Ilar ivi di ({ orso e imb eci lle ", in"os lwttitn d. ll"
a s:,id niti l di lui presso D. Marlcla lenn , li snr",>gliaYil att onturnIl !t '
o: c us t ode Lern o uoiosissimo s : e Pi et r o invidiuva la sort mi -
l Cfr. il mio urt.icol o, Il p. c :.1 li.
Cllrll'!!.'!;" di Pietro (tI ;\1, 1':";:<,\:\ 0 110 \ '1': 11 11 1 dal l i l;l ; al a curn di
F'rur... ..:";l:" Xovuti u .l'Emauuele Gruppi, Miluu o, ( \ 'I-( l illti , 1!I1Cl. Pi nnru IIU
uscito !iu!" il Il \"I, )IIIUC.
A:-;CORA TlE I C l C l ~ B F . 1 ;,! I
glinre di Al-ssandro, non soggetto corrie lui ad un Argo. (; 1\,
st.ode severo dr-Il a signora a cui egli serc i ra . )
Tra le molte cur iosit d'ogni gener e che agli studiosi del
Settecento offre quest o ri cchissimo carteggio verriauo, non S"II
delle meno a pprezza bili quel le confessioni, che ci aprono lauiino
di due qiocani siqnar] dat isi a corteggiare due dame, o w..gli o
a far loro da cicisbei, l'uno a Mil ano, l'altro a Roma. Y','ran
cicisbei inn ocui e ridi coli ; ina ve n'erano anche di quelli P"I;'
olosi per la tranquilli t dei mari ti delle cicisbee : AlessanI ro r-
Pietro \ Terr i, per que ll'ardo re che ci r ivel a no le 101"0 lettere, lWI!
erano dei primi davvero.
Tuttavi a non li coinvolgeremo nel biasimo e nello scherno
che si meritarono tant'altri cavulieri serve nti, perch essi sPp-
pero trovar in s virt snfficente per non render si al tutto schiavi
delle sciocche cost umanze del secolo ; e megli o pr ovvider o alla
loro fama dedicando la parte pi nobile della loro fervida in-
telligenza a quel rinnovamento, che nell a seconda met del se-
colo decimottavo si veniva ma turando, dell a societ e della let-
teratura italiana.
A IlD-EL-KADER SALZA.
I Questa parol a usat a dnl!o 3te380 Pietro " erri iI I, p. l" I.
L'ITAI.lA l'F.LLE RIVISTE STRANn;RE.
del fascicolo di settembre 1910 della Rivista d'Italia
G/i abitallti primi{iz'i ae/!'I rpillia.
Per /111 L.topardi II/a/ noto.
Poesia e P(leli dia/ella/i calabresi.
Un patri:;i,' ferrarese, soldato di j\rajo/e"'lt J .
UII indozind/o dantesco,
La nlloz'a A/hmia.
rincara di'i cicisbei.
A. de Blasto .
C. Rbcra .
A. Cipollini
Lo Giommi
G. Lanzone
G. de' Passera
A. Salza
I i, RISORG1ME:"TO ITALIANO. - 1\1. degli Alberti. Lettere inedite dr! conte III C
al Conte di Cai,tdborg".
il, JI.I.F.TfI:-iO BIBLIOGRAFICO.
50MlVIARIO
A"NO XIII
d'I t alia i pul.l.lica IO J'oma, IO f.l'cicoh mensili di CIrC zoo l'll in..
I, oni c \1\"'\" fori \l o. - l'n'1.," .l'aLboll mento l'''' l' Ilalin: 1111 anno L. 20, 11
I., 11. ) r-r l't ero t Il anno I r. 25 (ur. ,lIn drn Ire lr, 13 uro , J'''1.W <Ii un (,l<ciea
ralu l r I I I a J.. 2; ) r-r I E tero Fr. 2 .50.
IIlultrazl on l. - Cranio e corredo funebre nel cimitero neolitico della provincia di Avellino. - Frecce cl
la britto, fii di Alta\'illa Irpiula, di :\loulc(uscO, cii Calitri, di Monteverde. - PUlita di Iarl I.
'Iirabclli, Irecc iol lua di Alravi lta Irpiui a , JluRtI:lle di :\1oIl1cn:re. r oltr-If i, punm di nJ!'-pid...- 3 rtI li
punta .li (rt'ccia di l rpiuia. IIUCh:O trovato tra "U(allin e il Scie. - .\ltrc frecce lli C' I
Altavllta Jrpiuia. Mi-abclla, di H:'\gnoli Irpmo, di Zungolo, accrun. - L
<.l CII,lIes. - k tratto <Id Marcbese ErLOlc
Potrebbero piacerti anche
- 02 UNIV - SEVILLA - Hypnerotomachia Poliphili - Venecia, 1499 PDFDocumento468 pagine02 UNIV - SEVILLA - Hypnerotomachia Poliphili - Venecia, 1499 PDFDurruti MalatestaNessuna valutazione finora
- LA RONDA Rivista Anni I Numero 1 Aprile 1919 .Documento85 pagineLA RONDA Rivista Anni I Numero 1 Aprile 1919 .dertoninoNessuna valutazione finora
- EINAUDI Il Mio Piano Non È Quello Di Keynes (1933) // KEYNES Means To Prosperity (1933)Documento41 pagineEINAUDI Il Mio Piano Non È Quello Di Keynes (1933) // KEYNES Means To Prosperity (1933)dertoninoNessuna valutazione finora
- Guidotti 1791, Metodo Facile Per Formare Qualunque Sia Sorte Di VerniciDocumento172 pagineGuidotti 1791, Metodo Facile Per Formare Qualunque Sia Sorte Di VerniciMarco D'AgostinoNessuna valutazione finora
- In Memoria Del Cardinale Di Ferrara Curavit Roberto Borgia 2009Documento52 pagineIn Memoria Del Cardinale Di Ferrara Curavit Roberto Borgia 2009roberto_borgia1100% (1)
- Image GX197 Ab Miscellanea OpalDocumento81 pagineImage GX197 Ab Miscellanea Opalbijiso3768Nessuna valutazione finora
- Demetrio. (... ) Tragedia 00varaDocumento178 pagineDemetrio. (... ) Tragedia 00varaNahuel Facundo RandoNessuna valutazione finora
- 1641 La Finta PazzaDocumento109 pagine1641 La Finta Pazza渡辺憲一Nessuna valutazione finora
- Fenici A NapoliDocumento512 pagineFenici A NapoliRenato BenintendiNessuna valutazione finora
- Giuseppe Botti, Cleopatra Nella Tradizione RomanaDocumento35 pagineGiuseppe Botti, Cleopatra Nella Tradizione RomanadanielefrabottaNessuna valutazione finora
- Durero, Alberto. Della Simmetria Dei Corpi HumaniDocumento292 pagineDurero, Alberto. Della Simmetria Dei Corpi HumaniDavid D. BaudetNessuna valutazione finora
- Ramusio Giovanni Battista - Primo Volume Delle Nauigationi Et Viaggi 1550Documento817 pagineRamusio Giovanni Battista - Primo Volume Delle Nauigationi Et Viaggi 1550lololoNessuna valutazione finora
- CAROSO, Fabritio - Il Ballarino (1581) (Facsimile Dance & Music Source)Documento420 pagineCAROSO, Fabritio - Il Ballarino (1581) (Facsimile Dance & Music Source)Gérard Reyne100% (1)
- Stanze Ove Narra L Origine Fatti Dell Crnojevic 1575Documento105 pagineStanze Ove Narra L Origine Fatti Dell Crnojevic 1575Luka LOPICICNessuna valutazione finora
- Il Re Torrismondo (Torquato Tasso)Documento129 pagineIl Re Torrismondo (Torquato Tasso)pomegranate246Nessuna valutazione finora
- Le Opere Di Bernardo Davanzati, Vol. IIDocumento618 pagineLe Opere Di Bernardo Davanzati, Vol. IIAVENDRAGONessuna valutazione finora
- Arteaga, Stefano - Le Rivoluzioni Del Teatro Musicale Italiano (1783) Vol 1Documento442 pagineArteaga, Stefano - Le Rivoluzioni Del Teatro Musicale Italiano (1783) Vol 1Tarquinia MolzaNessuna valutazione finora
- Origine de Cognomi Gentilizj Nel Regno Di NapoliDocumento341 pagineOrigine de Cognomi Gentilizj Nel Regno Di NapoliSandroNessuna valutazione finora
- Trattato De' Giochi e De' Diver - SconosciutoDocumento440 pagineTrattato De' Giochi e De' Diver - Sconosciutogiyane6472Nessuna valutazione finora
- DiAlbertoDurero DellasimmetriadeicorpihumanilibriquattroTextoimpreso PDFDocumento292 pagineDiAlbertoDurero DellasimmetriadeicorpihumanilibriquattroTextoimpreso PDFLizeth Vanessa Escobar MolinaNessuna valutazione finora
- Tutti Trionfi Carri Mascherate o Canti - Vol 1Documento392 pagineTutti Trionfi Carri Mascherate o Canti - Vol 1lb4lb4Nessuna valutazione finora
- Lo Assedio Di Roma by Guerrazzi, Francesco Domenico, 1804-1873Documento427 pagineLo Assedio Di Roma by Guerrazzi, Francesco Domenico, 1804-1873Gutenberg.orgNessuna valutazione finora
- Cesare Ripa - Iconologia, Padova, 1618Documento704 pagineCesare Ripa - Iconologia, Padova, 1618PescadoNMadrid100% (2)
- Elogio Storico Di Donna Maria Gaetana AgnesiDocumento126 pagineElogio Storico Di Donna Maria Gaetana Agnesinicola_sprNessuna valutazione finora
- Le Ingeniosi SortiDocumento219 pagineLe Ingeniosi SortiMrio MartinNessuna valutazione finora
- Atti Del Processo A Giuseppe BalsamoDocumento216 pagineAtti Del Processo A Giuseppe BalsamoAntonio DegrandiNessuna valutazione finora
- Output.oDocumento446 pagineOutput.oLuiss GustavoNessuna valutazione finora
- Idea Dell'universo, Che Contiene La Storia Della Vita Dell'uomo...Documento226 pagineIdea Dell'universo, Che Contiene La Storia Della Vita Dell'uomo...jvlmgNessuna valutazione finora
- 015 Folengo Opere Italiane 1 Si116 PDFDocumento397 pagine015 Folengo Opere Italiane 1 Si116 PDFAnonymous Y2lFtAzSNessuna valutazione finora
- Capra Vol 1-2-1717 - La Nuova Architettura Civile e MilitareDocumento602 pagineCapra Vol 1-2-1717 - La Nuova Architettura Civile e Militarepvecci100% (1)
- Massimi Sistemi Del MondoDocumento516 pagineMassimi Sistemi Del MondoYao Alvarez RiveraNessuna valutazione finora
- Lolimpiadedramma257meta PDFDocumento62 pagineLolimpiadedramma257meta PDFdolloratNessuna valutazione finora
- CINTHIO, Giraldi. Hecatomithi (Italiano)Documento531 pagineCINTHIO, Giraldi. Hecatomithi (Italiano)AlmandoNessuna valutazione finora
- Boccaccio Vita Di DanteDocumento48 pagineBoccaccio Vita Di Dantealdosci100% (1)
- (Cesare Ripa) Iconologia PDFDocumento484 pagine(Cesare Ripa) Iconologia PDFFabien CamilleNessuna valutazione finora
- Cesare Ripa - Iconología, 2Documento458 pagineCesare Ripa - Iconología, 2Samuearl100% (1)
- (1643 Apr. 12) Delle Vite De' Pontefici Dal Salvator Nostro Sino A Paolo II (B. Platina)Documento1.010 pagine(1643 Apr. 12) Delle Vite De' Pontefici Dal Salvator Nostro Sino A Paolo II (B. Platina)cisu2006Nessuna valutazione finora
- Teatro Genealogico Et Istorico Dell Anti PDFDocumento273 pagineTeatro Genealogico Et Istorico Dell Anti PDFAnonymous WLU25pNessuna valutazione finora
- Felsina Pittrice Vite De' Pittori Bolognesi Tomo Terzo Alla Maesta de Carlo Emanuele III. Re Di Sardegna &c. &c..Documento460 pagineFelsina Pittrice Vite De' Pittori Bolognesi Tomo Terzo Alla Maesta de Carlo Emanuele III. Re Di Sardegna &c. &c..Toni RossoNessuna valutazione finora
- La Santità Degli Eremi - S Bruno Certosino PDFDocumento158 pagineLa Santità Degli Eremi - S Bruno Certosino PDFagamennoneNessuna valutazione finora
- Il Don Pilone LibroDocumento164 pagineIl Don Pilone LibroGandolfo DominiciNessuna valutazione finora
- Mavro Orbini - Il Regno Degli Sclavi, Kraljevstvo Slavena - Miće GamulinDocumento519 pagineMavro Orbini - Il Regno Degli Sclavi, Kraljevstvo Slavena - Miće GamulinMiće GamulinNessuna valutazione finora
- Dizionariodellom 00 GiuluoftDocumento532 pagineDizionariodellom 00 GiuluoftpalpitumNessuna valutazione finora
- La Morte e I Suoi Segreti Stanislas de GuaitaDocumento477 pagineLa Morte e I Suoi Segreti Stanislas de GuaitaRené0% (1)
- Straparola, Giovanni Francesco - Le Piacevoli Notti, Vol. I, 1927 - BEIC 1930099Documento265 pagineStraparola, Giovanni Francesco - Le Piacevoli Notti, Vol. I, 1927 - BEIC 1930099gordito100% (1)
- Discorsi Dell'Arte PoeticaDocumento233 pagineDiscorsi Dell'Arte PoeticaDreykon FernandesNessuna valutazione finora
- Il PimandroDocumento145 pagineIl PimandroVinícius ManassésNessuna valutazione finora
- Fabris - Della Vera Pratica e Scienza D'armiDocumento262 pagineFabris - Della Vera Pratica e Scienza D'armiLorenzo GazzolaNessuna valutazione finora
- Storia Delle Monete Della Repubblica Fiorentina / Data in Luce Da Ignazio Orsini Accademico Fiorentino, Apatista, e Socio ColombarioDocumento385 pagineStoria Delle Monete Della Repubblica Fiorentina / Data in Luce Da Ignazio Orsini Accademico Fiorentino, Apatista, e Socio ColombarioDigital Library Numis (DLN)Nessuna valutazione finora
- Informazioni Su Questo LibroDocumento273 pagineInformazioni Su Questo LibroRenato BenintendiNessuna valutazione finora
- Orginal Marvo OrbinDocumento528 pagineOrginal Marvo Orbinpetar100% (4)
- Cesare Ripa - Iconología, 1Documento492 pagineCesare Ripa - Iconología, 1Samuearl0% (1)
- Breve Nota Di Quel Che Si Vede in Casa DDocumento64 pagineBreve Nota Di Quel Che Si Vede in Casa DPaulo AndradeNessuna valutazione finora
- Pellegrino, Il Carrafa, o Vero Dell'epica Poesía (1584) .Documento269 paginePellegrino, Il Carrafa, o Vero Dell'epica Poesía (1584) .Humberto Huergo CardosoNessuna valutazione finora
- Folgore e Cenne Di Marzo VVVVDocumento7 pagineFolgore e Cenne Di Marzo VVVVdertoninoNessuna valutazione finora
- Benedetto Croce Discorsi Alla Costituente e Pagine Dai Taccuini. 1947Documento154 pagineBenedetto Croce Discorsi Alla Costituente e Pagine Dai Taccuini. 1947dertonino100% (1)
- Luigi Einaudi - Gian Giacomo Rousseau, Le Teorie Della Volontà Generale e Del Partito Guida e Il Compito Degli UniversitariDocumento18 pagineLuigi Einaudi - Gian Giacomo Rousseau, Le Teorie Della Volontà Generale e Del Partito Guida e Il Compito Degli UniversitaridertoninoNessuna valutazione finora
- LUIGI EINAUDI Bardature Della Crisi (1932)Documento20 pagineLUIGI EINAUDI Bardature Della Crisi (1932)dertoninoNessuna valutazione finora
- Luigi Einaudi Prediche Inutili - Concludendo (1959)Documento16 pagineLuigi Einaudi Prediche Inutili - Concludendo (1959)dertonino50% (2)
- Giuseppe Parini I CiarlataniDocumento16 pagineGiuseppe Parini I CiarlatanidertoninoNessuna valutazione finora
- Luigi Einaudi Bretton WoodsDocumento8 pagineLuigi Einaudi Bretton WoodsdertoninoNessuna valutazione finora
- Luigi Einaudi Prediche Inutili - Concludendo (1959)Documento16 pagineLuigi Einaudi Prediche Inutili - Concludendo (1959)dertonino50% (2)
- L'Anima - Rivista Diretta Da Papini e AmendolaDocumento33 pagineL'Anima - Rivista Diretta Da Papini e AmendoladertoninoNessuna valutazione finora
- Lacerba - Rivista Diretta Da Giovanni PapiniDocumento9 pagineLacerba - Rivista Diretta Da Giovanni Papinidertonino0% (1)
- Maccari Cremona Flaiano L'ANTIPATICO 1960Documento193 pagineMaccari Cremona Flaiano L'ANTIPATICO 1960dertonino100% (1)
- Continuity - WikipediaDocumento1 paginaContinuity - WikipediaSALVATORE IACOBELLO PhotographyNessuna valutazione finora
- Il Buon SamaritanoDocumento7 pagineIl Buon SamaritanogiangitaNessuna valutazione finora
- 8255 PDFDocumento47 pagine8255 PDFAlessandro MartinaNessuna valutazione finora
- MUT v-70 FT 11.05.31Documento2 pagineMUT v-70 FT 11.05.31ttiinneell8932Nessuna valutazione finora
- Il Miracolo Del PH Alcalino Robert O YoungDocumento6 pagineIl Miracolo Del PH Alcalino Robert O Youngcristiane100% (1)