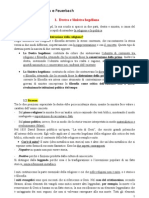Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
984 visualizzazioni10 pagineFrancesco Petrarca
Il documento descrive la vita e le opere di Francesco Petrarca, poeta italiano del Trecento. Petrarca visse tra Italia e Francia e fu un precursore dell'Umanesimo. La sua opera più importante fu il Canzoniere, una raccolta di 366 poesie dedicate al suo amore Laura.
Caricato da
Sonia CusumanoCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PPTX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
984 visualizzazioni10 pagineFrancesco Petrarca
Il documento descrive la vita e le opere di Francesco Petrarca, poeta italiano del Trecento. Petrarca visse tra Italia e Francia e fu un precursore dell'Umanesimo. La sua opera più importante fu il Canzoniere, una raccolta di 366 poesie dedicate al suo amore Laura.
Caricato da
Sonia CusumanoCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PPTX, PDF, TXT o leggi online su Scribd