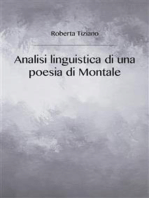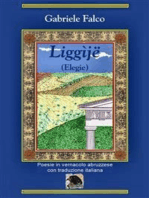Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Docsity Appunti Del Corso Lessicologia e Lessicografia Italiana 2020 2021 Mattarucco
Caricato da
Oscar GoldenTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Docsity Appunti Del Corso Lessicologia e Lessicografia Italiana 2020 2021 Mattarucco
Caricato da
Oscar GoldenCopyright:
Formati disponibili
Appunti del corso Lessicologia
e lessicografia italiana
2020/2021 Mattarucco
Lessicologia
Università per stranieri di Siena
32 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
1 Sia il termine lessicologia che il termine lessicografia sono collegati alla parola “lessico”.
Il lessico è l’insieme delle parole e delle locuzioni (espressioni formate da due o più parole).
Il lessico che analizzeremo riguarderà la lingua italiana, più specificamente quello di alcuni
settori, individui, gerghi, ambiti, testi.
La lessicografia quindi è la tecnica della raccolta o della descrizione del lessico di una
lingua. Il termine lessicografia è composto da due parole: lessico e grafia. La parola è stata
modellata dal francese lexicographie. In italiano la parola esiste dal 19 secolo, in francese
dal 18. L’elemento grafia viene dal greco (scrittura o descrizione). La raccolta o la
descrizione delle parole si trova nei dizionari o vocabolari. La lessicografia quindi designa
anche l’attività di redazione dei dizionari o vocabolari. Inoltre il termine lessicografia può
indicare anche l’insieme di dizionari stessi di una lingua (lessicografia italiana=dizionari di
italiano). Si può anche distinguere la lessicografia di vari secoli (es. del 21, del 19, sono
diversi, si possono quindi indicare opere specifiche).
Lessicologia è attestato in italiano dall’800. È formato dal termine lessico e dal termine logia
(logos, discorso in greco), basandosi anche qui dal francese lexicologie (del 700).
La lessicologia è lo studio scientifico del lessico e della sua evoluzione in una lingua. La
lessicologia quindi studia il sistema lessicale italiano che nel tempo si è evoluto, arricchito
e/o impoverito. Anche in questa materia i dizionari sono fondamentali.
“Dalla A alla Z” è un esempio di locuzione. Per trovare questa locuzione sul dizionario è più
opportuno cercarlo sotto la lettera Zeta piuttosto che sotto la lettera A perché quest’ultima ha
molte più locuzioni.
Il termine che si trova sul dizionario si chiama lemma ed è la forma base della parola. Nel
caso della parola zeta il genere che appare è sia femminile che maschile, in quanto una
volta si diceva anche “il zeta” (Orazio Lombardelli, la difesa del zeta) (esempio di evoluzione
di un termine).
Sul dizionario non posso cercare ad esempio la parola “studentessa”, perché essa non
verrebbe trovata: per convenzione sui dizionari la forma base a lemma è il maschile
singolare. Nel lemma viene poi specificata la forma femminile, ma quella registrata è la
maschile.
Per quanto riguarda i verbi la forma è all’infinito presente, ma nei repertori più antichi del
‘500 la forma base era considerata la prima persona del presente indicativo.
In seguito al lemma è presenta una serie di informazioni definita glossa. L’insieme del
lemma e della glossa è la voce. Dopo il lemma quindi ritroviamo la stessa parola del lemma
riscritta tra due parentesi quadre, divisa in sillabe e con l’accento tonico (non grafico).
L’accento tonico serve a dare un’informazione sulla pronuncia.
L’accento può essere grave o acuto.
Il verbo giocare è un esempio di parola piana. Le parole piane sono le più frequenti.
Esistono però anche parole tronche che hanno l’accento sull’ultima sillaba, questo accento
oltre ad essere tonico è anche grafico. Un esempio sono i verbi al futuro (mangerò).
Esistono anche parole sdrucciole, bisdrucciole e trisdrucciole.
Nella divisione in sillabe tra parentesi quadre occorre fare bene attenzione all’accento: se è
grave o acuto fa molta differenza (vocale aperta o chiusa). Non è presente la trascrizione
fonetica perché più o meno le parole in italiano li leggono come si scrivono. Ci sono però dei
punti critici come la pronuncia della z (sorda o sonora, differenza tra pazzo e razzo), della s
(sole e sdraio), la lettera “o” e la lettera “e” (una stessa lettera corrisponde a due fonemi
diversi). Nel ‘500 alcuni letterati proposero di riformare l’alfabeto italiano per far
corrispondere ad ogni segno un suono diverso (es, Claudio Tolomei, Giorgio Tríssino) ma
non ebbero successo.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
Nel caso della zeta quindi è presente un segno aggiuntivo per far capire se è sorda o
sonora.
Per quanto riguarda le parole straniere i dizionari danno proprio la trascrizione fonetica.
A volte si precisa se il plurale è comune o no e come sarebbe la forma.
In un dizionario la spiegazione può essere divisa in più parti chiamate accezioni (significati).
2
SV= sub voce ovvero sotto alla voce. Serve a rinviare a un lemma.
Per le citazioni di un libro o di un articolo a stampa è indispensabile indicare i numeri delle
pagine o il numero della pagina. Infatti per trovare qualcosa su un volume o su un periodico
dobbiamo sapere dove questo è.
Per i dizionari basta rinviare alle voci se queste sono in ordine alfabetico (come quasi
sempre accade) e il numero di pagine diventa superfluo. Semmai i dizionari a stampa hanno
dei segni al margine dei fogli che evidenziano le lettere con cui iniziano i lemmi, un po’ come
nelle rubriche telefoniche. Quando consultiamo un’edizione online la questione dell’ordine
alfabetico balza meno all’occhio perché cerchiamo direttamente il lemma che ci interessa.
Nel dizionario Sabatini-Coletti online in basso c’è scritto dizionario di italiano dalla A alla Z e
sotto c’è l’elenco delle lettere, se clicchiamo su una lettera escono i lemmi registrati che
iniziano con quella lettera. L’insieme dei lemmi registrati si chiama lemmario.
Tra il dizionario Sabatini-Coletti online e a stampa c’è qualche differenza: nel dizionario
online non ci sono tutti i lemmi che ci sono nell’edizione a stampa (es.zabro,nome di un
insetto, non c’è nell’edizione online ma si nell’edizione a stampa del 2007). Inoltre nel
dizionario online non c’è l’etimologia dei lemmi ma c’è solo la datazione(=data della prima
attestazione nota del lemma). Per voci antiche la prima attestazione non è databile con una
data precisa quindi viene datata per secolo (es.zabaione:secolo XV). Invece per le voci più
recenti quasi sempre c’è un anno ben preciso (es. onomatopea Zac:1961). La datazione è
riportata in tutti i dizionari della lingua italiana, a volte quando un lemma ha più
significati/accezioni queste risalgono a momenti diversi e distanti allora si può trovare anche
la datazione del singolo significato/singola accezione.
Sono molte le informazioni sulle parole fornite da dizionari come il Sabatini-Coletti e altri
dello stesso tipo a cominciare la divisione in sillabe. Spesso in un colpo solo troviamo la
sillabazione e alcune informazioni sulla pronuncia o quanto meno informazioni riguardanti i
punti critici cioè quei punti per cui in italiano non c’è corrispondenza biunivoca tra grafia e
pronuncia. Possiamo trovare anche la trascrizione fonetica completa per esempio per le
parole straniere non adattate.
Inoltre nei dizionari della lingua italiana in questione ci sono informazioni di tipo
grammaticale. È sempre indicata la categoria grammaticale, la parte del discorso (articolo,
nome, pronome…). Per convenzione a lemma per nomi e aggettivi si mette il maschile
singolare(salvo eccezioni).
Sui dizionari italiani non è detto che si possa trovare la parola “poetessa” menzionata da
Valeria Della valle, anzi si trova solo su dizionari più ampi e specialistici, sui dizionari normali
troviamo solo il maschile poeta.
Per i verbi è lemmatizzato l’infinito presente e non più la prima persona del presente
indicativo come si usava nei dizionari più antiche del latino o dell’italiano stesso.
Nei dizionari della lingua italiana che stiamo esaminando ci possono essere anche
informazioni grammaticali come le forme irregolari. Il Sabatini-Coletti ha una peculiarità:
segue il modello della grammatica valenziale Lucien Tesnière. Perciò il dizionario Sabatini-
Coletti dei verbi non dice solo se sono transitivi o intransitivi, ma dice più precisamente come
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
i verbi si costruiscono cioè a quali elementi si legano, come nella chimica gli elementi si
legano a secondo delle valenze, ecco perché si chiama Grammatica Valenziale. Es.
Andare= la maggior parte dei dizionari indica solo che intransitivo. Invece il Sabatini-Coletti
specifica che può avere un argomento retto da una preposizione (es. andare da Milano a
Roma=ha due argomenti/ Mario va a lavoro). Sul vocabolario treccani non c’è tutta la
struttura come nel dizionario Sabatini-Coletti.
Nel Vocabolario Treccani c’è il nome dell’editrice quindi anche del portale treccani.it e non il
nome di un autore. Nel tempo si sono occupati del vocabolario Treccani: Aldo Duro che ha
diretto l’edizione uscita tra fine anni ‘80 e inizio anni ‘90, “Il Treccani” è stato diretto da
Raffaele Simone a inizio millennio e infine Valeria della Valle ha curato la terza edizione
del 2008. I dizionari richiedono un lavoro di squadra ma a volte li citiamo sotto i nomi dei
principali artefici e responsabili (es. Sabatini-Coletti) altre volte citiamo il dizionario sotto il
nome dell’editore (es. Treccani).
Sia nel Sabatini-Coletti che nel Treccani che in tanti altri dizionari, troviamo molte altre
informazioni: troviamo eventuali varianti, derivati e alterati, locuzioni, sinonimi e
importantissimi sono gli esempi che vengono riportati per illustrare significati e usi del
lemma. Gli esempi riportati in questi dizionari che stiamo guardando sono esempi inventati :
in latino Exempla ficta, cioè frasi o sintagmi che ciascuno di noi può o potrebbe usare, quindi
esempi comuni o generici che non hanno una fonte precisa. Chi seleziona gli esempi può
mettere quelli che preferisce poiché sono inventati.
Nel Sabatini-Coletti o nel Treccani a volte sono riportate citazioni d’autore ma prevalgono gli
esempi inventati. Il Sabatini-Coletti e il Treccani sono dizionari dell’uso o generali così li
definiscono Giovanni Adamo e Valeria della Valle nel volume “le parole del lessico italiano”
edito da Carocci nel 2008.
In effetti i dizionari dell’uso non sono dizionari specialistici bensì dizionari generali e quando
parliamo di dizionari della lingua italiana senza altri specificazioni, si intende i dizionari
generali.
I vocabolari/dizionari dell’uso non registrano solo la lingua e il lessico d’uso ma rispecchiano
una parte imprescindibile della storia e della tradizione, riportando in qualche caso forme
antiche (letterarie) e in quei casi anche l'esemplificazione sarà letteraria. Inoltre, persino per
forme tuttora correnti, è possibile che venga riportata qualche citazione d’autore perché
particolarmente significativa.
Quindi i dizionari dell’uso non registrano solo i vocaboli e i significati in uso(quelli che
intendiamo conoscere o adoperare per parlare o scrivere ), ma registrano anche forme del
passato nonché forme più tecniche= le espressioni che possiamo trovare in articoli, romanzi,
poesie, le parole che non usiamo noi ma che vogliamo capire.
Sono dizionari dell’uso o generali il Sabatini coletti, il Treccani, il Palazzi Folena o il
Devoto Oli.
Il dizionario dell’uso per eccellenza però è lo Zingarelli dal nome di Nicola Zingarelli,
filologo e dantista originario di Cerignola (Puglia) e professore a Milano.
Nicola Zingarelli aveva ricevuto dagli editori milanesi Bietti e Reggiani la richiesta di
realizzare un vocabolario della lingua italiana. Zingarelli dopo un po’ di esitazione accettò nel
1912 e avrebbe dovuto consegnare l’opera entro 9 mesi. Invece però Zingarelli si trovò di
fronte a un lavoro enorme e riuscì a pubblicare il vocabolario solo a fascicoli a partire dal
1917 fino al 1921. Esso ebbe poi una seconda edizione in volumi nel 1922 ancora per Bietti
e Reggiani. Negli anni 30 seguono altre edizioni per i medesimi editori milanesi e nel 1935
Zingarelli muore. L’editore (Bietti da solo) dal 1940 al 1941 cedette il vocabolario Zingarelli a
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
un’altra casa editrice la Zanichelli di bologna, fondata nell’800 da Nicola Zanichelli
(modenese). Il vocabolario di Zingarelli conosce quindi una grande fortuna dopo la morte del
suo autore e diventa un po’ il pezzo forte della Zanichelli, che a partire dal 1941 ne pubblica
moltissime edizioni. Il nome di Zingarelli è sempre rimasto ma la squadra dei curatori è
cambiata negli anni, così l’ottava edizione del 1959 è stata aggiornata ed annotata da
Giovanni Balducci, professore di un liceo scientifico di Arezzo insieme a Italo Zingarelli,
giornalista e figlio di Nicola. La nona edizione del 1965 invece viene arricchita da
un’appendice coordinata da Miro Dogliotti (piemontese) che diventa uno storico
collaboratore del vocabolario Zingarelli. Egli ha diretto varie edizioni: nella decima edizione
del 1970 e nell’undicesima edizione del 1973 il nome di Dogliotti è affiancato da Luigi
Rosiello, linguista dell’università di Bologna e Paolo Valesio, critico e scrittore bolognese.
La squadra completa del vocabolario Zingarelli e Zanichelli era composta già allora da più di
100 persone. A partire dal 1993 lo Zingarelli viene aggiornato annualmente e viene
introdotta l’abitudine di mettere come intestazione l’anno successivo a quello dell’uscita
effettiva. L’ultimo è lo Zingarelli 2021, uscito quest’anno. Lo stesso discorso vale anche per
altri dizionari come il Sabatini-Coletti 2008, ma anche il Devoto-Oli 2021. In tal modo si
sottolinea la novità; lo Zingarelli dunque ha più di un secolo, la sua prima edizione risale al
1917 e nel 2017 ne è stato quindi festeggiato il centenario. (guarda filmato Robinson su e-
learning). Robinson è un settimanale culturale del quotidiano La Repubblica che pubblica la
domenica. Il servizio televisivo è stato realizzato nell’ottobre del 2017 nella sede di Roma
della Zanichelli. Beata Lazzarini, una delle curatrici attuali della Zanichelli, è la donna che
parla nel video. L’attuale Zingarelli è a cura di: Mario Cannella, Beata Lazzarini e Andrea
Zaninello. Mario Cannella è un lessicografo che si occupa da molto dello Zingarelli. In una
sintesi da lui redatta insieme a Roberta Balboni chiamata “Come nasce e cresce un
vocabolario” ci sono vari esempi dell’evoluzione dello Zingarelli; nelle prime edizioni alla
voce “spazzino” c’era scritto “gli spazzini milanesi sono pagati come eccellenze”, gli autori
spiegano che Zingarelli era arrabbiato perché nel primo dopoguerra i professori universitari
erano pagati poco. L’esempio è stato poi tolto per questione politiche. Alla voce “privatista”
Nicola Zingarelli aveva scritto “i privatisti accorrono a far gli esami dove sperano indulgenza”
anche questo esempio è stato successivamente rimosso. Un vocabolario quindi dice molto
del tempo a cui appartiene ma anche del redattore stesso. Nelle edizioni dopo la sua morte
venne registrato per la prima volta il lemma “Terrone” da Bruno Migliorini nell’appendice al
dizionario moderno di Alfredo Panzini del 1950. Fin dall’edizione del 1935, alla voce
“frigidario” (sala delle terme romane) viene aggiunta l’accezione moderna di ghiacciaia.
Nell’edizione dello Zingarelli del 1959 viene citato anche il francesismo Frigidaire mentre
frigo è ammesso solo nella decima edizione del 70, nello stesso anno appare anche la
parola “astronauta” (anno successivo all’Apollo 11). Nello Zingarelli è passato quindi un
mondo di parole; anche oggi esso punta molto sulle novità (guarda link alla pagina e leggi
anteprima 2021). La particolarità dello Zanichelli sono alcune note d’autore. Ogni giorno il
sito della Zanichelli propone una parola che il 23 ottobre era caffé, quella del 22 scacco
matto (parole di origine araba).
3 Tullio de Mauro fu un celebre linguista nato nel 1932 a Torre Annunziata. Egli insegnò in
varie università: Napoli, Chieti, Palermo, Salerno e Roma, dove si era trasferito da giovane
ed era poi tornato e vissuto fino alla morte il 5 gennaio 2017. Tullio de Mauro è stato anche
ministro della pubblica istruzione dal 2000 al 2001 nel governo Amato. A Tullio de Mauro si
devono libri di grande rilievo come “La storia linguistica dell’italia unita”, la cui prima edizione
risale al 1963 o come la “Prima lezione sul linguaggio” del 2002. De Mauro ha svolto un
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
importante lavoro lessicografico: ha curato e diretto studi e ricerche e anche proprio
dizionari. L’ultimo frutto di questo lavoro è il dizionario “Il nuovo de Mauro”, interamente
consultabile online nel sito “Internazionale”. “Internazionale” è un settimanale fondato e
diretto da Giovanni De Mauro, figlio di Tullio.
Alla base del vocabolario online c’è il “grande dizionario dell’uso” ideato e diretto da Tullio
de Mauro con la collaborazione di Giulio Lepschy e Edoardo Sanguineti, pubblicato dalla
Utet di Torino. Come indica il titolo, questo dizionario è un dizionario dell’uso ma anche un
grande dizionario, cioè un dizionario più vasto e completo e quindi destinato ad un pubblico
più specialistico. Il grande dizionario italiano dell’uso ha infatti avuto una prima edizione nel
1999 in 6 volumi, ci sono poi stati degli aggiornamenti e una seconda edizione nel 2007
sempre per i tipi della utet in 8 volumi in cartaceo e anche una versione digitale su chiavetta
usb. Riparleremo di questo grande dizionario dell’uso indicato con la sigla Gradit o Gdu. È
grande proprio anche nelle dimensioni: contiene infatti circa 270.000 lemmi. Nel frattempo
nel 2000 De Mauro aveva pubblicato anche un dizionario meno vasto, in un solo volume: “Il
dizionario della lingua italiana” in un solo volume, edito da Paravia. Esso aveva circa
160.000 lemmi, più o meno la taglia di uno Zingarelli o altri dizionari generali monovolume. Il
nuovo De Mauro in rete ha le medesime dimensioni del dizionario edito da Paravia (circa
160.000 lemmi) ma tiene conto anche degli aggiornamenti fatti per il Grande Dizionario del
2007, o meglio va oltre. Come si spiega nelle avvertenze del sito Internazionale, è previsto
che il nuovo de Mauro online continui a essere aggiornato e “progressivamente migliorato
introducendovi correzioni e completamenti”. Tutti coloro che consultano il dizionario sono
invitati a revisionarlo, è infatti riportato un indirizzo email a cui inviare eventuali segnalazioni
o proposte. Nelle avvertenze si illustrano poi criteri e caratteristiche del nuovo de Mauro. Si
dice che come da tradizione è lemmatizzato il maschile singolare, ma a differenza di quanto
accade in altri dizionari, gli avverbi in -mente sono invece lemmatizzati a sé, come lemmi
autonomi. Così per esempio si può trovare l’avverbio attentamente, avverbio che in altri
dizionari come Treccani o Sabatini Coletti figura sotto l’aggettivo attento. Un’altra peculiarità
dei dizionari di De Mauro riguarda le unità formate da due o più parole (comunemente
chiamate locuzioni) che vengono chiamate polirematiche. L’espressione “Dalla A alla Z” è
riportata tra le polirematiche sotto il lemma Z, oltre che come voce a sé. L’aggettivo “attento”
riporta una serie di informazioni come la divisione in sillabe con l’indicazione dell’accento
tonico grave, la qualifica grammaticale (agg.), la datazione della prima attestazione che
risulta, l’etimologia (dal latino attentum), e poi i vari significati (es. essere attenti a qualcosa,
eseguito con cura, attento!). Per ogni accezione c’è un’etichetta in rosso, nella prima c’è fo
(fondamentale), nelle altre due co (comune). Nell’avverbio attentamente c’era l’etichetta au
(alto uso) e nella voce zeta nella prima accezione c’è ad (alta disponibilità), nella seconda
c’è co. Queste etichette in rosso si chiamano marche d’uso.
Le marche d’uso sono molto particolareggiate perché introducono distinzioni piuttosto sottili
individuando ed evidenziando voci di alto uso, disponibilità, comuni ecc.
All’interno dei dizionari de Mauro si trovano marche d’uso diverse a seconda dei vari
significati di uno stesso lemma. Queste distinzioni sono frutto di una serie di ricerche
compiute da De Mauro con altri studiosi nel corso di molti anni. Imprescindibile è la guida
all’uso delle parole di De Mauro la cui prima edizione è stata pubblicata nel 1980 per gli
Editori Riuniti di Roma. L’ultima edizione risale al 2019 ed è una collana curata da Giuseppe
Antonelli per il Corriere della Sera. Come spiega De Mauro nella guida, in italiano così come
in tante altre lingue, esistono parole fondamentali (parole più usate) con le quali noi
costruiamo qualsiasi tipo di testo o discorso. Tra di esse vi sono le parole grammaticali
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
distinte dalle parole piene (che sono quelle a cui di solito si pensa se ci viene chiesto di
scegliere una parola), le parole con un contenuto semantico proprio. Le parole grammaticali
però sono importantissime, non hanno un contenuto semantico autonomo ma assolvono una
funzione sintattica (articoli, preposizioni, congiunzioni ecc.). Spesso le parole grammaticali
vengono anche definite parole vuote o elementi sincategorematici, elementi che acquistano
significato insieme a elementi categorematici. Le parole grammaticali (il, lo, a...) sono
fondamentali per costruire frasi e sono per lo più immutabili nel tempo. Le parole piene
(bello, cattivo, ciao...) invece sono numericamente maggiori ma alcune vengono usate più di
altre. Le parole fondamentali (sigla FO) sono parole indispensabili, rappresentano il nucleo
del lessico. Per De Mauro esse sono circa 2000, e con esse si fabbrica il 90% dei testi o
discorsi.
Ci sono poi parole altrettanto importanti anche se leggermente meno usati delle parole
fondamentali e vengono chiamate parole d’alto uso (AU); degli esempi sono sale, dono,
grazioso, vietare e attentamente. Esse comprendono 2750 termini e hanno al massimo il 6%
di possibilità di essere usate.
Ci sono poi le parole di alta disponibilità (ad), parole che tutti conosciamo ma che non
vengono utilizzate frequentemente, sono parole strategiche che sappiamo utilizzare quando
abbiamo bisogno: degli esempi sono aceto, dogana, margherita e annaffiare.
Questi tre strati costituiscono il vocabolario di base (VdB), il vocabolario di cui tutti abbiamo
bisogno, che conosciamo fin da ragazzini e comprende 7050 parole.
Per costruire il vocabolario di base sono serviti dati, studi e ricerche sulla frequenza delle
parole. Uno strumento di riferimento è stato il lessico di frequenza della lingua italiana
contemporanea (LIF) pubblicato da Umberta Bartolini, Carlo Tagliavini e Antonio Zampolli
nel 1970; esso era basato su un campione di testi scritti. Lo stesso de Mauro ha poi curato
insieme a Federico Mancini, Massimo Vedovelli e Miriam Voghera il “Lessico di frequenza
dell’italiano parlato” nel 1993 (LIP). I dati numerici però da soli non bastano, devono
essere integrati sulla base di altri elementi.
Ci sono state varie edizioni della Guida all’uso delle parole a partire dal 1980 fino a quella di
quest’anno. Esso ha avuto diverse applicazioni: non solo nella scuola ma anche nella
pubblica amministrazione per cercare di intervenire sul linguaggio burocratico spesso
incomprensibile; si veda il “codice di stile delle comunicazioni dell’amministrazione pubblica
del 1993” con una proposta e materiale di studio della presidenza del consiglio dei ministri,
dipartimento per la funzione pubblica; questo codice di stile che tiene conto del vocabolario
di base degli studi di De Mauro è stato voluto da Sabino Cassese, allora ministro della
funzione pubblica. Nel frattempo de Mauro aveva pubblicato più di un dizionario: Il Gradit
(vari volumi, prima edizione 1999, seconda nel 2007), Il dizionario della lingua italiana del
2000 (in un solo volume) e altri dizionari ancora. Dopo queste esperienze e per il fatto
stesso che la lingua e il lessico cambiano nel tempo, de Mauro ha sentito il bisogno di
rivedere il vocabolario di base e così nel 2016 è arrivato un nuovo vocabolario di base in
sigla NVDB. Nel sito c’è una data, 3 dicembre 2016, de Mauro sarebbe morto di lì a poco, il
5 gennaio 2017, quindi si tratta di uno dei suoi ultimi lavori; un lavoro condotto insieme a
Isabella Chiari e Francesca Ferrucci. I tre ordini di parole sono resi con caratteri tipografici
diversi: le parole fondamentali sono trascritte in grassetto, le parole di alto uso sono in tondo
e le parole di alta disponibilità in corsivo. La forma quindi è rimasta simile nella versione del
1980 e nella versione del 2016. Nella sostanza però ci sono stati cambiamenti: nel nuovo
vocabolario di base del 2016 ci sono differenze proprio nelle parole rispetto a quello del
1980 (guarda pdf). Nella versione del 2016 viene messo in evidenza il fatto che tra le parole
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
fondamentali o di alto uso ci siano anche una decina di parole di “accentuata volgarità” e si
specifica che questi termini volgari sono stati trovati più nella stampa e nello spettacolo che
non in altri campioni dello scritto e del parlato. Ormai dal 2016 sono passati 4 anni ma è
opportuno specificare che questa constatazione sull’uso massiccio di parole volgari
soprattutto in determinati testi e contesti vale ancora, basti pensare ai film americani doppiati
o risse in tv, solo in alcuni casi abbiamo usi ironici e consapevoli, molto spesso invece si
tratta di parole di rabbia usate anche a sproposito: tra queste parole quindi si ritrova anche
qualche parolaccia.
4 Nei dizionari di De Mauro, come in altri dizionari, ci sono molte altre voci rispetto a quelle
analizzate fino ad ora. Sul sito di “Internazionale” nelle avvertenze per la consultazione del
dizionario al paragrafo 8 “marca d’uso” ci sono una serie di etichette che identificano e
classificano parole e polirematiche, o anche singole accezioni di voci registrate nel dizionario
stesso. Le prime tre categorie sono FO (es. ascoltate quello che dico-> tutte parole
fondamentali), AU (es. universitario), AD (batuffolo, carrozzeria, dogana). La marca d’uso
CO (comune) identifica tutti quei vocaboli comunemente comprensibili, ovvero i vocaboli
usati e compresi indipendentemente dalla professione o collocazione regionale; essi sono
noti a chiunque abbia un livello medio-superiore di istruzione (es. segnalibro, poliziesco,
avvincente). Le parole comuni sono circa 50.000, ma il nuovo de Mauro contiene circa
160.000 lemmi quindi ci sono altre voci rispetto a quelle già citate. Un’altra sigla è BU, i
lemmi di basso uso, che comprende i vocaboli rari (es. risciacquamento). Inoltre ci sono
anche termini di lessico tecnico-specialistico (TS), vocaboli citati a particolari attività,
tecnologie e scienze, per tali termini viene citato ogni volta a quale ambito appartengono (es.
lessicografia-> appartenente alla linguistica, chiaroscuro-> appartenente all’ambito artistico,
musicale, teatrale). Nei dizionari dell’uso non troviamo però solo vocaboli adoperati oggi, vi
troviamo anche molte voci appartenente alla tradizione letteraria (LE). Nelle avvertenze si
parla di testi e autori canonici dal trecento al primo novecento, da Dante a D’Annunzio, ma in
realtà nel dizionario De Mauro si possono trovare altri autori come Montale al verbo arrosarsi
(Arsenio, ossi di seppia), o Ungaretti in gomitolo (Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di
strade). Certi vocaboli sono però caduti in disuso (OB, obsoleto) come robustoso. A volte in
disuso non è caduta tutta la parola ma solo una sua accezione come aceto, ormai obsoleto
nel senso figurato di spirito mordace.
Altre marche d’uso sono legate alla variazione geografica: ci sono i regionalismi (RE) come
strullo (toscano per stupido), sciocco (toscano per insipido) pizzato (truccato al sud), gerbido
(piemontese, presente in un’opera di Italo Calvino). I regionalismi potrebbero non essere
usati in una regione intera o addirittura in più di una.
Non sempre le etichette dei dizionari sono precisissime soprattutto per quanto riguarda
queste differenze geografiche. Ci sono poi i termini dialettali (DI) come guaglione
(dialettalismo napoletano) o cantarella (cicala un pisano). Ci sono poi gli esotismi (ES), i
lemmi stranieri avvertiti come tali e non adattati come abat-jour o bungalow.
Il nuovo de Mauro contiene 160.000 lemmi incluse le polirematiche, e quindi paragonabile
allo Zingarelli o altri dizionari generali. De Mauro ha però curato diversi dizionari insieme ad
altri lessicografi e collaboratori. Importantissimo è il GDU o GRADIT con la collaborazione di
Giulio C. Lepschy ed Edoardo Sanguineti pubblicato dalla UTET (l’edizione di riferimento è
la seconda, del 2007). Le marche d’uso utilizzare nel GRADIT sono le stesse del Nuovo de
Mauro; anch’esso è un dizionario dell’uso ma è un grande dizionario: ha un lemmario di
circa 270.000 parole. Tra le voci in più ci sono termini di basso uso come frivolità,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
improficuo, miaulio e porporescenza. Nel GRADIT troviamo anche qualche voce letteraria
aggiuntiva come fragorio (Pirandello e Leopardi) o semivivente (Montale). Nel GRADIT si
trovano anche voci regionali o dialettali aggiuntive come casatiello (dolce napoletano) e
tòrtano, o cicchetto (aperitivo veneto) e bacari (osterie venete). Nel GRADIT ci sono anche
molti forestierismi in più come à rebours (all’indietro, francesismo) o compliance (anglismo
per condiscendenza). Un grande dizionario come il GRADIT dà maggiore spazio ai termini
tecnico-specialistici come singenionimo (nomi che indicano una parentela) o detoponimico
(tratto da un toponimo, es. Milanese) o marchiònimo (nome commerciale di un prodotto
industriale come Vespa, Ferrari, Nutella). Il Gradit però ovviamente non può riportare tutti i
termini di ambito tecnico specifico e quindi esistono dizionari specialistici da integrare per i
vari ambiti. Esistono dizionari per ogni campo, anche proprio per la linguistica come quello di
Jean Dubois del 1979 per i tipi della Zanichelli o quello di Gian Luigi Beccaria pubblicato da
Einaudi nel 1994 e aggiornato nel 2004. Anche una voce apparentemente comune come
“lessico” in questi dizionari sarà spiegata in modo diverso, più specifico.
Tutti i dizionari danno indicazioni su varietà e registri d’uso settoriali dei lemmi, nonché sulle
origini delle voci (lingue straniere, dialetti ecc), però per quanto riguarda il livello di diffusione
delle parole, solo nei dizionari di De Mauro c’è una distinzione così particolareggiata che
tenta di individuare ben 3 ordini all’interno del vocabolario di base. Questa classificazione
però ha subito anche qualche critica; negli altri dizionari dell’uso si è preferito dividere i
lemmi in solo 2 blocchi: un nucleo (parole di uso quotidiano) e tutto il resto delle parole.
Nel sabatini-coletti nell’edizione Sansone del 2007 sono evidenziate con un fondino rosa
circa 9000 parole, le parole più disponibili ovvero quelle più conosciute dalla maggioranza
delle persone, le altre 81.000 parole non fanno parte del nucleo. In altre edizioni c’erano
circa 10.000 parole nucleo su 110.000 quindi le parole fondamentali costituiscono circa un
decimo del lemmario. Anche nel Devoto Oli le parole basilari sono circa 10.000 e sono
segnalate in maniera da distinguerle dalle altre voci, che sono 10 volte tanto. Nel devoto oli
2007 le parole fondamentali erano scritte in azzurro. Nello Zingarelli soltanto 5500 parole
sono considerate come fondamentali e sono contrassegnate da un piccolo rombo.
Sostanzialmente perciò in questi 3 dizionari c’è una dicotomia, una divisione in 2 blocchi:
parole indispensabili e tutto il resto del lemmario. Tutti adoperano abbreviazione per
segnalare le differenti varietà del lessico: su un dizionario dell’uso troviamo vocaboli che
appartengono a diversi momenti; troviamo arcaismi (arc), parole antiche (ant) o anche
antiquate. Inoltre c’è l’indicazione del registro dell’uso che si fa di una voce o di una sua
accezione e quindi c’è gergale (gerg), familiare (fam), volgare (volg). Viene anche
specificato se si tratta di un termine di uso burocratico o speciale-specialistico come
architettura (arc), botanica (bot), chimica (chi). In tutti i dizionari dell’uso sono indicati anche
regionalismi, dialettalismi e forestierismi.
Si trovano anche voci letterarie.
5 La parola tavola nel GRADIT presenta la trascrizione fonetica subito dopo il lemma
trascritta tra due barre. La trascrizione fonetica è composta da fonemi, che insieme
costituiscono il significante. Ferdinand de Saussure considerava il significante (sequenza di
suoni e fonemi) come immagine acustica o visiva del segno linguistico; al significante
corrisponde un significato, un senso, l’elemento concettuale. Non sono molti però i casi in
cui a un significante corrisponde un unico significato; questo può accadere nella
terminologia scientifica. Per esempio il significante Bosone dal cognome di un fisico indiano
ha solo un significato: particella elementare atomica o subatomica dotata di spin intero che
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
obbedisce alla statistica di Bose-Einstein. Nella maggior parte dei casi però ad un
significante corrispondono più significati e nei dizionari vengono contrassegnati con numeri
arabi (1-2-2a...). L’area della voce dove sono contrassegnati i significati si chiama area
semantica (dal greco ciò che è relativo al significato). La voce atomo nel Sabatini coletti ci
sono due significati, nel nuovo de Mauro ben 5. Un segno linguistico dotato di più significati
è detto polisemico (vs. monosemico). Quando si parla di significato o significante si parla
anche di referente (l’oggetto cui il segno linguistico fa riferimento); questi tre ambiti si
ritrovano nello schema del triangolo semiotico. Il referente può essere anche qualcosa di
immaginario come con il significante ippogrifo. Un caso analogo è drago, ma in realtà questo
significante ha anche un significato nella zoologia, perché è un rettile asiatico, ma si usa
anche per definire una persona abilissima “sei un drago”.
La parola tavola ha vari significati: il nuovo de Mauro online ne indica 19. Tra i più famosi c’è
asse di legno, supporto di un dipinto e mobile.
La parola tavola nel senso di mobile viene definita dal Sabatini coletti come: mobile formato
da un piano di varia forma in legno o altro materiale sostenuto da un supporto per lo più a
quattro gambe. Questa definizione contiene vari semi (al singolare sema): mobile, dotato di
4 gambe, ha un piano ecc.
Le parole gambe o piedi propriamente riferite al corpo umano vengono utilizzate anche in
altri ambiti per un fenomeno chiamato catacresi. Anche la parola sedia ha vari significati e
semi. Per la spiegazione del significato si fa proprio un’analisi dei semi. Nell’analisi semica si
privilegia il prototipo (un elemento statisticamente rappresentativo) come in tavolo in cui si
specifica mobile in legno a 4 gambe, anche se in realtà esistono molti tipi di tavoli fatti
diversamente. L’unità del lessico è il lessema. L’unità semantica espressa da un lessema è
un semema.
Può capitare che un dizionario individui più significati per un solo lemma ma un altro
dizionario invece fa corrispondere ai due significati due lemmi distinti. La parola tempo sul
nuovo De Mauro online ha 17 significati, nel Treccani ci sono 10 accezioni ulteriormente
articolate in vari punti, nel Sabatini Coletti ci sono due lemmi (tempo 1 e tempo 2) perché al
significante italiano tempo corrispondono più significati tra loro profondamente diversi (il
tempo cronologico, il tempo verbale, il tempo meteorologico). Nel Sabatini coletti quindi con
tempo 1 si indica il tempo storico, cronologico e quindi anche grammaticale, sportivo,
musicale e teatrale, distinto da tempo 2 che indica le condizioni metereologiche. La parola
italiana tempo è una sola etimologicamente e deriva dal latino tempus e col passare degli
anni ha assunto vari significati (polisemia). Si ha invece omonimia quando due parole
hanno lo stesso suono e la stessa grafia ma sono due forme distinte, ciascuno con un
diverso etimo oltre che diversi significati. È più facile riconoscere due omonimi quando
appartengono a due categorie diverse: amare (verbo) vs. amare (aggettivo), sale
(sostantivo) vs. sale (verbo). L’omonimia può essere anche grammaticale: esistono omonimi
appartenenti alla stessa categoria grammaticale come diligenza (1. dal latino diligentiam ->
modo di agire diligentemente, accuratezza, ma 2. dal francese, un tipo di carrozza trainata
da cavalli, questo termine deriva comunque dal latino prima di cambiare significato).
Tara viene da una voce araba che significa detrazione, e nella lingua italiana è attestata dal
15 secolo. Tara ha un altro significato: difetto o malattia per lo più ereditaria e deriva dal
francese, attestato dal 19 secolo. Il termine francese deriva però dall’arabo ed è per questo
che nel GRADIT c’è solo un lemma e non due. I confini tra la polisemia e l’omonimia non
sono sempre così definiti: c’è però una regola per stabilire se un lemma può essere diviso o
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
meno e questo dipende dalla complessità etimologica. Di solito per gli aggettivi sostantivati e
gli aggettivi si usa un solo lemma. In generale sono considerati due lemmi diversi il verbo e
l’infinito sostantivato (es. sapere verbo e il sapere)
6 Le parole non sono qualcosa di isolato ed è importante considerare i rapporti tra di esse;
quando un lessicografo decide di registrare due lemmi distinti è perché li considera come
forme distinte, e non come un caso di polisemia o evoluzione di una stessa forma. Esistono i
rapporti formali (tra i significanti) e i rapporti semantici (tra i significati), ma anche
rapporti etimologici (entrambi). I rapporti formali comprendono parole apparentemente
simili ma con significati diversissimi (cane, pane, lane, mane ecc). Le parole che si
differenziano solo per un fonema sono chiamate coppie minime. I rapporti formali sono
fondamentali per la poesia perché permettono di creare assonanze e consonanze ma anche
allitterazioni o rime.
Esiste anche un dizionario inverso italiano opera di Mario Alinei, pubblicato a L’Aia nel
1962. È costituito da un elenco di lemmi scritti in ordine alfabetico all’inverso: dall’ultima
lettera alla prima di ogni parola, dà quindi rilievo a come le parole finiscono. Questo
dizionario poteva essere utile per chi scrive in rima. I rapporti formali sono anche alla base di
alcuni giochi enigmistici come il gioco chiamato “zeppa” che consiste nell’inserire in una
parola una lettera o una sillaba in modo da ottenere un’altra parola di senso compiuto (casa,
cassa, casta); il gioco di segno opposto è “scarto”, il gioco in cui si toglie una lettera o una
sillaba per ottenere un’altra parola di senso compiuto (catene, cane). Il tipo cane-pane in
enigmistica rientra tra i “cambi”, il gioco in cui si ottiene una parola da un’altra sostituendo
una lettera o una sillaba. Un altro gioco enigmistico che lavora sui significanti è la ricerca dei
palindromi o parole bifronti, una parola che se letta al contrario rimane identica (oro, osso,
otto, anilina, yamamay, anna, ada, i topi non avevano nipoti ma anche con sillabe come
comico, o parole che lette al contrario hanno un altro significato come enoteca, bus, Roma).
Anche gli anagrammi sono giochi che lavorano sui significanti delle parole (es. giravolta-
travaglio, bibliotecario-beato coi libri).
I rapporti semantici possono essere di vario tipo; una relazione possibile è la concorrenza o
equivalenza anche detta sinonimia, che si verifica tra parole o locuzioni dotate dello
stesso significato o di un significato simile e quindi sostituibili una all’altra. È difficile trovare
equivalenti perfetti: spesso ci sono leggere differenze. Spesso accade anche però che due
significanti siano intercambiabili solo per una delle loro accezioni. La parola colore in una
delle sue accezioni più comuni equivale a tinta o tonalità. Di una persona o del suo viso si
può utilizzare colorito o cera. Nell’arte si può utilizzare tintura, vernice o colorante.
La parola buono ha moltissimi sinonimi: di una persona si intende benevola o tranquilla, di
un cibo “gustoso”, di una soluzione “valida o vantaggiosa”. Anche qualora coincida il
significato denotativo, può essere molto diversa la connotazione: madre e mamma indicano
entrambe lo stesso referente, ma la connotazione a livello emotivo e stilistico è diverso. I
casi di sinonimia perfetta sono eccezionali: un esempio sono le parole tra e fra, e le
congiunzioni o ed oppure. O però è più breve e in alcune locuzioni non può essere sostituito
“o la va o la spacca” soprattutto se posto all’inizio della frase. Altri due sinonimi pressoché
perfetti sono qui e qua (sono così intercambiabili che si possono usare entrambi in locuzioni
come qui/qua gatta ci cova). Anche lì e là sono quasi identici ma non intercambiabili in
espressioni come chi va là, alto là, al di là.
Quando invece due parole hanno senso opposto esse vengono definite “contrari” o
“antonimi” (antonimia, rapporto semantico). Spesso in italiano l’antonimo deriva dalla
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
parola stessa come nel caso di utile/inutile o logico/illogico o contento/scontento. Talvolta la
formazione dell’antonimo si è verificata già in latino (amico/nemico -> inimicum, facile/difficile
-> difficilem). Esistono anche coppie di contrari dotti come centripeto e centrifugo,
rispettivamente coniate da Newton. Molto spesso però l’antonimia non è grammaticalizzata
e si oppongono tra loro solo per il significato (buono/cattivo). Se una parola è polisemica
avrà per ciascun significato un proprio contrario. L’aggettivo dolce può avere vari contrari:
amaro, piccante, forte. La polisemia di un termine può portare al caso limite di significati tra
loro opposti (spolverare può significare togliere la polvere ma cospargere di polvere in una
ricetta culinaria) e prende il nome di enantiosemia. Si ha enantiosemia anche quando una
parola ha maturato un significato opposto rispetto a quello che aveva il suo etimo (feriale->
lavorativo, deriva da ferialem che significava festivo). Il caso di feriale si è avuto perché nel
linguaggio ecclesiastico dies ferialis significava giorno della festa di un santo, in
contrapposizione a dies domini (domenica); in francese il termine ha mantenuto il suo
significato etimologico. L’enantiosemia spiega perché partendo dalla stessa forma latina si
siano avuti due falsi amici. L’antifrasi permette di affermare un concetto utilizzando i termini
contrari (es. che genio! che in realtà significa sciocco). Un tipo particolare di contrari sono i
conversi o inversi, vocaboli i cui significati stanno tra loro in un rapporto ribaltato
(comprare/vendere, dare/ricevere, padre/figlio). Possiamo inserire tra i conversi parole che
indicano un rapporto di simmetria nello spazio (sopra/sotto). Molto rari sono i contrari
secchi, quelli che stanno in rapporti di combinazione binaria (vero/falso, pari/dispari).
Esistono anche termini contraddittori (la negazione) come veloce/non veloce. Gli antonimi
graduabili non si escludono a vicenda (caldo/freddo/tiepido ecc). Tra termini che hanno un
tratto semantico o una proprietà in comune ci sono rapporti di gradazione (felice, infelice,
normale, beato, raggiante, entusiasta, contento, lieto, mesto, afflitto). Esistono diversi
dizionari di sinonimi e contrari come Guida alla scelta dei sinonimi e contrari della lingua
italiana di Renato Rosselli del 1989, il Garzanti dei sinonimi e contrari diretto da Pasquale
Stoppelli del 1991, il nuovo dizionario dei sinonimi e contrari di Decio Cinti del 1999. Nel
nuovo millennio ricordiamo il Dizionario dei sinonimi e dei contrari dell’istituto
dell’enciclopedia italiana del 2003 di Raffaele Simone e il Dizionario dei sinonimi e dei
contrari della Utet di De Mauro. Anche nel portale Treccani è presente uno spazio dedicato a
sinonimi e contrari. Anche i dizionari generali propongono i sinonimi come è il caso del
Palazzi Folena. Talvolta i sinonimi sono parte integrante della spiegazione, altre volte sono
elencati come tali. Il GRADIT presenta sia i sinonimi che i contrari di ogni lemma.
7 La ricerca di un sinonimo sarà condizionata oltre che dalla polisemia, da gradazioni più o
meno sofisticate. Sinonimi di bello possono essere meraviglioso o incantevole, anche se di
gradazione più forte. Viceversa dire che qualcosa è abominevole e schifoso è peggiore di
brutto. Si crea quindi una scala, una gradazione possibile di significati. Visivamente
possiamo collocare i rapporti di sinonimia, gradazione e antonimia su un asse orizzontale. I
giudizi infatti, possono essere espressi spesso attraverso numeri, voti, stelle, ecc. oltre che
utilizzando parole come discreto, buono, ottimo ecc.
I rapporti di inclusione sono il tipo di relazione che interviene quando un termine di
significato generico include il significato di altri termini più specifici. Animale comprende
cane, gatto, cavallo, ecc. Il vocabolo sovraordinato o superordinato come animale è detto
iperonimo, il vocabolo sottordinato come cane è detto iponimo. La coppia di termini
iperonimo e iponimo è stata introdotta in italiano negli anni 70 attraverso la traduzione “La
linguistica teorica” di John Lions, che aveva coniato i termini corrispondenti inglesi a partire
dal greco. Gli iponimi di uno stesso iperonimo sono detti anche co-iponimi. Un termine può
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
essere iponimo di qualcosa ma iperonimo rispetto a qualcos’altro. Considerando il termine
cane, esso può essere iperonimo rispetto a bassotto, dalmata, volpino, ecc. Lo stesso vale
per gatto. Rapporti di iperonimia e iponimia sono alla base di tassonomie come quelle della
sistematica zoologica e botanica. Fiore è iperonimo di azalea, garofano ecc.
Un rapporto sempre di inclusione ma di altra natura è il rapporto di meronimia, il rapporto tra
i significati di termini che indicano una parte detti (meronimi) e termini che indicano il tutto
(olonimi). Radice, tronco, foglia sono meronimi di albero che è un olonimo.
Casa ha molti sinonimi come abitazione e dimora, ma talvolta il sinonimo è un iponimo come
appartamento o un meronimo come tetto. L’opposto quindi può diventare essere senza tetto
o stare all’aperto. La casa intesa come edificio rappresenta un iperonimo rispetto a tipi
particolari come baita, chalet, villa ecc. Se consideriamo la casa come un olonimo, avremo
meronimi come tetto, fondamenta, scale ecc.
Chiamiamo campi semantici gli insiemi di parole che coprono un’area di significati
omogenei, un’area concettuale riguardante un determinato campo o ambito. In genere, per
ogni campo semantico si individua una parola guida (es. casa). Nel campo semantico della
casa possiamo includere sinonimi di casa, iponimi e moltissimi meronimi. Possiamo
ritagliare campi semantici più o meno vasti; le parole dipendono dalla conoscenza che
abbiamo di un campo in una determinata lingua. Chi lavora nell’edilizia conosce termini
ignoti ad altre persone per il campo semantico casa.
Per conoscere i sinonimi o i vari campi semantici, non è necessario utilizzare grandi
dizionari, ma si può fare riferimento ai dizionari analogici (in passato tesoro, dal latino
thesaurus o vocabolario nomenclatore). In un dizionario di questo tipo ogni voce contiene un
campo semantico: al lemma corrisponde una voce guida e altre parole collegate allo stesso
lemma (sinonimi, meronimi, iponimi ecc.) Il lemma fiore in un vocabolario prevede la
spiegazione del lemma ma in un dizionario analogico troviamo tutt’altro. Il Dizionario
Analogico della Lingua Italiana, curato da Donata Feroldi e Elena dal Pra nel 2011 per i
tipi della Zanichelli, alla voce fiore illustra inizialmente sinonimi o alterati e poi molti altri
elenchi di parole. All’inizio ci sono caratteristiche e aggettivi che si riferiscono a parole, poi
analizza le parti del fiore passando per termini specifici.
Segue poi un paragrafo “relativo a” che elenca parole relative al fiore (es. impollinazione,
ticchiolatura). C’è poi una sezione chiamata Azioni (che si divide in 1 e 2) che comprende
parole come seccarsi. Un altro paragrafetto è per le persone che con i fiori hanno a che fare
(fioraio, vivaista) e un altro ancora per i luoghi (serra, giardino). Un accenno è fatto anche
alle discipline che si occupano dei fiori come la botanica.
Esiste poi un altro paragrafo intitolato “relativo a” con una serie di termini che comprendono
vaso, bouquet, interflora. C’è poi un elenco di modi di dire che comprendono la parola fiore
come “essere come un fiore di serra”, per una persona delicata. La voce fiore si conclude
con qualche curiosità come il fatto che Firenze è detta la città del fiore o la città del giglio.
Infine c’è un rinvio ad altre tre voci collegate a fiore: albero, pianta ed erba.
La voce fiori al plurale è presente in questo tipo di dizionario, diversamente dai dizionari
dell’uso. Questa scelta è stata fatta perché in questa voce vengono elencati tantissimi tipi di
fiori.
Un dizionario analogico come quello Zanichelli serve anche a trovare una parola di cui non
si ricorda il nome a partire da una categoria generale. Questo tipo di dizionario si chiama
analogico perché benché le parole siano disposte in ordine alfabetico, i termini ad esse
collegati sono disposti in maniera analogica. Questi dizionari vengono anche definiti
concettuali.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
Un altro dizionario analogico è il grande dizionario analogico della lingua italiana progettato
da raffaele simone per i tipi della Utet nel 2010 che si componeva di 2 volumi, e il dizionario
analogico della lingua italiana di Garzanti del 2002.
In passato questo tipo di dizionari oltre a tesori e nomenclatori venivano anche detti
sistematici o metodici. Il dizionario di Palmiro Premoli è intitolato il Tesoro della lingua
italiana, vocabolario nomenclatore illustrato. Tra parentesi c’è scritto anche che spiega e
suggerisce parole, sinonimi e frasi. Esso è definito il capolavoro del suo genere. Il tesoro
venne pubblicato per la prima volta a Milano dalla casa editrice Aldo Manuzio in due volumi
usciti rispettivamente nel 1909 e 1912. L’opera ha poi avuto riedizioni e ristampe che si
trovano anche in rete. Palmiro Premoli era lombardo, nato a Agnadello, in provincia di
Cremona nel 1856 ed è morto a Milano nel 1917. Era un giornalista, critico e soprattutto
divulgatore. Ha diretto l’enciclopedia popolare Sonzogno dalla fine dell’800 fino alla sua
morte. L’opera principale di Premoli però è proprio Il Tesoro. L’edizione del 1920 è stata
editata da Premes. Nel primo volume è presente una premessa intitolata “al cortese lettore”
ed è firmata dagli editori. In essa si spiega che il vocabolario nomenclatore dopo spiegata la
parola, mette intorno ad essa sinonimi, frasi, locuzioni, proverbi ma anche una pleiade di
altre parole che hanno relazione con essa.
La parola casa comprende ad esempio anche molte illustrazioni in bianco e nero. Nel
secondo volume alla voce fiore è affiancata anche la voce fiori ed una tavola a colori. Sono
elencati nomi di fiori e distinti in fiori di montagna, bosco, da giardino, carnivori, eduli,
medicinale ecc. Viene anche indicata la simbologia dei fiori come ad esempio la speranza
per il biancospino.
Si parla anche di fiori finti e sono elencati anche arnesi relativi ai fiori.
Alla fine del vocabolario è presente una postfazione intitolata “il perché e il percome di
questo vocabolario” in cui spiega che questo dizionario può essere utile quando abbiamo
una parola “sulla punta della lingua” ma non la ricordiamo ed esso ci aiuta a ricordare le
parole perdute.
8 Nei vocabolari nomenclatori i lemmi sono come dei titoli di un capitolo contenente parole
che sono correlate al lemma. Gli elenchi sono di solito divisi in paragrafi e sottoparagrafi. Se
il lemma è il nome di qualcosa, possiamo trovare nella voce una sezione dedicata agli
aggettivi che si prestano a descrivere la cosa in questione, un’altra con i verbi e così via.
Anche se i lemmi si susseguono in ordine alfabetico, all’interno delle sezioni di ogni voce si
segue un ordine concettuale (vengono definiti anche così).
Il vocabolario di Premoli nella postfazione evidenzia il fatto che molti italiani sapessero
parlare principalmente in dialetto anche dopo l’unificazione. Nella prefazione gli editori
menzionano il vocabolario metodico di Carena anche se per dire che quello di Premoli è
diverso e migliore. Giacinto Carena era un erudito piemontese nato a Carmagnola nel 1778
e morto a Torino nel 1859. Era studioso e professore di fisica e scienze naturali. Come
lessicografo si è occupato in primo luogo della nomenclatura scientifica, pubblicando già nel
1831 un lavoro intitolato “Osservazioni intorno ai vocabolari della lingua italiana
specialmente per quella parte che ragguarda alle definizioni delle cose concernenti alle
scienze naturali”. Nel 1840 Carena pubblicò un volumetto di una ventina di pagine in cui
evidenziava l’importanza dei vocabolari di tipo metodico e offre un prospetto di ciò che essi
avrebbero dovuto contenere. Dopo di che realizzò un proprio vocabolario metodico in più
volumi intitolato Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a
cose domestiche e altre di uso comune. La parte prima contenente il vocabolario
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
domestico esce nel 1846 (casa editrice Fontana), la seconda parte con il vocabolario
metodico di arte e mestieri nel 1853, mentre solo nel 1860 la terza parte con il vocabolario
dei veicoli su terra e dei veicoli su acqua e dei frammenti relativi ai vocaboli mercantili, alla
zecca ed al cavalcare.
La prima parte è introdotta da una prefazione i cui Carena ribadisce l’importanza di un
vocabolario in cui le parole tutte fossero in ordine logico collocate cioè le uno alle altre si
succedessero secondo la naturale relazione e dipendenza delle idee da esse rappresentate
Carena sottolinea infatti che un vocabolario comune alfabetico serve quando si vuole
conoscere il significato di una data parola (letta o sentita da qualche parte), viceversa ci
vuole un vocabolario metodico quando si sa quale significato esprimere ma non il
significante. Carena ammette che realizzare un vocabolario completo sarebbe stato
impossibile, quindi si è limitato a realizzarne alcune parti. Ha tenuto conto di altri repertori
metodici già esistenti oltre che a vocabolari. I repertori metodici però erano tradotti dal
francese e quindi erano pieni di francesismi. Carena decise di rifarsi alla fine al toscano
benché fosse piemontese perché considerata la lingua più corretta. In toscana e a firenze
fece grandi soggiorni. Si vede costretto a “accattare” (elemosinare) parole dal
toscano/fiorentino. Le parole sono registrate nell’ordine che gli sembra più naturale e non
alfabeticamente. Il volume ha 499 pagine oltre al paratesto. Il vocabolario domestico è diviso
in 4 capi (capitoli). Il primo tratta del vestire e delle sue accompagnature ed è ulteriormente
diviso in 4 paragrafi, uno sull’abbigliamento a uso personale e di ambi i sessi, uno
sull’abbigliamento maschile, uno femminile e uno da bambini con vocaboli “bambineschi”. I
termini sono diversi da quelli che usiamo oggi e troviamo parole come vestimenti,
calzamenta, arredi (ornamenti della persona). Di arredi nel senso moderno si parla nel
secondo capo o capitolo intitolato “dell’abitare” e contenente 10 paragrafi che vanno dal
tema dell’abitazione in generale ad un paragrafo che tratta degli strumenti della mensa e
credenza, poi si parla del mangiare e del bere in 4 paragrafi (in generale, alimenti e
condimenti di origine animale, vegetale e bevande). Il quarto capitolo parla dell’illuminazione
(luci, fanali ecc.). I capitoli sono preceduti da indici metodici in qui sotto le parole principali
Carena elenca in qualche modo i vocaboli dipendenti cioè iponimi o meronimi. Secondo
Manzoni però Carena non è stato abbastanza fiorentinista. Carena aveva inviato una copia
a Manzoni e lui aveva risposto con una lettera datata 26 febbraio 1847 in cui spiegava che
apprezzava l’opera ma faceva anche qualche critica come per esempio il fatto di aver
inserito termini anche non fiorentini. Carena aveva incoraggiato a pubblicare la lettera stessa
esaltato dalle lodi nella prima parte. Manzoni ha sostenuto la necessità di seguire il modello
del fiorentino in tutta l’Italia, perciò per lui Carena avrebbe dovuto utilizzare soltanto il
fiorentino. L’opera di Carena comunque è stata molto importante e ha ispirato vari altri
repertori.
La storia dei dizionari organizzati per campi semantici inizia ben prima del diciannovesimo
secolo. Un antecedente è rappresentato da La Fabrica del Mondo. Risale al sedicesimo
secolo, opera di Francesco del Bailo detto l’alunno. Anche Giacinto Carena nel suo opuscolo
del 1840 nomina La Fabrica del Mondo. Del Bailo era nato a Ferrara intorno al 1484 ed ha
poi vissuto soprattutto a Udine e Venezia. A lui si devono anche altri due repertori di parole,
alfabetici però, basati rispettivamente uno sul lessico di Petrarca e l’altro sul lessico di
Boccaccio. L’opera principale però è proprio La fabrica del mondo pubblicata a Venezia nel
1546-1548 dallo stampatore Nicolo de Bascarini bresciano. Nell’indicazione in fondo al
volume come data che corrisponde al “finito di stampare” è indicato 1546 (nella prima pagina
c’è scritto 1548). Forse il volume è stato finito di stampare nel 46 ma non è stato diffuso
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
subito. Lo stampatore ha poi ripreso in mano il volume, modificato qualcosa e inserito il
frontespizio con scritto 1548. Questa è l’ipotesi di Claudio Marazzini nel saggio “L’ordine
delle parole - storia di vocabolari italiani” del 2009 per i tipi del Mulino. La fabrica del mondo
è un dizionario nomenclatore rinascimentale ma l’impostazione è diversa rispetto a quella
dei moderni. Francesco Alunno divide il suo repertorio in 10 libri, cioè 10 parti (capitoli).
Ciascun libro è ulteriormente diviso in varie sezioni. L’ordine seguito corrisponde ad una
gerarchia basata sulla concezione filosofica e religiosa che Alunno ha del mondo. Il primo
libro è dedicato a Dio e ciò che riguarda Dio, analizzando le altre nominazioni e le
manifestazioni. La seconda sezione del primo libro è dedicata a Maria, la terza agli angeli
ecc.
Il secondo libro riguarda il cielo, in primis inteso come paradiso, poi il firmamento, l’olimpo, i
pianeti, i segni celesti, lo zodiaco ecc.
Il terzo libro riguarda il mondo inteso come nostro pianeta, il quarto riguarda gli elementi del
mondo (fuoco, aere, acqua e terra). Il quinto libro è dedicato all’anima, il sesto al corpo e il
settimo all’ “huomo” e comprende sottosezioni dedicate all’uomo e poi alla donna. L’ottavo
libro è dedicato a qualità e il nono a quantità. Il decimo riguarda l’inferno.
Questo numero totale dei libri (10) corrisponde alle categorie aristoteliche ma come abbiamo
visto adesso, gli argomenti sono diversi da esse salvo in due casi: i libri ottavo e nono.
Francesco Alunno si è ispirato anche ad altre opere filosofiche, teologiche ed
enciclopediche, opere del medioevo e del rinascimento. Le parole inserite dall’alunno nei
campi semantici dell’opera sono però tutte parole della tradizione letteraria, egli si vantava di
aver messo tutte le voci di Dante, Petrarca, Boccaccio ed altri autori. Tra questi autori figura
l’Ariosto, ferrarese come l’Alunno. L’ariosto linguisticamente aveva corretto il proprio Orlando
Furioso seguendo i modelli dei grandi scrittori fiorentini del trecento, quindi anche la Fabrica
del Mondo rispondeva al modello linguistico vincente nel 500. Si discosta quindi
doppiamente dai vocabolari nomenclatori, concettuali ecc, non solo perché ha un impianto
gerarchico diverso basato su determinate convinzioni religiose, ma anche perché si basa su
un modello linguistico letterario/arcaizzante riportando esempi e citazioni da un canone ben
preciso di autori. L’opera è rivolta ai letterati del 500, non solo italiani.
Luigi Romani menziona repertori del passato come quelli di Comenio, che hanno avuto
edizioni bilingui o plurilingui. Ma anche tra i dizionari monolingui esistono dizionari illustrati.
Ne è un esempio Il tesoro della lingua italiana, vocabolario nomenclatore illustrato con tavole
in bianco e nero e a colori di Premoli. Anche oggi si usano dizionari illustrati, come quelli per
bambini detti anche “di ingresso”. Tullio de Mauro ha curato una serie di dizionari per
bambini e ragazzini differenziati per fasce d’età. Il primo della serie è un dizionario illustrato
per i bambini dei primi anni delle scuole elementari; Tullio de Mauro ne è co-autore insieme
a Elio D’Agnello e Gisella Moroni. Questo dizionario si intitola Prime parole - dizionario
illustrato di base della lingua italiana, pubblicato dall’editore Paravia di Torino nel 1997. C’è
anche un dizionario destinato ai ragazzini più grandi delle elementari (8-11 anni), curata da
Tullio de Mauro e Gian Giuseppe Moroni e si intitola Dizionario di base della lingua
italiana e di solito viene indicato con la sigla DIB, è uscito nel 96 per i tipi di Paravia. Anche
il DIB comprende delle illustrazioni in un volumetto a sé chiamato dizionario visuale in
collaborazione con Angela Cattaneo. È stato riedito nel 2000. Il terzo dizionario della serie
è il Dizionario Avanzato dell’italiano corrente (DAIC) uscito nel 1997 per Paravia e
pensato per i ragazzi tra 11-15 anni. Anche il DAIC è opera di De Mauro e Angela Cattaneo
ed è abbinato ad un dizionario visuale. Nel dizionario visuale si segue un ordine concettuale,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
logico, per campi semantici. Ci sono disegni di strutture e ambienti con relativi meronimi ad
esempio. Nella parte del dizionario di parole si segue l’ordine alfabetico. Tutti e tre i dizionari
per bambini e ragazzini riflettono gli studi e le ricerche sul vocabolario di base. In questi
dizionari però invece che abbreviazioni come quelle che abbiamo visto per il GRADIT c’è
una simbologia più adatta, come ad esempio la luna piena per le parole fondamentali nel
DIB, una mezza luna contrassegna le parole di alta frequenza, un quarto di luna corrisponde
alle parole strategiche, e una chiave a fianco delle parole chiave come per esempio biologia
che rappresentano chiavi d’accesso a particolari settori. Per bambini esistono molti altri
dizionari come Italiano Junior - dizionario della lingua italiana a cura di Anna Cattaneo e
Maria Teresa Nesci pubblicato dalla Loescher dal 1995 in avanti, il Primo Zanichelli -
vocabolario di italiano a cura di Mario Cannella, rivolto a bambini delle scuole elementari.
Tutti questi dizionari sono meno estesi di quelli degli adulti, perciò sono detti anche minori e
compatti (come nelle edizioni del Devoto -Oli e Sabatini Coletti). Essi oltre ad avere meno
lemmi, hanno spiegazioni più semplici. Per i dizionari per i più piccoli le illustrazioni sono
fondamentali, ma dizionari minori e illustrati possono essere utili anche agli stranieri. Anche
nei normali dizionari dell’uso troviamo spesso alcune tavole con illustrazioni, che seguono
un ordine metodico, concettuale.
9 L’italiano è una lingua romanza, cioè una delle lingue nate dall’evoluzione del latino. Per
essere più decisi potremmo dire che il latino volgare parlato ha dato vita a molti dialetti
raggruppabili a seconda delle loro caratteristiche. Si sono così sviluppati dialetti spagnoli,
portoghesi, italiani eccetera. Tra i vari dialetti alcuni hanno avuto maggiore importanza e ciò
è avvenuto in modi diversi a seconda dei luoghi e dei Paesi. In Francia ad esempio il dialetto
dell’Ile de France comincia ad imporsi dall’undicesimo secolo. In spagna il castigliano dal
tredicesimo secolo. In Italia il dialetto fiorentino si afferma sugli altri dialetti dal trecento con i
capolavori di Dante, Petrarca e Boccaccio. Molte parole essenziali del vocabolario di base
derivano direttamente dal latino (madre, padre, fiore, pianta, tavola, buono...). Alcune parole
latine sono a loro volta derivate dal greco (melo, ciliegia, piazza, astro, delfino, tigre...). Tra
le voci di etimo latino si possono distinguere le voci di tradizione popolare e quelle di
tradizione dotta. Le forme di tradizione popolare (o ininterrotta) sono arrivate dal latino
all’italiano senza mai uscire dall’uso, attraverso il parlato e perciò hanno subito variazioni
fonetiche più o meno importanti. I latinismi di tradizione dotta invece potrebbero essere
stati presi dopo secoli di disuso e quindi sono rimasti perlopiù invariati. È capitato che dalla
stessa parola siano derivate due tradizioni: una dotta (es. angustia) ed una popolare
(es.angoscia) dal latino “angustia(m)” (allotropi). Un altro esempio è da “causa(m)” in cui si
è ereditato nella voce dotta “causa” e in quella popolare “cosa” (in latino originariamente res)
cambiando sia foneticamente che semanticamente. Un altro esempio è dal latino
clausura(m) che è diventato nella forma colta clausura e nella forma popolare chiusura. Un
ulteriore esempio è epiphania(m) a sua volta derivato dal greco, in cui abbiamo ereditato
nella forma dotta epifania e nella forma popolare befana. I doppioni di questo tipo sono molti:
circolo e cerchio, nitido e netto, plebe e pieve, razione e ragione, verecondia e vergogna,
vizio e vezzo (che è diventato per lo più positivo rispetto alla forma dotta).
Parola è un allotropo e trae origine dal latino tardo “parabola(m)”. Il latino parabola deriva dal
greco in cui significava similitudine o paragone. Di mezzo c’è la cultura religiosa del
cristianesimo con cui si indicava un esempio narrato da gesù per trasmettere un
insegnamento a chi lo ascoltava. Parabola poi ha significato anche la parola di gesù e
successivamente più in generale la parola di una persona qualsiasi. Il termine italiano parola
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
è quindi nato per tradizione popolare attraverso la tradizione cristiana. Dal latino parabola è
giunta fino a noi anche un allotropo colto indicando un racconto morale narrato da Gesù. La
forma parabola ha condotto anche allo spagnolo “palabra” e al francese “parole”.
Quest’ultimo termine però ha un uso specialistico nella terminologia introdotta da Ferdinand
de Saussure in cui il termine si oppone a la langue. La langue indica la lingua della società
mentre parole indica la realizzazione, l’atto. L’equivalente di parola in francese sarebbe
“mot” che discende da una voce del latino tardo “mottum” che indica una voce, un
borbottamento. Dalla stessa voce è derivato l’italiano “motto”. Possiamo aggiungere che dal
latino parabola deriva anche il verbo parlare. Nel latino classico per esprimere i medesimi
significati si usavano altre parole differenti come il verbo loqui che è stato poi soppiantato da
parabolare. Il verbo loqui ha comunque lasciato delle tracce nell’italiano come uterloquire,
loquace, eloquente, colloquio e loquela. Il vocabolo parola in latino classico era espresso dal
sostantivo “verbum” che ha lasciato altre tracce in italiano come verbo (che però è
polisemico e in alcune locuzioni ha ancora il senso originario del latino: non proferire verbo).
Dal latino verbum sono derivati anche verboso, verbale, verbalizzare, verbalizzazione.
Inoltre dal latino verbum sono discesi anche l’inglese word e altre voci delle lingue
germaniche. In latino esisteva anche un’altra voce nello stesso campo semantico “fabellam”
e da lì sono discesi i termini italiani favella e favellare che ritroviamo nella tradizione
letteraria. Da favella sono derivati anche lo spagnolo hablar e il portoghese falar.
In italiano abbiamo spesso sostantivi di tradizione popolare a cui corrispondono aggettivi che
sono latinismi di tradizione dotta. Spesso i nomi sono più usati degli aggettivi corrispondenti.
Oro (parola FO) è un nome di tradizione popolare che si affianca a aureo che è di tradizione
dotta. Lo stesso vale per pioggia/pluviale e mese/mensile. In questi casi la forma colta risulta
riconoscibile anche a colpo d’occhio ma in altri esempi la differenza è ancora meno evidente
poiché l’italiano si è allontanato dal latino meno rispetto alle altre lingue romanze e la forma
popolare è rimasta molto vicina a quella dotta. In latino al nome aqua corrispondeva
l’aggettivo aquosus, da queste parole in italiano sono discese acqua e acquoso (acqua->
parola di tradizione popolare ininterrotta, acquoso-> colta). Il francese eau è molto lontano
dal latino ma l’aggettivo aqueix è rimasto invece più fedele. In spagnolo c’è agua e aguoso,
in portoghese agua e aquoso. Per esprimere alcuni significati, il latino classico disponeva di
due sinonimi. Solo una di queste due parole però è sopravvissuta al latino volgare ed è stata
trasmessa all’italiano. Un esempio è stella/sidus di cui solo la prima è sopravvissuta, oppure
Terra/tellus. Però anche il nome caduto in disuso ha lasciato una traccia di sé in aggettivi di
tradizione dotta come sidereo e tellurico. In altri casi invece il vocabolo usato normalmente
in latino classico per dire una cosa è stato soppiantato da un iponimo che però ha assunto
un significato più generico. In latino classico si diceva ecus, mentre il cavallus era uno
specifico cavallo da lavoro ma poi il secondo ha soppiantato il primo seppur ecus abbia dato
origine a parole come equestre. Lo stesso vale per domus e casa (rustica, capanna) in cui la
seconda ha assunto il significato della prima ed è stata trasmessa fino ai giorni nostri
(domus ha dato origine a domestico). Talvolta la parola del latino classico è stata
soppiantata da una forma alterata come fratello che è un diminutivo di frater, ma restano
parole come fraterno oppure orecchia che deriva da oricula, diminutivo di auris. Anche il
ginocchio ha una storia simile, proviene infatti da genuculus e non genus. Inoltre nel
passaggio dal latino all’italiano si sono creati mutamenti semantici considerevoli come il
caso di feriale (enantiosemia) e cattivo.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
10 Dal latino volgare sono discesi i vari dialetti, non solo italiani ma anche spagnoli,
portoghesi ecc. Tra i vari dialetti ha prevalso il toscano fiorentino grazie anche a numerosi
letterati. Le forme del fiorentino si sono poi diffuse in tutta Italia. Manzoni indicò come
modello il fiorentino vivo, parlato dalle persone colte, lingua che lui stesso aveva adottato
per i Promessi Sposi. Spesso nei vari dialetti ci sono sinonimi (geosinonimi) quindi
significanti diversi per esprimere lo stesso significato e questo vale anche per le parole
fondamentali. Un esempio è papà e babbo (forma toscana, presente nella tradizione
letteraria come in Dante ma anche in altri scrittori come Verga, De Amicis o Svevo) ma in
alcuni casi come “babbo natale” “pagare a babbo morto” “figlio di papà” non si può cambiare
babbo con papà. Anche mamma è diverso da madre e in Campania si usa anche mammà.
La matita è chiamata in Toscano lapis e di conseguenza il temperamatite diventa
appuntalapis (di basso uso). La spillatrice può essere chiamata anche pinzatrice, cucitrice o
bucatrice e anche il verbo che ne consegue può essere spillare o pinzare. La gruccia è
chiamata anche stampella, appendino, attaccapanni o crocetta. Nel sito della Treccani è
presente una sezione chiamata sinonimi regionali dedicata appunto ai geosinonimi. Il calzino
viene definito anche pedalino o calzetta. I lacci possono essere chiamati anche stringhe o
aghetti. La sedia si chiama anche cadrega o seggiola. Shibboleth è un fenomeno che deriva
dalla Bibbia e serve proprio a capire la provenienza attraverso la pronuncia di una parola. Il
boccaccio è denominato anche arbanella, barattolo, alberetto o vasetto. La spazzatura è
chiamata anche sudicio, immondizia, monnezza, mondezza, rusco, rumenta. Il formaggio è
anche chiamato cacio (essere come il cacio sui maccheroni, essere alto come un soldo di
cacio, pizza ai 4 formaggi, pasta cacio e pepe). Il cocomero è chiamato anche anguria o
melone/mellone. Il melone è chiamato anche popone. I cenci sono chiamati anche
chiacchiere, frappe, galani o bugie. La spigola e il branzino sono la stessa cosa. L’acciuga è
chiamata anche alici. L’asino o somaro è chiamato ciuco in Toscana e ciuccio in Campania.
Un topo di fogna è chiamato anche zoccola o pantegana. Fidanzato è chiamato anche citto,
zito, moroso, ragazzo. Ci sono poi dei termini che dai dialetti sono giunti a tutta l’Italia
(prestiti dall’interno). Ciao viene dal veneziano ciavo, e cioè schiavo, che a sua volta viene
da slavo. Da Venezia si è diffuso anche grazie (che deriva a sua volta dal latino) e giocattolo
(che in toscano sono chiamati balocchi). La parola sommozzatore etimologicamente viene
dal verbo sommozzare, napoletano (a sua volta derivato dal latino). La parola scoglio è
ligure ma si trova già in Dante quindi vengono adottate dalla lingua italiana molto presto. I
dialettalismi sono chiamati anche dialettismi o localismi. I campi in cui queste cose si vedono
di più sono quelli della gastronomia. Ci sono anche le parole colorite e le parole della
malavita.
11 I geosinonimi sono forme concorrenti: a seconda della zona d’Italia spesso si usano
forme diverse. Marinare la scuola in Lombardia si dice bigiare, in Campania fare filone, in
Sardegna fare vela (?) e in Toscana fare forca. Per comprare una focaccia a Siena devo
chiedere un ciaccino, in altri posti schiaccia e pizza bianca. Chi dà dello stupido a qualcuno
in Veneto dirà mona, in Lombardia pirla, in Toscana grullo/strullo/bischero. I campi degli
insulti e della gastronomia sono particolarmente vari. A volte poi una forma dialettale ha
successo e si impone sulle altre in tutta italia, come “ciao” “giocattolo” o “scontrino” che sono
tutte parole di origine veneziana. Le voci che dai vari dialetti sono entrate nella lingua
italiana sono definite prestiti dall’interno. I prestiti esterni giungono invece da altre lingue e
sono definiti anche tout coeur. In molti casi non ci accorgiamo neppure di questi prestiti se
non conosciamo la storia. Molti prestiti sono adattati, cioè modificati morfologicamente e
foneticamente in modo da adattarle al sistema italiano, come la parola biglietto che deriva
dal francese billet. Un altro esempio è bistecca dall’inglese beef steak. Limone viene
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
dall’arabo. Appartamento dallo spagnolo apartamiento. Per riconoscere questi prestiti
dovremmo riconoscere l’etimologia. Restano riconoscibili però i prestiti non adattati, come il
francese pois o chic, lo spagnolo paella o l’inglese lockdown. In generale in italiano i prestiti
più antichi sono stati adattati mentre quelli più recenti sono rimasti invariati o quasi. Esistono
infatti passaggi o gradi intermedi: ci sono prestiti che con il passare del tempo hanno subito
progressive modifiche. Un esempio è “blu” dal francese bleu; nell’ottocento si usava la forma
blò e solo in seguito si è iniziato a dire blu. Le cose cambiano anche a seconda del canale
attraverso il quale il prestito si diffonde (scritto o orale): tunnel si pronuncia all’italiana perché
è stato trasmesso scritto, mentre budget in maniera orale per cui si pronuncia più o meno
all’inglese. Anche per prestiti ripresi nella forma dalla lingua cui provengono, interviene
comunque un qualche adattamento almeno a livello di pronuncia come ad esempio
computer in cui non usiamo la pronuncia perfetta inglese o biberon per il francese.
I prestiti si distinguono anche in prestiti di necessità e di lusso. I prestiti di necessità sono
quelli che entrano in una lingua per designare nuovi concetti o oggetti concreti. I prestiti di
lusso sono le parole di altre lingue (o locuzioni) che rimpiazzano espressioni già esistenti, il
prestito viene quindi preferito all’espressione preesistente perché suona più prestigioso
(prestiti di moda). Cacao e cioccolato sono considerati prestiti di necessità perché si tratta di
cose che in Italia prima non c’erano. Il cacao era infatti originario dell’america e veniva
coltivato dai Maya e con la scoperta dell’America i semi di cacao sono stati importati in
Europa e la bevanda che se ne ricava. La parola cacao deriva da una lingua azteca
precolombiana. Quanto al cioccolato/cioccolata il termine viene sempre da una voce nahuatl
(azteca) il cui senso era bevanda al cacao. A fare da tramite anche in questo caso è stato lo
spagnolo chocolate. Anche il francese e l’inglese hanno preso in prestito questi due termini
dallo spagnolo. Le parole importate non provengono necessariamente dalla lingua del paese
da cui viene il prodotto/concetto. Il vocabolo patata viene dallo spagnolo che ha ereditato la
parola batata dall'ara waka. Quando si scoprono e si innovano novità anziché ricorrere ad
un prestito da un’altra lingua, è sempre possibile inventare nuove parole. I francesi ad
esempio non hanno ereditato la parola patata ma l’hanno ribattezzata a modo loro (pomo di
terra). Il pomodoro nel sedicesimo secolo si è coniata questa parola, prima era pomo d’oro,
senza ricorrere all’azteco. In alcuni dialetti settentrionali però si hanno forme simili al
francese. Il termine computer deriva per noi italiani dall’inglese ma i francesi hanno coniato
ordinateur e gli spagnoli ordenador (in america latina computadora). Anche per altri termini
relativi alla tecnologia in Italia sono state adattate parole inglesi come mouse, ma in altre
lingue come lo spagnolo ratòn e in francese suri(?).
I prestiti di lusso sono definiti anche superflui.
Talvolta tra il nuovo termine e il vecchio c’è una minima differenza e quindi non può essere
definito superfluo. Il termine baby-sitter è entrato nell’italiano nel 900 e non è il sinonimo
perfetto di nessuna parola preesistente. Esso si contrappone a bambinaia poiché essa era
necessariamente di sesso femminile e si occupava dei bambini come professione. Baby
sitter è chiunque tenga bambini a pagamento, anche occasionalmente e può essere sia
maschile che femminile. La tata (risalente al diciassettesimo secolo) vale anch’essa solo per
una donna e indica una certa continuità nel mestiere e un rapporto più stretto e duraturo (è
una parola affettuosa). Con il termine nel primo novecento nurse ci allontaniamo ancora di
più: prima si indicava una istitutrice di madrelingua inglese o infermiera. Il termine
governante è una parola antica che nell’ottocento ha acquisito il senso di persona che lavora
a tempo pieno per una famiglia (modello del francese) ed essa non si occupa solo dei
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
bambini ma anche della casa. Baby sitter quindi ha avuto successo e ha coperto un vuoto
tanto che esistono anche altre forme come dog-sitter. Il termine pet non è un lusso in quanto
in italiano la traduzione è data da una locuzione. Food invece è un prestito superfluo (cibo)
come shop (negozio). Molti prestiti di lusso si hanno nell’ambito dell’abbigliamento o della
cosmesi. La pochette proviene dal francese (anni 70) ed è diventata clutch bag con un
prestito dall’inglese che si configura quindi come di lusso. Analogo il caso di make-up che ha
lo stesso significato di maquillage preceduto a sua volta da trucco.
A volte le parole e le locuzioni straniere vengono tradotte usando parole già esistenti nella
lingua ricevente e in questi casi si parla di calchi. I calchi sono semantici quando una parola
che già esiste nella lingua ricevente (italiano) assume un nuovo significato sul modello della
lingua straniera. Un esempio è farmacia, che ha un etimo greco ed esiste in italiano dal ‘500
nel senso di scienza che si occupa dei farmaci ed è andata poi ad indicare il negozio (che
prima si chiamava spezieria) usando il calco dal francese. Un altro esempio è il verbo
agitare (deriva dal latino) attestato sin dal 300 nel senso tutt’ora valido di muovere, scuotere;
da questo primo significato esiste anche il senso figurato di non essere calmi. Solo nel
diciannovesimo secolo questo verbo ha assunto anche il significato politico di incitare alla
lotta in espressioni come agitare le masse. Quest’ultimo significato è un calco dall’inglese.
Un altro esempio ancora è realizzare che proviene dal francese a sua volta derivato dal
latino e significa rendere reale (dal 700). Solo nel 900 realizzare ha anche assunto il
significato di rendersi conto e questo è un calco dall’inglese. Rientrano tra i calchi anche
quei casi in cui sul modello di un’espressione straniera vengono create nuove locuzioni o
parole derivate o composte utilizzando pezzi che l’italiano già possiede (calchi formali o
traduzione o strutturali). I calchi strutturali sono quindi neoformazioni italiane costituite da
basi con altri elementi (affissi, suffissi ecc). Un esempio è autogoverno, calco dell’inglese
self-government. Sono calchi imperfetti quelli in cui la traduzione non è proprio letterale (es.
Klassenkampf -> lotta di classe, singolare). Un esempio è grattacielo (in inglese skyscraper).
Questo tipo di calco è detto anche di composizione. L’ordine degli elementi in italiano però è
invertito rispetto all’inglese. Anche pallacanestro è invertito rispetto a basketball. Un altro
esempio è fine settimana (calco di weekend, al maschile). Un semicalco è quello fatto con
una certa libertà come campanilismo (da esprit de clocher). Esiste anche il calco sintattico
quando si ricalca una parte di un'espressione straniera (franco tiratore dal francese) come
colpo di fulmine. Talvolta si parla anche di calco sinonimico, quando si utilizza una forma
equivalente di ciò che si aveva nella lingua modello. Esiste anche calco omonimico quando
le due forme suonano molto simili.
12 I prestiti sono parole ereditate da altre lingue. Il termine però nell’uso comune ha un
senso molto diverso, infatti si intende una concessione temporanea di qualcosa. Per questo
il termine prestito linguistico spesso non sembra molto accurato poiché esso non viene mai
“restituito” e l’altra lingua non rimane priva di tali parole. Esistono però anche prestiti effimeri;
nel 2006 si è parlato anche in Italia di contraire premiere emboj (cpe) cioè un contratto primo
impiego (un contratto politico previsto in Francia che però poi non ha avuto successo).
Questo tipo di contratto avrebbe prolungato i periodi di prova di lavoro a due anni e
permesso i giovani in prova in qualsiasi momento senza nessun motivo. Anche in Italia si è
parlato di questo contratto e di queste proteste ma poi questo termine è sparito dalla
circolazione. Un espressione straniera di questo tipo può essere definita xenismo,
occasionalismo o peregrinismo (circola solo per un periodo breve). Ghali e Liberato,
mescolando lingue e dialetti propongono esempi di occasionalismi. Se alcuni forestierismi
sono occasionali e rari, altri esempi come chic e budget vengono utilizzati regolarmente
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
nella lingua italiana. In italiano chiamiamo prestito sia la parola straniera che fa da modello,
sia la parola in italiano (sia il fenomeno che il termine preso). Molto meno usato è il sinonimo
di prestito “imprestito”. Le voci prese da altre lingue si possono definire anche forestierismi
(prestiti adattati o non adattati e calchi). Raro è il sinonimo stranierismo (utilizzato da
Leopardi nello Zibaldone). Esiste anche il termine esotismo (calco dal francese) che è
generalmente sinonimo di forestierismo ma nel GRADIT e nel Nuovo de Mauro la marca
d’uso esotismo è applicata solo ai termini non adattati provenienti dalle altre lingue. Spesso
però esotismo è utilizzato soltanto per indicare le voci provenienti da Paesi lontani o
percepiti come tali (lontani geograficamente o culturalmente). Nella serie curata da
Giuseppe Antonelli per il corriere della sera c’è su questo argomento un volume a sé “Parole
esotiche” di Marco Mancini. Egli intende come esotismi i prestiti proveniente da lingue con le
quali il contatto italiano è stato o è pressoché inesistente”. Degli esempi sono pompelmo,
arem, mocha. La moka intesa come caffettiera è stata brevettata negli anni trenta da alfonso
bialetti con il marchionimo moka. La macchinetta in generale però si può scrivere anche con
ch. Il nome deriva da una città dello Yemen che era un porto molto rinomato per il
commercio del caffè. Tra le altre parole c’è anche ciripà, il nome delle pezze triangolari che
si usavano per fasciare i neonati prima che esistessero i pannolini usa e getta. Il sostantivo è
stato preso in prestito da una voce amerindiana riferita a una tribù che utilizzava il perizoma.
In passato il termine esotismo era utilizzato in modo dispregiativo, soprattutto sotto il
fascismo quando ha avuto luogo una vera e propria guerra contro le parole straniere. Il
fascismo infatti mirava all’autarchia anche da punto di vista linguistico. Un altro termine
molto usato sotto il fascismo usato per definire le parole straniere era “barbarismo”
fortemente dispregiativo.
In “le parole straniere” di Paolo Zolli è presente una panoramica dei vari prestiti della lingua
italiana. La lingua che più ha contribuito al lessico italiano è il francese. Nel territorio
francese il primo dialetto a prevalere è stato quello del sud, il provenzale antico, la lingua
d’oc o occitanica. Nel nord della francia si è sviluppata la lingua d’oil ovvero il francese
antico. I prestiti da queste due lingue sono dette gallicismi. Sono molti i gallicismi penetrati
nel volgare italiano delle origini come coraggio, viaggio (dal provenzale), omaggio, ostaggio
(dal francese antico), oltraggio (in entrambe le lingue). Questi sostantivi sono accomunati
dal suffisso “aggio” che in francese è age in francese e atge in provenzale. In italiano quindi
abbiamo importato anche il suffisso e utilizzato poi per altri vocaboli più moderni come
lavaggio e atterraggio (prima inteso per la marina). Lo stesso discorso vale per i gallicismi in
ie che hanno dato vita a cameriere, cavaliere, scudiere (dal provenzale) e cancelliere,
mestiere, giardiniere (d’oil). Anche qui è stato preso anche il suffisso ed è stato poi usato in
italiano per dare vita ai mestieri. Il francese antico si è imposto diventando lingua nazionale:
per tutti i prestiti dal francese antico al moderno si usa il termine francesismo (riferimenti:
L’influsso francese in Storia della lingua italiana, I gallicismi nei testi dell’italiano antico,
Francesismi in Enciclopedia dell’italiano e Francesismi in Le parole dell’italiano di Roberta
Cella). Tra i francesismi ci sono varie parole dell’ambito militare (maresciallo artiglieria) ma
anche nomi legati a scambi commerciali (quietanza e profitto). Altri francesismi riguardano la
gastronomia (burro, mostarda, ragù, purée, beignet, frappé, crêpe, flambé). Anche nella
moda c’è un grande repertorio di francesismi (abbigliamento, moda, felpa, scialle, stoffa,
foulard, chignon, flanella, pon pon) e colori (blu, bordeaux, lilla, beige, noisette). La francia è
stata al centro della cultura europea per secoli da vari punti di vista rappresentando spesso
un modello per altri paesi; nel 700 c’è stato un picco dei francesismi (responsabile,
rivoluzionario, federalista, burocrazia, franco tiratore, parola d’ordine, corte d’appello...). Dal
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
francese provengono anche molti nomi di mobili e arredi come secrétaire, étagère, chaise
longue, parquet, abat-jour e anche diverse parole dell’ambito dello spettacolo come cabaret
e tournée. Il francese rimane la lingua dominante fino alla prima metà del 20esimo secolo
(taxi, garage, limousine, pois, paillettes, salopette). Le battaglie fasciste infatti erano rivolte
soprattutto contro i francesismi e in particolare i prestiti non adattati (rif. la politica linguistica
del fascismo di Gabriella Klein). Alcune sostituzioni sono rimaste in uso mentre altre non
hanno mai avuto successo come bordeaux/ barolo, corvée/ faticaccia ma altre volte le due
possibilità coesistono hotel/albergo, dessert/dolce e omelette/frittata. Rari sono i casi in cui i
sostituti hanno soppiantato del tutto il francesismo (regista/régisseur, autista/ chauffeur).
Oggi come oggi il francese mantiene un certo prestigio nella moda e quindi molti termini
riferiti ad essa prevalgono nella forma francese (animalier) ma anche nel campo della moda
gli anglismi si vanno affermando sempre di più (trucco/maquillage/make up, fuseaux/leggins,
chanel/slingback, griffe/brand, mise/look). Il successo dell’inglese è relativamente recente;
gli anglismi o anglicismi prima del 700 erano pochissimi e sono a partire dalla seconda metà
del 900 la crescita è esponenziale. Oggi si trovano anglismi un po’ dappertutto, anche
nell’italiano comune (babysitter, lockdown) (rif. anglicismi in enciclopedia dell’italiano).
L’arabo ha avuto grande importanza nel medioevo sono infatti arabismi vocaboli come
azzurro, ragazzo, magazzino, cotone, arancio, albicocco, carciofo, zero, cifra, algoritmo. Gli
ispanismi o spagnolismi si sono diffusi in italia tra il 500 e il 600 durante la dominazione
spagnola (appartamento, regalare, compleanno, disinvoltura, sussiego, paella). Minore
importanza hanno avuto altre lingue iberiche infatti abbiamo poche voci dal portoghese dette
lusismi (caravella, marmellata, banana). Tra le lingue del gruppo germanico importante è
stato l’apporto dei longobardi presenti in italia nel medioevo (anca, schiena, guancia, milza,
nocca, strofinare, russare, panca, federa). Tra gli esotismi moderni ci sono molti nipponismi
(dal giappone) come tsunami, anime, ninja, sushi, origami. Per cercare l’etimo di una parola
basta un dizionario dell’uso.
Ci sono anche vocaboli che l’italiano ha dato ad altre lingue come ciao, voce di origine
veneziana che è giunta ad altre lingue. Molti italianismi sono relativi alla cultura italiana, a
momenti ed ambiti in cui l’italia e la sua lingua hanno goduto di grande prestigio. Si pensi a
un termine come sonetto (in francese sonnèt, in inglese sonnet, in spagnolo soneto e in
tedesco sonnet). Anche nel campo delle arti figurative (abbozzo, affresco, tempera, pastello,
chiaro scuro) ci sono stati molti prestiti ma anche nell’architettura (capitello, zoccolo, soffitto).
Altri prestiti sono parole relative all’ambito della guerra (bastione, cittadella) o alla musica
(tuba, flauto, controfagotto, adagio, soprano, allegro) o film (dolcevita). Quanto all’economia
si usano molti anglismi ma l’inglese cash deriva probabilmente dall’italiano cassa. Prima
infatti erano altre lingue a importare parole italiane come bilancio, cambio, credito, debitore,
saldatore, saldo, sconto. La moneta di firenze fiorino, ha dato origine ad altre monete come
quello olandese e ungherese. I prestiti però prevalgono nell’ambito della gastronomia con
parole come pizza, espresso, cappuccino, mozzarella, pasta, risotto ecc. Esiste un
dizionario di italianismi in francese inglese e tedesco pubblicato a Firenze dall’Accademia
della Crusca nel 2008 (DIFIT). Ci sono molti prestiti di ritorno che sono stati passati ad
un’altra lingua e tornati poi in italiano; un esempio è màscara, variante antica di maschera,
arrivata in Inghilterra e diventata il nome di un cosmetico cambiando genere, accento e
significato. Analogamente Pantalone (maschera di carnevale), in Francia diviene il nome
comune dell’indumento che il personaggio indossava, trasmettendo anche all’italiano questo
significato. Invece il termine disegno arrivato all’inglese tramite il francese è diventato
design. La rivista dedicata alla lingua italiana nel portale treccani è definita magazine, con un
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
anglismo, ma il vocabolo inglese viene dal francese che però a sua volta deriva dall’italiano
magazzino e ha a sua volta origine dall’arabo. A volte quindi le parole compiono viaggi
lunghissimi da una lingua ad un’altra.
13 Per giungere dal latino all’italiano alcune voci sono giunte per tradizione popolare, altre
per tradizione dotta ma dal latino non è nato l’italiano di oggi, dal latino si sono formati i vari
dialetti italiani e tra questi l’importantissimo fiorentino. Gli altri dialetti hanno contribuito
all’italiano con prestiti interni (birichino, iella, ciao, smammare). L’italiano ha dato origine a
molte parole nelle lingue straniere ma ha a sua volta ereditato molte parole (prestiti adattati
e non). A volte ci sono stati molti passaggi come scoglio (viene dal ligure che viene dal latino
che viene dal greco) o arsenale (che discende da una voce veneziana derivata dalla voce
araba, dalla medesima voce araba è arrivato anche darsena giunto da pisa o da genova).
Se guardiamo al lessico italiano ci accorgiamo che la maggior parte delle parole italiane
deriva dall’italiano stesso. Molte nuove parole infatti si formano a partire da parole già
esistenti attraverso meccanismi di composizione e derivazione. Una parola italiana già
esistente può essere anche proveniente da un dialetto o una lingua che l’italiano ha fatto
propria (quale che fosse il suo etimo). Prendendo una parola piena (di autonomia
semantica) chiamata anche base si ottengono variazioni. Prendendo fiore otteniamo ad
esempio fioraio, fiorellino, infiorare, cavolfiore, portafiori ecc. Una possibilità di creazione di
nuove parole quindi è quella di aggiungere un suffisso (la nuova forma è detta suffissata e il
meccanismo suffissazione). A volte ci sono però degli aggiustamenti fonetici (fiorista e non
fioreista). Si può anche aggiungere però un prefisso e ottenere nuove parole (prefissato,
prefissazione); anche nella prefissazione si verifica qualche modifica (impossibile e non
inpossibile). A volte ad una base si aggiungono sia un prefisso che un suffisso come
infiorare o ingrandire (parasintesi). Esistono anche gli infissi o interfissi che erano molto
comuni nel latino. In Italiano possiamo considerati infissi ic come in cuoricino oppure o ol in
sassolino o topolino. Queste forme legate che da sole non stanno in piedi sono dette affissi
(affisazione o derivazione) e a seconda della posizione prendono nomi diversi (prefissi,
suffissi, infissi). Le forme ottenute aggiungendo ad un prefisso sono quasi sempre della
stessa categoria grammaticale (contento, scontento sono entrambi aggettivo) ma con i
suffissi spesso essa cambia. Un’eccezione sono i sostantivi colore, odore e sapore che con i
prefissi diventano aggettivi e i sostantivi preceduti da anti che diventano anch’essi aggettivi.
Una possibile classificazione dei derivati e degli affissi dipende quindi proprio dal rapporto
tra la categoria grammaticale della base e la categoria grammaticale della formazione
(derivati denominali, deaggettivali, deverbali, deavverbiali). Si parla invece di composizione
quando si combinano più parole piene dando vita a composti (es. rossoblu, pastasciutta,
cavolfiore). Anche nei composti spesso è necessario qualche aggiustamento fonologico. A
metà strada tra derivazione e composizione sono i confissi, che sono i prefissoidi (primi
elementi) o suffissoidi (secondi elementi). Sono perlopiù elementi di origine greca o latina
come auto (autobiografia) o grafia (lessicografia). Alcuni confissi possono essere sia
suffissoidi che prefissoidi come logo, cardio, glotto e filo. I confissi possono essere uniti tra
loro per formare una parola senza il bisogno di una parola piena (al contrario degli affissi).
Gli alterati (alterazione) sono suddivisi in diverse categorie. I diminutivi o vezzeggiativi come
librino, gli accrescitivi come librone e i peggiorativi come libraccio. Il suffisso astro che è
spesso dispregiativo può anche avere valore scherzoso o affettuoso se a un bambino
diciamo topastro. Gli alterati mantengono le stesse categorie grammaticali delle parole di
partenza. Può capitare però che cambino genere, come nel caso di donna che diventa
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
donnona o donnone come febbre diventa febbrone. Anche gli avverbi possono avere forme
alterate come anche le interiezioni (accidenti, accidentaccio). Anche per i nomi propri le
forme ipocoristiche (affettuose o familiari) utilizzano diminutivi o vezzeggiativi come il caso di
Maria, Marietta, Mariuccia, Mariolina mentre Giuseppa può diventare Giuseppina da cui Pina
e anche Pinuccia. Uno dei tanti della famiglia dei Medici vissuto tra il 1513 e il 1548 era detto
Lorenzino perché piccolo e debole ma è passato alla storia anche come Lorenzaccio (che è
diventato anche un dramma a lui dedicato). Roberto Benigni ha scherzato alterando il
cognome di un papa (Wojtylaccio). La varietà degli alterati è un tratto caratteristico della
lingua italiana che ha da sempre affascinato gli stranieri. In opere si trovano spesso gli
alterati. Anche nel linguaggio usato con i bambini si usa spesso il diminutivo. Alcuni alterati
hanno avuto così tanto successo che si sono lessicalizzati e sono diventati così autonomi e
dotati di significato preciso. Un lettino non è solo un piccolo letto ma anche proprio un letto
per bambini dotato di sponde protettive. Il seggiolino è diventato proprio il sedile apposito
per bambini ma anche il sedile ribaltabile dei treni. La pastina è usata per indicare la pasta
da minestre. Una borsetta è una borsa più o meno piccola ma specificamente da donna. Il
centrino indica una tovaglietta ricamata. Il libretto è diventato l’opuscolo con il testo di
un’opera lirica. Libretto è anche quello dell’automobile o quello universitario. Anche tesserino
indica proprio una tessera di riconoscimento. Il fustino è un recipiente per detersivi. Il
telefonino è soltanto un cellulare. Anche motorino si è lessicalizzato come motociclo di
piccola cilindrata. Cavalletto designa l’elemento che sostiene una tela da dipingere o una
macchina fotografica. Per indicare quindi un piccolo cavallo si usa soltanto cavallino. Quanto
a cavalluccio si usa molto nella locuzione “prendere a cavalluccio” ma anche i dolcetti tipici
di siena (in cui un tempo vi era impressa l’immagine di un cavallo) o l’ippocampo. Si chiama
cavalluccio anche una citazione di uno dei magistrati di badia perché sopra c’era un disegno
che raffigurava un uomo a cavallo e adesso nel linguaggio burocratico è rimasto cavalluccio
per fare riferimento ad un foglio che nel dorso di un fascicolo riepiloga il contenuto di esso e
nell’università si chiamano cavallucci le cose che verranno discusse in riunioni che una volta
erano raccolte in fascicoli e adesso in un file. Quanto al femminile cavallina il termine è stato
lessicalizzato per definire il gioco che fanno i bambini saltando sulla schiena dell’altro e
anche l’attrezzo ginnico. Una donna cavallona è una donna molto alta rozza e poco
femminile. Il maschile cavallone ha lo stesso significato ma indica anche un’ondata alta e
violenta. Il rosone è un termine architettonico e non una grande rosa. Perfino pagliaccio
deriva da paglia e dipende dal fatto che i buffoni portavano un vestito di tela grezza, la
stessa tela usata per i pagliericci.
Con campo semantico si intende un insieme di parole che ruota intorno ad un tema. I campi
semantici possono dunque includere parole che hanno un rapporto di significato ma che non
hanno alcun rapporto formale tra loro (etimi diversissimi). Con famiglia di parole o famiglia
lessicale si intende una serie di parole che hanno la stessa radice e la stessa base lessicale,
quindi legate etimologicamente (discendono dallo stesso capostipite) e quindi hanno anche
rapporti formali. Nella famiglia lessicale di colore c’è colorino, colorire, colorificio, coloritura
ecc. La famiglia lessicale di fiore include fiorellino, fiorino, fioretto, fiorire, fioraio. Un
dizionario organizzato per famiglie di parole risale al 1988 ed è il Dizionario di italiano
ragionato (DIR) di Angelo Gianni. Il suo dizionario rappresenta un dizionario molto
intelligente. La voce veste ad esempio raggruppa vestiario, vestaglia, vestito ecc. Per molto
tempo il DIR è stato un unicum nel panorama italiano. Gianni elenca le parole che hanno
origine comune e affinità semantica in ordine alfabetico escludendo quindi le voci che pur
derivate dallo stesso capostipite hanno assunto significati diverse. Di recente l’ASIL scuola
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
(sezione per la scuola dell’associazione della storia della lingua italiana) ha promosso un
nuovo dizionario che raccogliesse il patrimonio del DIR chiamandolo RIF repertorio italiano
di famiglie di parole a cura di Michele Colombo e Paolo d’Achille pubblicato dalla Zanichelli
nel 2019. Al RIF hanno partecipato molti studiosi dell’Asil scuola. I criteri del RIF sono però
diversi dal DIR. Nel RIF infatti sono elencati tutti i discendenti di uno stesso capostipite
(spesso latino) e sono quindi state riportate le varie ramificazioni che da quel progenitore si
sono sviluppate in italiano.
14 A volte si uniscono più di due elementi nei composti e si chiamano conglomerati
(nontiscordardime, nonsoché, pomodoro, qualsivoglia, tiramisù). Tiramisù è anche un
esempio di dialettismo in quanto proveniente dal veneto. Se le parole del sintagma si sono
unite, parliamo di univerbazione (calzamaglia, pandoro). Non di rado siamo incerti se
scrivere le parole in questione attaccate o meno. Spesso nei dizionari si possono trovare un
più opzioni (fuggifuggi/ fuggi fuggi, caffè e latte/caffellatte/caffelatte). Il confine tra composti o
conglomerati e locuzioni spesso è molto sottile. Le locuzioni sono le espressioni formate da
due o più parole che però esprimono un significato unitario. Ferro da stiro è una locuzione.
Sono espressioni cristallizzate, lessicalizzate e quindi paragonabile a un composto o ad una
parola piena singola. Un altro termine per locuzione è polirematica (o unità polirematiche)
che troviamo nel GRADIT (in contrapposizione a monorematica, una parola sola). Altri
termini possono essere unità lessicale superiore, lessema complesso o anche parola
complessa. Si dice infatti tirare su e non su tirare, ferro da stiro e non da stiro ferro, lenti a
contatto e non a contatto lenti. Non possiamo quindi cambiare l’ordine delle parole in questi
casi perché la locuzione perderebbe di significato. A volte le locuzioni diventano composti
tramite univerbazione. Il significato è unitario e quindi spesso non dipende dalla singola
parola. Le locuzioni possono essere classificate in base al valore grammaticale: sostantivali
(lente a contatto), aggettivali (in gamba), verbali (tirare su), avverbiali (alla lunga),
preposizionali (al di sotto di), congiunzionali (dato che), esclamative (mamma mia).
Alcune locuzioni sono calchi come ad esempio colpo di fulmine dal francese o guerra fredda
dall’inglese. Esistono anche locuzioni (o espressioni idiomatiche) peculiari di una lingua o di
un dialetto e quindi intraducibili alla lettera. Molte locuzioni traggono spunto dalla vita rurale
(darsi la zappa sui piedi, cercare un ago nel pagliaio). Menare il can per l’aia significa
tergiversare, allungare un discorso senza arrivare al punto. Si dice così perché prima si
conduceva un bue su e giù per l’aia per fare la trebbiatura, il bue con il calpestio dei suoi
zoccoli separava i chicchi di grano dalla paglia e dal resto. Viceversa far passare un cane
non sarebbe servito a nulla e quindi significa qualcosa di inconcludente. Altri esempi sono
prendere due piccioni con una fava o conoscere i propri polli. La locuzione dare spago a
qualcuno significa assecondare qualcuno: i pastori allungavano la corda per lasciare gli
animali al pascolo per più tempo. L’espressione menare per il naso deriva dalla tradizione di
mettere anelli di metallo alle narici dei tori o mucche per tirarli. L’espressione mettere il carro
davanti ai buoi significa fare le cose nell’ordine sbagliato. Chiudere la stalla quando i buoi
sono scappati significa fare qualcosa quando è troppo tardi. Prendere un granchio significa
sbagliare, era un abbaglio per un pescatore prendere un granchio pensando di aver preso
un pesce. Stare con il fucile spianato o in bocca al lupo derivano dal mondo dei cacciatori.
Dall’ambito dei tessitori vengono frasi come sbrogliare la matassa oppure tutti i nodi
vengono al pettine (elemento del telaio). Lo scrittore Primo Levi osserva che tutti i linguaggi
sono pieni di metafore la cui origine si va perdendo. Menziona in particolare la locuzione
mangiare a 4 palmenti che significa mangiare con ingordigia e riprende l’immagine dei mulini
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
che potevano avere più o meno macine in funzione (un mulino con 4 palmenti macinava con
grande velocità). Primo Levi fa notare anche che benché l’equitazione adesso sia uno sport
praticato da poche persone, ancora oggi si utilizzano espressioni riferite ai cavalli quando
ancora venivano utilizzati per trainare carrozze ad esempio (ventre a terra, mordere il freno,
perdere le staffe, prendere le redini, a briglia sciolta). Adesso molte locuzioni sono legati alle
automobili (perdere colpi, partire in quarta, a tutto gas, essere su di giri e prendere una
sbandata). Altre frasi idiomatiche provengono dalla religione (avere il diavolo in corpo, avere
un diavolo per capello, essere come il diavolo e l’acqua santa o vendere l’anima al diavolo).
Altre locuzioni rimandano ai privilegi del clero come vita da papa o da canonico, il boccone
del prete (originariamente la parte posteriore del pollo). Molte locuzioni sono di origine
toscana (come il cacio sui maccheroni, avere l’acquolina in bocca e essere agli sgoccioli). La
letteratura ha contribuito molto alla diffusione di locuzioni toscane come ad esempio
mandare a quel paese usata dal poeta Giuseppe Giusti. Anche Collodi con Pinocchio ha
contribuito con locuzioni come rimettere al mondo (che pronuncia la frase Pinocchio dopo
che ha preso la medicina della fata) o legare come un salame, chi s’e visto s’è visto, alto
come un soldo di cacio. Ha invece origine veneziano essere nati con la camicia (camicia
significa membrana amniotica, quindi una condizione favorevole) o andare a ramengo (o
remengo, varianti di ramingo, cioè vagare). Fare un 48 ha origine milanese e fa riferimento
ai moti del 48 con le famose 5 giornate di milano. Fraseologia significa l’insieme delle frasi
idiomatiche proprie di una lingua.
tra le espressioni tipiche di una lingua o un dialetto sono fondamentali i proverbi, di carattere
sentenzioso. I proverbi sono in genere intere frasi a differenza delle locuzioni anche se
possono essere nominali. La disciplina che studia i proverbi si chiama paremiologia. Anche i
proverbi sono testimonianza di cultura e tradizioni. Parecchi proverbi riflettono misoginia o
comunque un’idea di subordinazione femminile (la donna bella è come la castagna bella
fuori e dentro ha la magagna, le donne ne sanno una più del diavolo, chi dice donna dice
danno, donna al volante pericolo costante, donne e buoi dei paesi tuoi). Non mancano le
contraddizioni: esistono proverbi che dicono una cosa e altri che dicono il senso opposto
(l’unione fa la forza, chi fa da sé fa per tre / la pazienza è la virtù dei forti, la pazienza è la
virtù degli asini). Gli animali sono molto presenti anche nei proverbi (lega l’asino dove vuole
il padrone, far come l’asino che porta il vino e beve l’acqua, in mancanza di cavalli trottano
gli asini, a caval donato non si guarda in bocca, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo
zampino, il lupo perde il pelo ma non il vizio). Sui normali dizionari dell’uso è riportata anche
la fraseologia ma esistono anche dizionari appositi (dizionario dei modi di dire della lingua
italiana di Lapucci, dizionario dei proverbi italiani di Lapucci, dizionario dei modi di dire di
Lurati, dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali italiani latini francesi spagnoli
tedeschi greci antichi di Arthaber)
15 anche i dizionari dell’uso danno conto di etimologia e datazione delle parole ma possono
mancare alcune parti (in particolare online). Nel sito di Internazionale è presente tutto.
Queste informazioni sono però molto succinte nei dizionari dell’uso e per più dettagli è
necessario consultare i dizionari etimologici. Il dizionario di Giovanni Alessio e Carlo Battisti
è intitolato Dizionario Etimologico Italiano (DEI) pubblicato a Firenze tra il 1950 e il 1957 in 5
volumi. Carlo Battisti era un filologo e dialettologo esperto di toponomastica, professore di
glottologia e accademico della crusca. Era nato nel 1882 a Trento, in un territorio allora
austriaco. Si laureò a Vienna e durante la prima guerra mondiale venne fatto prigioniero e si
ritrovò in Russia al momento della rivoluzione d’ottobre. Rientrato in italia, rimise in piedi la
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
biblioteca di Gorizia e insegnò all’università di Firenze. È stato perfino attore in un
capolavoro del neorealismo con Vittorio de Sica nel ruolo di Umberto VI. Giovanni Alessio fu
allievo di Battisti e per questo il suo nome era posto per secondo. Giovanni Alessio era di
Catanzaro dove era nato nel 1909 e morto a Firenze nel 1984. Era un linguistica,
dialettologo e professore di glottologia. Oltre che a Firenze insegnò in molte altre città come
Venezia e Napoli. Per redigere il dizionario ci sono voluti meno di 10 anni. Il DEI è molto
innovativo e ricco per l’epoca ma secondo Pellegrini ci sono stati alcuni errori o sviste. Il
nome cane è attestato in italiano dal tredicesimo secolo e già in petrarca si trova come
ingiuria. Deriva dal latino canis e si tratta di una voce di origine indoeuropea e panromanza,
ovvero diffusa in tutta l’area romanza anche se in spagnolo si dice perro.
Il dizionario di Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli è intitolato Dizionario Etimologico della lingua
italiana (DELI) anch’esso in 5 volumi editi dalla Zanichelli tra il 1979 e il 1988. Entrambi gli
autori erano stati allievi di Carlo Tagliavini. Paolo Zolli è famoso per il libro Le parole
straniere. Entrambi si sono occupati anche della sezione etimologica dello Zingarelli e si
sono rifatti proprio a quello per creare il DELI. Il DELI è molto preciso e risale alle prime
attestazioni risalendo anche all’evoluzione dei significati. Una seconda edizione è chiamata
Il nuovo etimologico del 1999 in un unico volume corredata da un cd. Questi dizionari
subiscono spesso modifiche grazie alle nuove scoperte in cui frequentemente ci si accorge
che è necessario retrodatare una parola. Nel nuovo DELI ci sono diverse retrodatazioni. La
retrodatazione più vertiginosa era quella della locuzione “pezzo di terra”. Tale locuzione era
retrodatata di ben 7 secoli (1871->12º secolo).
Nel 1979, stesso anno in cui è uscito il primo DELI, è uscito anche il primo fascicolo del
Lessico etimologico italiano (LEI), opera molto diversa dagli altri dizionari. Il LEI è stato
fondato da Max Pfister filologo e linguista svizzero. Nel DEI e nel DELI cerchiamo una parola
e ne troviamo l’etimologia e la storia; viceversa nel LEI il lemma è costituito dall’etimo e
quindi la voce esplora ciò che da quell’etimo è disceso. Nel LEI troviamo il lemma canis. Per
guidare nella ricerca delle parole ci sono degli indici che spiegano dove si trova il vocabolo
che ci interessa. È uscito in fascicoli via via raccolti in volumi. È un’opera molto vasta che
richiede lavoro da parecchie persone. Pfister diresse da solo il LEI inizialmente ma nel 2002
Wolfgang Schweickard si è affiancato a Pfister e quindi figurano i due nomi nelle ultime
edizioni. Dal 2015 Elton Prifti si occupa della digitalizzazione del LEI. Il LEI oggi è diretto da
Prifti e Schweikard. L’ultimo fascicolo del LEI uscito è il 136º del volume 16º come risulta dal
sito. La fine dei lavori è stata prevista per il 2033. L’opera è tedesca. Al LEI lavorano molti
studiosi italiani come Marcello Aprile. Anche l’università per stranieri di Siena collabora con il
LEI. La voce canis manca dal sito, ma è una voce lunghissima di oltre 60 pagine (divise in
due colonne). All’inizio della voce c’è un sommario che riassume com’è divisa la voce
stessa. Il LEI è incentrato sulla lingua italiana ma tiene d’occhio il contesto romanzo.
16 Il cinquecento è caratterizzato dalla questione della lingua. L’italia era frammentata e lo
sarebbe stata ancora a lungo ma nel 16º secolo era ormai acquisita la consapevolezza
dell’importanza del volgare che già vantava di una sua illustre tradizione letteraria e
culturale. I letterati del cinquecento perciò si interrogavano e discutevano anche con toni
molto accesi su come si dovesse scrivere in volgare. Infatti il principale problema era la
lingua scritta: si cercava di trovare quale fosse la lingua migliore e come tale lingua dovesse
essere denominata (volgare, toscano, fiorentino, italiano). Nel dibattito sono emerse
principalmente tre correnti: una corrente è quella arcaizzante che prendeva a modello il
fiorentino aureo (della fine del duecento, lingua delle tre corone e di altri autori toscani dello
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
stesso periodo, il principale esponente fu Pietro Bembo che indicò come modelli Petrarca
per la poesia e Boccaccio per la prosa), le lingue cortigiane (lingue ibride nelle quali
confluiscono elementi regionali o dialettali ma si evitano i localismi troppo marcati e si
innestano elementi toscani e latini), il toscano (il fiorentino vivo, contemporaneo o anche il
senese). La corrente che prevalse fu quella di Bembo. L’alunno si inserì in questa corrente
basandosi sul lessico petrarchesco e quello di boccaccio. La teoria arcaizzante viene ripresa
in varie opere: Niccoló Liburnio pubblicò Le Tre Fontane (fonti) parlando di Dante, Petrarca e
Boccaccio a metà strada tra grammatica e vocabolario. Comprendeva infatti elenchi di
parole divise in base alle categorie grammaticali. Ogni lemma è seguito dalla citazione
d’autore senza altre spiegazioni. Alberto Acarisio nel 1543 pubblicò Vocabolario Grammatica
e Ortografia della lingua volgare, un compendio grammaticale cui segue un ampio dizionario
basato sui tre autori. Erano quindi dizionari diversi da quelli di ora ed erano più simili alle
concordanze. I primi lessicografi del 500 sono stati quindi letterati di varie parti d’italia, in
particolare del nord est e non fiorentini in quanto gli “stranieri” dovevano imparare il toscano
come un’altra lingua nuova. Queste opere vennero stampate a Venezia, allora il maggiore
centro culturale. I toscani si sentirono un po’ defraudati e i letterati hanno reagito in vario
modo.
Ci fu quindi un desiderio di rivalsa da parte dei fiorentini. Benedetto Varchi tentò di riportare
la questione della lingua a Firenze cercando di conciliare l’idea di Bembo con la centralità
del fiorentino valorizzando la lingua viva e parlata. Un allievo di Varchi era Lionardo Salviati;
a lui si deve una orazione in lode della lingua fiorentina pronunciata nel 1564 all’accademia
fiorentina con l’intento di risvegliare l’orgoglio dei fiorentini. Più avanti tra il 1576 e il 1577
elaborò delle regole della Toscana favella destinate ad un ambasciatore del duca di Ferrara
a Firenze. Si tratta di una grammatichetta manoscritta rimasta inedita fino a quanto Anna
Antonini Remiri non l’ha studiata. Salviati si occupa poi del Decameron, opera inserita tra i
libri proibiti (1573) quando l’inquisizione proibì anche la versione con la rassettatura del
sacro concilio di Trento. Salviati curò quindi una nuova edizione del Decameron che uscì nel
1582 in cui tagliò parti scandalose e apportò modifiche e commentò. Nello stesso anno
nacque l’accademia della crusca i cui fondatori sono Giovan Battista Veti, Anton Francesco
Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini e Bastiano de Rossi. Anche Lionardo
Salviati entrò a far parte quasi da subito ed ebbe un ruolo determinante nell'indirizzare
l’accademia verso questioni linguistiche e filologiche. Il nome stesso dell’accademia si
associa all’idea di separare dalla crusca il fior di farina e cioè la buona lingua. I nomi assunti
dagli accademici fanno riferimento alla farina, Salviati infatti si fa chiamare l’accademico
infarinato. Salviati elaborò Gli avvertimenti della lingua sopra il Decamerone, due volumi
pubblicati tra il 1584 e il 1586. Salviati valorizzava anche Dante che a Bembo piaceva
linguisticamente meno. Salviati criticava molto Tasso, colpevole di essersi allontanato troppo
dal fiorentino puro. Salviati tiene conto anche del fiorentino più moderno per la pronuncia e
per la grafia, oltreché il fiorentino letterario per il lessico. Nel 1589 Salviati morì ma
l’accademia della crusca prosegui il proprio lavoro e dal 1590 venne assunto come simbolo
dell’accademia il frullone o buratto, una specie di setaccio con cui si separava la farina dalla
crusca e come motto venne preso un verso di Petrarca un po’ adattato “il più bel fior ne
coglie”.
L’opera più importante degli accademici della crusca è il vocabolario della crusca. La prima
testimonianza esplicita relativa al vocabolario risale al 1591; si conserva infatti invernale dal
quale risulta che gli accademici discutevano su come preparare le voci dividendosi le
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
schedature da fare. L’idea quindi risale a prima di quell’anno. Gli accademici pur essendo
dilettanti eseguono un’analisi rigorosa e ordinata e finiscono già nel 1595. Severina Parodi in
un saggio Gli Atti del Primo Vocabolario (1974) e Quattro Secoli di Crusca (1583-1983) dà
molte notizie sulla storia dell’accademia ma molte di esse si trovano anche sul sito
dell’accademia. Solo nel 17 secolo viene pubblicato il vocabolario, che non poteva essere
pubblicato prima per motivi economici. Gli accademici allora si finanziarono da soli e
ottennero un privilegio in Francia grazie all’intervento di Concino Concini, favorito di Maria
de’ Medici e divenuto potentissimo alla corte francese. Il vocabolario è infatti dedicato a lui.
L’opera viene stampata a Venezia con la cura di Bastiano de Rossi (L’inferigno). Nel 1612
esce il vocabolario a Venezia. Oggi il vocabolario si trova anche digitalizzato in rete. Il
vocabolario del 1612 si basa su opere di fiorentini antichi a cominciare dalle tre corone ma
anche molti altri autori minori. Gli esempi erano tratti non solo da testi a stampa, ma anche
da manoscritti inediti posseduti personalmente dagli accademici. Alcune di queste fonti
quindi, non essendo verificabili, verranno messe in dubbio da altri letterati dell’epoca. Se
vengono citati altri letterati, sono comunque fiorentini come Machiavelli e Salviati o altri
autori come Bembo e Ariosto che pur non essendo fiorentini, si erano attenuti al modello dei
grandi autori fiorentini del passato. L’escluso fu Tasso. Ciò comportava anche la
registrazione di varianti toscane antiche come “avvolterio” a fianco di adulterio. Gli
accademici si mostrano moderni eliminando alcune grafie latineggianti come quelle con h
etimologica in sintonia con quanto aveva indicato Salviati. Fu un’impresa unica a livello
europeo. Al vocabolario della crusca si sono ispirati i francesi per il dictionnaire de
l'académie francese e anche gli spagnoli per il vocabolario della real academia. Paolo Beni,
insegnante dell’università di Padova, pubblica L’Anticrusca, il paragone dell’italiana lingua
nel qual si mostra che l’antica sia rozza e la moderna regolata e gentile. Paolo Beni era un
continuatore della lingua cortigiana. Si opponeva agli arcaismi toscani e difendeva gli autori
moderni del cinquecento supportando lo stile di Tasso e rivendicandone la superiorità
rispetto ad autori come Boccaccio. Il più famoso anticruscano però è stato il modenese
Alessandro Tassoni che trascrive le sue riserve in un manoscritto intitolato Dell’incognito da
Modana contro alcune voci del vocabolario della Crusca. Mandò subito il manoscritto agli
accademici e criticando gli arcaismi e invitandoli a contrassegnarli come forme da evitare.
Gli accademici ignoravano questi suggerimenti. La seconda edizione del 1623 (venezia)
infatti non ebbero tali modifiche e vennero solo aggiunte delle citazioni. Alcune critiche
vengono recepite nella terza edizione in tre volumi nel 1691 (firenze) in cui con la sigla va si
contrassegnano alcune voci antiche. Vengono aggiunti alcuni autori Toscani come
Fiorenzuola, Guicciardini, Varchi, Chiabrera, Guarini, Annibal Caro e Tasso (resta ancora
escluso il marino) ma tali autori sono comunque citati solo in mancanza o a conferma di
esempi di autori antichi che rimangono il modello. La terza edizione dà maggiore spazio a
termini tecnici e scientifici grazie alla collaborazione di Francesco Redi o Lorenzo Magalotti.
Una quarta edizione esce a Firenze tra il 1729 e il 1738 in 6 volumi. Questa edizione rafforza
l’impostazione arcaizzante e quindi continuano anche le critiche. La quinta e ultima edizione
del vocabolario della crusca procede lentamente; solo nel 1863 viene pubblicato il primo
volume con dedica a vittorio emanuele II. L’opera si ferma nel 1923 al volume undicesimo
alla lettera O alla voce Ozono. Per un intervento di Giovanni Gentile viene interrotta l’attività
lessicografica dell’accademia della crusca. Oggi l’accademia della Crusca esiste ancora
anche se ha un ruolo molto diverso rispetto a quello del passato: si occupa di ricerca con
progetti, pubblicazioni e convegni. Sostiene la lingua italiana ma anche le politiche
plurilinguistiche ad esempio in Europa. È impegnata nella consulenza linguistica e per
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
rispondere alle curiosità delle persone comuni, attraverso il periodico La Crusca Per Voi ma
anche attraverso il sito. L’accademia ora ha sede nella Villa Medicea di Castello.
Il primo volume della quinta e ultima crusca esce nel 1873 a Firenze.
17 Nel 1861 escono a Torino i primi fascicoli del Dizionario della lingua italiana di Niccoló
Tommaseo e Bernardo Bellini. Viene completato nel 1879 ed è noto come Tommaseo-
Bellini. Il nome più famoso però è Tommaseo, letterato nato in Dalmazia e morto a Firenze
prima che il dizionario venisse completato. È noto come scrittore per il romanzo Fede e
bellezza del 1840 e anche come patriota e membro del governo provvisorio di Venezia
durante i moti del 48 dopo i quali andò in esilio. In precedenza aveva curato il Nuovo
dizionario dei sinonimi della lingua italiana del 1830. Bellini era un professore di materie
classiche originario di Como. Anche lui si era occupato di altri dizionari di italiano e latino.
Oggi quest’opera è in rete grazie a un accordo dell’accademia della Crusca e l’editore
Zanichelli che già aveva predisposto un cd di questo dizionario. Il Tommaseo-Bellini è nato
nel 1857 per volontà di un editore torinese Luigi Pomba che aveva in mente questo progetto
da molto tempo. Alcuni fascicoli di questo dizionario erano già pronti tra il 58 e il 59 quando
scoppiò la prima guerra di indipendenza quindi le prime dispense escono solo nel 1861. La
presentazione dell’opera firmata da Giuseppe Pomba è datata Torino, 15 giugno 1861. Dal
1865 fu l’unione tipografico editrice a pubblicare questo dizionario. Giuseppe Meini, filologo
grecista e traduttore fiorentino, aveva collaborato anche al dizionario dei sinonimi e ad altre
opere di Tommaseo e venne poi coinvolto nel dizionario della lingua italiana e ben presto ne
diviene il perno. Tommaseo infatti diventò cieco e nel 74 morì, due anni prima di Bellini. Sarà
proprio Meini quindi a continuare e terminare il dizionario della lingua italiana. Ci sono oltre
7000 pagine ed esce a dispense che vengono a formare 4 volumi divisi in 8 tomi. Il
tommaseo-bellini è un grande dizionario e dizionario storico, erede del dizionario della
crusca da cui sono presi molti esempi. Ci sono autori più moderni fino ad arrivare
all’ottocento stesso oltre che gli autori dalle tre corone. Ci sono molti esempi desunti da
trattati e quindi molti vocaboli tecnici-scientifici. Non si tratta comunque di un dizionario
specialistico. Nel Tommaseo-Bellini sono contemplati anche autori non toscani. Il titolo
completo è Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai signori Niccoló
Tommaseo e cavalier professore Bernardo Bellini con oltre 100.000 giunte ai precedenti
dizionari raccolte da Niccoló Tommaseo, Giuseppe Campi, Giuseppe Meini, Pietro Fanfani e
da molti altri filologi scienziati, corredato da un discorso preliminare di Niccolò Tommaseo.
Tutte le voci e anche le singole parti delle voci sono firmate e siglate da ogni singolo autore:
T sta per Tommaseo e i suoi commenti sono molto personali, spesso anche polemici e
spiritosi. È considerato un punto di riferimento per molti dizionari del diciannovesimo e
ventesimo secolo e tuttora viene consultato e studiato.
Nel 1961 è uscito il primo volume di un altro importantissimo repertorio: il Grande dizionario
della lingua italiana di Salvatore Battaglia e poi da Giorgio Barberi Squarotti pubblicato a
Torino dalla UTET. UTET sta per unione tipografico editrice torinese, cioè un’unione fondata
nel settecento dai fratelli Pomba (gli stessi del Tommaseo-Bellini). Il primo progetto di
Battaglia era proprio quello di rivedere il dizionario di Tommaseo-Bellini. Il progetto di
Battaglia però poi è stato ampliato e si è arrivati al GDLI, un dizionario storico e al tempo
stesso un grande dizionario, un’opera per specialisti. È noto anche come il Battaglia. Egli fu
in importante filologo e storico della letteratura italiana delle origine e di quella francese
antica, studioso di Boccaccio. Era originario di Catania. Collaborò all’enciclopedia Italiana.
Ha insegnato all’università filologia romanza e letteratura italiana. Dal 1938 Salvatore
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
Battaglia ha avuto una cattedra all’università a Napoli dove è morto nel 71. Giorgio Barberi
Squarotti era nato a Torino nel 1929 ed è stato un critico letterario professore di storia della
letteratura moderna e contemporanea a Torino e studio di Dante, Machiavelli, Tasso,
Manzoni, Pascoli e molti altri... Fu anche poeta. Il GDLI con Squarotti è giunto alla fine, alla
lettera zeta. L’ultimo volume, il ventunesimo, è uscito nel 2002. Ora anche questo dizionario
è stato digitalizzato e dal 2019 è consultabile online grazie ad un accordo con la UTET e
l’accademia della Crusca. Si tratta di un prototipo di edizione digitale del dizionario, è ancora
soggetto a modifiche. Il GDLI rappresenta il più grande dizionario storico della lingua italiana
finora elaborato. Ha quasi 23.000 pagine. La presentazione al primo volume è di Battaglia
del 1961 e parla delle tante tribolazioni patite per preparare il dizionario che ha richiesto
un’assidua prova di entusiasmo. Battaglia mette in rilievo la ricchezza di documenti e esempi
che caratterizza il suo dizionario (riferendosi a Voltaire “un dizionario senza citazioni è uno
scheletro”). Il GDLI è molto corposo e contiene moltissime citazioni. Il solo elenco degli
autori e dei testi citati richiede un intero volume a sé. Il GDLI è basato su testi della lingua e
della letteratura italiana che vanno dalle origini al presente. Per completarlo ci sono voluti più
di quarant’anni. Molti studiosi hanno collaborato al GDLI come Roberto Alonge, Gianluigi
Beccaria, Guido daVico Bonino, Bice Garavelli Mortara, Marziano Guglielminetti, Vincenzo
Mazzodrio. Molti dizionari si rifanno al GDLI. I primi volumi privilegiano testimonianze di
scrittori, citazioni letterarie non solo per vocaboli letterari ma anche per parole comuni; nei
volumi successivi è stato dato più spazio ad altre fonti come giornali, manuali, atti ufficiali pur
riconoscendo come fonte principale la tradizione letteraria. Nel GDLI vengono
minuziosamente distinti i diversi significati. Ci sono tre colonne per ogni pagina. Solo la voce
cane è divisa in 19 accezioni tra cui locuzioni. A differenza del vocabolario della crusca, non
ha intento normativo, ma è rivolta a specialisti con uno scopo descrittivo di studio del lessico
e della sua evoluzione. Arrivati alla Z è stato necessario pensare di fare aggiornamenti e
infatti ne sono stati pubblicati 2: il supplemento 2004 e il supplemento 2009 (non ancora in
rete) diretti da Edoardo Sanguineti.
18 1612 data da ricordare per l’accademia della crusca. Il vocabolario della crusca rientra tra
i dizionari storici. La maggior parte dei dizionari su cui abbiamo lavorato sono generali
(zingarelli, sabatini coletti ecc.) cioè privilegiano la dimensione sincronica e quindi la lingua
odierna. I dizionari dell’uso registrano comunque anche alcuni termini antichi che fanno
parte della tradizione letteraria ma non sono specialistici, quindi la maggior parte degli
esempi sono esempi inventati (exempla ficta), non sono citazioni (salvo eccezioni come
nelle parole di origini e letteraria). Il GDLI invece è un dizionario storico (si compone di 21
volumi a partire dal 1961 fino al 2002 con due supplementi) e quindi gli esempi sono tratti da
testi letterari, giornalistici ecc e non sono mai exempla ficta. Anche il Tommaseo-Bellini è un
dizionario storico erede della Crusca e che precede il GDLI. Tutti e tre sono dizionari storici
ma con differenze abissali: nel caso della Crusca gli esempi erano citazioni prese da autori
ma con l’intento di fornire un modello di lingua, nel Tommaseo-Bellini ci sono esempi di
autori e quindi c’è un intento descrittivo ma ci sono anche dei giudizi sui vari autori e quindi
si trova a metà strada, nel GDLI invece non c’è nessun intento normativo-prescrittivo e serve
solo per lo studio della lingua. Anche i dizionari etimologici riguardano la storia ma si
focalizzano sull’etimo. Il Battaglia ha un supplemento del 2004 in quanto ha impiegato
moltissimo ad essere completato e nel frattempo la lingua è cambiata e sono state fatte
anche nuove scoperte. Il supplemento è curato da Edoardo Sanguineti, un poeta di Genova.
Ha curato anche il supplemento del 2009. Anche il GRADIT di De Mauro è stato aggiornato
tra il 2003 e il 2007 per aggiungere i neologismi. Le nuove parole però non sempre entrano
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
nei dizionari perché si prevede che alcune vengano usate solo per un certo periodo di
tempo. La parola umarell(s) è stata ripresa dal 2005 ed è stata reinventata da Danilo Masotti
definendo come tale un signore anziano che gira per i cantieri con le mani dietro la schiena
e osserva. Nello Zingarelli del 2020 è stata inserita questa parola. Nello Zingarelli nuovo ci
sono molte altre nuove parole come anche cazzimma (di origine dialettale campana). Anche
questa parola non è recentissima ma è stata aggiunta solo ora. Nel 2012 è uscito un
approfondimento ad un quesito sulla parola cazzimma da parte dell’accademia della crusca.
Tutti i dizionari devono fare i conti con i neologismi. Esistono anche dei dizionari di
neologismi: il capostipite è il Dizionario moderno di Alfredo Panzini del 1905. Il Dizionario
moderno si definiva con il sottotitolo “supplemento ai dizionari italiani” che poi è diventato
Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni. Dopo Panzini molti
linguisti e lessicografi hanno curano repertori di neologismi come Alfredo Schiaffini e Bruno
Migliorini hanno continuato l’opera di Panzini e hanno messo un’appendice di 5000 voci con
parole bandite dal fascismo (pubblicato nel 1942). Nel 63 Migliorini da solo ha pubblicato un
altro repertorio di parole nuove. Lo stesso Mario Cortelazzo con Ugo Cardinale ha curato nel
1989 il dizionario di parole nuove (con le parole dal 64 all’87). Nel corso degli anni 80 fino al
primo millennio c’è stata un’ampia serie di dizionari di neologismi. Nel 90 Ottavio Lurati e
chiamato 3000 parole nuove (parole del 1980-1990), Michele Cortelazzo ha curato degli
annali del lessico contemporaneo italiano (ALCI), Valeria della Valle con Giovanni Adamo ha
pubblicato diversi repertori di neologismi che poi confluiscono nella Treccani. Online gli
aggiornamenti sono più rapidi. Nel sito della Treccani ogni settimana escono dei neologismi
(es. denatalisti -> chi non sostiene l’aumento della natalità). Esistono anche repertori che
raccolgono gerghi (es. giovanili, della malavita). Il sito ristretti riguarda il mondo carcerario e
comprende un glossario dei termini dei detenuti. Un primo modo per distinguere i dizionari è
vedere proprio come sono fatti: anche solo l’ordine delle parole ci fa capire molto (ordine
alfabetico/logico...), anche i destinatari di un dizionario ci fanno capire molto sul dizionario
stesso (specialistici, per bambini, per stranieri...), se hanno figure, se hanno supporto
(online), se fanno riferimento alla storia delle parole, se hanno novità, se riportano lemmi
dialettali ecc.
Nuove parole vengono formate anche grazie a sigle e acronimi. Altri tipi di parole sono le
parole macedonia (fusione di due o più parole, cartolibreria). A volte un nome proprio
diventa un nome comune, perde la maiuscola (deonomastica) come ad esempio l’asiago, il
gorgonzola, la bologna, il chianti, lo champagne. La deonomastica spesso è data anche da
nomi di persone, come il don giovanni, casanova, mecenate, watt, volt. I marchionimi sono
nomi comuni che derivano da un marchio. Il velcro è una sigla (velour e crochet). A volte le
parole nascono anche dagli errori: ci sono parole che usiamo che non sono altro che il frutto
di un errore (malapropismo) come ad esempio stravizio che non viene da vizio ma viene da
una parola serbo-croata (stravizzo) che voleva dire brindisi e si è associata quella parola a
vizio.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ivan-nyshchyy (i.nyshchyy@studenti.unistrasi.it)
Potrebbero piacerti anche
- Il nuovo Corso base di latino: Grammatica e traduzione con eserciziDa EverandIl nuovo Corso base di latino: Grammatica e traduzione con eserciziNessuna valutazione finora
- Corso base di latino. Vol. 1+2: Grammatica e traduzioneDa EverandCorso base di latino. Vol. 1+2: Grammatica e traduzioneNessuna valutazione finora
- BOURENANE - LING4 - Lo StrutturalismoDocumento6 pagineBOURENANE - LING4 - Lo StrutturalismoZahia MazizNessuna valutazione finora
- Esistono I Verbi Sintagmatici in Italiano - SimoneDocumento15 pagineEsistono I Verbi Sintagmatici in Italiano - SimoneMatías Costantini ReschiaNessuna valutazione finora
- La Fabbrica Delle ParoleDocumento8 pagineLa Fabbrica Delle ParoleMonica CellaNessuna valutazione finora
- Lezione Del 5 Marzo 2020Documento7 pagineLezione Del 5 Marzo 2020ljlNessuna valutazione finora
- Storia Della LinguaDocumento130 pagineStoria Della LinguaErica BonannoNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Grammatica Storica ItalianaDocumento24 pagineLezioni Di Grammatica Storica ItalianaFrancesco De Filippi100% (1)
- LESSICODocumento8 pagineLESSICOAniaNessuna valutazione finora
- L'italiano ContemporaneoDocumento5 pagineL'italiano ContemporaneoLuca Balestrino100% (2)
- MorfologiaDocumento12 pagineMorfologiaDaniele CalabròNessuna valutazione finora
- Appunti Linguistica ItalianaDocumento6 pagineAppunti Linguistica ItalianaFrensiNessuna valutazione finora
- Grammatica ItalianaDocumento8 pagineGrammatica ItalianaGiorgio MattaNessuna valutazione finora
- Il LessicoDocumento9 pagineIl LessicoArianna CuomoNessuna valutazione finora
- Caratteri Generali Di MetricaDocumento8 pagineCaratteri Generali Di MetricaMariagrazia QuarantaNessuna valutazione finora
- Doc. Fabio Atzori Linguistica Italiana Che Cos'è La Linguistica ItalianaDocumento28 pagineDoc. Fabio Atzori Linguistica Italiana Che Cos'è La Linguistica ItalianaNicola CalcabriniNessuna valutazione finora
- Bausi-Martelli MetricaDocumento4 pagineBausi-Martelli MetricaGiulia CardilloNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro SerianniDocumento23 pagineRiassunto Libro SerianniMarialuisa FinocchiaroNessuna valutazione finora
- Ortografia e fonologia. Teoria + esercizi svolti. La grammatica senza segretiDa EverandOrtografia e fonologia. Teoria + esercizi svolti. La grammatica senza segretiNessuna valutazione finora
- LINGUISTICADocumento16 pagineLINGUISTICAVincenzo CarusoNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO "Dalle Parole Ai Dizionari"Documento115 pagineRIASSUNTO "Dalle Parole Ai Dizionari"Giorgia VecchiottiNessuna valutazione finora
- VocabolarioDocumento2 pagineVocabolarioSusa SousaNessuna valutazione finora
- Morabito PDFDocumento33 pagineMorabito PDFSylviaAubergineManzione100% (1)
- Lanzarone - Elementi Di Lingua LatinaDocumento52 pagineLanzarone - Elementi Di Lingua LatinaFradplNessuna valutazione finora
- Books 2010 2019 077-2014-1 4Documento30 pagineBooks 2010 2019 077-2014-1 4Luoana EremiaNessuna valutazione finora
- Scrivere PoesiaDocumento26 pagineScrivere PoesiaRoberto FilippiNessuna valutazione finora
- Nuova Grammatica Latina digitale: con esercizi e appendice metricaDa EverandNuova Grammatica Latina digitale: con esercizi e appendice metricaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- Storia Della Lingua ItalianaDocumento44 pagineStoria Della Lingua ItalianaBeatrice RicciNessuna valutazione finora
- Fonologia Della Lingua ItalianaDocumento206 pagineFonologia Della Lingua ItalianaJeanJames KöningNessuna valutazione finora
- Linguistica Generale: Segmento Sonoro MinimoDocumento13 pagineLinguistica Generale: Segmento Sonoro Minimogiulia gaiaNessuna valutazione finora
- Domande Aperte 1 21Documento6 pagineDomande Aperte 1 21enza maria fiore100% (1)
- Propedeutica Latino 2 - Alfabeto e Accento (II)Documento16 paginePropedeutica Latino 2 - Alfabeto e Accento (II)Sara Di PalmaNessuna valutazione finora
- Berruto-Cerruti La Linguistica Cap. 3 MorfologiaDocumento5 pagineBerruto-Cerruti La Linguistica Cap. 3 MorfologiaLucyNessuna valutazione finora
- giống và khác nhưng tiếng ÝDocumento3 paginegiống và khác nhưng tiếng Ý1907090098Nessuna valutazione finora
- It Cont Lexicologie CURS Sinteza, R. Toma, An 3. Sem1, 91pgDocumento91 pagineIt Cont Lexicologie CURS Sinteza, R. Toma, An 3. Sem1, 91pgamariah1Nessuna valutazione finora
- 1 Lessicologia STUDENTI PDFDocumento217 pagine1 Lessicologia STUDENTI PDFAnđaNessuna valutazione finora
- Piccolo Vocabolario Triestino Italiano Con Qualche Nozione Di GrammaticaDocumento217 paginePiccolo Vocabolario Triestino Italiano Con Qualche Nozione Di GrammaticaNourredine MEZIANENessuna valutazione finora
- Grande Grammatica Italiana Di Consultazione A CuraDocumento9 pagineGrande Grammatica Italiana Di Consultazione A CuraFranklin BedoyaNessuna valutazione finora
- ABC Di MetricaDocumento7 pagineABC Di MetricaCiro NepiNessuna valutazione finora
- La MetricaDocumento15 pagineLa MetricaFABIOLA BASELICENessuna valutazione finora
- Glottologia - Appunti LezioniDocumento92 pagineGlottologia - Appunti LezioniCecilia PassarellaNessuna valutazione finora
- Corso Di Linguistica Generale - MorfologiaDocumento17 pagineCorso Di Linguistica Generale - MorfologiaEnzo Jesus Santilli100% (2)
- LEZIONE1Documento6 pagineLEZIONE1ljlNessuna valutazione finora
- 8 La Struttura Della Sillaba Sequenze Di Suoni Possibili in ItalianoDocumento5 pagine8 La Struttura Della Sillaba Sequenze Di Suoni Possibili in ItalianoNunzio PucaNessuna valutazione finora
- Introduzione Al Gotico Atta UnsarDocumento4 pagineIntroduzione Al Gotico Atta UnsarClaudia OlleicamotNessuna valutazione finora
- Linguistica ItalianaDocumento108 pagineLinguistica ItalianaLeonardo G. StentaNessuna valutazione finora
- L'italiano PDFDocumento61 pagineL'italiano PDFAuroraNessuna valutazione finora
- Git2te Compendiovs1.6bDocumento24 pagineGit2te Compendiovs1.6bemmawillaumepersoNessuna valutazione finora
- Differenza Tra Fono, Fonema e AllofonoDocumento6 pagineDifferenza Tra Fono, Fonema e AllofonoSharon D'apranoNessuna valutazione finora
- Giuseppe Patota Grammatica Di Riferimento Della Li PDFDocumento4 pagineGiuseppe Patota Grammatica Di Riferimento Della Li PDFMarioNessuna valutazione finora
- Propedeutica Latina 4 - MorfologiaDocumento19 paginePropedeutica Latina 4 - MorfologiaSara Di PalmaNessuna valutazione finora
- Storia Della Lingua Italiana CompletoDocumento30 pagineStoria Della Lingua Italiana Completoclara83.cgNessuna valutazione finora
- Lezione - Fonetica e FonologiaDocumento3 pagineLezione - Fonetica e FonologiasevignaniNessuna valutazione finora
- Grammatica Latina Essenziale PDFDocumento131 pagineGrammatica Latina Essenziale PDFHerminia Delgado Núñez100% (1)
- Ritorno Ai Longobardi PDFDocumento34 pagineRitorno Ai Longobardi PDFbruno pausaNessuna valutazione finora
- Lez2 Metodologia Generale Dell'insegnamento S Trumentale Didattica Della ComplessitàDocumento24 pagineLez2 Metodologia Generale Dell'insegnamento S Trumentale Didattica Della Complessitàbottesini76Nessuna valutazione finora
- Studio Di FunzioneDocumento77 pagineStudio Di FunzioneRita MazzeiNessuna valutazione finora
- GD DORIGO - Home Door Collections 2019 PDFDocumento228 pagineGD DORIGO - Home Door Collections 2019 PDFreysanchez88Nessuna valutazione finora