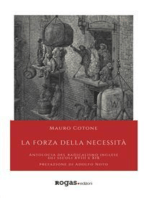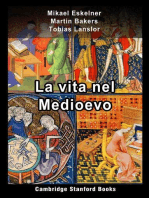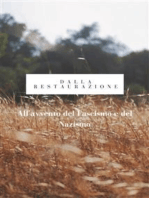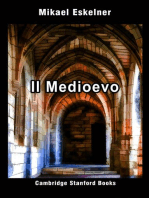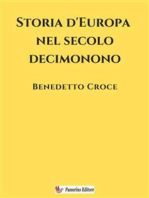Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Stato Moderno
Caricato da
Anna Pia RuoccoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Stato Moderno
Caricato da
Anna Pia RuoccoCopyright:
Formati disponibili
Stato moderno
martedì 11 gennaio 2022 08:41
Stato moderno
La teoria dello S.m. rimane controversa, ed è oggetto di discussione se il concetto di S.m. possa
essere impiegato per definire forme politiche diverse da quelle europee e possa rappresentare
una chiave efficace per cogliere il senso dello sviluppo politico nell’Età moderna e contemporanea.
Sebbene già nella Roma imperiale e in alcuni periodi del Medioevo sia possibile rintracciare alcuni
dei caratteri dello S.m, le origini di tale forma politica vengono di solito collocate nel 15° sec.,
quando si determinò la crisi dei grandi poteri universali (papato e impero) e dei poteri signorili e
feudali, e si formarono grandi Stati monarchici a base dinastica (Francia, Inghilterra, Spagna),
impegnati in costanti conflitti per l’egemonia sull’Europa.
Proprio la guerra rappresentò il principale stimolo a rafforzare all’interno il potere del sovrano,
che divenne l’agente principale di un lungo processo di razionalizzazione politica, basato sulla
costruzione di eserciti permanenti e di solidi apparati burocratici, capaci di drenare le risorse
necessarie allo sforzo bellico, sull’affermazione del primato della giustizia statale e sul
disciplinamento della nobiltà. Tale processo comportò anche un consistente aumento della tassa-
zione, che sempre più fu imposta senza il consenso dei ceti e gruppi sociali (in primo luogo la
nobiltà e il clero), ai quali era riconosciuto il diritto di consentire all’imposta, attraverso le loro
assemblee rappresentative (parlamenti e assemblee di Stati)
questa prima fase del superamento del tradizionale «Stato per ceti» successe, tra il 16° e il 17°
sec., una seconda fase della costruzione dello S.m., contraddistinta dalla progressiva
neutralizzazione dei conflitti religiosi apertisi con la riforma protestante e dall’affermazione di una
teoria e una pratica di governo (➔ assolutismo), che affermavano l’assoluta libertà del sovrano da
istanze politiche superiori o inferiori e relizzavano un crescente intervento della burocrazia statale
sulla realtà dei singoli Stati.
Crisi---> sbocco democratico/totalitario (novecento)
lungo periodo Pagina 1
date
mercoledì 12 gennaio 2022 12:00
fondata alla fine del XVII secolo dallo storico tedesco Christoph Keller, il quale trasferì
nella storiografia
una periodizzazione nata in età umanistica in ambito letterario, ma caricata di una
valenza religiosa. Per
Keller, l'età moderna non fu altro che la storia della rigenerazione spirituale dell'Europa
data dalla
Riforma protestante. La storiografia successiva ha mantenuto questo schema,
alternando epoche di
decadenza ed epoche di rinascita (es. Controriforma-Illuminismo / Restaurazione-
Risorgimento).
2.3: ALCUNE PROPOSTE DI PERIODIZZAZIONE: QUANDO INIZIA E QUANDO
FINISCE L'ETA' MODERNA?
Inizio:
•1453: caduta di Costantinopoli e fine dell'Impero romano d'Oriente; avanzata islamica
nel
Mediterraneo; esodo degli intellettuali greci in Italia e inizio dell'Umanesimo greco.
Ipotesi
fortemente eurocentrica o occidocentrica.
•1492: scoperta del Nuovo Mondo americano che potremmo considerare come l'inizio
del mondo
"globalizzato", con il conseguente allargamento degli orizzonti geografici ed economici
e
straordinaria espansione della civiltà europea. Data della definitiva conquista del
Califfato di
Cordova e Granada da parte del re cattolico Ferdinando d'Aragona e conseguente
cacciata
prima di musulmani e poi di ebrei.
•1517: data dell'affissione delle 95 tesi di Martin Lutero sulla cattedrale di Wittemberg.
Fine:
•1789: scoppio della Rivoluzione francese che pone fine all'Antico Regime e quindi alla
fine
dell'età moderna e inizio di quella contemporanea.
•1815: in Italia si preferisce questa data che corrisponde all'inizio del periodo della
Restaurazione
e che fa rientrare nell'età moderna sia la Rivoluzione francese che l'età napoleonica.
•1848: grandi rivoluzioni europee e l'emergere del movimento socialista (con Karl Marx)
da un
lato e dei partiti liberali dall'altro.
•1861: alcuni storici italiani indicano in quest'anno che corrisponde alla nascita del
Regno d'Italia,
la vera fine dell'Antico Regime per la penisola.
•1870: fine del potere temporale dei papi e completamento dell'unità d'Italia; guerra
franco-
lungo periodo Pagina 2
franco-
prussiana; caduta di Napoleone III; proclamazione della Terza Repubblica di Francia e
tragica
esperienza della Comune di Parigi
Da <https://www.studocu.com/it/document/universita-degli-studi-di-verona/storia-moderna/riassunto-manuale-la-societa-di-antico-regime-xvi-xviii-secolo-temi-e-problemi-
storiografici/6342298>
lungo periodo Pagina 3
Potrebbero piacerti anche
- Giuseppe Mazzini nel Risorgimento italiano. Pensiero/azione/educazione/politicaDa EverandGiuseppe Mazzini nel Risorgimento italiano. Pensiero/azione/educazione/politicaNessuna valutazione finora
- Tra 700 e 800Documento23 pagineTra 700 e 800samiha gasmiNessuna valutazione finora
- Breve Storia del Cristianesimo Medievale: da Roma a WittenbergDa EverandBreve Storia del Cristianesimo Medievale: da Roma a WittenbergNessuna valutazione finora
- Storia contemporanea facile: attraverso mappe concettuali, schemi e riassuntiDa EverandStoria contemporanea facile: attraverso mappe concettuali, schemi e riassuntiNessuna valutazione finora
- Umanesimo e RinascimentoDocumento3 pagineUmanesimo e RinascimentoandreafrigauNessuna valutazione finora
- Storia ModernaDocumento335 pagineStoria ModernaAlessia RussoNessuna valutazione finora
- La libertà religiosa in Messico: Dalla rivoluzione alle sfide dell’attualitàDa EverandLa libertà religiosa in Messico: Dalla rivoluzione alle sfide dell’attualitàNessuna valutazione finora
- Italiano Autori VariDocumento20 pagineItaliano Autori Varifrancesca bonifacioNessuna valutazione finora
- La forza della necessità: Antologia del radicalismo inglese dei secoli XVIII e XIXDa EverandLa forza della necessità: Antologia del radicalismo inglese dei secoli XVIII e XIXNessuna valutazione finora
- La "Comune" di Parigi. Otto conferenze: Raccolta di otto conferenzeDa EverandLa "Comune" di Parigi. Otto conferenze: Raccolta di otto conferenzeNessuna valutazione finora
- Storia ModernaDocumento49 pagineStoria Modernamartaa.gardinNessuna valutazione finora
- Umanesimo e Rinascimento in Italia/ Le Grandi Potenze Del XVI SecoloDocumento4 pagineUmanesimo e Rinascimento in Italia/ Le Grandi Potenze Del XVI SecoloAlessandroPinnaNessuna valutazione finora
- L'umanesimo e Il RinascimentoDocumento2 pagineL'umanesimo e Il RinascimentoRoberto Leonardo RusenNessuna valutazione finora
- Restaurazione e Rivoluzioni 1815-1848Documento16 pagineRestaurazione e Rivoluzioni 1815-1848w2pt274k2gNessuna valutazione finora
- 800 ItalianoDocumento5 pagine800 Italiano6fzwqdyxy7Nessuna valutazione finora
- Il XVI Secolo: Umanesimo, Rinascimento e Carlo VDocumento2 pagineIl XVI Secolo: Umanesimo, Rinascimento e Carlo VDavideBordigoni100% (1)
- Capitolo 10Documento5 pagineCapitolo 10linda.dececco09Nessuna valutazione finora
- Teologia dell'insurrezione: Thomas Müntzer e la guerra dei contadini: una rivolta di popolo nel cuore dell’Europa ModernaDa EverandTeologia dell'insurrezione: Thomas Müntzer e la guerra dei contadini: una rivolta di popolo nel cuore dell’Europa ModernaNessuna valutazione finora
- Rinascimento, Umanesimo e Le Grandi Potenze Del XVI SecoloDocumento3 pagineRinascimento, Umanesimo e Le Grandi Potenze Del XVI SecoloSaraMiliaNessuna valutazione finora
- Storia Dello Stato ModernoDocumento19 pagineStoria Dello Stato ModernoAntonio SantoroNessuna valutazione finora
- Storia ModernaDocumento8 pagineStoria Modernamcbelsito06Nessuna valutazione finora
- Riassunto: Dalla Restaurazione All'unificazione Italiana e TedescaDocumento9 pagineRiassunto: Dalla Restaurazione All'unificazione Italiana e TedescaGianfranco Marini100% (1)
- I Moti Del '20 e Del '30Documento10 pagineI Moti Del '20 e Del '30Giulia CostaNessuna valutazione finora
- La Guerra Dei 30 AnniDocumento3 pagineLa Guerra Dei 30 Annimariavittoriaminini06Nessuna valutazione finora
- Riassunto Formigoni Storia InternazionaleDocumento52 pagineRiassunto Formigoni Storia InternazionalefedemmerolaNessuna valutazione finora
- Hilaire BellocDocumento4 pagineHilaire BellocHistorica VariaNessuna valutazione finora
- La Controriforma Di Elena BonoraDocumento16 pagineLa Controriforma Di Elena BonoraShaco TheReaperNessuna valutazione finora
- Il 700 PDFDocumento33 pagineIl 700 PDFGiulio Lo BelloNessuna valutazione finora
- Dalla Restaurazione all’avvento del Fascismo e del NazismoDa EverandDalla Restaurazione all’avvento del Fascismo e del NazismoNessuna valutazione finora
- Interrogazione Storia Restaurazione PDFDocumento5 pagineInterrogazione Storia Restaurazione PDFFoxyNessuna valutazione finora
- L'Educazione Fisica e lo Sport nel Pensiero RinascimentaleDa EverandL'Educazione Fisica e lo Sport nel Pensiero RinascimentaleNessuna valutazione finora
- Controstoria del franchismo: Fatti, retroscena e scomode verità sul regime del CaudilloDa EverandControstoria del franchismo: Fatti, retroscena e scomode verità sul regime del CaudilloNessuna valutazione finora
- I Moti Del 30Documento2 pagineI Moti Del 30imanNessuna valutazione finora
- RinascimentoDocumento4 pagineRinascimentoSinartNessuna valutazione finora
- La vita Italiana nel Cinquecento: Conferenze tenute a Firenze nel 1893Da EverandLa vita Italiana nel Cinquecento: Conferenze tenute a Firenze nel 1893Nessuna valutazione finora
- Scritto Appunti + Libro 1Documento15 pagineScritto Appunti + Libro 1Enrico SbaragliaNessuna valutazione finora
- Eta Napoleonica PDFDocumento8 pagineEta Napoleonica PDFPepe AlessandroNessuna valutazione finora
- Turchia 2Documento11 pagineTurchia 2Ale MelliNessuna valutazione finora
- Storia MedievaleDocumento58 pagineStoria MedievaleFabrizio GabbaniniNessuna valutazione finora
- L'Occidente MedievaleDocumento5 pagineL'Occidente MedievaleMatteoAngioniNessuna valutazione finora
- Rivoluzione IndustrilDocumento4 pagineRivoluzione Industrilranieri.lorenzo2006Nessuna valutazione finora
- Cavazza Storia ContemporaneaDocumento80 pagineCavazza Storia ContemporaneaImma PezzulloNessuna valutazione finora
- Rapporti tra Stato e Chiesa. La revisione del 1984Da EverandRapporti tra Stato e Chiesa. La revisione del 1984Nessuna valutazione finora
- Dalla Restaurazione Austriaca Alla Spedizione Dei 1000Documento3 pagineDalla Restaurazione Austriaca Alla Spedizione Dei 1000giannibarabba310106Nessuna valutazione finora
- Uomini, popoli e giustizia: Dall’Europa di Versailles all’Unione Europea e oltre. Diplomazia, guerre e politica nell’arco di un secolo, 1919-2019Da EverandUomini, popoli e giustizia: Dall’Europa di Versailles all’Unione Europea e oltre. Diplomazia, guerre e politica nell’arco di un secolo, 1919-2019Nessuna valutazione finora
- MACHIAVELLIDocumento9 pagineMACHIAVELLIGaia VerduraNessuna valutazione finora
- Il Primo SeicentoDocumento4 pagineIl Primo SeicentoElisabetta RoccaNessuna valutazione finora
- La Rivoluzione Francese (Obiettivi Minimi)Documento2 pagineLa Rivoluzione Francese (Obiettivi Minimi)Nakedsoul ArNessuna valutazione finora
- Appunti Di Storia Della Filosofia Politica (Acocella) PDFDocumento35 pagineAppunti Di Storia Della Filosofia Politica (Acocella) PDFDario CositoreNessuna valutazione finora
- Filosofia Analitica PraticaDocumento3 pagineFilosofia Analitica PraticaAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Storia Moderna DateDocumento39 pagineStoria Moderna DateAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- ModalsDocumento4 pagineModalsAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Mappa StoriaDocumento1 paginaMappa StoriaAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Sociologia Dei New MediaDocumento41 pagineSociologia Dei New MediaAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Fonti Del DirittoDocumento2 pagineFonti Del DirittoAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- ArticlesDocumento2 pagineArticlesAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- ParlamentoDocumento4 pagineParlamentoAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Articolo 2Documento2 pagineArticolo 2Anna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Moby DickDocumento2 pagineMoby DickAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Whiteness of The WhaleDocumento3 pagineWhiteness of The WhaleAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Chinese SchoolDocumento3 pagineChinese SchoolAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Chinese Words LoveDocumento1 paginaChinese Words LoveAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Chinese Words-MaoDocumento2 pagineChinese Words-MaoAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- RomanticismoDocumento15 pagineRomanticismoAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Post MaoistaDocumento2 paginePost MaoistaAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Epoca MaoistaDocumento2 pagineEpoca MaoistaAnna Pia RuoccoNessuna valutazione finora
- Appunti Sui LongobardiDocumento70 pagineAppunti Sui LongobardiEttore D'AscenziNessuna valutazione finora
- Enrico VIII e Le Sue Sei MogliDocumento2 pagineEnrico VIII e Le Sue Sei MogliRosario BuscemaNessuna valutazione finora
- IMPERATORI Del Sacro Romano Impero (800-1439)Documento2 pagineIMPERATORI Del Sacro Romano Impero (800-1439)Luciano CataliotoNessuna valutazione finora
- Focus Storia Collection - Primavera 2016Documento148 pagineFocus Storia Collection - Primavera 2016edmondo dantini100% (1)
- Scienza Politica Sbobbina Del Libro CaramaniDocumento21 pagineScienza Politica Sbobbina Del Libro Caramanisara manciniNessuna valutazione finora
- Storia-Moderna Dall' OlioDocumento19 pagineStoria-Moderna Dall' OlioGreta GentileNessuna valutazione finora
- Françoise-Athénaïs Di MontespanDocumento8 pagineFrançoise-Athénaïs Di MontespanKevinSpacey77Nessuna valutazione finora
- (D&D 3.0 ITA) Accessorio - Atlante GreyhawkDocumento36 pagine(D&D 3.0 ITA) Accessorio - Atlante GreyhawkLunetta Mello Riccioni100% (2)
- All 1 Francia 600 e Stato AssolutoDocumento9 pagineAll 1 Francia 600 e Stato AssolutoGiovanni PorcedduNessuna valutazione finora
- Albero Genealogico Della Real Casa Di Borbone Della Due SicilieDocumento1 paginaAlbero Genealogico Della Real Casa Di Borbone Della Due SicilieavivenzioNessuna valutazione finora
- Salvo Mastellone - Storia Della Democrazia in EuropaDocumento70 pagineSalvo Mastellone - Storia Della Democrazia in EuropaThomas TosiNessuna valutazione finora