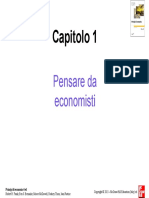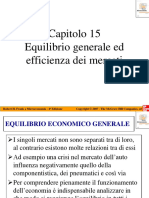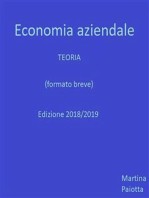Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Principi Di Economia Mankiw Taylor
Caricato da
BeatriceTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Principi Di Economia Mankiw Taylor
Caricato da
BeatriceCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|5870648
PRINCIPI DI ECONOMIA – N.G. MANKIW E M.P. TAYLOR
CAPITOLO 1: I DIECI PRINCIPI DELL’ECONOMIA
La parola economia vuol dire “chi si occupa della famiglia”: famiglie e sistemi economici hanno
molte cose in comune, per esempio, ogni famiglia deve allocare risorse scarse tra i propri membri,
tenendo conto di capacità, impegno e desideri di ciascuno. Così come le famiglie, anche le società
deve prendere molte decisioni: gestire le risorse è importante perché le risorse sono scarse. Scarsità
vuol dire che la società dispone di risorse limitate e non può produrre tutti i beni e i servizi che i
suoi membri desidererebbero. Proprio come in una famiglia nessuno ha sempre esattamente ciò che
desidera, in una società non si può garantire a ciascuno il massimo tenore di vita a cui aspira. L’eco-
nomia, quindi, studia i modi in cui la società gestisce le proprie risorse scarse. Lo studio dell’econo-
mia presenta sfaccettature diverse, ma tutte accumunate da alcuni concetti fondamentali. Poiché il
comportamento di un’economia riflette il comportamento degli individui che la compongono, il
nostro studio dell’economia parte dai quattro principi che regolano le decisioni individuali:
• Principio 1 – gli individui devono scegliere tra alternative (trade-off): per ottenere qualcosa che
piace, di solito si deve rinunciare a qualcos’altro. Prendere decisioni significa scegliere fra
alternative. Un trade-off molto importante che la società deve affrontare è quello tra efficienza e
equità: efficienza è ciò che permette alla società di ottenere il massimo risultato possibile, date
le risorse scarse di cui si dispone mentre, l’equità, è ciò che le permette di ripartire tra i propri
membri, secondo giustizia, i benefici che derivano dall’uso di tali risorse. Riconoscere che gli
individui devono scegliere tra alternative non basta, in sé, a stabilire quali decisioni essi
vogliano o debbano scegliere: riconoscere i trade-off della vita è importante perché è più facile
prendere le decisioni giuste se si sanno comprendere le alternative con cui ci si confronta
• Principio 2 – il costo di qualcosa è ciò a cui si deve rinunciare per ottenerlo: dovendo fronteg-
giare dei trade-off, per prendere decisioni corrette gli individui sono chiamati a confrontare i
costi e i benefici di comportamento alternativi. Il costo-opportunità di un bene è ciò a cui si deve
rinunciare per ottenerlo: nel prendere qualunque decisione si deve sempre considerare il costo-
opportunità delle alternative a disposizione
• Principio 3 – gli individui razionali pensano “al margine”: per descrivere le variazioni
incrementali rispetto a un piano d’azione già definito, gli economisti usano il termine variazioni
marginali, in questo caso margine vuol dire “limite”, per cui le variazioni marginali sono ag-
giustamenti al limite. Gli individui e le imprese possono prendere decisioni migliori pensando al
margine: chi decide razionalmente intraprende un’azione se, e solo se, il beneficio marginale
che ne trae è maggiore del costo marginale che sostiene
• Principio 4 – gli individui rispondono agli incentivi: dato che gli individui prendono decisioni
sulla base di costi e benefici, il loro comportamento cambia se questi ultimi si modificano, ciò
significa che gli individui rispondono agli incentivi
I prossimi principi riguardano, invece, l’interazione tra individui:
• Principio 5 – lo scambio può essere vantaggioso per tutti
• Principio 6 – i mercati sono di solito uno strumento efficace per organizzare l’attività econo-
mica: in un’economia di mercato alle decisioni dei pianificatori si sostituiscono le decisioni di
milioni di individui e di imprese: le economie di mercato hanno dimostrato la propria efficacia
nell’organizzare l’attività economica in modo da promuovere il benessere economico generale
• Principio 7 – a volte l’intervento dello Stato può migliorare il risultato prodotto dal mercato:
sono due le ragioni per cui lo Stato può intervenire nell’economia: per promuovere l’efficienza e
per promuovere l’equità. La mano invisibile di solito porta il mercato ad allocare le risorse in
maniera efficiente, ma in determinate situazioni non riesce a farlo. Per indicare tali situazioni,
gli economisti usano il termine fallimento di mercato. Una possibile causa di fallimento di
mercato sono le esternalità, cioè gli effetti non compensati dell'azione di un individuo sul benes-
sere di un altro individuo non direttamente coinvolto. Un’altra possibile causa di fallimento del
mercato è il potere di mercato, ovvero la capacità di un soggetto di influenzare sostanzialmente
indebitamente i prezzi di mercato. Affermare che lo Stato possa a volte migliorare i risultati di
mercato non significa essere certi che sia sempre in grado di farlo
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Gli ultimi tre principi riguardano il funzionamento dei sistemi economici nel loro complesso. Uno
dei concetti chiave è quello di crescita economica, ovvero l’aumento percentuale della quantità di
beni e servizi prodotta in un dato periodo di tempo, di solito corrispondente a un trimestre o
all’anno solare:
• Principio 8 – il tenore di vita di un paese dipende dalla sua capacità di produrre beni e servizi:
come si possono giustificare i divari così ampi nel tenore di vita di paesi diversi e in diversi
momenti sociali? Quasi tutti questi divari sono dovuti a differenze di produttività, cioè dalla
quantità di beni e servizi prodotti da un individuo nell’unità di tempo (generalmente un’ora).
Nei paesi dove il singolo lavoratore riesce a produrre grandi quantità di beni e di servizi per
unità di tempo, la maggior parte della popolazione gode di un tenore di vita elevato; nei paesi
dove i lavoratori sono meno produttivi, la maggior parte dei cittadini conduce un'esistenza più
misera. Analogamente, il tasso di crescita della produttività di un paese determina il tasso di
crescita sul suo reddito medio
• Principio 9 – i prezzi aumentano quando lo Stato stampa troppa moneta: l'inflazione è la crescita
del livello generale dei prezzi in un sistema economico. Ma, da cosa è provocata l'inflazione?
Nella maggior parte dei casi di inflazione elevata o permanente, il colpevole è sempre lo stesso:
la crescita della quantità di moneta. Se lo Stato stampa quantità eccessiva di moneta, il valore di
questa è destinato a crollare
• Principio 10 – nel breve periodo i sistemi economici si confrontano con un trade-off tra inflazio-
ne e disoccupazione: quando un governo aumenta la quantità di moneta presente nell’economia,
uno dei risultati che ottiene è l’inflazione. Un altro risultato, almeno nel breve periodo, è un più
basso livello di disoccupazione. La curva che descrive il trade-off di breve periodo fra inflazio-
ne e disoccupazione è detta curva di Phillips. In un periodo di uno o due anni, molti provve-
dimenti di politica economica spingono l'inflazione e la disoccupazione in direzioni opposte. I
responsabili della politica economica devono misurarsi con questo trade-off indipendentemente
dal fatto che il livello di partenza dell’inflazione e della disoccupazione siano elevati, contenuti
o a un qualunque livello intermedio. Il trade-off fra inflazione e disoccupazione è solo tempora-
neo, ma può durare per svariati anni. La curva di Phillips è rilevante per l'analisi del ciclo eco-
nomico: le fluttuazioni tanto marcate quanto imprevedibili dell'attività economica, misurata dal
numero degli occupati o della produzione di beni e servizi.
CAPITOLO 2: PENSARE DA ECONOMISTA
L’interazione tra teoria e osservazione esiste anche in economia. Gli economisti formulano teorie e
le sottopongo a verifica come fanno tutti gli altri scienziati, ma devono fare i conti con un ostacolo
che rende loro lavoro particolarmente delicato: la difficoltà della sperimentazione in campo econo-
mico. Gli economisti, in generale, devono accontentarsi dei dati che il mondo mettere a loro dispo-
sizione. Non potendo sperimentare in laboratorio, gli economisti dedicano molta attenzione agli
esperimenti naturali offerti dalla storia. Gli economisti ricorrono a modelli per descrivere il mondo:
i loro modelli sono composti da grafici ed equazioni. Un’altra analogia utile, quando si pensa al
ruolo delle ipotesi nei modelli economici, è quella delle mappe. Le mappe sono rappresentazioni in
scala ridotta del mondo e, come tali, omettono alcuni dettagli del mondo reale. Ma come si decide
cosa includere in una mappa e cosa escludere? La risposa dipende dall’uso al quale la mappa è des-
tinata. Per capire al meglio il funzionamento di un sistema economico abbiamo bisogno di un
modello che spieghi com’è organizzato il sistema economico e come i soggetti che partecipano
all’economia interagiscono fra loro. Uno dei modelli del sistema economico è il diagramma di
flusso circolare, secondo il quale, nel sistema economico agiscono due tipi di soggetti: individui ed
imprese. Le imprese producono beni e servizi utilizzando elementi quali il lavoro, la terra e il capi-
tale detti fattori di produzione. Gli individui sono i proprietari dei fattori di produzione e consuma-
no tutti i beni e i servizi prodotti dalle imprese. Imprese e individui interagiscono in due tipi di
mercati. Nei mercati di beni e servizi gli individui sono i compratori e le imprese i venditori; nei
mercati dei fattori di produzione gli individui sono i venditori e le imprese i compratori. Il dia-
gramma di flusso circolare descrive in maniera semplice l’organizzazione di tutte le transazioni che
intercorrono tra individui e imprese in un sistema economico.
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
L’anello interno del diagramma di flus-
so circolare rappresenta il flusso dei be-
ni e dei fattori di produzione tra indivi-
dui e imprese: gli individui offrono alle
imprese l’uso della terra, del lavoro e
del capitale nel mercato dei fattori di
produzione; le imprese, a loro volta, uti-
lizzano questi fattori per produrre beni e
servizi, che vengono venduti agli indi-
vidui nel mercato dei beni e dei servizi.
Dunque i fattori di produzione fluiscono
dagli individui alle imprese, mentre beni
e servizi fluiscono dalle imprese agli
individui. L’anello esterno del diagram-
ma del flusso circolare rappresenta il
corrispondente flusso di moneta: gli
individui spendono denaro per acqui-
stare beni e servizi dalle imprese; queste utilizzano parte del ricavo per acquistare fattori di produ-
zione; ciò che rimane è il profitto, distribuito ai proprietari delle imprese, che sono a loro volta indi-
vidui. Quindi la spesa per l’acquisto di beni e servizi fluisce dagli individui alle imprese, mentre il
reddito – in forma di salari, rendite e profitti – fluisce dalle imprese agli individui. Un diagramma di
flusso circolare più realistico dovrebbe includere il ruolo dello Stato e il commercio internazionale.
Grazie alla sua semplicità, questo modello è particolarmente utile per descrivere sinteticamente i
rapporti e le relazioni tra le carie componenti dell’economia.
Diversamente dal diagramma di flusso circolare, la maggior parte dei modelli economici fa ricorso
a strumenti matematici. La frontiera delle possibilità di produzione è un grafico nel quale si
mostrano le possibili combinazioni di due beni che il sistema può produrre dati i fattori di produzio-
ne disponibili e lo stato della tecnologia
utilizzabile per trasformare le risorse in
beni di consumo. Nel sistema descritto,
se tutte le risorse disponibili venissero
utilizzate dall’industria che produce il
bene 1, si potrebbero produrre 1000
unità del bene 1 e nessuna unità del be-
ne 2; se tutte le risorse venissero impie-
gate nell’industria del bene 2, si otter-
rebbero 3000 unità del bene 2 e nessuna
unità del bene 1. i punti in cui la curva
incontra gli assi cartesiani rappresenta-
no queste due possibilità estreme. Se
l’economia dovesse ripartire le proprie
risorse fra questi due beni, si potrebbe
produrre un quantitativo medio
rappresentato dal punto A. Il risultato
presentato dal punto D, invece, non è
raggiungibile perché le risorse sono scarse: l’economia non dispone di fattori di produzione a suf-
ficienza per sostenere quel livello di produzione. In altre parole, il sistema economico può raggi-
ungere qualunque combinazione dei due beni che si trovi lungo la frontiera delle possibilità di pro-
duzione (come i punti A e C) o al suo interno, ma non può produrre combinazioni che si trovano
all’esterno della frontiera. Una combinazione di produzione è detta efficiente se il sistema sfrutta
completamente e nel migliore dei modi le risorse disponibili. I punti che si trovano esattamente sul-
la frontiera delle possibilità di produzione rappresentano livelli di produzione efficiente. Quando
l’economia si trova in uno di tali punti non c’è modo di produrre una quantità maggiore di un bene
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
se non riducendo la quantità prodotta dell’altro. Il punto B rappresenta, invece, una combinazione di
produzione inefficiente.
L’economia può essere studiata a diversi livelli, infatti, a partire dagli ani 1930, l’economia è stata
suddivisa in due discipline: la microeconomia è lo studio dei processi decisionali dei singoli attori
economici (imprese e individui) e della loro interazione in particolari mercati e la macroeconomia
ovvero lo studio dei fenomeni che riguardano il sistema economico nel suo complesso. Microecono-
mia e macroeconomia sono strettamente correlate. I cambiamenti del sistema economico sono gene-
rati dalle decisioni di milioni di singoli attori economici; è quindi impossibile affrontare un’analisi
macroeconomica se non si sono compresi a fondo i processi microeconomici soggiacenti. Nono-
stante i legami impliciti che le unisono, la macroeconomia e la microeconomia sono due discipline
distinte. L’economista ricopre diversi “ruoli”: quando un economista cerca di spiegare il mondo, è
uno scienziato mentre, quando cerca di migliorarlo, diventa un consigliere politico. Avendo obietti-
vi diversi, scienziati e consulenti politici devono utilizzare il linguaggio in modo diverso. In termini
generali ogni affermazione rientra in due diverse categorie. La prima è un’affermazione positiva che
descrive e cerca di spiegare il mondo com’è mentre, la seconda, è un’affermazione normativa che
ha carattere prescrittivo e cerca di spiegare il mondo come dovrebbe essere. Una differenza fonda-
mentale tra le affermazioni positive e normative è il criterio che si deve usare per comprovarne la
validità. In linea di principio possiamo confermare o confutare un’affermazione positiva esamina-
ndo i dati empirici; la valutazione di un’affermazione normativa, invece, si basa non solo sui fatti
ma anche sui valori. Naturalmente, le affermazioni positive e quelle normative possono essere stret-
tamente collegate. Gli economisti, come categoria, sono spesso criticati per la contraddittorietà dei
consigli che danno ai governanti; le ragioni fondamentali sono due:
1. gli economisti possono essere in disaccordo sulla validità delle diverse teorie positive che
spiegano il funzionamento del sistema economico
2. economisti diversi possono avere valori differenti e, perciò, assumere posizioni normative
diverse su ciò che i governanti dovrebbero fare
Possiamo affermare che l’economia è la scienza dei processi decisionali. Gli economisti formulano
decisioni in un modo molto particolare. Inizialmente cercano di identificare il problema o la questi-
one legata alla decisione. La fase successiva consiste nell’esaminare i costi e i benefici della decisi-
one che, oltre ai costi e ai benefici privati per l’individuo interessato, includono anche i costi e i be-
nefici per le terze parti non direttamente coinvolte nella decisione. Avendo individuato costi e bene-
fici, l’economia cerca quindi di attribuire loro un valore, in modo da farsi un’idea del rapporto fra
costi e i benefici connessi con la decisione. Una volta calcolata la somma di costi e benefici, la
scelta diventa più chiara: se i costi eccedono i benefici, non è una decisione saggia ma, se i costi
sono inferiori ai benefici, può essere giustificato intraprenderla. Tuttavia, i responsabili della poli-
tica economica potrebbero voler stabilire in che misura i costi eccedono i benefici o viceversa.
CAPITOLO 3: INTERDIPENDENZA E BENEFICI DELLO SCAMBIO
Gli economisti usano il termine vantaggio assoluto quando mettono a confronto la produttività di
una persona, impresa o nazione con quella di un’altra. Chi impegna quantità inferiori di fattori nella
produzione di un bene ha un vantaggio assoluto nella produzione di quel bene. Si può determinare il
costo di produzione di un bene seguendo anche un altro percorso: invece di mettere a confronto i
fattori impiegati, possiamo comparare il costo-opportunità dei due beni. Il costo-opportunità misura
il trade-off tra le due produzioni. Gli economisti usano il termine vantaggio comparato per definire
il rapporto tra i costi-opportunità di due produttori. Il produttore che deve rinunciare a una minore
quantità di altri beni per produrre una unità aggiuntiva del bene X sostiene il minor costo-opportuni-
tà nel produrre il bene X e dunque gode di un vantaggio comparato nella produzione del bene X.
Mentre è possibile che un solo individuo goda di un vantaggio assoluto nella produzione di entra-
mbi i beni, è invece impossibile che un individuo abbia un vantaggio comparato in entrambi; infatti
il costo-opportunità di un bene è il reciproco di quello dell’altro e, quindi, se uno è basso in termini
relativi, l’altro non potrà che essere alto, sempre in termini relativi. Il vantaggio comparato riflette il
costo-opportunità relativo: a meno che i due individui non abbiano identici costi-opportunità, il
primo godrà di un vantaggio comparato nella produzione di un bene, il secondo nella produzione
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
dell’altro. Le differenze di costo-opportunità e di vantaggio comparato generano i benefici dello
scambio. Quando ogni individuo si specializza nella produzione del bene in cui gode di un vantag-
gio comparato, la produzione totale dell’economia cresce. In altre parole, nella misura in cui due
soggetti hanno un diverso costo-opportunità, ciascuno di loro può trarre beneficio dallo scambio,
ottenendo un bene a un prezzo inferiore al proprio costo-opportunità di quel bene. In altre parole, gli
scambi apportano benefici a tutte le parti in causa, perché permettono a ciascuno di specializzarsi
nelle attività in cui gode di un vantaggio comparato.
Anche le popolazioni di nazioni diverse possono trarre beneficio dallo scambio. Molti dei beni che i
cittadini italiani consumano sono prodotti all’estero e molti dei beni prodotti in Italia vengono ven-
duti all’estero. I beni prodotti all’estero e venduti nel nostro paese sono denominati importazioni
mentre, quelli prodotti internamente e venduti all’estero sono detti esportazioni.
CAPITOLO 4: LE FORZE DI MERCATO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
La domanda e l’offerta sono le forze che fanno funzionare le economie di mercato, che determinano
la quantità venduta di ciascun bene e il relativo prezzo di vendita. I termini domande e offerta si
riferiscono al comportamento di individui che interagiscono in un mercato: un mercato è l’insieme
dei venditori e dei compratori di un determinato bene o servizio; il gruppo dei compratori determina
la domanda, quello dei venditori stabilisce l’offerta.
La maggio parte dei mercati che compongono un sistema economico sono fortemente
concorrenziali. Un mercato concorrenziale è un mercato nel quale operano molti compratori e
venditori, sicché ciascuno di loro ha un impatto irrilevante sul prezzo di mercato: il venditore non
controlla il prezzo, poiché altri venditori offrono un prodotto analogo al suo, inoltre, ha scarso
interesse ad applicare un prezzo inferiore a quello corrente e, se applica un prezzo superiore, i
compratori fanno i loro acquisti altrove. I mercati in concorrenza perfetta sono identificabili da due
caratteristiche fondamentali:
1. i prodotti offerti in vendita sono uguali gli uni dagli altri e, di conseguenza, i compratori non
hanno preferenza per un venditore o per l’altro e
2. compratori e venditori sono talmente numerosi da non poter influenzare singolarmente il prezzo
di mercato
Non tutti i beni e i servizi, però, si scambiano in mercati perfettamente concorrenziali. In alcuni è
presente un solo venditore che, di conseguenza, può determinare il prezzo del proprio prodotto: tale
mercato viene detto monopolio. Alcuni mercati, invece, rientrano fra i due estremi della concorrenza
perfetta e del monopolio: in una di queste forme di mercato, detta oligopolio, opera un numero
limitato di venditori che non sempre competono aggressivamente fra loro. Un altro tipo di mercato è
la concorrenza monopolistica, o concorrenza imperfetta, nel quale sono attivi numerosi venditori,
ciascuno dei quali offre un prodotto relativamente diverso da quelli di tutti gli altri. Dato che i
prodotti non sono esattamente identici, ciascun venditore, in una certa misura, ha la capacità di
stabilire il prezzo di ciò che vende.
Il punto di partenza del nostro studio dei mercati è il comportamento dei compratori. La quantità
domandata di un bene è la quantità di quel bene che i compratori vogliono e possono acquistare.
Dato che la quantità domandata aumenta se il prezzo diminuisce e diminuisce se il prezzo aumenta
(legge della domanda), si può affermare che la quantità domandata è inversamente correlata al
prezzo. Molto importante è la scheda di domanda ovvero una tabella nella quale si illustra in forma
numerica la relazione tra il prezzo di un bene e la quantità domandata, tenendo costanti tutti gli altri
elementi che possono influenzare la quantità di bene che l’individuo desidera acquistare. La retta
con pendenza negativa che mette il rapporto prezzo e quantità domandata è detta curva di domanda.
Per analizzare il funzionamento di un mercato, però, si deve determinare quella che è la domanda di
mercato che corrisponde alla somma di tutte le domande individuali di un dato bene o servizi. Per
ottenere la domanda di mercato, le curve di domanda individuali vengono sommate
orizzontalmente, ciò significa che, per trovare la quantità domandata complessivamente nel mercato
per ogni dato prezzo si sommano i corrispondenti valori riscontrati sull’asse delle ascisse delle
curve di domande individuali. Poiché siamo interessati ad analizzare il funzionamento del mercato,
nella maggior parti dei casi utilizzeremo curve di domanda di mercato. La curva di domanda di
mercato illustra come varia la quantità domandata totale di un bene al variare del prezzo del bene
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
stesso, a parità di tutti gli altri elementi che possono influenzare la quantità del bene che i
consumatori desiderano acquistare.
È importante fare una distinzione tra uno spostamento della curva di domanda e un movimento
lungo la curva di domanda. Uno spostamento della curva di domanda è provocato da un fattore che
influenza la domanda diverso da una variazione del prezzo. Uno spostamento della curva di
domanda è detto aumento o diminuzione della domanda. Un movimento lungo la domanda, invece,
si verifica a fronte di una variazione del prezzo e può essere determinato da un mutamento delle
condizioni dell’offerta, nell’ipotesi che i fattori che influenzano la domanda rimangano invariati.
Una variazione del prezzo comporta un movimento lungo le curva di domanda che viene detto
variazione della quantità di domanda. Qualsiasi cambiamento che faccia aumentare la quantità
domandata totale di un bene fa spostare la curva di domanda verso destra ed è detto espansione o
aumento della domanda. Qualsiasi cambiamento che faccia diminuire la quantità domandata totale
per ogni dato prezzo fa spostare verso sinistra la curva di domanda ed è detto contrazione o
riduzione della domanda. Sono molte le variabili che possono provocare spostamenti della curva di
domanda:
• il reddito: se il reddito diminuisce, gli
individui hanno meno capacità di spesa e,
probabilmente spendono meno per l’acquisto
di alcuni beni, se non di tutti, i beni. Se la
domanda di un bene diminuisce al diminuire
del reddito, si dice che il bene in questione è
un bene normale. Non tutti i beni, però, sono
normali. Se la domanda di un bene aumenta al
diminuire del reddito, ci troviamo di fronte e
un bene inferiore
• il prezzo di altri beni: quando la
diminuzione del prezzo di un bene
provoca una riduzione della domanda di
un altro bene si dice che i due beni sono
sostituti. I sostituti sono spesso coppie di
beni che vengono utilizzati in maniera
intercambiabile (hot dog/hamburger);
quanto più due beni sostituti sono strettamente correlati, tanto maggiore è l’effetto sulla domanda se
il prezzo dell’uno varia mentre quello dell’altro rimane inalterato. Quando la diminuzione di un
prezzo di un bene induce un aumento della domanda di un altro bene si dice che i due beni sono
complementari; i beni complementari sono spesso coppie di beni che vengono utilizzati insieme
(benzina/automobili)
• le preferenze
• le aspettative
• la dimensione e la struttura della popolazione: a parità di altre condizioni, una popolazione più
numerosa comporta una maggiore domanda di tutti i beni e i servizi. Anche i cambiamenti della
struttura demografica di una popolazione influenza la domanda (con più anziani aumento della
domanda su case di riposo, polizze assicurative)
Variabile Un cambiamento in questa variabile induce..
Prezzo Un movimento lungo la curva di domanda
Reddito Uno spostamento della curva di domanda
Prezzo di altri beni Uno spostamento della curva di domanda
Preferenze Uno spostamento della curva di domanda
Aspettative Uno spostamento della curva di domanda
Numero di compratori Uno spostamento della curva di domanda
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
La quantità offerta di un bene o di un servizio è la quantità che venditori vogliono e possono
vendere. Molte sono le determinanti della quantità offerta ma, anche in questo caso, il ruolo
principale è svolto dal prezzo. Dato che la quantità offerta aumenta all'aumentare del prezzo e
diminuisce al suo diminuire, diciamo che la quantità offerta è direttamente correlata al prezzo: la
relazione tra prezzo e quantità offerta è detta legge dell'offerta quindi, a parità di altre condizioni, se
il prezzo di un bene aumenta, aumenta anche la quantità offerta se il prezzo diminuisce, diminuisce
la quantità offerta. La scheda di offerta è una tabella che descrive in forma numerica la relazione tra
il prezzo del bene e la quantità offerta, mentre la curva che esprime la relazione tra un pezzo e
quantità offerta è detta curva di offerta: tale curva ha pendenza positiva poiché, a parità di altre
condizioni, a prezzi più elevati corrisponde una quantità offerta maggiore. L'offerta di mercato è la
somma delle offerte individuali di tutti i venditori. Bisogna, però, distinguere fra gli spostamenti
della curva di offerta e i movimenti lungo la curva di offerta. Uno spostamento della curva di offerta
è causato da un fattore che influenza l'offerta diverso da una variazione del prezzo; uno spostamento
della curva di offerta detto anche aumento o diminuzione dell’offerta. Un movimento lungo la curva
di offerta si verifica a fronte di una variazione del prezzo e può essere determinato dal mutamento
delle condizioni della domanda, nell'ipotesi che gli altri fattori che influenzano l'offerta rimangano
costanti; una variazione del prezzo porta movimento lungo la curva di offerta che viene descritto
come una variazione della quantità offerta.
Qualsiasi cambiamento che faccia
aumentare la quantità offerta per ogni
dato prezzo provoca uno spostamento
verso destra della curva di offerta ed è
chiamato espansione o aumento
dell'offerta. Analogamente, qualunque
cambiamento che faccia diminuire la
quantità offerta per ogni dato prezzo
provoca uno spostamento verso sinistra
della curva di offerta ed è detto
contrazione o diminuzione dell’offerta.
Sono molte le variabili che possono
provocare spostamenti della curva di
offerta:
• il prezzo dei fattori: se, per qualsiasi
ragione, il prezzo di fattori diminuisce,
la produzione diviene più redditizia e le
imprese hanno un incremento a offrire
una maggiore quantità ad ogni dato prezzo. Dunque, la quantità offerta di un bene è inversamente
correlata al prezzo dei fattori di produzione
• la tecnologia: i progressi tecnologici fanno aumentare la produttività permettendo di produrre una
maggiore quantità usando meno fattori di produzione; di conseguenza, sia il costo totale sia quello
unitario diminuiscono e l’offerta aumenta
• le aspettative: se ci si aspetta che il prezzo di un dato bene aumenti nel prossimo futuro,
probabilmente il venditore aumenterà fino da ora la produzione per immagazzinare una parte e
offrirla nel mercato in futuro a prezzi più elevati
• il numero dei venditori: l'offerta del mercato dipende anche dal numero di imprese nel settore
• fattori naturali e sociali
Variabile Un cambiamento di questa variabile induce...
Prezzo Un movimento lungo la curva di offerta
Prezzo dei fattori di produzione Uno spostamento della curva di offerta
Tecnologia Uno spostamento della curva di offerta
Aspettative Uno spostamento della curva di offerta
Numero di venditori Uno spostamento della curva di offerta
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
L'equilibrio si definisce come una condizione di stabilità, un punto nel quale non ci sono forze che
agiscono a favore di un cambiamento. Gli economisti si riferiscono a domanda e offerta come a
forze di mercato. In qualsiasi mercato la relazione tra domanda e offerta esercita una forza sul
prezzo; tuttavia c'è un punto in cui le due curve si intersecano: questo punto è detto di equilibrio. Il
prezzo corrispondente al punto di intersezione è il prezzo di equilibrio mentre la quantità
corrispondente è la quantità di equilibrio. Al prezzo di equilibrio, la quantità del bene che i
compratori vogliono e possono acquistare è esattamente uguale alla quantità del bene che i venditori
vogliono e possono vendere. Il prezzo di equilibrio viene a volte definito prezzo di mercato perché,
in corrispondenza di questo valore, tutti i soggetti attivi sul mercato sono soddisfatti.
Possiamo trovarci di fronte a
un’eccedenza, o surplus, del bene: i
venditori non sono in grado di vendere
quanto vorrebbero a quel dato livello di
prezzo. Tale situazione non è definita
eccesso di offerta: al diminuire del prezzo,
la quantità domandata aumenta e la
quantità offerta diminuisce. Il prezzo
continua a diminuire fino a quando il
prezzo di mercato raggiungerà il livello di
equilibrio. Ci possiamo trovare, poi, in
una situazione di penuria, o carenza, del
bene: i compratori non riescono ad
acquistare tutto il bene che vorrebbero.
Tale situazioni è definita eccesso di
domanda: con così tanti acquirenti e così
poco prodotto, i venditori hanno buon
gioco ad aumentare il prezzo senza
prevedere vendite. All'aumentare del prezzo, la quantità domandata diminuisce, la quantità offerta
aumenta e il mercato si porta ancora una volta verso l'equilibrio. Dunque, interazione di compratori
e venditori spinge automaticamente il prezzo di mercato verso il livello di equilibrio; una volta
raggiunto l'equilibrio, compratori e venditori sono soddisfatti e non esercitano pressioni sul prezzo
né a rialzo né a ribasso. Nella maggior parte dei mercati liberi, tuttavia, le situazioni di eccedenza o
di penuria sono temporanee perché i prezzi tendono naturalmente all'equilibrio. Nella realtà questo
fenomeno è talmente diffuso da essere noto come legge della domanda e dell'offerta. Il prezzo e la
quantità di equilibrio dipendono dalla posizione delle curve di offerta e di domanda: se si verifica
un evento che provoca uno spostamento di una delle due curve, il punto di equilibrio cambia.
L’analisi di questo cambiamento è detta statica comparata perché implica il confronto di due
situazioni stabili: un equilibrio iniziale e un nuovo equilibrio. Nell’analizzare l’effetto di un dato
evento sul mercato, si adotta una procedura in tre fasi:
1. dapprima si deve stabilire se l’evento provoca uno spostamento della curva di domanda, di
offerta o di entrambe
2. poi si deve individuare la direzione dello spostamento
3. infine, ricorrendo al grafico di domanda e offerta, si mettono a confronto il vecchio e il nuovo
equilibrio per stabilire come gli spostamenti influenzano prezzo e quantità di equilibrio
In questo caso, il termine offerta si riferisce alla posizione della curva, mentre la quantità offerta si
riferisce alla quantità che i venditori desiderano offrire. Uno spostamento della curva di offerta o
della curva di domanda è detto cambiamento di offerta o cambiamento della domanda; un
movimento lungo una curva di offerta viene definito variazione della quantità offerta o variazione
della quantità domandata.
Offerta invariata Offerta aumenta Offerta diminuisce
Domanda invariata P invariato P diminuisce P aumenta
Q invariata Q aumenta Q diminuisce
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Domanda aumenta P aumenta P ambiguo P aumenta
Q aumenta Q aumenta Q ambigua
Domanda diminuisce P diminuisce P diminuisce P ambiguo
Q diminuisce Q ambigua Q diminuisce
N.B. I prezzi come segnali
Le teorie sul funzionamento dei mercati si fondono in massima parte sull'ipotesi di comportamento
razionale, definito come preferenza per quantità maggiori rispetto a quantità minori. La principale
funzione del prezzo in un libero mercato è agire da segnale sia per i compratori sia per i venditori.
Ai compratori, il prezzo indicato ciò a cui si deve rinunciare per acquisire i benefici associati al
possesso di un bene o alla funzione di un servizio. Questi benefici sono spesso definiti come l'utilità
(soddisfazione) derivante dal consumo. A un prezzo più elevato corrisponde un sacrificio maggiore
in termini del valore dei benefici che si potrebbero tenere da scelte alternative, per cui l'individuo è
sempre meno propenso a compiere tale scelta. Nei confronti dei venditori, il prezzo agisce come
segnale in relazione alla redditività della produzione. Per la maggior parte dei venditori, aumentare
la produzione di un bene comporta un incremento dei costi; per coprire i costi aggiuntivi e per
remunerare il venditore per il rischio che si assume nelle decisioni di produzione è necessario che il
prezzo aumenti. Tale remunerazione del rischio è detta profitto. In un libero mercato, un aumento
dei prezzi invia ai venditori e ai compratori segnali diversi ma collegati. Al venditore l'aumento dei
prezzi indica che vi è una penuria del bene; vi è dunque un incentivo ad aumentare la produzione
perché il venditore sa di poter vendere tutto ciò che produce. Inoltre, all'aumentare del prezzo si
modifica la natura del trade-off con cui i compratori si confrontano: per ottenere il bene adesso si
devono fare maggiori rinunce e quindi bisogna decidere se il valore dei benefici che si traggono
dall'acquisto di quel bene vale il maggior pezzo che si deve pagare.
CAPITOLO 5: L’ELASTICITA’ E LE SUE APPLICAZIONI
L’elasticità misura la reattività di venditori e compratori alle variazioni delle condizioni di mercato
e permette di analizzare la domanda e l’offerta con maggiore precisione.
L’elasticità della domanda al prezzo misura la variazione della quantità domandata al variare del
prezzo. La domanda di un bene è elastica se la quantità domandata reagisce più che proporzional-
mente a variazioni del prezzo, mentre è anelastica se la reazione è meno che proporzionale.
Esistono alcune regole generali che determinano l’elasticità della domanda al prezzo:
• la disponibilità di beni sostituiti: beni che hanno buoni sostituti tendono ad avere una domanda
più elastica, perché per il consumatore è facile sostituirli con altri beni che soddisfano il
medesimo bisogno
• beni necessari e beni di lusso: i beni necessari tendono ad avere una domanda anelastica, quelli
di lusso una domanda elastica
• la definizione del mercato: l’elasticità della domanda in qualunque mercato dipende da come
sono tracciati i confini del mercato stesso: un mercato delimitato in maniera molto precisa tende
ad avere una domanda più elastica di uno i cui confini affondano nel vago, poiché è più facile
trovare sostituti per i beni specifici
• la porzione di reddito destinata all’acquisto del bene: alcuni prodotti hanno un prezzo
relativamente elevato e assorbono una porzione di reddito maggiore: quanto maggiore è la quota
destinata all’acquisto di un bene, tanto maggiore tende ad essere l’elasticità della domanda al
prezzo, in valore assoluto
• l’orizzonte temporale: la domanda di un dato bene tende ad essere più elastica nel lungo periodo
Gli economisti calcolano l’elasticità della domanda al prezzo come rapporto tra la variazione
percentuale della quantità domandata e la variazione percentuale del prezzo, cioè:
Variazione percentual e della quantità domandata
Elasticità della domanda = Variazione precentual e del prezzo
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Poiché la quantità domandata di un bene è negativamente correlata al prezzo, le variazioni percentu-
ali della quantità domandata hanno sempre segno opposto del prezzo.
Il metodo del punto medio calcola la percentuale dividendo la variazione per il punto medio tra il
livello iniziale è quello finale. Dato che il metodo del punto medio offre la medesima risposta
indipendentemente dalla direzione del cambiamento, vi si ricorre spesso per calcolare l’elasticità
della domanda al prezzo tra due punti. Possiamo esprimere il metodo del punto medio per il calcolo
dell'elettricità della domanda al prezzo tra due punti (Q1, P1) e (Q2, P2) con la seguente formula:
(Q 2 Q1) /[(Q 2 Q1) / 2]
Elasticità della domanda al prezzo =
( P 2 P1) /[( P 2 P1) / 2]
Il numeratore di questa espressione è la variazione percentuale della quantità domandata, calcolata
con il metodo del punto medio; il denominatore è la variazione percentuale del prezzo calcolata con
la medesima formula. La domanda è elastica quando il valore dell’elasticità è superiore a 1 e quindi
la variazione della quantità è più che proporzionale a quella del prezzo; la domanda è anelastica
quando il valore dell'elasticità è inferiore a 1, quindi la variazione della quantità è men che
proporzionale a quella del prezzo; se l’elasticità ha valore 1, la quantità reagisce nella medesima
proporzione del prezzo e si dice che la domanda ha elasticità unitaria. Si vanno ad illustrare
graficamente cinque casi. Nel caso estremo l'elasticità è 0, la domanda è perfettamente anelastica e
la curva di domanda è verticale: a qualsiasi prezzo, a quantità domandata rimane invariata.
All’aumentare del valore dell’elasticità la curva diventa progressivamente più piatta. All' estremo
opposto si trova il caso della domanda perfettamente elastica che si registra quando il valore
dell’elasticità al prezzo tende all’infinito, ovvero quando la curva di domanda è orizzontale e il
minimo cambiamento del prezzo può provocare variazioni incommensurabili della quantità
domandata.
Nello studiare cambiamenti della domanda e dell'offerta in un mercato, due delle variabili che
terremo in considerazione sono la spesa totale e ricavo totale, cioè l'ammontare complessivamente
pagato dei consumatori e incassato dai venditori del bene. In qualunque mercato il ricavato totale è
uguale a PxQ, ovvero al prodotto del prezzo al quale il bene è venduto per la quantità venduta del
bene. Analogamente, la spesa totale è data dalla quantità totale moltiplicata per il prezzo pagato.
Come varia la spesa totale muovendosi lungo la curva di domanda? La risposta dipende
dall’elasticità della domanda al prezzo: se la domanda è anelastica un aumento dei prezzi induce un
aumento della spesa totale mentre, se la domanda è elastica, un aumento del prezzo provoca una
diminuzione della spesa totale. Abbiamo così alcune regole di carattere generale:
• se la domanda è anelastica (l’elasticità della domanda al prezzo è minore di 1), il prezzo e la
spesa totale variano nella stessa direzione
• se la domanda è elastica (l’elasticità della domanda al prezzo è maggiore di 1), il prezzo e la
spesa totale variano in direzioni opposte
• se la domanda ha elasticità unitaria (l’elasticità della domanda è esattamente uguale a 1),
qualsiasi variazione del prezzo lascia inalterata la spesa totale
Non sempre l’elasticità è costante in tutti i punti della curva di domanda; una curva di domanda
rettilinea ha un’elasticità variabile a seconda del punto in cui viene rilevata. Una curva di domanda
rettilinea ha pendenza costante. Anche se la pendenza della curva di domanda rettilinea è costante,
l’elasticità non l’è. infatti, la pendenza è il rapporto tra le variazioni di due variabili, mentre
l’elasticità è il rapporto tra le variazioni percentuali delle due variabili.
Oltre all’elasticità della domanda al prezzo, gli economisti utilizzano altre elasticità per descrivere il
comportamento dei consumatori in un mercato:
• l’elasticità della domanda al reddito: misura la variazione della quantità domandata al variare
del reddito del consumatore; il suo valore viene calcolato mettendo in rapporto la variazione
percentuale della quantità domandata con la variazione percentuale del reddito. Visto che la
maggior parte dei beni sono beni normali all’aumentare del reddito aumenta anche la quantità
domandata: dato che la quantità domandata e reddito si muovono nella stessa direzione, i beni
normali hanno elasticità positiva. In altri beni, che invece vengono definiti beni inferiori, un
10
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
aumento del reddito ne fa diminuire la quantità domandata, dunque il valore dell’elasticità della
domanda al reddito è negativo
• l’elasticità incrociata della domanda al prezzo: viene usato per valutare come varia la quantità
domandata di un bene al variare del prezzo di un altro bene; questo parametro è calcolato come
il rapporto tra la variazione percentuale della quantità domandata del bene 1 e la variazione
percentuale del prezzo del bene 2. Il segno positivo o negativo dell’elasticità incrociata della
domanda al prezzo dipende dal fatto che i due beni siano sostituiti (elasticità positiva) o
complementari (elasticità negativa)
Secondo la legge dell’offerta, a prezzi più alti di un bene corrisponde la maggiore quantità offerta.
L’elasticità dell’offerta al prezzo misura la relazione della quantità offerta alle variazioni del
prezzo: l’offerta di un bene si dice elastica se la quantità offerta varia notevolmente a fronte di
variazioni contenute del prezzo; si dice invece anelastica se le variazioni della quantità offerta sono
contenute anche a fronte di variazioni pronunciate del prezzo. L’elasticità dell’offerta al prezzo
dipende dalla flessibilità dei venditori nel modificare la quantità dei beni che producono. Nella
maggior parte dei mercati il fattore chiave nel determinare l’elasticità dell’offerta al prezzo è il lasso
di tempo preso in considerazione: l’offerta è normalmente più elastica nel lungo che nel breve
periodo. Gli economisti calcolano l’elasticità dell’offerta al prezzo come rapporto tra la variazione
percentuale della quantità offerta e la variazione percentuale del prezzo, cioè:
Variazione percentual e della quantità offerta
Elasticità dell’offerta al prezzo = Variazione percentual e del prezzo
Poiché l’elasticità dell’offerta al prezzo misura la sensibilità della quantità offerta al prezzo, il suo
valore determina l’aspetto della curva di offerta. Possiamo averne molti casi: nel caso estremo,
l’elasticità ha valore 0, l’offerta è perfettamente anelastica e la curva di offerta è verticale; in questo
caso la quantità offerta è indipendente dal prezzo. All’aumentare del valore dell’elasticità, la
pendenza della curva diminuisce, riflettendo il fatto che la quantità offerta diventa più sensibile alle
variazioni del prezzo. All’estremo opposto troviamo il caso di un’offerta perfettamente elastica,
ovvero con valore dell’elasticità tendente all’infinito: in questo caso la curva di offerta è orizzontale
e riflette il fatto che variazioni infinitesime del prezzo provocano reazioni incommensurabili nella
quantità offerta.
CAPITOLO 6: DOMANDA, OFFERTA E POLITICA ECONOMICA
Seguendo un ragionamento abbastanza ovvio se affermiamo che i compratori di un bene desiderano
sempre un prezzo più basso e venditori un prezzo più alto va da se che i loro interessi sono
contrapposti. Se i consumatori riescono ad esercitare una pressione politica più efficace, il governo
emana un provvedimento per determinare un tetto al di sopra del quale il prezzo di quel determinato
bene non può salire, questo tetto viene definito livello massimo di prezzo; se invece fosse più
potente l'associazione dei produttori, il provvedimento legislativo determinerebbe un livello al di
sotto del quale il prezzo non posso scendere, cioè un livello minimo di prezzo. Se il governo
impone un livello massimo di prezzo nel mercato di un determinato bene, possono verificarsi due
risultati. Nel primo caso il prezzo di equilibrio è inferiore a livello massimo di prezzo imposto dal
governo, tale prezzo è non vincolante. Le forze del mercato spingono automaticamente il prezzo
verso il livello di equilibrio e il provvedimento non sortisce alcun effetto. Nel secondo caso, invece,
il prezzo di equilibrio del mercato è superiore al prezzo imposto dal governo che va a costituire un
vincolo al mercato: le forze della domanda e dell'offerta tenderebbero a spingere il prezzo verso il
livello di equilibrio ma, dal momento che il prezzo non può superare la soglia imposta dal governo,
il limite diventa il prezzo di mercato. Dato questo limite vincolante al prezzo, gli incentivi
cambiano: alcuni venditori non troveranno redditizio produrre quel bene e taglieranno la produzione
o usciamo dal mercato. Nel formulare un provvedimento di politica economica, le autorità devono
valutare chi siano i beneficiari e il possibile valore di questo beneficio in relazione al costo. Se il
governo impone un livello massimo di prezzo vincolante in un mercato concorrenziale, si crea una
penuria del bene e i venditori devono razionare il bene scarso tra un gran numero di potenziali
11
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
acquirenti. I meccanismi di razionamento che si sviluppano quando viene imposto un livello
massimo di prezzo difficilmente sono desiderabili. Al contrario, il meccanismo di razionamento che
determina la quantità venduta in un libero mercato concorrenziale è efficiente e impersonale:
quando il mercato di un determinato bene è in equilibrio, chiunque sia disposto a pagare il prezzo di
mercato riesce a ottenere quel bene. I mercati liberi praticano il razionamento attraverso il
meccanismo dei prezzi. Se il governo impone un livello minimo di prezzo nel mercato di un
determinato bene, si possono produrre due risultati. Se il livello minimo di prezzo è minore del
prezzo di mercato, il minimo legale non è relativamente vincolante dato che le forze di mercato
riescono comunque a portare naturalmente il prezzo al livello di equilibrio. Se, invece, il livello
minimo del prezzo è superiore al pezzi di equilibrio, le forze di mercato non sono più in grado di
riportare il mercato in equilibrio perché il pezzo non può diminuire nella misura necessaria. A quel
determinato prezzo alcuni venditori non riescono a vendere il bene pur volendo farlo e si genera
un’eccedenza. Come il livello massimo di prezzo e la conseguente penuria, così il livello minimo di
prezzo e la conseguente eccedenza possono provocare effetti previsti di razionamento: in un
mercato libero il prezzo è il meccanismo di razionamento e, al prezzo di equilibrio, ogni venditore
trova sempre tutti componenti che desidera.
Tutte le amministrazioni pubbliche ricorrono alla tassazione per raccogliere risorse da destinare a
scopi di pubblico interesse. Gli economisti usano il termine incidenza delle imposte per riferirsi alle
questioni che attengono alla distribuzione dell’onere fiscale. Consideriamo il caso di un’imposta
sulla vendita di un bene. L’imposta crea un divario tra il prezzo pagato dai compratori e quello
incassato dai venditori. Tale divario è identico, indipendentemente dal fatto che l’imposta gravi sui
compratori o sui venditori: nella realtà, molti governi preferiscono tassare i venditori e non i com-
pratori. Il divario modifica posizione relativa delle curve di domanda e di offerta e, nel nuovo
equilibrio che si viene a formare, compratori e venditori condividono l'onere fiscale. Quindi,
quando un bene è soggetto a tassazione, compratori e venditori si spartiscono l'onere dell’imposta;
ma come viene diviso esattamente tale onere? Solo eccezionalmente la divisione sarà in parti uguali
e, ciò che va a influenzare la divisione è l’elasticità relativa alle curve di domanda e offerta.
Andiamo ad analizzare l’effetto di un’imposta in un mercato in cui l’offerta è molto elastica e la
domanda è relativamente anelastica. In questo caso i venditori sono molto sensibili alla variazione
del prezzo (la curva di offerta è relati-
vamente piatta) e i compratori lo sono
proporzionalmente meno (la curva di
domanda è relativamente ripida).
Un'imposta introdotta in un mercato con
questa elasticità non fa diminuire di
molto il prezzo ricevuto dai venditori,
mentre ha un effetto sostanziale sul
prezzo pagato dai compratori, che
sostengono la parte più considerevole
dell’onere dell’imposta.
Andiamo ora ad analizzare quali sono gli effetti
di un'imposta in un mercato nel quale l’offerta è
relativamente anelastica la domanda relati-
vamente elastica. In questo caso, i venditori
sono scarsamente sensibili al prezzo (la curva di
offerta è più ripida) mentre i compratori sono
molto reattivi (la curva di domanda è più piatta).
Con l'introduzione dell’imposta il prezzo pagato dal compratore non aumenta di molto, mentre
quello ricevuto dal venditore diminuisce sensibilmente; dunque l'imposta grava
maggiormente rivenditori che sui compratori. In questa circostanza, il venditore sa che se tenterà di
trasferire l'onere dell’imposta sul compratore, la domanda diminuirà in misura relativamente
marcata.
12
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Da questi due casi particolari possiamo
trarre una conclusione di carattere
generale su come si ripartisce l’onere
dell’imposta: l’onere fiscale ricade più
pesantemente sulla componente del
mercato meno elastica. In sostanza,
l'elasticità misura la volontà del com-
pratore o del venditore di uscire dal
mercato nel momento in cui si
verificano condizioni a lui sfavorevoli:
una bassa elasticità della domanda
significa che i compratori non hanno
buone alternative disponibili al
consumo di un determinato bene; una
scarsa elasticità dell'offerta significa che i venditori non hanno buone alternative alla produzione di
quel specifico bene. Se tale bene viene soggetto a tassazione, la componente del mercato che
dispone di meno alternative valide non può uscire facilmente dal mercato e, perciò, deve sopportare
l'onere dell’imposta in misura più rilevante.
Il sussidio è il contrario dell’imposta. I sussidi vengono disposti quando il governo vuole incorag-
giare il consumo di un “bene” che ritiene non sia prodotto nella quantità socialmente desiderabile. I
sussidi sono generalmente concessi ai venditori e hanno l’effetto di abbattere i costi di produzione,
contrariamente a un’imposta, che mi fa aumentare.
CAPITOLO 7: CONSUMATORI, PRODUTTORI ED EFFICIENZA DEI MERCATI
L’economia del benessere è lo studio della relazione che intercorre tra l’allocazione delle risorse e il
benessere economico. Lo studio
dell’economia del benessere prende avvio
dall’analisi dei benefici che i compratori
possono trarre dal partecipare al mercato.
Il surplus del consumatore è la diffe-
renza tra il prezzo massimo che un
compratore è disposto a pagare per
l’acquisto di un bene e il prezzo che
effettivamente paga; in altre parole, il
surplus del consumatore misura il
beneficio che i compratori traggono dal
partecipare a un mercato. Il surplus del
consumatore è strettamente legato alla
curva di domanda in quanto, la curva di
domanda riflette la disponibilità a pagare
dei compratori, quindi può essere
utilizzata per misurare il surplus del
consumatore. L’area compresa tra la
curva di domanda e il livello del prezzo è la misura del surplus del consumatore nel mercato. Infatti,
l’altezza della curva di domanda indica il valore attribuito dal consumatore al bene, come misurato
dalla sua disponibilità a pagare; la differenza tra la disponibilità a pagare e il prezzo ef-fettivamente
pagato è il surplus del con-sumatore di ciascun compratore; quindi, l’area sottesa dalla curva di
domanda al di sopra del livello del prezzo rappresenta la sommatoria di tutti i surplus del
consumatore di tutti gli acquirenti del bene o del servizio di mercato. Ovviamente, tutti i compratori
vogliono sempre pagare il meno possibile per il bene che desiderano acquistare, quindi una
diminuzione del prezzo apporta un bene-ficio a tutti i compratori.
L’aumento del surplus del consumatore può essere suddiviso in due componenti:
1. la prima rappresenta l’aumento del surplus del consumatore per quei compratori che già
acquistavano la quantità Q1 al prezzo P1 e che ora beneficiano di un prezzo inferiore
13
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
2. la seconda è rappresentata dal surplus del consumatore dei nuovi compratori che sono disposti
ad acquistare il bene soltanto perché il suo prezzo è diminuito
Il surplus del venditore, invece, è la differenza tra il prezzo pagato al venditore e il suo costo di
produzione; tale differenza misura il
beneficio di cui il venditore gode in virtù
della sua partecipa-zione al mercato. Come
il surplus del consumatore è strettamente
legato alla curva di domanda, così il surplus
del produttore è strettamente legato alla
curva di offerta. L’altezza della curva è
correlata ai costi dei venditori: per ogni data
quantità, il prezzo determinato sulla curva
di offerta corrisponde al costo del venditore
marginale, ovvero del primo venditore che
lascerebbe il mercato se il prezzo
diminuisse ulteriormente. Poiché la curva di
offerta riflette i costi dei venditori,
possiamo utilizzarla per misurare il surplus
del produttore. L’are compresa tra la curva
di offerta e il livello di prezzo misura il
surplus del produttore di un mercato;
l’altezza della curva di offerta misura il costo del produttore e la differenza tra costo e prezzo è il
surplus di ciascun produttore; ne consegue che l’area totale è equivalente alla somma-toria del
surplus del produttore di ciascun venditore. L’aumento del surplus del produttore è com-posto da
due parti:
1. la prima rappresenta l’aumento del surplus del produttore per quei venditori che già cedevano la
quantità Q1 al prezzo P1 e che ora beneficiano di un prezzo superiore
2. la seconda parte è rappresentata dal surplus del produttore dei nuovi venditori che sono disposti
a vendere il bene solo perché il suo prezzo è aumentato
Surplus del consumatore e del produttore sono gli strumenti fondamentali a cui ricorrono gli
economisti per studiare il benessere di compratori e venditori in un mercato: la somma dei due
surplus va a costituire quello che è il surplus totale. Visto che il surplus del consumatore è il bene-
ficio che il compratore trae dal mercato e che il surplus del produttore è il beneficio che il venditore
trae dal mercato, è naturale utilizzare la somma di tali quantità per misurare il benessere comples-
sivo della società.
Surplus totale = valore per i compratori –
costo per i venditori
Dunque, il surplus totale di un mercato è
la differenza tra il valore totale dei beni
per i compratori, misurato sulla base della
loro disponibilità a pagare, e il costo
sostenuto dai venditori per produrre i beni
in oggetto. Se una data allocazione delle
risorse massimizza il surplus totale,
diciamo che ha caratteristica di efficienza.
Se un’allocazione non è efficiente, alcuni
dei benefici dello scambio tra compratori
e venditori non si realizzano. Oltre
l’efficienza, però, bisognerà tener conto
anche dell’equità, ovvero della giusta
distribuzione del benessere tra compratori
e venditori.
14
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Ricordando che il surplus del consumatore è rappresentato dall’area compresa tra la curva di
domanda e il livello del prezzo, mentre quello del produttore dall’area compresa tra il livello del
prezzo e la curva di offerta: di conseguenza, l’area compresa tra la curva di domanda e quella di
offerta, alla sinistra del punto di equilibrio, rap-presenta graficamente il surplus totale del mercato.
Disponiamo di tre considerazioni sui risultati del mercato:
1. un libero mercato alloca l’offerta di un bene ai compratori che gli attribuiscono il valore più
elevato, misurato in termini di disponibilità a pagare
2. un libero mercato alloca la domanda di un bene ai venditori che possono produrlo al costo più
contenuto
3. un libero mercato produce esattamente la quantità di bene che massimizza la somma del surplus
del consumatore e del produttore
Insieme, queste tre considerazioni ci dicono che l’equilibrio di mercato massimizza la somma del
surplus del consumatore e del produttore. In altre parole, la situazione di equilibrio rappresenta
un’allocazione efficiente delle risorse.
L’analisi è fondata sull’ipotesi che i mercati siano perfettamente concorrenziali: nel mondo reale,
invece, la concorrenza è spesso ben lontana dall’essere perfetta. In alcuni mercati un singolo
compratore o venditore può essere in grado di esercitare un controllo sui prezzi di mercato. Questa
prerogativa è detta potere di mercato e può generare risultati inefficienti dal momento che mantiene
prezzi e quantità a livelli diversi da quelli di equilibrio della domanda e dell’offerta. Inoltre, questa
analisi ipotizza che i risultati del marcato guardino soltanto i compratori e i venditori che vi
partecipano: eppure, nel mondo reale, le decisioni di compratori e venditori in un mercato influi-
scono anche su soggetti che non partecipano a quel mercato. Questi effetti collaterali, detti
esternalità, fanno si che il benessere prodotto da un mercato non dipenda solo dal valore per il
consumatore e dal costo del produttore. Poiché compratori e venditori non prendono in considera-
zione tali effetti collaterali nel momento in cui formulano le proprie decisioni di consumo e di pro-
duzione, l’equilibrio in un mercato può essere inefficiente dal punto di vista della società nel suo
complesso. Potere di mercato ed esternalità sono solo esempi di un fenomeno generale detto
fallimento del mercato: l’incapacità di un mercato non regolamentato di allocare le risorse in modo
efficiente. Quando un mercato fallisce, l’intervento pubblico può potenzialmente rimediare al
problema e accrescere l’efficienza economica.
CAPITOLO 8: UN’APPLICAZIONE PRATICA: IL COSTO DELLA TASSAZIONE
Le imposte sono uno strumento per prelevare legalmente denaro da individui e organizzazioni. Con
l’emanazione di un’imposta ci si domanda subito chi, tra compratori e venditori, la debba pagare: se
l’imposta viene pagata dai compratori, la
curva di domanda si sposta verso il basso
in misura equi-valente all’ammontare
dell’imposta stessa; se l’imposta grava sui
venditori, sarà la curva di offerta a
spostarsi verso l’alto nella stessa misura.
In entrambi i casi il prezzo pagato dai
compratori aumenta, quello incassato dai
venditori diminuisce e, alla fine, entrambi
i gruppi si sobbarcano una quota
dell’onere fiscale, indipendentemente da
chi dei due mette mano al portafoglio.
L’imposta va a creare un divario tra il
prezzo pagato dai compratori e quello
incassato dai venditori. Poiché, a causa di
tale differenza, la quantità venduta
diminuisce rispetto a quella precedente
all’introduzione dell’imposta, la tassazione
di un bene comporta la riduzione della dimensione del mercato.
15
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Per analizzare gli effetti della tassazione sul benessere economico, misureremo il beneficio che lo
Stato trae dall’imposta con le entrate che ne ricava: tale beneficio, però, non è goduto dallo Stato in
quanto tale, ma dai cittadini a favore dei quali le entrate saranno spese. Le entrate fiscali saranno
rappresentabili graficamente dal rettangolo compreso tra le curve di offerte e di domanda, con i soli
vertici destri che toccano le due curve: l’altezza del rettangolo è pari a T, ovvero all’ammonta-re
dell’imposta, mentre la sua base è data da Q, cioè dalla quantità venduta del bene. Poiché la
superficie di un rettangolo si calcola moltiplicando la misura della base per quella dell’altezza,
l’area di tale rettangolo è TxQ, ovvero l’ammontare delle entrate fiscali. In assenza di impostazione
fiscale il prezzo P1 e la quantità Q1 vengono deter-minati dall’interazione delle curve di domanda e
di offerta. Poiché la curve di domanda riflette la disponibilità a pagare dei compratori, il surplus del
consumatorie è l’area compresa tra la curva di domanda e il livello del prezzo, composta dalle aree
A+B+C. Analogamente, poiché la curva di offerta riflette il costo di produzione dei venditori, il
surplus del produttore è individuato dall'area compresa tra la curva di offerta e livello del prezzo,
composta dalle aree D+E+F. In questo caso, poiché non ci sono imposte, le entrate fiscali sono
nulle. Il surplus totale, ovvero la somma
del surplus del consumatore e del
produttore, equivale alla somma delle
aree A+B+C+D+E+F. Ipotizziamo ora
che venga introdotta un'imposta. Il
prezzo pagato dai compratori aumentata
da P1 a PB e il surplus del consumatore è
equivale alla sola area A; il prezzo
ricevuto dai venditori, invece,
diminuisce da P1 a PS e il surplus del
produttore è ora uguale alla sola area F.
La quantità venduta diminuisce da Q1 a
Q2 e lo Stato raccoglie entrate fiscali per
un ammontare pari alla somma delle
aree B+D. Il surplus totale in presenza di
tassazione corrisponde alla somma della
superficie com-posta delle aree
A+B+D+F. La tassazione, quindi, ha
degli effetti sul benessere: l'imposta provoca una diminuzione del surplus del consumatore in
misura pari alle aree B+C e di quello del produttore in misura pari a D+E; le entrate fiscali passano
da zero a B+D. Deduciamo, quindi, che la tas-sazione danneggia compratori e venditori a vantaggio
dello Stato. Il benessere totale diminuisce di una quantità rappresentata dalle aree C+E. Dunque, le
perdite subite da compratori e venditori a causa dell'introduzione dell’imposta sono maggiori del
beneficio che lo Stato ne ricava.
In assenza di imposta In presenza di imposta Variazione
Surplus del consumatore A+B+C A -(B+C)
Surplus del produttore D+E+F F -(D+E)
Entrate fiscali Nessuna B+D +(B+D)
Surplus totale A+B+C+D+E+F A+B+D+F -(C+E)
La perdita di surplus totale risultante dall'introduzione di un'imposta viene detta perdita secca ed è
misurata dalla superficie delle aree C+E. Ma, cosa determina la dimensione della perdita secca? Le
elasticità della domanda e dell’offerta al prezzo. Un’imposta genera una perdita secca perché induce
i parte-cipanti al mercato a modificare il proprio comportamento: alzando il prezzo di acquisto,
induce i compratori ad acquistare meno; diminuendo il prezzo di vendita, induce i venditori a
produrre meno. A causa di queste modifiche del comportamento la dimensione del mercato si riduce
al di sotto del livello ottimale. Poiché le elasticità della domanda e dell’offerta al prezzo misurano,
ris-pettivamente la sensibilità di compratori e venditori alle variazioni di prezzo, tali elasticità sono
la misura precisa degli effetti discorsivi delle imposte. In conclusione, quanto maggiori sono i valori
16
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
dell’elasticità al prezzo di domanda e offerta, tanto maggiore è la perdita secca associata all’imposta
fiscale. La perdita secca aumenta più rapidamente di quanto faccia l'ammontare dell'imposta: la
ragione sta nel fatto che la perdita secca è l'area di un triangolo, la quale dipende dal quadrato delle
dimensioni del triangolo stesso. Le entrate fiscali sono uguali all'area del rettangolo compreso tra le
curve di domanda ed offerta. Se l'ammontare dell'imposta è modesto, anche l'area del rettangolo è
modesta; al progressivo cresce dell'imposta, l'area del rettangolo aumentata fino a raggiungere il
massimo per poi tornare a diminuire a causa della radicale riduzione della dimensione del mercato a
fronte di un’imposta di ammontare particolarmente elevato.
Paradossalmente, un'imposta di ammontare eccessivo non genererebbe alcuna entrata per lo Stato,
perché gli individui smetterebbero completamente di consumare produrre il bene.
CAPITOLO 9: UN’APPLICAZIONE PRATICA: IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Attraverso il confronto tra il prezzo interno e quello mondiale si può stabilire se un Paese gode di un
vantaggio comparato dalla produzione di un bene. Il prezzo interno, infatti, riflette il costo-opportu-
nità del bene, cioè la quantità di moneta locale a cui un individuo deve rinunciare per ottenere un’u-
nità del bene stesso. Se il prezzo è basso, produrre il bene ha un costo basso e possiamo ipotizzare
che quel Paese abbia un vantaggio comparato nella produzione di quel bene rispetto al resto del
mondo; se il prezzo interno è alto, allora produrre quel bene è molto costoso e possiamo ipotizzare
che gli altri paesi abbiano un vantaggio comparato nella produzione del bene. Con il prezzo interno
uguale al prezzo mondiale, la quantità offerta dai produttori interni differisce dalla quantità doman-
data dai consumatori interni. Poiché la quantità offerta dai produttori interni eccede la quantità do-
mandata sul mercato interno il Paese che vende quel determinato bene ad altri paesi, diventa espor-
tatore di quel bene.
Consideriamo ora guadagni e perdite
che derivano dell'apertura delle
frontiere. Gli scambi interna-zionali
spingono il prezzo intero verso l’alto,
fino al livello del prezzo mondiale. I
produttori interni vengono favoriti
potendo vendere il bene a un prezzo più
elevato; sono, infatti, i consumatori
interni a subire il danno. Per quantificare
guadagni e perdite, dobbiamo
considerare le variazioni del sur-plus del
consumatore e quello del produttore. In
assenza di scambi internazionali il
prezzo interno del bene è tale da
garantire l'uguaglianza tra quantità
offerta e quantità domandata
internamente. Il surplus del consumatore
è rappresentato dall’area A+B, mentre, il surplus del produttore è rappre-sentato dall’area C; il
surplus totale in assenza di commercio internazionale è rappresentato dall’area A+B+C. Con
17
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
l'avvento del commercio internazionale il prezzo interno aumenta, adeguandosi a quello mondiale, e
il surplus del consumatore si riduce all'area A, il surplus del produt-tore diventa invece equivalente
all'area B+C+D. Quindi, il surplus totale in pre-senza di commercio internazionale è rappresentato
dall'area A+B+C+D. Dal computo del benessere totale si deduce chi trae beneficio e chi viene
danneggia-to dal commercio internazionale in un paese esportatore: i venditori guadagna-no perché
il surplus del produttore aumenta dell'aria B+D; invece i consu-matori subiscono una perdita, dal
momento che loro surplus diminuisce dell'area B. Tuttavia il beneficio per i venditori è superiore
alla perdita dei compratori di una misura equivale all'area D, quindi il surplus totale del paese
aumenta. Questo ci porta a formulare due conclusioni relativamente ai paesi esportatori:
1. quando un paese apre le proprie frontiere e diventa esportatore di un bene, i produttori interni ne
traggono un beneficio, mentre i consumatori interni subiscono un danno
2. il commercio internazionale fa aumentare il benessere totale della nazione, dal momento che i
guadagni dei venditori sono superiori alle per dire di compratori.
In assenza di scambi In presenza di scambi Variazione
Surplus del consumatore A+B A -B
Surplus del produttore C B+C+D +(B + D)
Surplus totale A+B+C A+B+C+D +D
Supponiamo ora che il prezzo interno, in assenza di scambi internazionali, sia più elevato del prezzo
mondiale: anche in questo caso, una volta aperte le frontiere al commercio, il prezzo del bene
interno si allineerà a quello mondiale. La differenza tra la quantità domandata e la quantità offerta
interamente viene colmata dei prodotti stranieri e il paese diventa importatore del bene.
Quando le forze di mercato spingono
verso il basso il prezzo interno, i
consumatori vedono migliorare le
proprie condizioni, mentre i produttori
nazionali subiscono una perdita. Le
variazioni dei surplus del consumatore
e del produttore ci permetteranno di
misurare guadagni e perdite. In
assenza di scambi il surplus del
consumatore equivale all’area A,
quello del produttore all’area B+C e
quello totale ad A+B+C. Con
l’apertura delle frontiere il surplus del
consumatore diventa A+B+D, il
surplus del produttore diventa pari
all’area C e il surplus totale equivale
all’area A+B+C+D. i consumatori ci
guadagnano, dal momento che il loro
surplus aumenta dell’area B+D; i produttori ci perdono perché il loro surplus diminuisce dell’area
B; il benessere totale del paese aumenta, perché il surplus totale aumenta dell’area D. Questo ci
porta a formulare due conclusioni relativamente ai paesi importatori:
1. quando un paese apre le frontiere e diventa importatore di un bene, i consumatori interni
traggono un beneficio, mentre i produttori interni subiscono un danno
2. il commercio internazionale fa aumentare il benessere totale del paese, dal momento che i
guadagni dei compratori sono superiori alle perdite dei venditori
In assenza di scambi In presenza di scambi Variazione
Surplus del consumatore A A+B+C +(B + D)
Surplus del produttore B+C C -B
Surplus totale A+B+C A+B+C+D +D
18
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Un dazio è un’imposta sui beni importati; il dazio non ha alcun effetto se un paese è esportatore ma
diventa rilevante solo nel caso in cui il paese fosse importatore di un determinato bene. Mettiamo
ora a confronto il benessere economico in assenza e presenza di dati. In virtù del libero scambio il
prezzo interno è identico a quello mondiale. Un dazio fa aumentare il prezzo del bene importato,
rispetto al prezzo mondiale, di un ammontare corrispondente al dazio stesso. Si può ora vendere
quel bene a un prezzo pari alla somma del prezzo mondiale e dell'ammontare del dazio. Quindi, il
prezzo del bene, sia prodotto internamente sia importato, aumenta dell'ammontare del dazio e si
porta a un livello più vicino a quello che si determinerebbe in un mercato chiuso.
Poiché il dazio fa aumentare il prezzo del bene, la quantità domandata interna si contrae da Q1D a
Q2D, mentre aumenta la quantità offerta internamente da Q1O a Q2O. Dunque, il dazio riduce le
importazioni e fa muovere il mercato interno verso una posizione più vicina all'equilibrio in assenza
di scambi. Essendo aumentato il prezzo interno, i venditori nazionali sono avvantaggiati e i compra-
tori nazionali danneggiati; inoltre lo Stato può contare su entrate fiscali aggiuntive. Prima dell'appli-
cazione del dazio il prezzo interno e quello mondiale sono identici. Il surplus del consumatore cor-
risponde alle aree A+B+C+D+E+F; il surplus del produttore è pari all'area G; le entrate fiscali sono
nulle e il surplus totale è pari alle aree A+B+C+D+E+F+G. L'introduzione del dazio fa aumentare il
prezzo interno rispetto a quello mondiale in un ammontare corrispondente al dazio stesso. Il surplus
del consumatore diminuisce ad A+B; quello del produttore aumenta a C+G; le entrate fiscali, pari
all'ammontare del dazio moltiplicato per la quantità importata dopo l'applicazione del dazio, equiva-
le all'area E. Di conseguenza, il surplus totale a seguito dell'introduzione del dazio è equivalente
all’area A+B+C+E+G.
Per valutare l'effetto complessivo del
dazio sul benessere economico, si
devono sommare le variazioni del
surplus del consumatore (negativa), del
surplus del produttore (positiva) e delle
entrate fiscali (positiva). Così facendo
scopriamo che il surplus totale del
mercato diminuisce di una quantità
corrispondente all’area D+F che rappre-
senta la perdita secca causata dal dazio.
Un dazio provoca una perdita secca per
la semplice ragione che un tipo partico-
lare di imposta e, come tutte le imposte
sulla vendita di un bene, distorce gli
incentivi e provoca un’allocazione sub-
ottimale delle risorse scarse. In questo
caso il dazio provoca due feti distinti: in
primo luogo, fa aumentare il prezzo
applicato dai produttori nazionali del bene rispetto al prezzo mondiale e, di conseguenza, li stimola
ad aumentare la produzione (da Q1O a Q2O); in secondo luogo, fa aumentare il prezzo pagato dai
compratori nazionali, inducendoli così a ridurre i consumi (da Q1D a Q2D). L'area D rappresenta la
perdita generata dalla sovrapproduzione, l'area F quella dovuta al sottoconsumo. La perdita secca
totale è uguale alla somma di queste due aree.
In assenza di dazio In presenza di dazio Variazione
Surplus del consumatore A + B + C + D + E + F A+B -(C + D + E + F)
Surplus del produttore G C+G +C
Entrate fiscali Nessuna E +E
Surplus totale A+B+C+E +F+G A+B+C+E+G -(D + F)
19
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Andiamo ora ad analizzare gli effetti dell’imposizione di un contingentamento, ovvero di un limite
massimo alla quantità importabile di un bene. Gli economisti di un paese mettono a confronto il
livello di benessere che si ottiene in un regime di libero scambio con quello associato all’imposi-
zione di un contingentamento. Vediamo ora l’effetto di un contingentamento delle importazioni sul
mercato di un paese per un determinato
bene. Al di sopra del prezzo mondiale la
curva di offerta si sposta verso destra di
un ammontare corrispondente alla
quantità di importazioni contingentata (al
di sotto del prezzo mondiale la curva di
offerta non si sposta, perché, in tale
circostanza, per i detentori delle licenze
le importazioni non sono convenienti). Il
prezzo del bene si aggiusta in modo da
garantire l’equilibrio di domanda e
offerta. Il contingentamento spinge il
prezzo interno al di sopra del prezzo
mondiale: la quantità domandata interna
si contrae da Q1D a Q2D mentre la quantità
offerta internamente aumenta da Q1O a
Q2O. Essendo aumentato il prezzo interno,
i venditori nazionali sono avvantaggiati e
i compratori nazionali danneggiati; anche i detentori di licenze di importazione sono avvantaggiati,
perché realizzano un profitto acquistando il bene al prezzo mondiale e rivendendolo al prezzo
interno più elevato. Prima dell’introduzione del’ contingentamento il prezzo interno e quello
mondiale sono identici. Il surplus del consumatore corrisponde alle aree A+B+C+D+E 1+ +E2+F. Il
surplus del produttore è pari all’area G. il surplus dei detentori di licenze di importazione è nullo,
perché non vi sono licenze. Il surplus totale, misurato come surplus del consumatore, surplus del
produttore e surplus dei detentori di licenze, è pari alle aree A+B+C+D+E1+E2+F+G. L’introduzione
del contingentamento e la distribuzione delle licenze di importazione fanno au-mentare il prezzo
interno rispetto a quello mondiale. Il surplus del consumatore diminuisce da A+B: quello del
produttore aumenta a C+G; i detentori di licenze di importazione realizzano per ogni unità
importata un profitto pari alla differenza fra il prezzo del bene e il prezzo mondiale. Il loro surplus è
pari al differenziale di prezzo moltiplicato per la quantità di importazioni autorizzate ed è perciò
equivalente all’area del rettangolo E1+E2. Il surplus totale in presenza di contingenta-mento
corrisponde alle aree A+B+C+E1+E2+G e diminuisce di una quantità corrispondente all’area D + F
che rappresenta la perdita secca causata dal contingentamento delle importazioni.
In presenza di
In assenza di contingentamento Variazione
contingentamento
Surplus del -(C + D + E1 +
A + B + C + D + E1 + E2 + F A+B
consumatore E2 + F)
Surplus del
G C+G +C
produttore
Entrate
Nessuna E1+E2 +(E1 + E2)
fiscali
Surplus
A + B + C + D + E1 + E2 + F + G A + B + C + E1 + E2 + G -(D + F)
totale
Sia il dazio sia il contingentamento fanno aumentare il prezzo interno del bene, riducendo il benes-
sere dei consumatori nazionali, accrescono il benessere dei produttori nazionali e provocano una
perdita secca. L’unica differenza rilevabile fra questi due strumenti di restrizione del commercio è
che il dazio crea entrate erariali mentre il contingentamento genera un surplus per i detentori di
licenze di importazione. Sebbene l’analisi dei dazi e contingentamenti condotta fin qui lasci suppor-
20
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
re che i due provvedimenti restrittivi del commercio provochino una perdita secca di proporzioni
simili, i contingentamenti possono provocare in realtà una perdita secca di entità relativamente mag-
giore, a seconda del meccanismo utilizzato per distribuire le licenze di importazione. In questo caso
la licenza ha un prezzo implicito: il costo dell’attività di lobbying. Questo prezzo, invece di essere
destinato allo Stato, viene dissipato in attività di pressione politica. La perdita secca, in questo caso,
oltre alle perdite dovute alla sovrapproduzione (area D) e al sottoconsumo (area F), include anche la
parte del surplus dei detentori di licenze (area E1+E2) che va sprecata nella attività di lobbying.
Ci sono molte argomentazioni a favore delle restrizioni al libero scambio:
• occupazione: gli oppositori del libero scambio sostengono spesso che la concorrenza internazi-
onale distrugge posti di lavoro
• sicurezza nazionale: quando un settore è minacciato dalla concorrenza internazionale, gli op-
positori del libero scambio spesso sostengono l’importanza determinante di quel settore per la
sicurezza nazionale. Gli economisti sono disposti a riconoscere che legittime preoccupazioni di
sicurezza nazionale possono giustificare la protezione di alcuni settori fondamentali, ma sanno
anche che questo è un argomento troppo facilmente utilizzabile da chiunque voglia ricavare un
profitto ai danni dei consumatori. Infatti, per chi appartiene a un settore produttivo è forte la
tentazione a esagerare il proprio ruolo ai fini della sicurezza nazionale per ottenere protezione
dalla concorrenza estera
• protezione delle industrie nascenti: i nuovi settori industriali spesso richiedono restrizioni
temporanee al commercio per riuscire a crescere e svilupparsi. Dopo un periodo di protezione e
sostegno questi settori matureranno e saranno in condizione di competere alla pari con le impre-
se straniere. Analogamente, i settori maturi talvolta sostengono di aver bisogno di protezione per
potersi adeguare alle nuove condizioni di mercato. Gli economisti sono spesso scettici di fronte
a tali richieste. La ragione fondamentale è che la protezione delle industrie nascenti è difficile da
mettere in pratica. Per attuare una protezione efficace, lo Stato dovrebbe essere in grado di
stabilire quali settori sono potenzialmente redditizi e se i costi da sostenere sono ragio-nevoli a
fronte di benefici futuri per l’industria e del danno attuale per il consumatore. Dunque, per
stabilire a priori chi avrà successo è molto difficile; il processo è reso ancora più ostico dai
meccanismi della politica, che tendono a premiare quei settori che hanno un peso politico. Inol-
tre, i provvedimenti temporanei tendono a diventare permanenti se chi ne beneficia è politica-
mente potente
• concorrenza sleale: uno degli argomenti protezionistici più diffusi è che il libero scambio sia
desiderabile soltanto se tutti i paesi sono soggetti alle medesime regole del gioco: se imprese di
diversi paesi sono soggette a leggi e regolamenti differenti, è iniquo permettere che si facciano
concorrenza nei mercati mondiali
• protezionismo come arma di trattativa: un ulteriore argomento a favore delle restrizioni al libero
scambio riguarda le strategie di negoziazione. La minaccia di ritorsioni commerciali può aiutare
a rimuovere le barriere al libero scambio erette dai governi dei paesi stranieri. Il problema di tali
strategie di trattativa è che la minaccia potrebbe non funzionare e, di conseguenza, condurre il
paese in un vicolo cieco.
N.B. Gli altri vantaggi del commercio internazionale
Esistono molti antri benefici economici oltre a quelli già analizzati:
• maggiore varietà di beni: i beni prodotti in paesi diversi non sono necessariamente identici; il
libero scambio offre ai consumatori di tutti i paesi la possibilità di scegliere tra una gamma più
ampia di beni
• minori corsi, grazie alle economie di scala: alcuni beni possono essere prodotti a basso costo
solo in grandi quantità
• aumento della concorrenza: aprire le frontiere agli scambi significa incentivare la concorrenza e
permettere alla mano invisibile di realizzare la propria magia
• miglioramento del flusso delle conoscenze: la diffusione del progresso tecnologico nel mondo è
spesso collegato al commercio internazionale dei beni che incorporano innovazioni
21
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
• stimolo alla crescita economica
CAPITOLO 10: LE ESTERNALITA’
Un’esternalità è l’effetto dell’azione di un soggetto economico sul benessere di altri soggetti non
coinvolti direttamente nell’azione: se tale effetto è dannoso avremo un’esternalità negativa, se è
benefico, un’esternalità positiva. In presenza di esternalità l’interesse sociale nei confronti del risul-
tato del mercato si estende al di là del benessere di compratori e venditori, per comprendere anche
quello dei terzi che ne vengono condizionati. Tuttavia, poiché compratori e venditori tendono a non
considerare gli effetti esterni delle proprie azioni nel determinare la quantità domandata o offerta,
l’equilibrio del mercato non riesce a massimizzare il beneficio totale per la società nel suo comples-
so. Al momento di prendere una decisione gli individui on tengono in considerazione tutti gli effetti
esterni del proprio comportamento; lo Stato reagisce cercando di influenzare tale comportamento in
modo da proteggere gli interessi dei terzi. Ma, qual è l’effetto di un’esternalità sull’efficienza del
risultato del mercato? A causa dell’esternalità, il costo della produzione di un bene per la società è
più elevato di quello sostenuto dai produttori, per ogni unità di bene prodotta il costo sociale (o
esterno) include, oltre al costo privato della produzione del bene, anche il danno che l’inquinamento
arreca a terzi. La curva del costo totale è più alta rispetto alla curva di offerta, perché include anche
i costi esterni che gravano sulla collettività a causa della produzione del bene in questione. A ogni
dato prezzo, il costo sociale è maggiore del costo privato, quindi possiamo affermare che la curva di
costo sociale è pari alla somma del
costo privato e del costo sociale, o
costo esterno. Lo spazio tra le due
curve è equivalente al costo
dell’inquinamento emesso dai
produttori del bene. Si noti che la
quantità di equilibrio, QMERCATO, è
maggiore della quantità socialmente
ottima, QOTTIMO. La ragione di tale
inefficienza discende dal fatto che
l’equilibrio di mercato riflette soltanto
il costo privato di produzione. Questo
significa che in corrispondenza di
QMERCATO la curva di domanda si trova
al di sotto della curva di costo sociale e
che quindi, riducendo la produzione e
il consumo del bene rispetto al livello
di equilibrio, è possibile aumentare il
benessere economico totale. Possiamo misurare le variazioni di benessere sociale con le perdite di
benessere associate ai diversi esiti di mercato. In sostanza, misuriamo la differenza del valore
attribuito dai consumatori a ciascuna unità marginale di produzione del bene tra QOTTIMO e QMERCATO
(evidenziato dal triangolo nella figura). Come può il pianificatore benevolo portare l’economia al
punto di equilibrio ottimale? Un modo potrebbe essere quello di introdurre un’imposta su ogni unità
di bene venduto; tale imposta sposterebbe verso l’alto la curva di offerta e, se il suo ammontare
fosse accuratamente calcolato, la nuova curva di offerta coinciderebbe con la curva di costo sociale.
Nella nuova condizione di equilibrio i produttori fabbricherebbero la quantità ottimale del bene.
Applicare un’imposta di questo genere significa internalizzare l’esternalità, poiché si offre a
compratori e venditori attivi nel mercato un incentivo a prendere in considerazione gli effetti esterni
delle loro azioni. L’analisi delle esternalità positive è analoga a quella già condotta per le esternalità
negative. In presenza di esternalità positive, la curva di domanda non riflette il valore del bene per
la società. Dato che il valore sociale è superiore a quello privato, la curva del valore sociale giace al
di sopra della curva di domanda. In particolare, la curva del valore sociale è pari alla somma del
valore privato del beneficio esterno per la società a ogni dato livello di prezzo. Per ogni prezzo il
beneficio per la società è maggiore del beneficio privato, quindi la curva del valore sociale giace
alla destra della curva del beneficio privato. La quantità ottimale è definita dall’intersezione tra la
22
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
curva di offerta (che rappresenta il
corso) e quella del valore sociale.
Anche in questo caso lo Stato può
correggere il fallimento del mercato. Il
provvedimen-to adeguato, nel caso delle
esternalità positive, è esattamente
opposto a quello che si rivela efficace
nel caso di esternalità negative: per
collocare il mercato in una posizione di
equilibrio più vicina a quella ottimale,
un’esternalità positiva richiede
l'erogazione di un sussidio. In sintesi: le
esternalità negati-ve inducono il mercato
a produrre quantità in eccesso rispetto a
quelle socialmente desiderabili. Le
esternalità positive inducono il mercato a produrre quantità in difetto rispetto a quelle socialmente
desiderabili. Per risolvere il problema, il legislatore può internalizzare le esternalità tassando i beni
la cui produzione presenta esternalità negative e sussidiando quelli che genera esternalità positive.
Le esternalità sono causa di inefficienza, ma non sempre è necessario l’intervento dello Stato per
risolvere il problema. Il alcune circostanza si possono mettere in atto soluzioni private. A volte il
problema delle esternalità può essere risolto attraverso codici etici o sanzioni sociali. Un’altra
soluzione privata al problema è la beneficenza e l’attività di enti e fondazioni deputati a gestirla
oppure il mercato può gestire le esternalità con il sistema dei contratti. Quanto efficacemente il
mercato riesce a gestire le esternalità? I risultati del teorema di Coase dimostrano che il mercato
può essere molto efficace nella maggior parte delle circostanze. Secondo il teorema di Coase, se alle
parti in causa viene concesso di negoziare senza costi l’allocazione delle risorse, il mercato riesce
sempre a risolvere il problema delle esternalità e ad allocare le risorse in modo efficiente. In sintesi,
secondo teorema di Coase i soggetti economici privati possono risolvere il problema delle esternali-
tà senza l'intervento dello Stato. Qualunque sia la distribuzione iniziale dei diritti, le parti in causa
possono sempre negoziare un accordo grazie al quale tutti traggono vantaggio e il risultato sia
efficiente. Nonostante la logica cristallina del teorema di Coase, spesso i soggetti economici privati
non riescono a risolvere autonomamente il problema delle esternalità. Infatti, il teorema di Coase si
applica solo nel caso in cui le parti in causa non devono sostenere costi per raggiungere e mettere in
atto un accordo. Nella realtà, invece, non sempre i negozianti giungono a un risultato positivo,
anche se è possibile un accordo di mutuo vantaggio. A volte la ragione del fallimento delle trattative
dirette a risolvere un problema di esternalità riescono a causa dei costi di transazione, ovvero dei
costi in cui le parti incorrno allo scopo di raggiungere un accordo e metterlo in atto. Raggiungere un
accordo efficiente è particolarmente difficile quando le parti in causa sono molte perché, coordinare
molti individui, è costoso; vi sono altre due ragioni fondamentali per le quali raggiungere un accor-
do efficiente potrebbe essere impossibile: l'informazione asimmetrica e l'ipotesi del comportamento
razionale. Quando un esternalità provoca un'allocazione inefficiente delle risorse di mercato, lo Sta-
to può reagire in due modi: con provvedimenti di disposizione e di controllo e, quindi, regolando
direttamente i comportamenti o con politiche di mercato. Infatti, invece di regolamentare diretta-
mente i comportamenti, lo Stato può adottare provvedimenti fondati sui meccanismi del mercato per
allineare il sistema degli incentivi all'efficienza sociale. Le imposte introdotte per correggere gli
effetti di un'esternalità negativa sono dette imposte pigouviane. Un'imposta pigouviana definisce
un prezzo per diritto a inquinare. Come il mercato alloca un bene a quei compratori che gli attribuis-
cono il valore più elevato, così un'imposta pigouviana alloca l'inquinamento a quegli impianti
produttivi che dovrebbero sostenere il costo più alto per ridurlo. Qualunque sia il livello di inquina-
mento considerato socialmente accettabile, tale obiettivo potrà essere raggiunto al costo più basso
attraverso un'imposta correttiva. Gli economisti spesso argomento che un'imposta pigouviana sareb-
be più desiderabile anche per l'ambiente. A fronte di una regolamentazione delle emissioni, nessuna
impresa ha un incentivo a ridurre l'inquinamento al di sotto della soglia massima consentita; l'im-
posta invece incentiva le imprese a sviluppare tecnologie di produzione non inquinanti, dal momen-
23
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
to che attraverso queste potrebbero minimizzare, se non annullare, l'esborso. L'imposta pigouviana,
correggendo il sistema degli incentivi per tener conto delle esternalità, induce un'allocazione delle
risorse più prossima a quella socialmente desiderabile. Dunque, un'imposta pigouviana, pur gene-
rando entrate fiscali per lo Stato, riesce migliorare l'efficienza economica.
Uno dei vantaggi dei permessi di emissione negoziabili è che l’allocazione iniziale dei permessi è
influente ai fini dell’efficienza. Le imprese che hanno maggiore facilità nel ridurre le proprie emis-
sioni inquinanti saranno disposte a vendere tutti i permessi che detengono, mentre quelle che pos-
sono farlo solo a costi elevati sarebbero disposte ad acquistare tutti i permessi di cui hanno bisogno.
Se il mercato dei diritti di emissione di inquinanti è libero, l’allocazione finale sarà efficiente, indi-
pendentemente dall’allocazione iniziale. Sebbene ridurre l'inquinamento attribuendo permessi di
emissione possa sembrare molto diverso dall’applicazione di un'imposta correttiva, in realtà le due
strategie hanno molto in comune: in entrambi i casi le imprese devono pagare per le loro emissioni
inquinanti. Con un'imposta correttiva, le imprese inquinanti pagano un'imposta allo Stato; con i
permessi di emissione negoziabili, le imprese inquinanti pagano per acquisire i permessi.
In alcuni casi si possono trovare soluzioni private alle esternalità, ma è necessaria una qualche for-
ma di supporto giuridico per abilitarle. Uno di questi esempi è la definizione dei diritti di proprietà:
i diritti di proprietà garantiscono a un individuo, gruppo o organizzazione un diritto esclusivo sulla
destinazione e l'uso di una risorsa. L'estensione dei diritti di proprietà comporta anche che il propri-
etario di una risorsa possa esercitare il diritto di venderla o condividerla, se lo ritiene opportuno, a
un prezzo convenuto e accettato. L'attribuzione di diritti di proprietà permette a individui, gruppi e
organizzazioni di giungere a soluzioni efficienti. L'estensione dei diritti di proprietà presenta, però,
alcuni problemi; come possibile ripartire i diritti di proprietà su risorse come l'aria, il mare, un fiu-
me o la terra? Il costo di definire tali diritti e di trovare un accordo internazionale sulle implicazioni
di un simile sistema è molto elevato e potrebbe annullare i benefici sociali che ne potrebbero deriva-
re. Alcuni ambientalisti affermano che, in un certo senso, sia moralmente sbagliato permettere a
chiunque di inquinare in cambio della corresponsione di un prezzo. Come si può attribuire un prez-
zo all'aria pulita o all'acqua limpida? L'ambiente è talmente importante, affermano, che dobbiamo
proteggerlo a qualunque costo. Gli economisti hanno scarsa simpatia per questo genere di argomen-
tazioni. Come la domanda di ogni altro bene, anche quella di aria e acqua pulite risponde al prezzo:
quanto più basso è il costo della tutela dell'ambiente, tanto più le persone ne faranno richiesta. L'ap-
proccio economico dell’imposta pigouviana o dei permessi di emissione negoziabili riduce il costo
della protezione dell'ambiente e, perciò, dovrebbe far aumentare la domanda di ambiente pulito.
CAPITOLO 11: I BENI PUBBLICI E LE RISORSE COLLETTIVE
I beni gratuiti rappresentano una sfida particolare all’analisi economica: beni e servizi, nei nostri
sistemi economici, vengono allocati perlopiù da mercati nei quali i compratori pagano per ricevere e
i venditori vengono pagati per ciò che forniscono. Il prezzo è quindi il punto di riferimento per le
decisioni di venditori e compratori e, tali decisioni, portano a un’allocazione efficiente delle risorse.
Se i beni sono disponibili gratuitamente, invece, le forze del mercato che normalmente presiedono
all’allocazione delle risorse non si possono esprimere. Quando un bene non ha prezzo, i mercati non
possono assicurare che esso venga prodotto e consumato in quantità appropriate: in questo caso
l’intervento dello Stato può potenzialmente rimediare al fallimento del mercato e far aumentare il
benessere economico. Qual è l’efficacia del marcato nel fornire un bene a chi lo desidera? La
risposta dipende dal tipo di bene. Nel pensare ai beni presenti in un sistema economico, può essere
utile raggrupparli secondo due caratteristiche: il bene esclusivo e il bene rivale. Ricorrendo a queste
due categorie, possiamo dividere i beni in quattro tipi:
1. i beni privati che sono esclusivi e rivali nel consumo
2. i beni pubblici che non sono né esclusivi, né rivali nel consumo; questo significa che non si può
impedire a qualcuno di fruire di questi beni e che il fatto che un individuo ne fruisca non
impedisce ad altri di fare altrettanto
3. le risorse collettive sono, invece, rivali nel consumo ma non esclusive
4. infine, se un bene è esclusivo ma non rivale nel consumo, è un esempio di bene prodotto da un
monopolio naturale
24
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Un free rider è un individuo che gode del vantaggio di un bene senza pagarne il prezzo. Poiché i
beni pubblici sono non esclusivi, il problema del free rider impedisce al marcato privato di fornirli.
Lo Stato, tuttavia, può potenzialmente rimediare al problema. Se lo Stato o un altro operatore pub-
blico stabilisce che i costi di un bene pubblico sono inferiori ai benefici, può fornire il bene, finanzi-
ando con le entrate fiscali e far aumentare il benessere economico.
Lo Stato fornisce i beni pubblici perché il mercato privato, lasciato a se stesso, non riuscirebbe a
produrre una quantità efficiente. Ma stabilire che lo Stato debba avere uno in tal senso è solo un pri-
mo passo: lo Stato deve anche determinare quali beni pubblici fornire e in quale quantità. Per pren-
dere una decisione, lo Stato incarica un gruppo di economisti e di tecnici di eseguire uno studio,
detto analisi costi-benefici, il cui obiettivo è la stima del costo totale e dei benefici del progetto per
la società nel suo complesso. Analizzare e comprare costi e benefici è un compito difficile in quanto
l'analisi dei costi-benefici non si può fondare su alcun segnale di prezzo per valutare se lo Stato deb-
ba fornire un bene pubblico e in che misura. Per questa ragione i risultati delle analisi costi-benefici
sono, nel migliore dei casi, rozze approssimazioni. Le risorse collettive, come beni pubblici, sono
non esclusive: sono infatti disponibile gratuitamente per chiunque le voglia sfruttare. Ma, diversa-
mente dai beni pubblici, le risorse collettive sono rivali nel consumo: l'uso di una risorsa collettiva
da parte di un individuo può impedire ad altri individui di goderne. Dunque, le risorse collettive
sollevano un nuovo problema: una volta che il bene è stato reso disponibile, lo Stato si deve preoc-
cupare di quanto e come viene usato. Il migliore esempio per comprendere questo problema è una
parabola classica: la tragedia di terreni comuni. La tragedia dei terreni comuni è un esempio parti-
colare che ci permette di trarre una conclusione di carattere generale: quando l'individuo sfrutta la
risorsa collettiva, impedisce ad altri di goderne nella stessa misura. A causa di tale esternalità nega-
tiva le risorse collettive tendono a essere sfruttate eccessivamente. Lo Stato può risolvere il proble-
ma attraverso provvedimenti di regolamentazione o introducendo forme di tassazione. In alternativa
lo Stato a volte può trasformare la risorsa collettiva in un bene privato.
CAPITOLO 13: I COSTI DI PRODUZIONE
L’organizzazione industriale studia come le decisioni dell’impresa relative a prezzi e quantità da
offrire siano condizionate dalla situazione del mercato in cui essa opera. Gli economisti ipotizzano
che l'obiettivo dell'impresa sia la massimizzazione del profitto. Ma, che cos'è il profitto? La somma
che l'impresa incassa complessivamente per la vendita del proprio prodotto è il ricavo totale. La
somma che l'impresa spende complessivamente per acquistare i fattori di produzione è il costo
totale; definiamo profitto la differenza tra ricavo totale e costo totale, cioè:
profitto = ricavo totale - costo totale
possiamo riscrivere questa espressione come π = RT – CT, dove π rappresenta il profitto. I costi che
richiedono a un esborso di denaro da parte dell'impresa sono costi espliciti; ci sono, però, anche dei
costi impliciti ai quali non corrisponde un movimento di denaro. Questa distinzione tra costi impli-
citi ed espliciti sottolinea una differenza importante tra il punto di vista dell'economista e quello del
contabile nell'analisi delle attività economiche. Gli economisti sono interessati a studiare le moda-
lità secondo le quali le imprese prendono le proprie decisioni di prezzo e di produzione e, perciò,
nel valutare i costi, prendono in considerazione tutti i così-opportunità. I contabili, invece, si limi-
tano a registrare tutti i movimenti monetari da e verso l'impresa e prendono in considerazione i soli
costi espliciti, ignorando quasi completamente quelli impliciti. Economisti e contabili misurano i
costi, e quindi profitto, in maniera diversa. L’economista misura il profitto economico, sottraendo al
ricavo totale tutti i costi-opportunità (espliciti e impliciti) connessi con la produzione e la vendita
del bene o del servizio. Il contabile misura il profitto contabile dell'impresa, sottraendo la ricavo
totale solo i costi espliciti. Il profitto contabile, non prendendo in considerazione costi impliciti, è
sempre maggiore del profitto economico. Dal punto di vista dell'economista un'impresa genera pro-
fitto solo se il suo ricavo totale è superiore a tutti i costi-opportunità espliciti ed impliciti.
La relazione che intercorre tra la quantità di fattori e la quantità di prodotto è detta funzione di pro-
duzione. Il prodotto marginale di un fattore di produzione è l’aumento della quantità prodotta che si
ottiene aumentando di una unità il fattore stesso. Il costo totale può essere suddiviso in due
25
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
componenti: i costi fissi che sono indipendenti dalla quantità prodotta e sussistono anche se la quan-
tità prodotta è nulla e i costi variabili che, invece, variano in funzione della quantità prodotta. Va da
se che il costo totale dell’impresa è uguale alla somma di costi fissi e costi variabili.
Per trovare il costo medio dell’unità prodotta bisogna dividere il costo totale per la quantità prodot-
ta. Il costo totale diviso per la quantità prodotta è detto costo medio totale. Poiché il costo totale non
è che la somma di costi fissi e costi variabili, il costo medio totale può essere espresso a sua volta
come la somma del costo medio fisso e del costo medio variabile. Il costo medio fisso è pari al tota-
le dei costi fissi diviso per la quantità prodotta; il costo medio variabile è pari al totale dei costi vari-
abili diviso per la quantità prodotta. Il costo medio totale misura il costo della tipica unità di prodot-
to e poco dice su come il costo totale cambia al variare della quantità prodotta. Questo valore è det-
to costo marginale.
Costo totale CT
Costo medio totale (CMeT) =
Quantità Q
e
Variazione del cos to totale CT
Costo marginale (CM) = Variazione della quantità Q
Le curve del costo medio totale (CmeT), la curva del costo medio fisso (CMeF), la curva di costo
medio variabile (CMeV) e la curva del costo marginale (CM) hanno in comune tre caratteristiche
peculiari:
1. la forma della curva di costo marginale: il costo marginale aumenta all’aumentare della quantità
prodotta a causa del prodotto marginale decrescente
2. la forma della curva di costo medio totale: la curva di costo medio totale ha una forma a U. Per
comprendere la ragione, si ricordi che il costo medio totale è uguale alla somma del costo medio
fisso e del costo medio variabile. Il costo medio fisso diminuisce progressivamente all’aumenta-
re della produzione, dal momento che un ammontare predeterminato viene ripartito su una base
di produzione più ampia; il costo medio variabile aumenta più che proporzionalmente al cresce-
re della produzione a causa del prodotto marginale decrescente. La curva di costo medio totale
riflette entrambe le caratteristiche: a livelli molto bassi di produzione il costo medio totale è ele-
vato perché il costo fissi si ripartisce su una base di produzione ristrettissima; poi il costo medio
totale diminuisce progressivamente fino a raggiungere un minimo. Il punto più basso della curva
a U corrisponde alla quantità che minimizza il costo medio totale, tale quantità è definita dimen-
sione efficiente dell’impresa
3. la relazione tra costo marginale e costo medio totale: se il costo marginale è inferiore al costo
medio totale, il costo medio totale è decrescente mentre, se è superiore, il costo medio totale è
crescente. Se il costo dell’unità aggiuntiva di prodotto è maggiore del costo medio delle unità
prodotte fino a quel punto, il nuovo costo medio tenderà ad aumentare. Ma il costo di un’unità
aggiuntiva è quello che gli economisti chiamano costo marginale, per cui ciò che abbiamo testé
asserito equivale ad affermare che, se il costo marginale è minore del costo medio, il costo me-
dio è decrescente; se, invece, il costo marginale è maggiore, il costo medio è crescente. Tale
relazione tra la curva di costo medio totale e la curva di costo marginale ha un importante corol-
lario: la curva di costo marginale interseca quella di costo medio totale nel suo punto di minimo,
corrispondente alla dimensione efficiente. Perché? Per bassi livelli di produzione la curva di
costo marginale si colloca al di sotto di quella di costo medio totale quindi, quest’ultima, è de-
crescente; ma dopo l’intersezione delle due curve la curva di costo marginale si colloca al di
sopra di quella di costo medio totale quindi, quest’ultima, è crescente. Per la ragione appena il-
lustrata, il costo medio totale deve cominciare a crescere esattamente nel punto di intersezione
delle due curve, che non potrà che essere il punto minimo della curva stessa.
Per molte imprese la suddivisione dei costi tra fissi e variabili dipende dall’organizzazione tempora-
le presa in considerazione. Poiché molte decisioni sono fisse nel breve periodo ma variabili nel lun-
go periodo, la curva di costo di lungo periodo di un’impresa è diversa da quella di breve periodo. La
curva di costo medio totale di lungo periodo ha una forma più appiattita della curva di costo medio
totale nel breve periodo. Inoltre, tutte le curve di breve periodo giacciono al di sopra o sulla curva di
26
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
lungo periodo. Tali proprietà discendono dal fatto che le imprese godono di una maggiore flessibili-
tà nel lungo periodo. In sintesi, nel lungo periodo l’impresa sceglie quale curva di breve periodo vu-
ole usare ma, nel breve periodo, l’impresa deve usare la curva di breve periodo scelta nel passato.
La forma delle curve di costo medio totale di breve e lungo periodo suggerisce importanti conside-
razioni sulla tecnologia di produzione di un bene. Se il costo medio totale di lungo periodo diminui-
sce al crescere della quantità prodotta vanno a realizzarsi economie di scala. Se il costo medio tota-
le di lungo periodo cresce al crescere della quantità prodotta si realizzano delle diseconomie di sca-
la. Se il costo medio totale di lungo periodo resta invariato al variare della quantità prodotta, la pro-
duzione presenta rendimenti di scala costanti. Cosa provoca le economie o le diseconomie di scala?
Le economie di scala spesso si generano perché volumi più elevati di produzione consentono di
strutturare la specializzazione dei lavoratori, permettendo a ciascuno di loro di massimizzare la pro-
pria produttività in una specifica mansione. Le diseconomie di scala sono provocate spesso da pro-
blemi di coordinamento impliciti in qualsiasi organizzazione di grandi dimensioni. Questa analisi
spiega perché le curve di costo medio di lungo periodo hanno sovente forma a U. Per bassi livelli di
produzione l’impresa trae beneficio dall’aumento delle dimensioni perché gode degli effetti di una
maggiore specializzazione senza patire di danni causati dai problemi di coordinamento. A elevati
volumi di produzione tutti i benefici della specializzazione del lavoro sono già sfruttati e i pro-blemi
di coordinamento si aggravano al crescere della dimensione aziendale. Dunque la curva di costo
medio di lungo periodo è decrescente a bassi volumi di produzione grazie ai benefici della specia-
lizzazione e crescente a elevati volumi di produzione a causa dei problemi di coordinamento.
Espressione
Termine Definizione
aritmetica
Costo esplicito Costo che comporta un flusso di denaro -
Costo implicito Costo che non comporta un flusso di denaro -
Costo fisso Costo che non varia al variare della quantità prodotta CF
Costo variabile Costo che varia al variare della quantità prodotta CV
Valore di mercato di tutti i fattori utilizzati nella
Costo totale CT = CF + CV
produzione
Costo medio
Costo fisso diviso per la quantità prodotta CMeF = CF/Q
fisso
Coso medio
Costo variabile diviso per la quantità prodotta CMeV = CV/Q
variabile
Costo medio
Costo totale diviso per la quantità prodotta CMeT = CT/Q
totale
Aumento del costo totale indotto da un aumento unitario
Costo marginale CM = ∆CT/∆Q
della quantità prodotta
CAPITOLO 14: LE IMPRESE IN UN MERCATO CONCORRENZIALE
Un mercato è detto concorrenziale se ogni compratore e ogni venditore è così piccolo, rispetto alla
dimensione del mercato, da non poter influenzare il prezzo con le proprie decisioni. Se, al contrario,
le singole imprese sono in condizione di poter influenzare il prezzo del bene che producono e ven-
dono, si dice che godono di un potere di mercato. Il termine “concorrenza” si riferisce a una situa-
zione nella quale la presenza di più produttori rivali permette al consumatore di operare una scelta.
Compratori e venditori in un mercato concorrenziale devono accettare il prezzo che il mercato stes-
so determina e, perciò, si dice che subiscono il prezzo (o sono price taker). Un’impresa in un merca-
to concorrenziale ha per obiettivo la massimizzazione del profitto, che è pari alla differenza tra il ri-
cavo totale e costo totale. Il ricavo medio indica quanto incassa in media l’impresa per unità di pro-
dotto venduta ed è dato dal ricavo totale diviso per la quantità prodotta. Il ricavo totale è invece
uguale al prezzo per la quantità (PxQ) e il ricavo medio è uguale al ricavo totale (PxQ) diviso per la
quantità venduta (Q) quindi, per tutte le imprese, il ricavo medio è uguale al prezzo del bene. Il rica-
vo marginale, invece, è la variazione del ricavo totale generata da un aumento unitario della quanti-
tà venduta. In base a ciò c’è una considerazione di carattere generale che si applica in un mercato
27
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
concorrenziale: il ricavo totale è PxQ e P, in un mercato concorrenziale, è una costante; perciò,
quando Q aumenta di una unità, il ricavo totale aumenta di P; per le imprese operanti in regime di
concorrenza, il ricavo marginale è uguale al prezzo.
L’obiettivo dell’impresa operante in regime di concorrenza è la massimizzazione del profitto, ovve-
ro della differenza tra ricavo totale e costo totale. Il valore del profitto viene calcolato sottraendo il
costo totale al ricavo totale. Se il ricavo marginale è maggiore del costo marginale, per l’impresa è
conveniente aumentare la produzione mentre, sempre a livello di produzione che massimizza il
profitto, il ricavo marginale è esattamente uguale al costo marginale. Ora si può stabilire come
l’impresa concorrenziale decide la quantità da offrire nel mercato. Poiché subisce il prezzo, il suo
ricavo marginale è uguale al prezzo di mercato; per ogni dato prezzo di mercato, la quantità che
massimizza il profitto dell’impresa operante in regime di concorrenza può essere individuata all’in-
tersezione del livello del prezzo con la curva del costo marginale (QMAX).
Fino a questo punto ci siamo occupati di quanto un’impresa dovrebbe produrre ci sono, però, circo-
stanze nelle quali un’impresa può decidere di non produrre. A questo punto è necessario distinguere
tra una sospensione temporanea della produzione e l’uscita permanente dell’impresa del mercato.
La sospensione della produzione è la decisione di non produrre a breve termine durante un periodo
specifico e a causa di condizioni presumibilmente contingenti al mercato. L’uscita dal mercato è,
invece, una decisione di lungo periodo che riguarda la sopravvivenza stessa dell’impresa. L’impresa
sospende la produzione se il ricavo che otterrebbe restando in attività è inferiore ai suoi costi varia-
bili di produzione; infetti, non vale la pena produrre un bene che costa più del ricavo generato attra-
verso la vendita. Se l’impresa continuasse a produrre, vedrebbe diminuire i profitti o aumentare le
perdite esistenti. Se RT è il ricavo totale e CV il costo variabile, la decisione dell’impresa può esse-
re scritta a livello matematico come:
Sospendere la produzione se RT < CV
Dunque l’impresa sospende la produzione se il ricavo totale è inferiore al costo variabile. Dividendo
entrambi gli elementi per la quantità prodotta Q otteniamo:
Sospendere la produzione se (RT/Q) < (CV/Q)
Questa formulazione può essere semplificata ricordando che RT/Q, ovvero il rapporto tra ricavo to-
tale e quantità prodotta, è semplicemente il ricavo medio che corrisponde al prezzo del prodotto P.
Analogamente, CV/Q corrisponde al costo medio variabile CMeV. Dunque il criterio che l’impresa
segue per decidere se sospendere la produzione è:
Sospendere la produzione se P < CMeV
Ovvero, un’impresa decide di sospendere la produzione se il prezzo di mercato è inferiore al proprio
costo medio. Gli economisti definiscono costi sommersi quei costi che non possono essere recuper-
ati. In un certo senso, un costo sommerso è l’opposto di un costo-opportunità: quest’ultimo è ciò a
cui si deve rinunciare a fronte di una scelta, il primo è un costo che non può essere recuperato, indi-
pendentemente dalle scelte effettuate.
I parametri sulla base dei quali un’impresa decide se entrare o uscire dal mercato sono analoghi a
quelli considerati per la sospensione della produzione; in questo caso però, l’effetto della decisione
è quello di annullare i costi fissi, insieme a quelli variabili. Per questa ragione l’impresa esce dal
mercato se il ricavo che trae dalla produzione è inferiore al costo totale. Secondo la formula mate-
matica se RT è il ricavo totale e CT è il costo totale, il criterio adottato dall’impresa sarà:
Uscire dal mercato se RT < CT
L’impresa esce dal mercato se il ricavo totale è inferiore al costo totale. Dividendo entrambe le parti
per la quantità Q otteniamo:
28
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Uscire dal mercato se (RT/Q) < (CT/Q)
Tale espressione può essere ulteriormente semplificata ricordando che RT/Q corrisponde a ricavo
medio, che a sua volta è uguale al prezzo P e che CT/Q è il costo medio totale, CMeT. Perciò pos-
siamo descrivere il criterio dell'impresa come:
Uscire dal mercato se P < CmeT
Dunque l’impresa decide di uscire dal mercato se il prezzo del bene è inferiore al costo medio totale
di produzione. Il criterio di entrata è esattamente speculare a quello di uscita: l’impresa entrerà nel
mercato se in conseguenza di tale decisione potrà ottenere per il bene prodotto un prezzo superiore
al costo medio totale di produzione. Il criterio di entrata è quindi:
Entrata nel mercato se P > CMeT
Il profitto è uguale alla differenza tra ricavo totale (RT) e costo totale (CT) quindi si ha che il profit-
to = RT – CT. Si può scrivere l'eguaglianza moltiplicando e dividendo la sua parte destra per la
quantità Q: profitto = (RT/Q – CT/Q) x Q. Poiché RT/Q è il ricavo medio, che corrisponde a prezzo
P, e CT/Q è il costo medio totale CMeT si ottiene: profitto = (P – CMeT) x Q. Un'impresa può rea-
lizzare un profitto positivo o negativo.
Quando un’impresa realizza un profitto
positivo, l’altezza del rettangolo è pari a
(P – CMeT), ovvero alla differenza tra il
prezzo e il costo medio totale; la sua base
è pari alla quantità Q; la superficie del
rettangolo, che è data dal prodotto di base
e altezza, è pari quindi a:
(P - CMeT ) x Q, ovvero al profitto
dell’impresa.
Analogamente, viene mostrato il caso di
un’impresa che subisce una perdita,
ovvero che realizza un profitto negativo.
In questo caso la massimizzazione del
profitto corrisponde alla massimizza-
zione della perdita. Pendendo in
considerazione il rettangolo evidenziato,
notiamo che la sua altezza è (P – CMeT)
e la sua base è Q; ne consegue che la
superficie del rettangolo (P – CMeT) x Q
è il profitto (negativo) dell’impresa.
Poiché nel caso esemplificato l’impresa
non è nella condizione di coprire il
proprio costo medio totale.
29
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Passiamo ora alla curva di offerta del mercato affrontando due casi distinti: un mercato con un
numero limitato di imprese e un mercato in cui le imprese possono entrare e uscire liberamente,
facendo variare il numero dei soggetti offerenti. Entrambi i casi sono rilevanti dal mo-mento che
riflettono due orizzonti temporali diversi: il breve e il lungo periodo
• nel breve periodo, offerta di mercato con numero fisso di imprese: consideriamo l’ipotesi di un
mercato nel quale operano un tot di imprese identiche: a ogni dato livello di prezzo, ciascuna
impresa produce la quantità di prodotto per la quale il prezzo è uguale al costo marginale. Ques-
to significa che, finché il prezzo è superiore al costo medio variabile, la curva di costo marginale
di ciascuna impresa è la sua curva di offerta. Dato che tutte le imprese sono identiche, la quanti-
tà offerta sul mercato è mille volte quella offerta dalla singola impresa a ogni dato livello di
prezzo
• nel lungo periodo, offerta di mercato con libertà di entrata e uscita: ricordando che la formula
del profitto economico è (P – CMeT) x Q si deduce che un’impresa attiva realizza un profitto
economico nullo solo se il prezzo è uguale al costo medio totale di produzione del bene. Se il
prezzo è superiore al costo medio totale, il profitto è positivo e nuove imprese hanno un incen-
tivo a entrare nel mercato: se il prezzo è inferiore al costo medio totale, il profitto è negativo e le
imprese esistenti hanno un incentivo a uscire dal mercato. Il processo di entrata e uscita ha
termine solo quando il prezzo è uguale al costo medio totale. In questo caso, l’equilibrio di
lungo periodo di un mercato concorrenziale con libertà di entrata e di uscita si ottiene quando
tutte le imprese operano alla propria dimensione efficiente (produzione corrispondente al costo
medio totale minimo). Se c’è libertà di entrata nel (e di uscita dal) mercato, un unico livello di
prezzo è coerente con il profitto nullo: il costo medio totale minimo; perciò la curva di offerta di
mercato di lungo periodo è una retta orizzontale a questo livello di prezzo. Qualunque prezzo
superiore a questo incentiva l’entrata di nuove imprese mentre qualunque prezzo inferiore a
questo provoca perdite con conseguente uscita delle imprese dal mercato.
A prima vista potrebbe sembrare strano che imprese di concorrenza perfetta realizzino un profitto
nullo nel lungo periodo. Spesso ci si riferisce al profitto nullo come a una situ-azione nella quale
l’impresa realizza un profitto normale: l’ammontare minimo di profitto necessa-rio per mantenere
i fattori nell’uso a cui sono stati destinati. Si rammenti che i contabili misurano i costi in maniera
diversa dagli economisti di conseguenza, nell’equilibrio con profitto nullo è il pro-fitto economico
ad avere valore zero, mentre il profitto contabile è positivo. Nel breve periodo il profitto può essere
maggiore di zero, quindi maggiore del profitto normale: a questa situazione ci si riferisce spesso con
il termine di sovraprofitto.
Poiché le imprese possono entrare nel (e uscire dal) mercato nel luogo ma non nel breve periodo, le
reazioni di un mercato alle variazioni della domanda hanno effetti diversi a seconda dell’orizzonte
temporale di riferimento. Se la domanda del bene aumenta, il risultato di lungo periodo è un
aumento del numero delle imprese presenti nel mercato e della quantità totale offerta, senza alcun
cambiamento di prezzo. Tuttavia, la curva di offerta di mercato di lungo periodo potrebbe avere
pendenza positiva, per due ragioni. La prima è che alcune delle risorse utilizzate nella produzione
potrebbero essere disponibili solo in quantità limitate. La seconda ragione è che imprese diverse
potrebbero avere costi differenti. Si noti che, se le imprese hanno profili di costo diversi, alcune
realizzano un profitto anche nel lungo periodo. In questo caso il prezzo di mercato corrisponderà al
costo medio totale dell’impresa marginale, cioè della prima che uscirebbe dal mercato se il prezzo
diminuisce. Tale impresa realizza profitti nulli, ma quelle che presentano costi inferiori realizzano
un profitto positivo; l’entrata di nuove imprese nel mercato non annulla i profitti, perché i potenziali
entranti hanno costi più elevati delle imprese già presenti nel mercato, e le nuove imprese entrano
nel mercato solo se il prezzo aumenta abbastanza da rendere l’ingresso nel mercato profittevole
anche per loro. Dunque, per queste due ragioni, la curva di offerta di mercato di lungo periodo
potrebbe avere pendenza positiva, invece di essere orizzontale; in questo caso si rende necessario un
aumento del prezzo per indurre un aumento della produzione. Dato che le imprese possono entrare o
uscire con maggiore facilità nel lungo periodo, la curva di offerta di mercato di lungo periodo è soli-
tamente più elastica di quella di breve periodo.
30
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
CAPITOLO 15: IL MONOPOLIO
L’impresa in concorrenza perfetta subisce il prezzo mentre, l’impresa in regime di monopolio lo
determina: i monopolisti fanno pagare prezzi elevati per i loro prodotti e gli acquirenti non hanno
altra alternativa che sborsare qualsiasi cifra venga loro richiesta dal monopolista. Il monopolista può
determinare il prezzo del bene che produce ma le sue possibilità di profitto non sono illimitate.
L’obiettivo delle imprese monopolistiche, come in quelle concorrenziali, è la massimizzazione del
profitto. Un’impresa è in un monopolio quando è l’unico venditore di un bene per il quale non esi-
stono buoni sostituti. La causa fondamentale del monopolio sono le barriere all’entrata: un mono-
polista è l’unico venditore presente nel mercato perché altre imprese non possono entrarvi e compe-
tere con lui. Le barriere dell’entrata vengono generate da quattro principali ordini di cause:
1. una risorsa chiave è detenuta da un’unica impresa
2. lo stato concede a un’unica impresa il diritto esclusivo di produrre un bene
3. la struttura dei costi di produzione rende la singola impresa più efficiente di una molteplicità di
produttori: un settore è un monopolio naturale se una singola impresa può fornire il bene o il
servizio all’intero mercato a costi inferiori rispetto a quelli sostenuti da una molteplicità di im-
prese. Si crea generalmente un monopolio naturale quando si registrano economie di scala
rilevanti su un ampio intervallo di produzione. Quando gode di un monopolio naturale un’im-
presa non teme che nuovi concorrenti possano entrare nel mercato ed erodere il suo potere mo-
nopolistico. Normalmente, se non ha l’esclusiva di una risorsa o non è garantita dalla protezione
dello Stato, un’impresa ha problemi a mantenere la propria posizione di monopolio: il profitto
del monopolista è molto attraente per i potenziali entranti e le nuove entrate rendono il mercato
più concorrenziale. Ma entrare in un mercato nel quale l’impresa dominane ha un monopolio
naturale non è affatto allettante: i potenziali entranti sanno di non potere mai raggiungere il me-
desimo livello di costo del monopolista perché, a ogni nuova entrata, ogni impresa può contare
su una quota sempre più ridotta di mercato
4. un’impresa è in grado di acquisire il controllo delle altre imprese che agiscono nel medesimo
mercato, crescendo in dimensioni: molte delle più grandi imprese al mondo sono conosciute
tramite acquisizioni, fusioni o offerte pubbliche d’acquisto di altre società. Quando questo ac-
cade, il settore in cui operano diventa più concentrato poiché il numero di imprese che operano
nel settore diminuisce
La differenza fondamentale tra l’impresa concorrenziale e quella monopolistica è la capacità di
quest’ultima di influenzare il prezzo di mercato del proprio prodotto. Analizzando la massimizza-
zione del profitto dell’impresa concorrenziale, graficamente il prezzo di mercato viene descritto
come una retta orizzontale. Dato che l’impresa concorrenziale può vendere qualsiasi quantità a quel
prezzo, anche la sua curva di domanda è orizzontale. L’impresa monopolistica, invece, essendo
l’unico produttore, ha una curva di domanda che corrisponde alla domanda di mercato. Il monopo-
lista, quindi, interagisce con una curva di domanda con pendenza negativa. La curva di domanda di
mercato limita la capacità del monopolista di sfruttare il proprio potere di mercato. Se potesse, il
monopolista preferirebbe vendere enormi quantità del bene che produce a prezzi esorbitanti, ma ciò
è possibile data la struttura della domanda di mercato. In particolare, la curva di domanda di merca-
to descrive combinazioni di prezzo e quantità che il monopolista ha a disposizione: aggiustando la
quantità prodotta, il monopolista può scegliere di collocarsi in qualunque punto della curva di do-
manda, ma mai al di fuori di essa. Il ricavo marginale di un'impresa monopolistica è sempre infe-
riore al prezzo: questa situazione è implicita nel fatto che il monopolista interagisce con una curva
di domanda con pendenza negativa e quindi, per poter vendere una quantità superiore del bene,
l'impresa deve offrirlo a un prezzo più basso. Il ricavo marginale ha, dunque, un andamento molto
diverso per il monopolista e per l’impresa operante in regime di concorrenza. Quando il monopoli-
sta aumenta la quantità venduta, sortisce due effetti sul ricavo totale (PxQ):
• l'effetto produzione: aumenta la quantità venduta quindi Q è maggiore e ciò tende a far
aumentare il ricavo totale
• l'effetto prezzo: il prezzo diminuisce quindi P è minore e ciò tende a far diminuire il ricavo
totale
31
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Dal momento che il regime di concorrenza la singola impresa subisce il prezzo, il ricavo marginale
è uguale al prezzo; in regime di monopolio, invece, se l'impresa aumenta la produzione di 1 unità,
deve ridurre il prezzo per tutte le unità vendute. Di conseguenza, il ricavo marginale del monopoli-
sta è sempre inferiore al prezzo e può avere valore negativo: ciò avviene quando l'effetto prezzo è
superiore all’effetto produzione; in questo caso produrre 1 unità aggiuntiva provoca un calo del
prezzo tale da determinare la diminuzione del ricavo totale, nonostante l'aumento della quantità
venduta.
Dopo aver esaminato il ricavo
dell'impresa monopolistica, si è pronti
per esaminare come questa proceda alla
massimizzazione del profitto. Le curve
di domanda, di ricavo marginale e di
costo di un’impresa monopolistica
hanno tutte le informazioni necessarie
per determinare il livello di produzione
che massimizza il profitto. Per prima
cosa, ipotizziamo che monopolista abbia
scelto un basso livello di produzione
individuato da Q1: in questa situazione il
costo marginale è inferiore al ricavo
marginale e l'impresa può aumentare il
profitto aumentando la produzione. Il
ragionamento è analogo nel caso che
l’impresa scelga un elevato livello di
produzione, individuato da Q2: in questo caso, il costo marginale è superiore al ricavo marginale e
l'impresa può aumentare il profitto dimi-nuendo la produzione. Alla fine l'impresa monopolistica
tenderà a collocarsi a un livello di produzi-one QMAX per il quale il ricavo marginale è uguale al
costo marginale. Pertanto la quantità di pro-dotto che massimizza il profitto del monopolista viene
determinata dall'intersezione delle curve di costo marginale e di ricavo marginale nel punto A. Sia
in un'impresa concorrenziale che in una monopolistica la quantità che massimizza il profitto
corrisponde all’uguaglianza tra ricavo margina-le e costo marginale. La differenza sta nel rapporto
tra prezzo, ricavo marginale e costo marginale, infatti, il ricavo marginale dell'impresa
concorrenziale è uguale al prezzo, men-tre quello dell'impresa monopolistica è inferiore al prezzo.
In che modo il monopolista determina il prezzo del prodotto che massimizza il profitto? Attraverso
la curva di doman-da, poiché questa mette in relazione il prezzo che i consumatori sono disposti a
pagare con la quantità venduta. Da ciò consegue che, dopo aver individuato il livello di produzione
che permette di massimizzare il profitto eguagliando costo e ricavo marginale, il monopolista usa la
curva di domanda per individuare un prezzo coerente con tale quantità (nella figura è il punto B).
Ora si può determinare la differenza fondamentale tra i mercati concor-renziali e i mercati
monopolistici: nei mercati
concorrenziali il prezzo è uguale al costo
marginale mentre, nei mercati
monopolistici, il prezzo è maggiore del
ricavo marginale.
Quanto profitto genera il monopolio?
Per calcolarlo, ricordiamo che il profitto
è uguale al ricavo totale (RT) meno il
costo totale (CT); la formula può essere
riscritta come:
Profitto = (RT/Q – CT/Q) x Q
32
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
ma essendo RT/Q il ricavo medio, che equivale al prezzo P, e CT/Q il costo medio totale CMeT,
otteniamo:
Profitto = (P – CMeT) x Q
Questa equazione ci permette di pervenire a una rappresentazione grafica del profitto. Il rettangolo
in evidenzia ha un’altezza (segmento BC) pari alla differenza tra il prezzo e il costo medio totale (P
– CMeT) che corrisponde al profitto unitario, mentre la base (segmento DC) corrisponde alla
quantità venduta QMAX. L’area del rettangolo BCDE è quindi equivalente al profitto del
monopolista.
Possiamo valutare gli effetti del monopolio sul benessere mettendo a confronto il livello di produzi-
one scelto autonomamente dal monopolista con quello che verrebbe scelto dal pianificatore benevo-
lo. Come abbiamo visto, il monopolista si colloca a quel livello di produzione che gli permette di
eguagliare il ricavo marginale e costo marginale, mentre il pianificatore benevolo si colloca a quello
che eguaglia prezzo e costo marginale. Ma poiché il ricavo marginale è sempre inferiore al ricavo
medio (prezzo), il monopolista produce meno della quantità socialmente efficiente. Possiamo
considerare l'efficienza del monopolio dal punto di vista del prezzo monopolistico; poiché la curva
di domanda descrive una relazione negativa tra prezzo e la quantità del bene, a una quantità ineffici-
entemente bassa corrisponde un prezzo inefficientemente elevato e viceversa. Quando un monopoli-
sta pratica un prezzo superiore al costo marginale, alcuni potenziali consumatori attribuiscono al
bene un valore superiore al costo marginale ma inferiore al prezzo di monopolio e decidono di non
acquistarlo. Tuttavia, poiché il valore che tali consumatori attribuiscono al bene è superiore al costo
marginale, il risultato è inefficiente. Dunque, il prezzo di monopolio impedisce che si realizzino
scambi reciprocamente vantaggiosi. Ricordiamo che la curva di domanda riflette il valore del bene
per il consumatore e quella di costo marginale il costo del produttore monopolista quindi, l'area del
triangolo compreso tra la curva di domanda e la curva di costo marginale corrisponde alla perdita di
surplus totale provocata dalle decisioni di prezzo del monopolista. La perdita secca casa da un mo-
nopolio è analoga a quella provocata da un’impresa: in entrambi i casi, tale differenziale provoca
una caduta della quantità prodotta al di sotto del livello socialmente ottimo. La differenza tra i due
casi è che le imprese generano un’entrata per lo Stato, mentre monopolio crea profitto per l'impresa.
Fin qui si è ipotizzato che l’impresa monopolistica applichi il medesimo prezzo a tutti i propri cli-
enti. Ma in molti casi le imprese tentano di vendere lo stesso prodotto a consumatori diversi a prezzi
diversi: tale pratica è detta discriminazione di prezzo; ovviamente tale prassi è impossibile in un
mercato concorrenziale. La discriminazione di prezzo è una strategia razionale per il monopolista
che vuole massimizzare il profitto. Il monopolista può applicare a ogni cliente il prezzo massimo
che questi è disposto a pagare per il bene. La discriminazione di prezzo è possibile solo se si pos-
sono suddividere i consumatori sulla base della rispettiva disponibilità a pagare. Esistono, però, al-
cune forze di mercato che possono impedire la discriminazione di prezzo: una di queste è la pos-
sibilità di arbitraggio, ovvero di trarre vantaggio dai differenziali di prezzo acquistando a basso
prezzo in un mercato per vendere a prezzo più elevato nell’altro mercato. In ogni caso, però, la
discriminazione di prezzo fa aumentare il benessere economico.
Consideriamo più formalmente le conseguenze della discriminazione di prezzo sul benessere eco-
nomico. Ipotizziamo che il monopolista possa praticare una discriminazione di prezzo perfetta: que-
sto significa che il monopolista conosce esattamente la disponibilità a pagare di ogni singolo consu-
matore e applica a ciascuno un prezzo diverso. In questo caso il monopolista fa pagare a ciascun
consumatore esattamente quanto questi è disposto a pagare, accaparrandosi così l'intero surplus
generato da ogni transazione. In assenza di discriminazione, il monopolista stabilisce unico prezzo,
superiore a costo marginale; poiché alcuni potenziali consumatori non acquistano il bene, pur attri-
buendogli un valore superiore al costo marginale, il prezzo di monopolio provoca una perdita secca.
Invece, un’impresa che pratica una discriminazione di prezzo perfetta, applica a ogni consumatore
un prezzo quale alla sua disponibilità a pagare; in tal modo hanno luogo tutti gli scambi reciproca-
mente vantaggiosi, non si genera alcuna perdita secca e tutto il surplus che si genera nel mercato va
al monopolista in forma di profitti.
33
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
In tutti i paesi industrializzati vigono procedure di qualche sorta per impedire legalmente le fusioni
contrarie al pubblico interesse. La legislazione in materia di concorrenza copre tre ambiti principali:
1. il sanzionamento dei carrelli e delle imprese che attuano pratiche restrittive alla concorrenza
limitanti la libertà degli scambi
2. la proibizione delle strategie di prezzo anticoncorrenziali e di tutti i comportamenti che possono
portare a una limitazione della concorrenza
3. il controllo e la supervisione sulle operazioni di fusione e acquisizione
La legislazione permette alle autorità competenti di erogare sanzioni amministrative alle imprese
dichiarate colpevoli di comportamenti anticoncorrenziali, di ordinare alle imprese di modificare i
propri comportamenti e di evitare operazioni di fusione e acquisizione. Un altro modo in cui lo Sta-
to può affrontare il problema del monopolio è regolamentare il comportamento del monopolista. In
questo caso l'impresa non può determinare autonomamente il prezzo di ciò che vende, ma è costret-
ta ad applicare la tariffa imposta dalle autorità di controllo. Un’ulteriore strategia utilizzata dallo
Stato per gestire problema del monopolio è la proprietà pubblica: questo significa che, invece di re-
golamentare il comportamento del privato, lo Stato gestisce direttamente il monopolio naturale;
un'impresa di proprietà pubblica è detta “nazionalizzata”. Tutte le strategie per ridurre il problema
del monopolio che sono state descritte hanno, però, effetti collaterali negativi e, di conseguenza,
alcuni economisti sostengono che per lo Stato spesso sia meglio non cercare di porre rimedio alle
inefficienze generate dal prezzo di monopolio.
Concorrenza perfetta Monopolio
Analogie
Massimizzazione del Massimizzazione del
Obiettivo d’impresa
profitto profitto
Regola di massimizzazione RM = CM RM = CM
L’impresa può realizzare un profitto nel
Sì Sì
breve periodo?
Differenze
Numero di imprese Molte Una
Ricavo marginale RM = P RM < P
Prezzo P = CM P > CM
Raggiunge il livello di prodotto che
Sì No
massimizza il benessere?
Ingresso di nuove imprese nel lungo
Sì No
periodo?
L’impresa può realizzare profitti nel lungo
No Sì
periodo?
È possibile la discriminazione di prezzo? No Sì
N.B. Perché l’impresa monopolistica non ha una curva di offerta
Una curva di offerta descrive la quantità che l’impresa decide di produrre ogni dato livello di prez-
zo; questo concetto ha senso solo in un mercato concorrenziale dove le imprese subiscono il prezzo.
Non ha senso domandarsi quale sia la quantità che un’impresa monopolistica produce a ogni dato
prezzo dal momento che essa definisce il prezzo simultaneamente alla quantità offerta.
CAPITOLO 16: LA CONCORRENZA MONOPOLISTICA
La concorrenza monopolistica è una struttura di mercato che si trova tra i due casi limite della
concorrenza perfetta e del monopolio e descrive un mercato con le seguenti caratteristiche:
• molteplicità di venditori: molte imprese competono per lo stesso gruppo di consumatori
• differenziazione del prodotto: ogni impresa produce un prodotto leggermente differente da
quello dei concorrenti; invece di subire pezzo, si confronta con una curva di domanda con
pendenza negativa
34
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
• libertà di entrata: le imprese posso entrare nel (o uscire dal) mercato senza restrizioni, quindi il
numero delle imprese presenti nel mercato si aggiusta in modo da far tendere il profitto
economico a zero
In concorrenza monopolistica ci sono molti venditori, ciascuno dei quali ha dimensioni risibili
rispetto al mercato, ma offre un prodotto non perfettamente sostituibile a quello degli altri venditori:
e qui sta la differenza con il caso della concorrenza perfetta. Per massimizzare il profitto, l’impresa
in concorrenza monopolistica - come il monopolista – determina la quantità prodotta in modo che il
costo marginale sia uguale al ricavo marginale e definisce il prezzo sulla base della domanda, in
modo che sia coerente con quella quantità. La quantità che massimizza il profitto viene individuata
dall’intersezione della curva di costo marginale con quella di ricavo marginale e possiamo avere
due risultati diversi se andiamo ad analizzare la situazione dal punto di vista del profitto: il prezzo
può essere superiore al costo medio totale e quindi l'impresa realizza un profitto o il prezzo può
essere inferiore al costo medio totale e l'impresa, essendo incapace di realizzare un profitto positivo,
si limita a minimizzare le perdite. Un'impresa in concorrenza monopolistica determinata quantità e
prezzo esattamente come farebbe monopolista; nel breve periodo queste due strutture di mercato
sono sostanzialmente analoghe. Il profitto stimola l'ingresso di nuovi concorrenti e ciò provoca uno
spostamento verso sinistra della curva di domanda; al diminuire della domanda dei prodotti delle
imprese esistenti, i profitti subiscono una contrazione. Nel caso opposto, le perdite stimolano alcune
imprese ad uscire dal mercato; la loro uscita sposta verso destra la curva di domanda delle imprese
che rimangono in attività e questo provoca un aumento di profitto (o una diminuzione delle perdite).
Il processo di entrata e di uscita continua fintanto che le imprese sul mercato realizzano un profitto
(o subiscono una perdita). Raggiunto il punto di equilibrio, le nuove imprese non hanno alcun in-
centivo a entrare nel mercato, mentre le imprese presenti nel mercato non sono incentivate ad usci-
rne. Principalmente sono due le caratteristiche che descrivono l’equilibrio di lungo periodo in un
mercato in concorrenza monopolistica:
1. come un mercato monopolistico, il pezzo è superiore al costo marginale. Infatti la massimiz-
zazione del profitto impone l'uguaglianza di costo marginale ricavo marginale e, data una curva
di domanda con pendenza negativa, il ricavo marginale è sempre inferiore al prezzo
2. come in un mercato concorrenziale, il prezzo è uguale al costo medio totale; infatti, la libera
entrata nel (o uscita dal) mercato porta all’azzeramento del profitto
Mettendo a confronto l'equilibrio di lungo periodo di mercati in concorrenza monopolistica e in
concorrenza perfetta notiamo due differenze notevoli:
1. la capacità produttiva in eccesso: come abbiamo visto, l'entrata nel (e l'uscita dal) mercato po-
rtano tutte le imprese attive in un mercato in concorrenza monopolistica a collocarsi sul punto di
tangenza tra la curva di domanda e quella del costo medio totale. La quantità che massimizza il
costo medio totale viene detta dimensione efficiente. Nel lungo periodo le imprese in concor-
renza perfetta producono beni in quantità corrispondenti alla rispettiva dimensione efficiente
mentre, quelle in concorrenza monopolistica, producono quantità inferiore e, quindi, hanno
capacità produttiva in eccesso. In altre parole, l’impresa in concorrenza monopolistica, diversa-
mente dall’impresa perfettamente concorrenziale, potrebbe diminuire il proprio costo medio to-
tale aumentando la produzione
2. markup: una seconda differenza tra le due strutture di mercato si riscontra nella relazioni tra
prezzo e costo marginale. Per l'impresa in concorrenza perfetta il prezzo è uguale al costo mar-
ginale; per l'impresa in concorrenza monopolistica, il prezzo è superiore al costo marginale. Co-
me si spiega l'esistenza di markup (ricarico) sul costo marginale in condizioni di libertà di entra-
ta e profitto nullo? La condizione di profitto nullo impone soltanto che il prezzo sia uguale al
costo medio totale e nulla dice a proposito dell’eguaglianza tra prezzo e costo marginale. Infatti,
nel lungo periodo, l’impresa in concorrenza monopolistica opera nella porzione discendente del-
la curva di costo medio totale; quindi, se il prezzo è uguale al costo medio totale, deve essere
necessariamente superiore al costo marginale
Un’altra possibile inefficienza della concorrenza monopolistica è legata al numero delle imprese
che operano nel mercato. quando un’impresa decide di entrare in un mercato, lo fa prendendo in
considerazione i potenziali profitti futuri; ma l’entrata provoca anche due effetti esterni:
35
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
1. l’esternalità della varietà del prodotto: poiché i consumatori beneficiano di un certo surplus in
virtù dell’introduzione del nuovo prodotto, all’entrata sul mercato è associata un’esternalità
positiva
2. l’esternalità della sottrazione di quote di mercato: poiché le imprese perdono clienti a causa
dell’entrata di un nuovo concorrente nel mercato, a questa è associata un’esternalità negativa
Dunque, in un mercato in concorrenza monopolistica l’ingresso di nuove imprese nel mercato
genera esternalità sia negative che positive: in funzione della prevalenza dell’una o dell’altra, nel
mercato può essere presente un numero eccessivo o insufficiente di prodotti. Entrambe le esternalità
sono strettamente collegate alla caratteristiche strutturali del mercato. L’esternalità della varietà di
prodotto sorge perché la nuova impresa offre un prodotto diverso da quello delle altre; l’esternalità
della sottrazione di quote di mercato si verifica perché il nuovo entrante ha un prezzo superiore al
costo marginale ed è quindi sempre disposto a vendere unità aggiuntive di prodotto.
Oggi è quasi impossibile evitare il bombardamento della pubblicità. Tale comportamento è conna-
turato alla concorrenza monopolistica: quando nello stesso mercato sono attive molte imprese che
vendono prodotti differenziati e applicano prezzi superiori al costo marginale, ognuno di esse ha un
forte incentivo a pubblicizzare la propria attività, per attirare il maggior numero possibile di consu-
matori vero il proprio prodotto. L’investimento pubblicitario varia ampiamente da prodotto a pro-
dotto. Determinare il valore sociale della pubblicità è difficile e spesso genera accese diatribe tra gli
economisti. Chi critica la pubblicità afferma che le imprese investono in pubblicità per manipolare
le preferenze dei consumatori e che la maggior parte degli annunci pubblicitari ha carattere psicolo-
gico più che informativo: l'obiettivo dello spot è indurre a livello subconscio o addirittura sublimi-
nare un determinato messaggio. Chi critica la pubblicità afferma che questo tipo di annuncio genera
desideri che altrimenti non esisterebbero. I critici inoltre affermano che la pubblicità è un ostacolo
alla concorrenza, infatti, la pubblicità tenta spesso di convincere il pubblico che tra i prodotti ci sia
una differenza maggiore di quella che realmente esistente. I difensori della pubblicità affermano che
le imprese ricorrono alla pubblicità per diffondere presso i consumatori informazioni relative al pro-
dotto. La pubblicità comunica il prezzo dei beni offerti, segnala l'esistenza di nuovi prodotti e la lo-
calizzazione dei punti vendita, tutte informazioni che permettono al consumatore di formulare una
scelta d'acquisto migliore e, così, aumentano la capacità del mercato di allocare le risorse in maniera
efficiente. I fautori della pubblicità affermano anche che questa stimola la concorrenza permettendo
a tutti i consumatori di essere più informati sulle imprese che operano nel mercato e sui prodotti che
offrono. Molte tipologie di messaggi pubblicitari contengono poche informazioni esplicite sul
prodotto. I difensori della pubblicità affermano che anche i comunicati che sembrano non contenere
alcuna informazione utile in realtà possono dire al consumatore qualcosa sulla qualità del prodotto:
la volontà di un'impresa di spendere molto denaro nella pubblicità può essere di per sé un segnale
per il consumatore sulla qualità del prodotto offerto. L’informazione rilevante non è il contenuto del
comunicato, ma semplicemente la sua esistenza e l’investimento che comporta.
La pubblicità è strettamente legata al branding, ovvero alla differenziazione del marchio. In molti
mercati sono presenti due tipi di imprese: quelle che vendono prodotti con un marchio diffusamente
conosciuto e quelli che vendono sostenuti generici. Molto spesso l'impresa che vende prodotti di
marca spende in pubblicità più delle concorrenti che offrono prodotti generici. Così come c'è disac-
cordo sull'economia della pubblicità, c’è disaccordo anche l'economia dei marchi e della loro diffe-
renzazione. I critici del prodotto di marca affermano che il branding tende a far percepire ai consu-
matori differenze che in realtà non esistono. In molti casi il bene sostituto prodotto da un’azienda
anonima ha le medesime caratteristiche del prodotto di marca e, sempre secondo tali critici, la
maggiore disponibilità a pagare che il consumatore dimostra nei confronti dei prodotti di marca è
una forma di irrazionalità indotta dalla pubblicità. In tempi più recenti, però, gli economisti hanno
preso a difendere il ruolo dei marchi come un modo per garantire al consumatore la qualità di ciò
che acquista sulla base di due documentazioni tra loro collegate. In primo luogo, il marchio fornisce
al consumatore informazioni sulla qualità, ove la qualità non sia percepibile in anticipo rispetto
all'acquisto. In secondo luogo, il marchio crea un incentivo a continuare a produrre beni di qualità,
poiché l’impresa ha un interesse economico a difendere la reputazione del proprio marchio. Si noti
che un prodotto di marca non corrisponde necessariamente a un prodotto di alta qualità: alcune
36
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
imprese dichiarano apertamente di produrre beni “senza pretese” ma si affrettano ad aggiungere che
offrono al consumatore un buon rapporto qualità-prezzo.
Struttura di mercato
Concorrenza Concorrenza Monopolio
perfetta monopolistica
Caratteristiche condivise dalle tre strutture
Obiettivo d’impresa Massimo profitto Massimo profitto Massimo
profitto
Regola di massimizzazione RM = CM RM = CM RM = CM
L’impresa può realizzare un profitto nel
Sì Sì Sì
breve periodo?
Caratteristiche comuni a concorrenza monopolistica e monopolio
Il prezzo è dato? Sì No No
Prezzo P = CM P > CM P > CM
Raggiunge il ivello di prodotto che
Sì No No
massimizza il benessere
Caratteristiche comuni a concorrenza monolitica e concorrenza perfetta
Numero di imprese Molte Molte Una
Ingresso nel lungo periodo? Sì Sì No
L’impresa può realizzare profitti nel lungo
No No Sì
periodo?
N.B. I mercanti contenibili
La teoria dei mercati contenibili è stata elaborata d aWilliam J. Baumon, John Parizar e Rober Wil-
lig nel 1982. La caratteristica fondamentale di un mercato perfettamente contenibile è che le impre-
se sono minacciate dall'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato. L'ipotesi di Baumon e dei suoi
colleghi è che le imprese possano deliberatamente ridurre i propri profitti per scoraggiare l'ingresso
di nuovi attori nel mercato. Un'altra caratteristica dei mercati perfettamente contendibili è che non
ci sono barriere all'entrata e all'uscita, né costi sommersi. Per porre un limite ai profitti, le imprese
possono adottare una prassi operativa nota come entry limit pricing, che consente nel mantenere
artificialmente bassi i prezzi per scoraggiare potenziali nuovi entranti. Analogamente, le imprese
possono praticare prezzi predatori, cioè mantenere per un certo periodo i prezzi al di sotto del costo
medio totale per eliminare i concorrenti dal mercato o impedire a nuove imprese di entrarvi. Le
imprese già presenti nel mercato potrebbero essere in grado di sostenere una tale strategia poiché
potrebbero avere acquisito alcuni vantaggi in termini di economie di scala, dei quali i nuovi entrati
potrebbero non beneficiare
CAPITOLO 17: L’OLIGOPOLIO
La situazione in cui nei settori dove le imprese hanno alcuni concorrenti ma in numero limitato e
non sono costrette a subire il prezzo di mercato viene chiamata concorrenza imperfetta. Un parti-
colare tipo di concorrenza imperfetta è l’oligopolio. In un mercato oligopolistico sono presenti solo
poche imprese, pertanto è improbabile che si facciano una concorrenza spietata; le loro intenzioni
strategiche assumono invece un’importanza cruciale. Di conseguenza, le azioni del singolo vendito-
re possono avere notevoli conseguenze sul profitto degli altri venditori. Un oligopolio è un mercato
nel quale pochi venditori offrono prodotti molto simili, se non identici, tra loro.
Se un mercato è dominato da un certo numero limitato di venditori, si dice che è concentrato. Il
rapporto di concentrazione si calcola come la quota del mercato totale che fa capo alle prime X im-
prese del settore. Una delle caratteristiche determinanti del mercato è il conflitto tra cooperazione e
interesse proprio. Il gruppo degli oligopolisti si avvantaggerebbe dal cooperare e comportarsi come
un monopolista, producendo una bassa quantità di prodotto per venderla a un prezzo superiore al
37
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
costo marginale. Eppure, poiché ogni oligopolio agisce esclusivamente in vista del proprio profitto,
esistono forti incentivi che impediscono a un gruppo di imprese di esercitare il proprio potere mo-
nopolistico. Un accordo tra imprese sulla quantità da produrre e il prezzo da applicare viene detto
collusione e il gruppo di impresa che agisce in maniera coordinata viene detto carrello. In presenza
di un carrello, in effetti, è come se il mercato fosse servito da un monopolista. Un carrello deve ac-
cordarsi non soltanto sulla quantità totale da produrre ma anche sulla quantità prodotta da ciascun
membro. Ciascun membro del carrello desidera di per sé una grossa quota di mercato poiché una
quota di mercato maggiore corrisponde a un profitto maggiore. Gli oligopolisti tendono a formare
carrelli per godere di profitti monopolistici anche se non sempre ci riescono.
La condizione di equi-librio è detta equilibrio di Nash; un equilibrio di Nash è una situazione nella
quale i soggetti eco-nomici, attraverso l’interazione reciproca, determinano la propria strategia ot-
timale, date le strategia scelte dagli altri soggetti. L’equilibrio di Nash illustra il conflitto tra coope-
razione e interesse proprio: gli oligopolisti trarrebbero vantaggio dalla cooperazione perché ciò
permetterebbe loro di realizzare un profitto di monopolio; ma, poiché perseguono il proprio interes-
se, non riescono a raggiungere l’equilibrio di monopolio e a massimizzare il profitto congiunto.
Ciascun oligopolista è tentato ad aumentare la quantità prodotta per conquistare una maggiore quota
di mercato e, poiché tutti si comportano allo stesso modo, la produzione totale aumenta e il prezzo
diminuisce. Allo stesso tempo il proprio interesse non spinge tale processo fino alle estreme conse-
guenze della concorrenza perfetta. Per questa ragione il processo si ferma prima di raggiungere il
risultato socialmente efficiente, per il quale il prezzo è uguale al costo marginale. Consideriamo ora
come il numero di imprese nel mercato influenza l’analisi marginale del singolo oligopolista.
Quanto maggiore è il numero dei venditori, tanto minore è l’effetto che il singolo provoca sul
prezzo di mercato: ovvero, quanto maggiore è il numero delle imprese, tanto minore è l’effetto
prezzo. Nel caso in cui l’oligopolio fosse molto ampio, l’effetto prezzo scomparirebbe completa-
mente, lasciando solo l’effetto quantità; in questo caso estremo ogni impresa continua ad aumentare
la produzione fintanto che il prezzo rimane più elevato del costo marginale. Possiamo quindi dedur-
re che un oligopolio non collusivo di grandi dimensioni è essenzialmente un gruppo di imprese con-
correnziali. L’impresa concorrenziale, nel decidere se aumentare la produzione, prende in conside-
razione il solo effetto quantità perché, dal momento che subisce il prezzo, l’effetto prezzo è assente.
Quindi, all’aumentare del numero dei partecipanti all’oligopolio, il mercato oligopolistico tende ad
assomigliare sempre più a un mercato concorrenziale: il prezzo si avvicina progressivamente al
costo marginale e la quantità prodotta al livello socialmente efficiente.
Come si è visto, le imprese che operano in regime di oligopolio vorrebbero comportarsi alla
maniera del monopolista, ma ciò renderebbe necessaria una cooperazione non facile da raggiungere,
né da mantenere. Per analizzare gli aspetti economici della cooperazione, dobbiamo dotarci della
teoria dei giochi. La teoria dei giochi è lo studio del comportamento individuale in situazioni
strategiche. Con il termine “strategico” si denotano le situazioni nelle quali ciascun individuo, nel
decidere quali azioni intraprendere, deve prendere in considerazione le reazioni degli altri individui
alla sua azione. Nel linguaggio della teoria dei giochi una strategia è detta dominante se rappresenta
la migliore scelta possibile per un giocatore, indipendentemente dalle strategie prescelte dagli altri.
Un “gioco” particolarmente importante è quello detto dilemma del prigioniero: in questo gioco ha
come protagonisti due criminali sospettati di aver commesso un crimine e, la condanna che ciascu-
no deve scontare, dipende sia dalla decisione di confessare o meno, sia dalla decisione presa dal
complice. Ma, cosa ha a che fare il dilemma del prigioniero con i mercati e la concorrenza imperfet-
ta? Come vedremo, il gioco degli oligopolisti che cercano di raggiungere il risultato del monopolio
è simile a quello dei due prigionieri del dilemma. Gli oligopoli solo raramente riescono ad appropri-
arsi del profitto del monopolista. Il profitto del monopolista è razionale per l’oligopolio nel suo
complesso ma, considerato indipendentemente dagli altri, ciascun oligopolista ha un forte incentivo
a violare i patti. Proprio come spinge il prigioniero a confessare, così il perseguimento del proprio
interesse rende difficile per l’oligopolio raggiungere e mantenere un accordo che massimizzerebbe
il profitto di tutti i partecipanti. In ogni caso, il dilemma del prigioniero illustra la difficoltà della
cooperazione, ma non ne dimostra l’impossibilità; molto spesso la ragione per la quale i giocatori
possono risolvere il dilemma del prigioniero è che non giocano una sola volta, ma ripetutamente.
Entrambe le parti scelgono di rispettare l’accordo nella misura in cui si preoccupano dei profitti fu-
38
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
turi. Quindi, se il dilemma del prigioniero viene ripetuto, i due giocatori dovrebbero essere in grado
di raggiungere e mantenere un comportamento cooperativo.
Si dibatte da sempre sui comportamenti che dovrebbero essere sanzionati dalla normativa antitrust.
Molti commentatori concordano che gli accordi tra imprese concorrenti diretti alla fissazione del
prezzo siano da considerare illegali, ma la normativa antitrust è stata utilizzata anche per condan-
nare altre prassi aziendali i cui effetti non sono altrettanto evidenti:
• l’impostazione del prezzo al dettaglio: un esempio di prassi aziendale controversa è l’imposta-
zione del prezzo al dettagli del prodotto; a prima vista il prezzo imposto potrebbe apparire con-
trario alla libera concorrenza, quindi dannoso per la società: come l’accordo tra i membri di un
carrello, impedisce ai rivenditori di competere sul prezzo. Per questa ragione i tribunali hanno
spesso considerato il prezzo imposto come una violazione della normativa antitrust. Ma alcuni
economisti hanno preso le difese del prezzo imposto sulla base di due considerazioni: innanzi-
tutto essi negano che il prezzo imposto limiti la concorrenza e, in secondo luogo, gli economisti
pensano che il prezzo imposto abbia un obiettivo legittimo. Se il prezzo al dettaglio non fosse
imposto, alcuni clienti potrebbero utilizzare il servizio più accurato di alcuni rivenditori per
valutare l’opportunità dell’acquisto, per poi comprare a prezzo scontato da un altro rivenditore.
In questo caso i rivenditori a prezzo basso si avvantaggiano indebitamente del servizio offerto
dai rivenditori più qualificati, portando a un livello di servizio inferiore a quello desiderabile
• i prezzi predatori: le aziende utilizzano il potere di mercato di cui dispongono per aumentare il
prezzo al di sopra del livello concorrenziale. Sebbene una della accuse più comuni nelle
indagini antitrust sia quella di applicare prezzi predatori, alcuni economisti sono scettici al
riguardo e ritengono che i prezzi predatori siano raramente, per non dire mai, una strategia
redditizia. Infatti, per fare in modo che una guerra dei prezzi costringa l’avversario a uscire dal
mercato, i prezzi devono scendere a un livello inferiore di costo
• le vendite a pacchetto: un altro esempio di prassi aziendale controversa è la vendita a pacchetto;
ma, perché esiste la vendita a pacchetto? Una possibilità è che essa rappresenti una forma di
discriminazione di prezzo. L’argomentazione che la vendita a pacchetto permette a un’impresa
di ampliare il proprio potere di mercato non è solidamente fondata.
N.B. John Nash
Al centro delle idee di Nash vi era una combinazione di giochi cooperativi e non cooperativi: nei
primi vi sono accordi applicabili fra i giocatori, nei secondi no. L'aspetto fondamentale, in entrambi
i casi, è che i giocatori sanno di non poter prevedere con certezza cosa farà l'altro. Analogamente,
ciascun giocatore sa cosa vuole ma è consapevole che tutti gli altri giocatori pensano in maniera
analoga a lui. La posizione di "equilibrio" si raggiunge quando ogni giocatore prende la decisione
che rappresenta il miglior risultato possibile in relazione alle decisioni degli altri giocatori. L'equili-
brio di Nash può essere definito come un punto nel quale nessun giocatore può migliorare la propria
condizione e tutti hanno adottato la strategia migliore e non intendono modificarla.
N.B. Robert J. Aumann e Thomas C. Schelling, due esperti della teoria dei giochi
Shelling ha individuato due aspetti della teoria dei giochi: la teoria dei giochi non cooperativi e la
teoria dei giochi cooperativi. La teoria dei giochi cooperativi ipotizza che ci sia un gruppo di risulta-
ti o di accordi noti a tutti i giocatori e che ogni giocatore abbia un ordine di preferenze rispetto a tali
risultati. La teoria dei gliochi non cooperativi ipotizza che i giocatori abbiano una serie di strategie
che possono usare per ottenere un risultato, e che ogni giocatore abbia un ordine di preferenze ris-
petto ai risultati. Il comportamento degli individui o delle imprese può essere influenzato da negozi-
azioni che implicano una qualche forma di conflitto di interessi, ma in sostanza ogni giocatore cerca
di massimizzare il proprio rendimento, pur sapendo che un qualche accordo è preferibile alla totale
assenza di accordo. Schelling ha proposto che possa esistere nell'interesse del giocatore peggiorare
le proprie opzioni in modo da guadagnare concessioni da un altro giocatore. Le difficoltà sorgono
quando entrambe le parti in un conflitto assumono posizioni che sono percepite come irreversibili e
inconciliabili. Il risultato può essere una situazione di stallo e un conflitto potenzialmente grave.
39
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Schelling ha anche inserito ulteriori complicazioni nell’analisi, osservando come la strategia di
ciascuno dei giocatori cambia alla luce delle minacce e delle azioni. Secondo Schelling, i giocatori
potrebbero dover riconoscere che il costo dell’inganno per conseguire un beneficio di breve periodo
è di gran lunga controbilanciato dal costo a lungo termine della perdita di fiducia che risulta dall’in-
ganno.
CAOITOLO 18: I MERCATI DEI FATTORI DI PRODUZIONE
La domanda e l'offerta di lavoro, terra e capitale determinano il prezzo pagato ai lavoratori, ai pro-
prietari della terra e ai proprietari dei capitali. Dunque, per capire perché alcuni sono pagati più di
altri, dobbiamo esaminare più approfonditamente il mercato dei servizi che offrono. Lavoro, terra e
capitale sono i tre fattori di produzione più importanti: i fattori di produzione sono i beni e servizi
che vengono utilizzati per produrre altri beni e servizi. I mercati dei fattori di produzione sono per
molti aspetti simili a quelli dei beni e servizi, ma se ne differenziano per almeno un aspetto rilevan-
te: la domanda dei fattori di produzione è una domanda derivata. Questo significa che la domanda
di un fattore di produzione da parte di un’impresa dipende dalle sue decisioni di offerta in un altro
mercato.
Il mercato del lavoro è regolato dalle forze della domanda e dell'offerta: i servizi del lavoro non so-
no beni finali immediatamente fruibili dal consumatore ma sono utilizzati come fattori per la produ-
zione di altri beni. Per decidere quanti lavoratori assumere, l'impresa deve valutare il rapporto tra la
forza lavoro utilizzata e il livello di produzione. In altre parole deve stabilire come il numero dei la-
voratori condiziona la quantità del bene prodotta e venduta. Non dimentichiamo che gli individui
razionali pensano al “margine”: questo concetto è fondamentale anche per capire come le imprese
determinano la quantità di lavoro da utilizzare. Il prodotto marginale del lavoro è l’aumento di
prodotto generato da un aumento unitario della quantità di lavoro: al crescere del numero di lavora-
tori, il prodotto marginale del lavoro diminuisce; si rammenti che stiamo aggiungendo un fattore va-
riabile (il lavoro) a una quantità fissa di altri fattori (terra e capitale) perché stiamo analiz-zando uno
scenario nel breve periodo. Questa caratteristica è definita prodotto marginale decrescente. All'au-
mentare del numero di lavoratori il contributo che il lavoratore addizionale può dare alla produzione
è sempre meno elevato e pertanto la funzione di produzione diventa progressiva-mente più piatta
all’aumentare del numero di lavoratori. L'impresa vuole, ovviamente, massimizzare il profitto, per-
ciò è preoccupata più del denaro che del bene. Di conseguenza, nel decidere quanti lavoratori assu-
mere, valuta il profitto che ciascun lavoratore può apportare. Poiché il profitto è la differenza tra ri-
cavo totale e costo totale di produzione, il profitto generato da un lavoratore aggiuntivo è pari alla
differenza tra il contributo che questo dà al ricavo e il salario che percepisce. Per stabilire quale sia
il contributo di un lavoratore al ricavo totale, dobbiamo convertire il prodotto marginale del lavoro
in un valore monetario utilizzando a tal fine il prezzo del bene. Il valore del prodotto marginale di
un fattore di produzione è pari al prodotto marginale del fattore moltiplicato per il prezzo di mercato
del prodotto. Poiché il prezzo di mercato per l'impresa concorrenziale è costante, il valore del pro-
dotto marginale diminuisce all'aumentare del numero di lavoratori. Alcuni economisti chiamano
questa grandezza ricavo del prodotto marginale dell'impresa: è il ricavo aggiuntivo che l'impresa
ottiene dall'utilizzo di unità addizionale di un fattore di produzione. Il valore del prodotto marginale
viene rappresentato con una curva con pendenza negativa perché il prodotto marginale del lavoro è
decrescente al crescere del numero di lavoratori. In sostanza, un'impresa concorrenziale che vuole
massimizzare il profitto assume un numero di lavoratori tale che il valore del prodotto marginale del
lavoro sia uguale al salario del lavoratore. Possiamo ora analizzare la curva di domanda di lavoro
che è semplicemente un riflesso del valore del prodotto marginale del lavoro. Sulla base di questa
considerazione possiamo individuare quali sono gli eventi che possono provocare uno spostamento
della curva di domanda del lavoro:
• il prezzo del prodotto: il valore del prodotto marginale è pari al pezzo del prodotto moltiplicato
per il prodotto marginale. Dunque, se il prezzo del prodotto cambia, cambia il valore del prodot-
to marginale e la curva di domanda di lavoro si sposta
• il progresso tecnologico: scienziati e progettisti immagino continuamente nuovi modi per fare le
cose più svariate e questo ha una profonda implicazione per il mercato del lavoro. In generale, il
progresso tecnologico fa aumentare il prodotto marginale del lavoro e, di conseguenza, la do-
40
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
manda di lavoro, facendo spostare verso destra la curva di domanda di lavoro. Il progresso tec-
nologico spiega la crescita persistente dell’occupazione nonostante la crescita dei salari
• l'offerta di altri fattori: la quantità disponibile un fattore di produzione può condizionare il pro-
dotto marginale di altri fattori
Avendo analizzato nel dettaglio la domanda di lavoro, prendiamo in considerazione quella dell'of-
ferta di lavoro. Il trade-off tra lavoro e del tempo libero è il fondamento della curva di offerta di
lavoro. Visto che il costo di qualcosa è ciò che si deve rinunciare per averla, a cosa si deve rinuncia-
re per un'ora di tempo libero? A un'ora di lavoro o, in via del tutto equivalente, a un’ora di retribu-
zione. La curva di offerta di lavoro riflette in modo in cui le decisioni dei singoli lavoratori relative
al trade off del lavoro e del tempo libero rispondono variazioni del costo opportunità. La curva di
offerta di lavoro con pendenza positiva indica che all’aumentare del salario i lavoratori sono dispos-
ti lavorare di più. Dato che il numero delle ore di una giornata è definito, più ore di lavoro significa
meno ore di tempo libero; questo significa che il lavoratore reagisce all’aumento di costo-opportu-
nità del tempo libero dedicandovi meno ore. La curva di offerta di lavoro non deve necessariamente
avere pendenza positiva; in altre parole, all’aumentare del salario il lavoratore potrebbe decidere di
lavorare di meno. La curva di offerta di lavoro si sposta se cambia la quantità di lavoro che gli
individui intendono offrire a ogni dato livello di salario; ciò può dipendere da alcuni eventi:
• i cambiamenti delle preferenze
• i cambiamenti delle opportunità alternative
• l’immigrazione: se un lavoratore emigra da un paese a un altro, l’offerta di lavoro aumenta nel
secondo paese e diminuisce nel primo
A questo punto abbiamo stabilito due fattori sulla determinazione dei salari nei mercati del lavoro
concorrenziali:
1. il salario varia in modo da eguagliare domanda e offerta di lavoro
2. il salario è uguale al valore del prodotto marginale del lavoro
Nel mercato del lavoro in equilibrio il salario e la quantità di lavoro sono tali da bilanciare domanda
e offerta di lavoro. Quando il mercato è in equilibrio, ogni impresa ha assunto al salario di equili-
brio il numero di lavoratori che ritiene redditizio, ovvero, ha seguito la regola della massimizzazio-
ne del profitto: assumere lavoratori fino a quando il valore del prodotto marginale del lavoro non è
uguale al salario. Dunque, quando domanda e offerta sono in equilibrio, il salario è uguale al valore
del prodotto marginale del lavoro. Questo ci porta a una conclusione importante: qualsiasi evento
che modifichi l’offerta o la domanda di lavoro deve far variare in egual misura il salario di equili-
brio e il valore del prodotto marginale del lavoro perché queste due variabili devono sempre essere
uguali. Alcuni eventi possono provocare,
però, spostamenti di tali curve.
Prendiamo l’esempio dell’offerta di
lavoro che si sposta verso destra da O1 a
O2. Al salario iniziale W1 la quantità di
lavoro offerta ora eccede quella
domandata e l’eccesso di offerta di
lavoro spinge verso il basso il salario
che passa da W1 a W2; la caduta del
salario rende più profittevole per le
imprese il ricorso al lavoro; le imprese
assumono quindi più lavoratori. Con
l’aumento del numero dei lavoratori
impegnati, il prodotto marginale del
lavoro diminuisce e altrettanto accade al
valore del prodotto marginale del lavoro.
Nella nuova situazione di equilibrio il
salario e il valore del prodotto marginale
del lavoro sono entrambi più bassi di quanto fossero prima dell’arrivo della massa di nuovi
lavoratori.
41
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Analizziamo ora il caso dove è la curva di
domanda a lavoro a spostarsi: all’aumentare
del prezzo del bene, diventa redditizio
assumere più lavoratori. Se la domanda di
lavoro si sposta D1 a D2, il salario di
equilibrio aumenta da W1 a W2 e
l’occupazione di equilibrio aumenta da L1 a
L2. Il salario e il valore del prodotto
marginale del lavoro si muovono ancora
una volta all’unisono.
Nei mercati del lavoro concorrenziali
l’offerta e la domanda di lavoro insieme
determinano il salario di equilibrio e gli
spostamenti di dette curve ne provocano la
variazione; allo stesso tempo, la
massimizzazione del profitto da parte delle imprese che domanda-no lavoro garantisce che il salario
di equilibrio sia sempre uguale al valore del prodotto marginale del lavoro.
Oltre a dover decidere quanti lavoratori assumere, le imprese devono prendere delle decisioni anche
riguardo agli altri fattori di produzione. I fattori di produzione possono essere classificati in tre cate-
gorie: lavoro, terra e capitale. Con capitale gli economisti definiscono la quantità di attrezzature e
strutture utilizzate per la produzione. Il capitale di un sistema economico rappresenta dunque l’ac-
cumulazione di beni prodotto nel passato e destinati nel presente alla produzione di altri beni e ser-
vizi. Come si determina la remunerazione dei proprietari della terra e del capitale per il rispettivo
contributo al processo di produzione? Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo effettuare
una distinzione tra due prezzi: il prezzo di acquisto e il prezzo di locazione. Il prezzo di acquisto
della terra o del capitale è ciò che un individuo paga per garantirsi indefinitamente la proprietà di un
fattore di produzione. Il prezzo di locazione è il prezzo che un individuo paga per utilizzare tale fat-
tore per un periodo di tempo limitato. Il prezzo di locazione della terra e quello del capitale sono
determinati dall’intersezione di offerta e domanda. Inoltre la domanda di terra e di capitale viene
determinata esattamente come la domanda di lavoro. L’impresa utilizza una quantità di capitale e di
terra tale per cui il valore del prodotto marginale di ciascun fattore sia uguale al suo prezzo. Dun-
que, la curva di domanda di ciascun fattore riflette la produttività marginale del fattore stesso. Se
l’offerta di un qualunque fattore di produzione varia, gli effetti non si esplicano esclusivamente sul
mercato del fattore in oggetto, ma anche su quelli degli altri fattori. Un evento che provochi variazi-
oni dell’offerta di un qualsiasi fattore di produzione può far variare la remunerazione degli altri fat-
tori. Tale variazione può essere valutata analizzando gli effetti dell’evento sul valore del prodotto
marginale degli altri fattori.
N.B. Domanda di fattori e offerta di beni e servizi
Abbiamo visto come un’impresa concorrenziale determini la quantità di prodotto da offrire in modo
da massimizzare il profitto: scegliere il livello di produzione per il quale il prezzo del bene è uguale
al costo marginale di produzione. In questo capitolo abbiamo visto come la stessa impresa decide la
quantità di lavoro da utilizzare: sceglie la quantità di lavoro per il quale il salario è uguale al valore
del prodotto marginale del lavoro. Poiché la funzione di produzione mette in relazione la quantità
dei fattori con la quantità prodotta, non dovrebbe sorprendere scoprire che le decisioni dell’impresa
sulla domanda di fattori sono strettamente correlate a quelle sull’offerta di beni e servizi. Se W è il
salario e l’unità di lavoro aggiuntiva produce PML unità di prodotto, il costo marginale dell’unità
aggiuntiva di prodotto è CM = W/PML. Questa analisi dimostra la stretta correlazione esistente tra
il prodotto marginale decrescente e il costo marginale decrescente. Prendiamo in considerazione il
criterio che abbiamo definito per la massimizzazione del profitto: l’impresa che massimizza il pro-
fitto sceglie la quantità di lavoro per la quale il valore del profitto marginale (P x PML) è uguale al
salario W (ovvero P x PML = W). Dividendo entrambi i membri dell’equazione per PML ottenia-
mo: P = W/PML. Tuttavia, come abbiamo appena notato W/PML è uguale al costo marginale e
perciò possiamo sostituire per ottenere P = CM. Ne deduciamo che il prezzo del prodotto dell’im-
42
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
presa è uguale al costo marginale di produzione. Quindi, se l’impresa in un mercato concorrenziale
impiega lavoro in una quantità tale che il valore del prodotto marginale è uguale al salario, non può
che produrre la quantità per la quale il prezzo è uguale al costo marginale di produzione.
N.B. Il monopsonio
Un mercato in cui esiste un unico compratore è detto monopsonio. Un monopsonio è, sotto molti
aspetti, simile al monopolio. Un’impresa monopsonistica assume meno lavoratori di quanti ne as-
sumerebbe un’impresa in concorrenza perfetta; riducendo il numero di posti di lavoro disponibili si
muove lungo la curva di offerta di lavoro tenendo basso il salario e aumentando il proprio profitto.
L’esistenza di un potere di mercato distorce il risultato e provoca una perdita secca.
CAPITOLO 19: RETRIBUZIONI E DISCRIMINAZIONE
Quando un lavoratore decide se accettare un posto di lavoro, la retribuzione è solo una delle varia-
bili che prende in considerazione, per esempio l’offerta di lavoro per occupazioni facili, divertenti e
sicure è maggiore di quella per lavori difficili, noiosi e pericolosi. Perciò i posti “buoni” tenderanno
ad avere un salario di equilibrio più basso dei posti “cattivi”. Gli economisti usano il termine diffe-
renziale di compensazione per indicare le differenze di salario giustificate da differenze delle ca-
ratteristiche non monetarie delle diverse mansioni. Oltre al capitale fisico, bisogna tener conto an-
che di un altro capitale: il capitale umano, ovvero l’accumulazione delle conoscenze e delle com-
petenze maturate dagli individui. La forma più importante di capitale umano è l’istruzione: l’inve-
stimento nell’istruzione è legato al singolo individuo. Dal punto di vista della domanda e dell’offer-
ta di lavoro è facile capire perché il salario aumenta al crescere dell’istruzione: le imprese sono dis-
poste a pagare di più i lavoratori con elevata scolarizzazione perché questi hanno una produttività
marginale più alta; i lavoratori sono disposti a sostenere i costi dell’istruzione superiore solo se rie-
scono a trarne un beneficio. Il talento naturale è importante per i lavoratori in tutti i campi di attivi-
tà. A causa dell'ereditarietà e dell'educazione ricevuta, gli individui diversi per caratteristiche men-
tali e fisiche. Queste e molte altre caratteristiche personali determinano la produttività del lavoratore
e, di conseguenza, sono determinanti per la definizione del salario guadagnato. Strettamente colle-
gato al talento è l'impegno: non sorprende scoprire che chi lavora più duramente ha una produttività
superiore e quindi viene pagato di più. Entro un certo limite le imprese premiano direttamente i la-
voratori, remunerandoli sulla base di quanto producono individualmente. Anche caso al ruolo nella
determinazione dei salari.
Alcuni economisti hanno proposto una teoria alternativa alla teoria del capitale umano: secondo
questa nuova teoria, le imprese considerano i risultati ottenuti negli studi come un modo per
distinguere i lavoratori meglio dotati da quelli peggio dotati. Secondo questa teoria alternativa, chi
ottiene una laurea non è, di per sé, più produttivo, ma invia al datore di lavoro un segnale di una sua
maggiore capacità; questa teoria prende il nome di teoria del segnale. Abbiamo così enunciato due
diverse teorie della scolarizzazione: quella del capitale umano e quella dei segnali. Entrambe spie-
gano la ragione per la quale lavoratori con diversi livelli di scolarizzazione tendenzialmente gua-
dagnano cifre diverse. Secondo la teoria del capitale umano, i lavoratori più istruiti sono più pro-
duttivi, mentre secondo la teoria dei segnali l’istruzione è correlata ai talenti naturali dell’individuo.
La maggior parte delle analisi sui differenziali salariali tra i lavoratori si fondano sul modello di
equilibrio del mercato del lavoro: si ipotizza che i salari si aggiustino in modo da equilibrare do-
manda e offerta di lavoro. Ma questa ipotesi non è di generale applicazione: per alcuni lavoratori il
salario è fissato a un livello superiore a quello che porterebbero offerta e domanda in equilibrio. Tra
le molte ragioni che possono spiegare questo stato di cose prendiamone in considerazione tre:
1. la presenza di una legge sul salario minimo
2. il potere di mercato dei sindacati: un sindacato è un’associazione di lavoratori che negozia con i
datori di lavoro dei propri associati o dei lavoratori in generale. I sindacati riescono spesso a far
salire i salari al di sopra del livello di equilibrio, ricorrendo anche alla minaccia di una
sospensione delle attività lavorative, detta sciopero
3. teoria del salario di efficienza: la teoria del salario di efficienza afferma che un’impresa può
trarre beneficio dal corrispondere salari elevati perché, il tal modo, può far aumentare le
produttività dei lavoratori. In particolare, corrispondere salari elevati fa diminuire il turnover dei
43
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
dipendenti, aumentare l’impegno profuso nel lavoro e crescere la quantità dei candidati a
eventuali posti vacanti. Inoltre, un’impresa potrebbe decidere di offrire salari più elevato per
attirare e motivare i lavoratori migliori
Spingere un salario al di sopra del livello di equilibrio fa aumentare la quantità di lavoro offerta e
ridurre quella domandata; il risultato è un’eccedenza di lavoro, ovvero di disoccupazione.
Un’altra causa di diseguaglianza del reddito è la discriminazione. Si ha discriminazione quando il
mercato offre opportunità diverse a individui che hanno caratteristiche simili ma differiscono per
razza, gruppo etnico, genere, età o altre caratteristiche personali. La discriminazione è l’effetto dei
pregiudizi di alcuni individui contro alcuni gruppi della società. I mercati concorrenziali offrono un
antidoto naturale alla discriminazione da parte dei datori di lavoro. L’entrata nel marcato di imprese
che si curano esclusivamente del profitto tende a eliminare le discriminazioni salariali, che
persistono nei mercati del lavoro concorrenziali solo se i consumatori sono disposti a pagare di più
per mantenere la discriminazione o se lo stato impone una legislazione discriminatoria.
CAPITOLO 20: DISUGUAGLIANZA DEL REDDITO E POVERTA’
I fattori che determinano i salari sono responsabili in massima parte anche della distribuzione del
reddito tra i membri della società. In alte parole, stabiliscono chi è ricco e chi è povero. I dati sulla
distribuzione del reddito e sul tasso di povertà aiutano a formarsi un’idea del grado di disuguaglian-
za della nostra società, ma la loro interpretazione non è così univoca come potrebbe sembrare. Que-
sti dati, infatti, si fondano sulla rilevazione del reddito annuale delle famiglie; ma ciò che sta a cuo-
re alle perone non è tanto il proprio reddito, quanto la capacità di mantenere un tenore di vita adegu-
ato. Per almeno tre ragioni i dati sulla distribuzione del reddito e sul tasso di povertà forniscono un
quadro incompleto delle disuguaglianze di tenore di vita:
1. il ciclo della vita economica: il reddito varia con una certa prevedibilità nel corso della vita degli
individui; questa diffusa tendenza del reddito viene denominata ciclo di vita. Gli individui pos-
sono risparmiare o indebitarsi per ammortizzare l’andamento altalenante del reddito durante il
ciclo di vita; per questa ragione, il tenore di vita in ogni dato anno dipende più dal reddito gua-
dagnato complessivamente nel corso di tutto il ciclo di vita che da reddito annuale
2. e 3. reddito transitorio e reddito permanente: il reddito individuale non è soggetto solamente alle
prevedibili variazioni cicliche ma anche a eventi casuali e transitori. La capacità di una famiglia
di procacciarsi beni e servizi dipende in larga misura dal suo reddito permanente, che è il suo
reddito normale o medio. Per valutare la diseguaglianza di tenore di vita, la distribuzione del
reddito permanente è più rilevante di quella del reddito annuale. Molti economisti sono convinti
che gli individui fondino le proprie decisioni di consumo sul reddito permanente; di conseguen-
za, la disuguaglianza di consumo è una misura della disuguaglianza di reddito permanente. Dato
che reddito permanente e consumo sono meno influenzati dalle variazioni transitorie del reddito,
la loro distribuzione è meno diseguale di quella del reddito corrente.
A causa della forte mobilità economica, la povertà è un problema di lungo periodo per un numero
relativamente ristretto di famiglia. Chi è temporaneamente povero deve affrontare problemi diversi
rispetto a chi li è in via permanente, pertanto i provvedimenti volti a combattere la povertà devono
distinguere tra le due condizioni. Un altro modo per valutare la mobilità economica è la costanza
del successo economico tra diverse generazioni della stessa famiglia. Per valutare la disuguaglianza
di reddito si ricorre spesso al tasso di povertà, ovvero la percentuale di popolazione che dispone di
un reddito inferiore a un valore prestabilito, definito soglia di povertà. La povertà è un concetto
relativo per questa ragione, gli economisti sono soliti distinguere fra povertà assoluta e povertà
relativa. Si ha povertà assoluta quando l’individuo non è in grado di soddisfare i bisogni
fondamentali della vita: alimentazione, riparo, abbigliamento. Si ha povertà relativa quando
l’individuo è escluso dalla capacità di usufruire di ciò che è socialmente considerato un tenore di
vita normale e accettabile. Ma cosa dovrebbe fare lo Stato a fronte della diseguaglianza economica?
• Utilitarismo: una delle correnti di pensiero più importanti della filosofia politica è l’utilitarismo,
dottrina che ha avuto per padri fondatori Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Fondamento
dell’utilitarismo è la nozione di utilità: il livello di felicità e di soddisfazione che un individuo
trae dalle circostanze in cui si trova. L’utilità è una misura del benessere e, secondo gli utilitaris-
ti, deve essere l’obiettivo ultimo dei comportamento privati e pubblici. L’obiettivo dello Stato,
44
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
secondo costoro, dovrebbe essere la massimizzazione della somma delle utilità individuali dei
membri della società. L’argomento utilitarista per la ridistribuzione del reddito di fonda sull’i-
potesi di utilità marginale decrescente: al crescere del reddito, il benessere aggiuntivo che si
ricava da un aumento unitario del reddito diminuisce. A prima vista parrebbe che l’argomenta-
zione utilitaristica implichi che lo Stato dovrebbe procedere alla ridistribuzione del reddito af-
finché tutti i membri della società abbiano esattamente il medesimo reddito. In effetti questo
sarebbe vero se la quantità del reddito totale fosse costante, ma non l’è. lo Stato utilitarista deve
trovare il giusto equilibrio tra i benefici che derivano da una maggiore equità e i costi che
discendono dalla distorsione degli inventivi.
• Liberalismo: un secondo indirizzo di pensiero sulla disuguaglianza è il liberalismo, sviluppato
dal filosofo John Rawls. Rawls parte dalla premessa che le istituzioni, le leggi e le strategie poli-
tiche di una società devono essere giuste. Da tale premessa sorge naturale una domanda: come
possiamo noi, in quanto membri della società, accordarci su cosa sia giusto? Possiamo determi-
nare oggettivamente cosa è giusto per la società? Nel progettare la politica economica, si do-
vrebbe tendere a migliorare il benessere della persona che si trova nelle condizioni peggiori.
Questo significa che, invece di massimizzare la somma delle utilità di tutti, come farebbe un uti-
litarista, Rawls preferisce massimizzare l'utilità minima: tale regola è sinteticamente denominata
criterio del massiminimo. Il criterio del massiminimo porta a concentrare l'attenzione sull'indi-
viduo più fortunato della società, giustificando perciò i provvedimenti volti all’equalizzazione
del reddito: trasferendo il reddito dai ricchi ai poveri, la società fa aumentare il benessere dei più
sfortunati. Il criterio del massiminimo, tuttavia, non conduce a una società completamente
egualitaria.
• Libertarismo: la terza concezione della disuguaglianza viene definita libertarismo. I pensatori
libertari affermano che la società in sé non produce alcun reddito; solo i singoli individui produ-
cono reddito: secondo i libertari, lo Stato non deve prendere da alcuni per dare ad altri in modo
da ottenere una specifica distribuzione del reddito. Mentre gli utilitaristi e i liberali cercano di
stabilire il grado di diseguaglianza socialmente desiderabile, Nozick nega la validità della ques-
tione. L'alternativa libertaria alla valutazione del risultato economico è la valutazione del pro-
cesso attraverso il quale il risultato viene ottenuto. Se la distribuzione del reddito viene ottenuta
attraverso un processo iniquo, lo Stato ha il diritto e il dovere di porre rimedio al problema ma,
fino a quando il processo attraverso il quale il reddito viene distribuito è giusto, la distribuzione
che ne consegue non può essere giusta, indipendentemente dal grado di diseguaglianza. I liber-
tari giungono alla conclusione che l’eguaglianza delle opportunità è più importante dell’ugua-
glianza del reddito e sono convinti che lo Stato debba difendere i diritti individuali per garantire
a tutti la stessa opportunità di mettere a frutto le proprie doti e avere successo. Una volta che le
regole del gioco sono stabilite, lo Stato non ha alcuna ragione per modificare la distribuzione del
reddito che ne risulta.
• Paternalismo liberatorio: il paternalismo liberatorio riconosce che gli individui dovrebbero esse-
re liberi di scegliere, ma che gli architetti delle scelte (i governi) hanno un ruolo legittimo nel
cercare di influenzare i comportamenti delle persone al fine di rendere la loro vita più lunga, sa-
na e, in ultima istanza, migliore, incrementando la loro utilità.
Come abbiamo appena visto, i filosofi della politica hanno posizioni differenti rispetto al ruolo che
lo Stato dovrebbe assumere nella distribuzione del reddito. Nonostante si continui a dibattere, la
maggior parte degli individui è convinta che, come minimo, lo Stato debba cercare di assistere chi
ne ha più bisogno. La povertà è uno dei problemi più difficili che i governanti si trovano ad affron-
tare. Ma come può il governo ridurre il numero delle famiglie che vivono in condizioni di povertà?
Prendiamo in considerazione alcuni provvedimenti:
• Leggi sul salario minimo:
• Sicurezza sociale: lo Stato può migliorare il tenore di vita dei poveri sussidiando il loro reddito.
Lo strumento principale di questa politica è il sistema di assistenza e previdenza sociale, altri-
menti detto sicurezza sociale
• Imposta negativa sul reddito: molti economisti sostengono la necessità di un'imposta negativa
sul reddito al fine di sussidiare il reddito delle famiglie più povere. Secondo questa strategia
45
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
impositiva, ogni famiglia dovrebbe dichiarare il proprio reddito allo Stato: le famiglie ricche do-
vrebbero pagare un'imposta sulla base del proprio reddito, mentre quelle povere riceverebbero
dallo Stato un sussidio, “pagando” un’imposta negativa. In regime di imposizione negativa sul
reddito, le famiglie povere ricevono assistenza finanziaria senza dover dimostrare lo stato di
bisogno: la sola caratteristica necessaria per accedere al beneficio è il basso reddito.
• Trasferimenti in natura: un altro modo per aiutare i poveri è fornir loro direttamente i beni e i
servizi necessari per elevare il loro tenore di vita. I sostenitori dei trasferimenti in natura affer-
mano che questi garantiscono che i poveri abbiano almeno ciò di cui più necessitano. Secondo
altri, invece, i trasferimenti in natura sono inefficienti e irrispettosi. Lo Stato non può sapere di
quali beni e servizi il singolo individuo ha maggiormente bisogno. Invece di fornire ai poveri
beni e servizi che non desiderano, sarebbe meglio dar loro del denaro e lasciare che lo impieghi-
no per acquistare ciò che ritengono sia loro necessario.
• Programmi anti-povertà e incentivi al lavoro: molti provvedimenti che hanno la finalità di aiuta-
re ipoveri possono avere uno spiacevole effetto collaterale, ovvero, non stimolano le persone a
darsi da fare per sfuggire alla povertà. Con il lodevole intendo di aiutarle, lo Stato scoraggia le
famiglie povere dal lavorare: secondo i critici del sistema di assistenza sociale, questi provvedi-
menti alterano l’attitudine al lavoro e creano una “cultura della povertà”. Il problema connesso
con tale soluzione è l’aumento del costo dei programmi anti-povertà. Se i benefici vengono eli-
minati gradualmente al crescere del reddito delle famiglie povere, anche quelle che si trovano
appena al di sopra della soglia di povertà continuano a godere di alcuni benefici; quanto più
graduale è l’eliminazione dei benefici, tanto più numerose saranno le famiglie che beneficiano
dell’assistenza e tanto maggiori saranno i costi del programma. Dunque, i governanti si trovano
di fronte al trade-off tra scaricare sui poveri l’onere di una pseudo-imposta con aliquota margi-
nale elevata o scaricare sul contribuente l’onere di maggiori costi. Con sono molti altri modi per
cercare di ridurre il disincentivo al lavoro generato dai programmi anti-povertà, come sospende-
re o ridurre le prestazioni assistenziali agli individui che non trovano un impiego entro un deter-
minato periodo di tempo o che rifiutano un’offerta di lavoro senza un valido motivo.
CAPITOLO 21: LA TEORIA DELLE SCELTE DEL CONSUMATORE
La teoria delle scelte del consumatore esamina i trade-off1 che gli individui fronteggiano nel loro
ruolo di consumatore. Questa teoria analizza come gli individui, di fronte a questi trade-off,
formulano le proprie decisioni e reagiscono a cambiamenti ambientali. Lo studio del comportamen-
to del consumatore parte dall’analisi del rapporto tra reddito e spesa: consumiamo meno di quanto
vorremmo perché la nostra spesa è vincolata, ovvero limitata, dal nostro reddito. È in questo
contesto che troviamo il vincolo di bilancio, ovvero la rappresentazione grafica che mostra le
possibili combinazioni di beni che il consumatore si può permettere di acquistare. La pendenza del
vincono di bilancio misura il rapporto di sostituzione economica di un bene con l’altro; la pendenza
è uguale al prezzo relativo dei due beni, ovvero al prezzo di un bene espresso in rapporto all’altro
bene. Tuttavia, le scelte del consumatore dipendono non soltanto dal vincono di bilancio ma anche
dalle sue preferenze rispetto ai beni. Se gli si offrono due combinazioni diverse, il consumatore
sceglie quella che meglio soddisfa i suoi gusti; se le due combinazioni soddisfano in egual misura i
suoi gusti, diciamo che il consumatore è indifferente tra le due combinazioni. Come si rappresenta
graficamente il vincono di bilancio del consumatore, così si può fare per le sue preferenze,
ricorrendo alle curve di indifferenza. Una curva di indifferenza mostra le diverse combinazioni di
consumo che soddisfano il consumatore in egual misura. La pendenza della curva di indifferenza in
qualsiasi punto corrisponde al rapporto al quale il consumatore è disposto a scambiare un bene con
l’altro. Tale rapporto è detto saggio marginale di sostituzione (SMS): non essendo le curve di indif-
ferenza rettilinee, il saggio marginale di sostituzione non è costante lungo la curva. D’altra parte, il
rapporto al quale il consumatore è disposto a scambiare un bene a favore dell’altro dipende dalla
quantità di bene che sta già consumando. Il consumatore è ugualmente soddisfatto in qualsiasi
punto di una data curva di indifferenza ma è più o meno soddisfatto a seconda della curva di indif-
1
Relazione funzionale tra due variabili tale che la crescita di una risulta incompatibile con la crescita dell’altra e ne
comporta anzi una contrazione. Si parla di trade-off quando si deve operare una scelta tra due opzioni ugualmente
desiderabili ma tra loro contrastanti.
46
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
ferenza sulla quale si trova. Poiché, in generale, si trae maggiore soddisfazione dal maggior
consumo, quanto più una curva di indifferenza è lontana dall’origine degli assi, tanto più grande è la
soddisfazione del consumatore. Le curve di indifferenza sintetizzano le preferenze del consumatore
e hanno alcune proprietà che riflettono il sistema delle preferenze:
• Proprietà 1 - Le curve di indifferenza più alte garantiscono un livello di soddisfazione più
elevato: i consumatori di solito preferiscono consumare quantità maggiori anziché minori
• Proprietà 2 – Le curve di indifferenza hanno pendenza negativa: nella maggior parte dei casi il
consumatore trae soddisfazione da entrambi i bene e, se la quantità di un bene si riduce, la
quantità dell’altro deve aumentare per mantenere inalterata la soddisfazione
• Proprietà 3 – Le curve di indifferenza non si intersecano
• Proprietà 4 – Le curve di indifferenza sono curve rispetto agli assi cartesiani
La forma delle curve di indifferenza rivela molte informazioni sulla disponibilità di un consumatore
a sostituire un bene con un altro; se due beni sono facilmente sostituibili l'uno all'altro, la curva di
indifferenza tende a essere meno concava; una concavità più marcata, invece, è indice di una scarsa
sostituibilità tra i due beni. Il massimo livello di soddisfazione che il consumatore può raggiungere
è rappresentato dalla curva di indifferenza che tocca in un solo punto il vincolo di bilancio; il punto
nel quale la curva di indifferenza e il vincolo di bilancio si toccano è detto ottimo. Nel punto di
ottimo (il punto in cui la curva di indifferenza è tangente al vincolo di bilancio) la pendenza della
curva di indifferenza e quella del vincolo di bilancio sono uguali; ne consegue che il consumatore
sceglie la combinazione di beni in corrispondenza della quale il saggio marginale di sostituzione è
uguale al prezzo relativo. Il prezzo relativo è il rapporto al quale il mercato è disposto a scambiare
un bene per un altro, mentre il saggio marginale di sostituzione è quello la quale consumatore stesso
è disposto a farlo. Nel punto di ottimo il valore relativo che il consumatore attribuisce ai due beni
corrisponde a quello che attribuisce loro il mercato.
L’effetto della variazione del prezzo di un bene sul consumo può essere scomposto in un effetto di
reddito e un effetto di sostituzione. Possiamo descrivere graficamente l’effetto di reddito di
sostituzione per mezzo di curve di indifferenza: l’effetto di reddito è la variazione del consumo che
risulta dal passaggio a una curva di indifferenza più alta; l’effetto di sostituzione è la variazione del
consumo indotta dal passaggio a un punto della medesima curva di indifferenza con un saggio
marginale di sostituzione diverso.
Gli economisti usano il termine bene di Giffen per definire un bene che viola la legge della doman-
da in quanto è un bene per il quale un aumento del prezzo fa aumentare la quantità domandata.
N.B. L’utilità
Per rappresentare le preferenze del consumatore, abbiamo analizzato le curve di indifferenza. Un
altro modo molto comune per farlo è ricorrere al concetto di utilità. L’utilità è una misura astratta
della soddisfazione o della felicità che un consumatore trae da un paniere di beni. Le curve di indif-
ferenza e l’utilità sono fortemente correlate. Poiché il consumatore preferisce qualsiasi paniere col-
locato su una curva di indifferenza più elevata rispetto a qualunque paniere collocato su una più
bassa, l’utilità associata alla curva di indifferenza più elevata è superiore a quella associata alla cur-
va di indifferenza più bassa. Poiché ogni paniere che si trova su una stessa curva di indifferenza dà
al consumatore la medesima soddisfazione, l’utilità è la stessa lungo tutta la curva. L’utilità margi-
nale di un bene è l’aumento di utilità che il consumatore trae dalla funzione di una unità addizionale
di quel bene. Si assume che la maggior parte dei beni abbiano utilità marginale decrescente: quanto
maggiore è la quantità di bene a disposizione del consumatore, tanto minore è l’utilità che egli trae
da un’unità addizionale di quel bene. Il saggio marginale di sostituzione è pari al rapporto tra le
unità marginali dei due beni.
CAPITOLO 23: MISURARE IL REDDITO DI UNA NAZIONE
I principali dati economici misurano il reddito totale dell’economia (PIL), la crescita del livello dei
prezzi (inflazione), la quota di forza lavoro priva di impegno (disoccupazione), la spesa per consu-
mi, il saldo degli scambi tra il paese e il resto del mondo (deficit o surplus della bilancia commerci-
47
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
ale). Tutti quelli che abbiamo citato sono dati macroeconomici: non si riferiscono a una particolare
famiglia o impresa, ma al sistema economico nel suo complesso.
Per stabilire se un sistema economico sta andando bene o male bisogna prendere in considerazione
la sommatoria dei redditi guadagnati da tutti i componenti della società, cioè il prodotto interno
lordo (PIL). Il PIL misura due cose contemporaneamente: il reddito totale dei componenti della
società e la spesa totale per l’acquisto di ciò che nella società stessa è prodotto e venduto. La ragio-
ne per la quale il PIL può riuscire a misurare due cose contemporaneamente è che le due variabili
sono identiche: per un sistema economico nel suo complesso, il reddito deve essere uguale alla spe-
sa. Il PIL può, quindi, misurare il flusso di denaro in due modi: sommando la spesa totale dei singo-
li individui o sommando i redditi totali (salari, profitti e rendite) pagati dalle imprese. Poiché ogni
euro speso da qualcuno è un euro di reddito di qualcun altro, il valore del PIL non dipende dalla
modalità di calcolo prescelta. Dopo aver discusso il significato del prodotto interno lordo in termini
generali, verifichiamo come viene misurato questo dato. Prendendo in esame la definizione del PIL,
ovvero il valore di mercato di tutti i beni e i servizio finali prodotti in un paese in un dato periodo
di tempo, ci accorgiamo che, questa stessa definizione, mette in evidenza la complessità del calcolo
del prodotto interno loro; analizziamo nel dettaglio la definizione:
• “Il PIL è il valore di mercato...”: il PIL somma diversi generi di prodotti in un’unica misura del
valore dell’attività economica. Per poterlo fare deve ricorrere, però, ai prezzi di mercato. Misu-
rando quanto gli individui sono disposti a pagare per l’acquisto di beni e servizi, i prezzi di mer-
cato riflettono il valore monetario attribuito a tali beni
• “...di tutti...”: il PIL deve essere onnicomprensivo, cioè, deve includere tutti i beni prodotti
nell’economia e venduti legalmente. Alcuni prodotti vengono esclusi dal computo del PIL, poi-
ché è difficile misurarne il valore: sono i beni e i servizi venduti e prodotti illegalmente
• “...i beni e i servizi”: il PIL comprende sia i beni tangibili sia i servizi intangibili
• “...finali...”: non si tiene conto di beni e servizi intermedi
• “...prodotti...”: il PIL comprende i beni e i servizi prodotti nel periodo corrente e non quelli pro-
dotti nel passato
• “...in un paese...”: il PIL misura il valore della produzione nell’ambito dei confini geografici di
un paese, indipendentemente dalla nazionalità del produttore
• “...in un periodo di tempo”: il PIL misura il valore della produzione generata in uno specifico
intervallo temporale; di solito questo intervallo corrisponde all’anno solare o al trimestre. Il PIL
misura i flussi di reddito e di spesa che hanno luogo nel periodo considerato
Per comprendere come l’economia utilizza le proprie risorse scarse, gli economisti sono spesso
interessati a studiare la ripartizione del Pil tra le diverse voci di spesa. A tal fine, il PIL, che chiame-
remo sinteticamente Y, può essere composto in quattro elementi:
1. consumo (C), la spesa degli individui per l’acquisto di beni e servizi: vengono inclusi i beni du-
revoli, i beni di consumo, i servizi immateriali e la spesa per gli individui per l’istruzione
2. investimento (I), la spesa per l’acquisto di beni che saranno utilizzati in futuro per produrre altri
beni e servizi; si tratta della somma degli acquisti di beni capitali e attrezzature, scorte e
strutture
3. spesa pubblica (G), comprende gli acquisti di beni e di servizi da parte dell’amministrazione
stata e dell’amministrazioni locali; nella voce sono inclusi i salari dei dipendenti pubblici e la
spesa per le opere pubbliche. Esisto, però, alcune spese (come quelle pensionistiche) dette
trasferimento perché non è fatta in contropartita della cessione di un bene o di un servizio
prodotti nel periodo in oggetto. Dal punto di vista strettamente macroeconomico i trasferimenti
equivalgono a un’imposta negativa. I trasferimenti, inoltre, non rientrano nel computo della
spesa pubblica
4. esportazioni nette (NX), sono pari alla differenza tra il valore dei beni di produzione interna
acquistati da stranieri (esportazioni) e quello dei beni di produzione estera acquistati all’interno
(importazioni). L’aggettivo “nette” che si associa a “esportazioni” sta a significare che il valore
delle importazioni viene sottratto a quello delle esportazioni; tale sottrazione deve essere
effettuata perché i beni e i servizi importati vengono automaticamente inclusi nella altre tre
componenti del PIL
48
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
Unendo tutti questi elementi avremo che Y = C + I + G + NX: questa espressione algebrica è
un’identità, ovvero, è necessariamente vera, data la definizione delle variabili che la compongono.
In questo caso, poiché ogni euro di spesa incluso nel PIL appartiene per definizione a una delle
quattro categorie, la somma di queste non può che essere uguale al PIL.
Se da un anno all’altro la spesa aumenta, le ragioni possono essere due: è aumentata la produzione
di beni e servizi oppure sono aumentati i prezzi. Per analizzare l’andamento dell’economia nel tem-
po, è necessario separare i due effetti. Per farlo gli economisti usano il PIL reale e il PIL nominale.
Il PIL nominale utilizza i prezzi correnti per attribuire un valore ai beni e servizi prodotti dall’eco-
nomia; il PIL reale valorizza la produzione a prezzi costanti relativi a un anno base. Il valore del
PIL reale è indipendente dalla dinamica dei prezzi, quindi le sue variazioni riflettono esclusivamen-
te variazione della produzione. Dunque, il PIL reale è una misura della produzione di beni e servizi.
L’obiettivo del calcolo del PIL è valutarle prestazioni dell’economia nel suo complesso. Poiché il
PIL reale misura la produzione di beni e servizi generata dal sistema economico, riflette la capacità
dell’economia di soddisfare i bisogni e i desideri degli individui e, quindi, costituisce un indice di
benessere economico migliore del PIL nominale. Grazie al PIL nominale e il PIL reale possiamo
ricavare un terzo dato statistico ovvero il deflatore del PIL che riflette i prezzi dei beni e servizi, ma
non le quantità prodotte. Il deflatore si calcola come segue:
PIL nomiale
Deflatore del PIL = PIL reale
x 100
SE il PIL reale e PIL nominale sono identici all’anno base, il deflatore del PIL di quell’anno è sem-
pre uguale a 100. Il deflatore del PIL degli anni successivi misura i cambiamenti del PIL nominale
rispetto all’anno base che non possono essere attribuiti a variazioni del PIL reale. Il deflatore del
PIL misura il livello attuale dei prezzi in relazione al livello dei prezzi dell’anno base.
Come abbiamo visto, il PIL misura il reddito totale dell’economia, che corrisponde anche alla spesa
total per beni e servizi. Il PIL pro capite indica quindi il reddito medio del singolo membro del sis-
tema economico. Poiché la maggior parte degli individui preferisce avere redditi più elevati e una
superiore capacità di spesa, il PIL pro capite sembra una misura naturale del benessere economico
individuale. Il PIL non è una misura diretta di ciò che contribuisce alla qualità della vita ma è
misura della possibilità di ottenere i mezzi per vivere una vita degna di essere vissuta. Alla fine, il
PIL è una buona misura del benessere economico per molti aspetti ma non per tutti ed è per questo
che è molto importante tenere presente cosa tale benessere include e cosa no. Va da se che il PIL
non è una misura perfetta perché non tiene conto per esempio del tempo libero, la qualità dell’ambi-
ente e non dice nulla sulla distribuzione del reddito. Il PIL utilizza i prezzi di mercato per valutare
beni e servizi, quindi non può comprendere il valore di tutte le attività che avvendono al di fuori di
un mercato.
N.B. Altre misure del reddito
Esistono altre misure, differenti dal PIL per il fatto di includere o escludere alcune voci, che
permettono di misurare alcuni tipi di reddito:
• il prodotto nazionale lordo (PNL) è il reddito totale guadagnato da chi risiede permanentemente
nel paese. Differisce dal PIL perché include il reddito che i cittadini guadagnano all’estero ed
esclude quello realizzato da stranieri nel territorio preso in esame
• il prodotto nazionale netto (PNN) è il reddito totale dei residenti di una nazione al netto degli
ammortamenti: gli ammortamenti sono una misura contabile del consumo e dell’utilizzo dei
beni capitali e delle strutture presenti nell’economia
• il reddito nazionale è il totale del reddito prodotto dai cittadini di un paese nella produzione di
beni e servizi. Differisce dal PNN perché non comprende le imposte indirette e include i sussidi
alle imprese. PNN e reddito nazionale differiscono anche a causa di discrepanze statistiche che
insorgono nella rilevazione dei dati
• il reddito personale è il reddito ricevuto dagli individui e dalle società di persone. Diversamente
dal Pil e dal PNN, il reddito disponibile non computa i redditi non distribuiti, ovvero quella
49
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
parte di reddito che le società di capitali non distribuiscono tra i soci in forma di dividendi. Il
reddito personale comprende gli interessi che gli individui ricevono come remunerazione della
sottoscrizione di titoli del debito pubblico e i trasferimenti, come le prestazioni previdenziali e i
programmi di assistenza
• il reddito disponibile è il reddito del quale gli individui e le società di persone possono disporre,
al netto di tutte le imposte
Se il PIL cresce rapidamente, anche queste misure hanno tassi di crescita sostenuti e se il PIL dimi-
nuisce, anche queste diminuiscono.
CAPITOLO 24: MISURARE IL COSTO DELLA VITA
L’indice dei prezzi al consumo permette di stabilire come varia il costo della vita nel tempo; gli
economisti usano il termine inflazione per descrivere una situazione nella quale il livello generale
dei prezzi tende ad aumentare mentre, il tasso di inflazione è la variazione percentuale del livello
dei prezzi rispetto al periodo precedente. L’indice dei prezzi di consumo (IPC) è una misura del
costo complessivo dei beni e dei servizi acquistati dal consumatore tipo. Per calcolare l’indice dei
prezzi al consumo e il tasso di inflazione si segue un processo di calcolo diviso in cinque fasi:
1. determinazione del paniere: bisogna stabilire quali siano i prezzi importanti per il
consumatore tipo; questi pesi vengono determinati analizzando il comportamento dei
consumatori e definen-do un paniere di beni e servizi acquistati dal consumatore medio
2. rilevazione del prezzo: rilevare il prezzo al quale ogni bene o servizio del paniere viene venduto
in diversi momenti
3. calcolo del costo del paniere: vengono utilizzati i dati ricavati per calcolare il prezzo del paniere
di beni e servizi in diversi anni (o negli anni presi in esame)
4. individuazione dell’anno base a calcolo dell’indice: designare un anno da utilizzare come base
di calcolo, rispetto al quale eseguire i confronti con gli altri anni. Per calcolare l’indice, il prezzo
del paniere di beni e servizi rilevato in ogni anno viene diviso per il prezzo rilevato nell’anno
base e moltiplicato per 100; il numero che ne risulta è l’indice dei prezzi di consumo
5. calcolo del tasso d’inflazione: infine, calcolare il tasso d’inflazione, cioè la variazione percentu-
ale dell’indice dei prezzi tra una rilevazione e l’altra, a partire dall’indice dei prezzi di consumo.
Il tasso di inflazione tra due anni consecutivi è calcolato con la seguente formula:
IPC nell ' anno 2 IPC nell ' anno 1
Tasso d’inflazione nell’anno 2 = IPC nell ' anno 1
x 100
Oltre all’indice dei prezzi al consumatore per l’economia in generale, si possono calcolare anche gli
indici dei prezzi per categorie più ristrette di beni e servizi, nonché un indice dei prezzi alla produ-
zione, che misura la variazione del prezzo di un paniere di beni e servizio acquistati dall’impresa ti-
po, invece che dal consumatore. L’indice dei prezzi al consumo cerca di stabilire di quanto debbano
aumentare i redditi per poter mantenere inalterato il tenore di vita; l’indice, però, non è una misura
perfetta del costo della vita, essendo inficiata da tre problemi ai quali è difficile ovviare:
1. il primo di questi problemi è noto come distorsione da sostituzione: i prezzi non variano propor-
zionalmente da un anno all’altro ma i prezzi di alcuni beni aumentano più di quelli di altri. Il
consumatore reagisce a queste diverse variazioni acquistando quantità inferiori dei beni i cui
prezzi aumentano e quantità superiori dei beni i cui prezzi sono stabili o diminuiscono. Ovvero,
il consumatore tende a sostituire i beni relativamente più costosi con quelli relativamente più a
buon mercato. Però l’indice del costo della vita viene calcolato ipotizzando che il paniere sia
costante e, perciò, senza considerare le variazioni e le abitudini di acquisto indotte delle varia-
zioni dei prezzi. Di conseguenza, l’indice tende a sovrastimare l’aumento del costo della vita da
un anno all’altro
2. il secondo problema discende dall’introduzione di nuovi beni: quando viene introdotto sul mer-
cato un nuovo bene, il consumatore si trova di fronte a una gamma di scelte più ampia. Un mag-
gior numero di possibilità, a sua volta, fa aumentare il valore di ogni unità monetaria. Per questa
ragione, il consumatore ha bisogno di meno moneta per mantenere inalterato il proprio tenore di
50
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
vita. Ma poiché l’indice dei prezzi al consumo si fonda su un paniere fisso di beni, esso non rie-
sce a riflettere questo cambiamento nel potere d’acquisto della moneta
3. il terzo problema associato all’IPC deriva dall’impossibilita di misurare le variazioni qualitative:
se la qualità di una categoria di beni si deteriora da un anno all’altro, il valore della moneta di-
minuisce anche se il prezzo del bene rimane inalterato. Analogamente, se la quantità di un bene
aumenta da un anno all’altro, il valore della moneta aumenta
Un ultimo problema dell’indice è che gli individui potrebbero non considerare l’IPC una misura
dell’inflazione rilevante per la loro particolare situazione. Infatti, le abitudini di spesa del singolo
sono un fatto personale e potrebbero non rispecchiare quelle del consumatore medio, su cui si basa-
no i dati ufficiali, a causa delle diverse percezioni individuali dell’inflazione e degli effetti di
quest’ultima sui singoli e sulle famiglie, nel 2007 l’ONS (l’Office for National Statistics) ha pubbli-
cato un calcolatore dell’inflazione personale: il PIC (Personal Inflation Calculator). Il PIC consente
agli utenti di inserire i propri dati personali, relativi alla spesa mensile complessiva e a diverse cate-
gorie di spesa. Inoltre, il calcolatore tiene conto anche della spesa per i servizi di pubblica utilità.
Ma, perché è stato introdotto l’IPC? La ragione principale per l’adozione dell’IPC è che viene cos-
truito in maniera esattamente uguale agli indici dei prezzi calcolati in altri paesi membri dell’Unio-
ne europea. Dal momento che questi indici dei prezzi vengono calcolati maniera uniforme in tutti i
paesi europei, vengono chiamati indici armonizzati dei prezzi al consumo o IAPC. Il vantaggio di
questi indici è quello di consentire un confronto diretto tra tassi d’inflazione degli Stati membri
dell'UE. L'IAPC è stato e continua a essere definito e calcolato dall’Eurostat in coordinamento con
gli uffici statistici degli Stati membri.
Per valutare il tasso al quale aumentano i prezzi, economisti e politici prendono in considerazione
sia il deflatore del PIL sia l'indice dei prezzi al consumo. Di solito le due statistiche hanno valori
analoghi, ma possono essere discrepanti per almeno due ordini di cause: 1) la prima differenza è
dovuta al fatto che il deflatore del PIL riflette i prezzi di tutti i beni e servizi prodotti internamente,
mentre l'indice dei prezzi al consumo riflette i prezzi di tutti i beni e i servizi acquistati dai consu-
matori, mentre, 2) la seconda differenza è più sottile e riguarda il peso che viene attribuito ai singoli
prezzi per giungere a calcolare un unico valore del livello generale dei prezzi. L’indice dei prezzi al
consumo si fonda su un paniere costante di beni e servizi, la cui composizione viene modificata solo
occasionalmente dall’ONS. Il deflatore del PIL, invece, mette a confronto il prezzo dei beni e servi-
zi di produzione corrente con quello che questi stessi beni avrebbero avuto nell'anno base, quindi il
paniere su cui si fonda cambia automaticamente nel tempo. La formula che si utilizza per trasforma-
re i valori monetari dell’anno T in valori monetari attuali è la seguente:
Livello dei prezzi corrente
Valore monetario corrente = valore monetario nell’anno T x Livello dei prezzi nell ' anno T
Per misurare il livello generale dei prezzi e, quindi, determinare la correzione necessaria per depura-
re gli effetti dell’inflazione, possiamo ricorrere a un indice dei prezzi come l’IPC.
Quando un valore monetario viene automaticamente, per legge o per contratto, corretto per l'inflazi-
one si dice che è indicizzato. La correzione delle variabili economiche per gli effetti dell'inflazione è
particolarmente importante quando si considerano i tassi d'interesse. Il concetto stesso di tasso
d'interesse implica necessariamente il confronto di somme di denaro in diversi momenti del tempo.
Il tasso d'interesse corrisposto dalla banca è detto tasso d'interesse nominale, mentre il tasso d’in-
teresse corretto per l'infezione è chiamato tasso d'interesse reale. La relazione tra tasso d'interesse
nominale, tasso d'interesse reale e tasso di inflazione può essere descritta come segue:
Tasso d’interesse reale = tasso di interesse nominale – tasso di inflazione
Il tasso d'interesse nominale stabilisce quanto aumenta nel tempo l'ammontare di denaro depositato
in banca; il tasso di interesse reale stabilisce quanto aumenta nel tempo il potere d'acquisto di una
somma depositata.
N.B. Le rilevazioni dell’indice dei prezzi in Italia
51
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
In Italia, le rilevazioni del livello generale dei prezzi vengono effettuate dall’Istat. L’Istat produce
tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l’intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) e l’indice armonizzato europeo (IPCA). I tre indici hanno, ovviamente, fi-
nalità diverse. Il NIC misura l’inflazione a livello dell’intero sistema; il FOI si riferisce ai consumi
dell’insieme che fanno capo a un lavoratore dipendente e l’IPCA vene assunto come indicatore per
verificare la convergenza dell’economie dei paesi membri dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso
e della permanenza nell’Unione monetaria. NIC e FOI si basano sullo stesso paniere, ma il peso at-
tribuito a ogni bene o servizio è diverso: per il NIC la popolazione di riferimento è l’intera popola-
zione italiana; per il FOI è l’insieme delle famiglie che fanno capo a un operario o un impiegato.
L’IPCA ha in comune come il NIC la popolazione di riferimento ma si differenzia dagli altri due in-
dici perché il paniere esclude le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicu-
razioni sulla vita. Un’ulteriore differenziazione tra gli indici riguarda il concetto di prezzo conside-
rato: il NIC e il FOI considerano sempre il prezzo pieno di vendita mentre l’IPCA si riferisce, inve-
ce, al prezzo effettivamente pagato dal consumatore.
CAPITOLO 25: PRODUZIONE E CRESCITA
Come abbiamo visto, il prodotto interno lordo (PIL) di un’economia misura sia il totale dei redditi
guadagnati sia la spesa per l’acquisto dei beni e i servizi prodotti nell’economia. Il livello del PIL è
un buon parametro della prosperità economica e la sua crescita è perciò un buon parametro dei pro-
gressi dell’economia. Il tasso di crescita misura la velocità a cui aumenta il PIL reale pro capite
nell’anno tipo e con il termine produttività si indica la quantità di beni e servizi che un lavoratore
può produrre in un’ora di lavoro; una nazione può godere di un elevato tenore di vita solo se riesce
a produrre grandi quantità di beni e servizi. I fattori più importanti che determinano la quantità sono
essenzialmente quattro:
1. capitale fisico: i lavoratori sono più produttivi se dispongono di strumenti con i quali lavorare:
la dotazione di attrezzature e di strutture utilizzate per la produzione di beni e sevizi è detta
capitale fisico o, più sinteticamente, capitale. Uno degli aspetti peculiari del capitale è che si
tratta di un fattore di produzione che è a sua volta un prodotto; in altre parole, il capitale è un
fattore della produzione che, nel passato, è stato il prodotto di un processo produttivo. Dunque,
il capitale è un fattore di produzione utilizzato per produrre ogni genere di beni, incluso altro
capitale
2. capitale umano: ovvero, le conoscenze e le capacità accumulate dai lavoratori attraverso l’istru-
zione, la formazione e l’esperienza. Il capitale umano comprende le conoscenze e le competenze
accumulate durante l’età scolare, all’università o in età adulta e grazie all’esperienza acquisita
direttamente sul lavoro
3. risorse naturali: ovvero, i fattori di produzione forniti dalla natura: la terra, i fiumi e i giacimenti
minerari. Le risorse naturali possono assumere due forme: rinnovabili e non rinnovabili; va da
se che la diversa disponibilità di risorse naturali è una delle causa della diversità del tenore di vi-
ta tra i paesi del mondo. Le risorse naturali, per quanto importanti, non sono una condizione ne-
cessaria per attingere a un elevato livello di produttività
4. conoscenze tecnologiche: ovvero, la conoscenza dei modi più efficaci di produrre beni e servizi
(si definisce tecnologia l’applicazione della conoscenza all’ambiente in modo da esercitare un
maggior controllo su di esso). La conoscenza tecnologica può assumere molte forme: una parte
della tecnologia entra a far parte del bagaglio di conoscenze comuni, altre forme di tecnologia
sono difendibili dalla concorrenza e diventano parte del patrimonio dell’impresa che le ha svi-
luppate mentre altre forme di tecnologia sono difendibili sono per un limitato periodo di tempo.
È importante sottolineare la differenza esistente tra conoscenze tecnologiche e capitale umano: le
conoscenze tecnologiche si riferiscono alle conoscenze sul funzionamento del mondo diffuse nella
società, mentre il capitale umano, si riferisce alle risorse per diffondere questa conoscenza tra la for-
za lavoro.
Ma che cosa può fare un governo per aumentare la produttività e, per suo tramite, il tenore di vita?
• Risparmio e investimento: poiché il capitale è un fattore di produzione che viene a sua volta
prodotto, la quantità di capitale disponibile in un dato sistema economico può variare nel tempo.
Se oggi l’economia produce una gran quantità di nuovi prodotti capitali, domani disporrà di uno
52
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
stock di capitale più vaso e potrà produrre più beni e servizi di tutti i tipi. Dunque, un modo per
aumentare la produttività futura è investire una quota maggiore delle risorse attuali nella produ-
zione di capitale. Dato che le risorse sono scarse, dedicarne una quota maggiore alla produzione
di capitale significa dedicarne una minore alla produzione per il consumo attuale; di conseguen-
za, per la società nel suo complesso, investire di più nel capitale significa consumare meno e ris-
parmiare di più. La crescita che si genera attraverso l’accumulazione di capitale non è esente da
costi: richiede di sacrificare il consumo attuale di beni e servizi a favore di consumi più elevati
nel futuro
• Rendimenti decrescenti e effetto catch-up: nell’interpretazione tradizionale del processo di
produzione, il capitale è soggetto a rendimenti decrescenti: all’aumentare dello stock di capitale,
la quantità aggiuntiva che si può produrre grazie a un apporto unitario ulteriore di capitale
diminuisce. In altre parole, se i lavoratori già dispongono di una grande quantità di capitale per
produrre beni e servizi, fornirgliene un’unità addizionale fa aumentare solo limitatamente la loro
produttività. I rendimenti decrescenti del capitale hanno un’altra importante implicazione: a
parità di altre condizioni, per un paese povero è relativamente più facile raggiungere elevati
tassi di crescita. Questa influenza delle condizioni iniziali sulla crescita è detto effetto catch-up
• Investimento estero: un investimento posseduto e gestito da un soggetto straniero è detto invest-
imento diretto estero, mentre, un investimento finanziato con denaro estero ma gestito da resi-
denti viene detto investimento estero di portafoglio. Sebbene una parte dei benefici che ne deri-
vano prendano la via del ritorno verso le tasche degli investitori, l’investimento estero fa au-
mentare il capitale fisico disponibile nell’economia, spingendo verso una maggiore produttività
e salari più elevati. In aggiunta, l’investimento estero è uno degli strumenti con cui i paesi in via
di sviluppo possono procurarsi tecnologie avanzate, sviluppate e utilizzate nei paesi più ricchi
• Istruzione
• Salute e alimentazione: a parità di altre condizioni, un lavoratore più sano è anche più produtti-
vo. Per chi vive nei paesi in via di sviluppo, infatti, una salute precaria e un’alimentazione insuf-
ficiente sono il maggiore ostacolo al raggiungimento di una produttività più elevata e di un teno-
re di vita migliore. Il nesso casuale tra salute e benessere è a doppio senso: i paesi poveri sono
poveri anche perché la loro popolazione non è sana e la popolazione non è sana anche perché è
povera e non si può permettere assistenza sanitaria e un alimentazione adeguata
• Diritti di proprietà, stabilità politica e buon governo: un prerequisito importante per il corretto
funzionamento del sistema dei prezzi è l’assoluto rispetto dei diritti di proprietà che si riferisco-
no alla capacità di esercitare la potestà sulle risorse che ci appartengono. Una comune minaccia
ai diritti di proprietà è costituita dall’instabilità politica: se in un paese si susseguono rivoluzioni
e colpi di Stato, permane il dubbio che i diritti di proprietà instaurati durante un regime vengano
rispettati dal regime successivo. Dunque, la possibilità economica dipende anche dalla prospetti-
va politica: un paese con un sistema giudiziario efficiente, funzionari pubblici onesti e un ordi-
namento giuridico stabile gode, a parità di condizioni, di un tenore di vita migliore di quello di
un paese dove il sistema giudiziario è inefficiente, i funzionari pubblici sono corrotti e il diritto
incerto; sono queste le caratteristiche di un buon governo
• Libero scambio
• Ricerca e sviluppo: sebbene la maggior parte delle innovazioni tecnologiche sia il frutto delle
ricerche di singoli e imprese, promuovere questi sforzi è di interesse pubblico. La conoscenza,
nel senso più ampio del termine, è un bene pubblico: una volta che un individuo ha acquisito
una conoscenza, questa entra nel patrimonio culturale della società e altre persone la possono
usare più o meno liberamente. È compito dello Stato incentivare l’attività di ricerca attraverso
brevetti, laboratori di ricerca pubblici o con delle sovvenzioni offerte ai ricercatori più promet-
tenti
• Crescita della popolazione: la crescita della popolazione interagisce con gli altri fattori di
produzione secondo modalità meno dirette è più controverse
- lo sfruttamento delle risorse naturali: secondo Malthus la continua crescita della popolazione
avrebbe messo in discussione la capacità della società di mantenere se stessa e, di conseguenza,
avrebbe inevitabilmente gettato l’umanità nella povertà più abietta. Malthus giungeva alla con-
53
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
clusione che la forza della popolazione è infinitamente più grande della capacità della Terra di
produrre quanto necessario alla sussistenza dell’uomo. Fortunatamente le previsioni di Malthus
si sono rilevata errate; ma, dove ha sbagliato Malthus? Egli ha ipotizzato erroneamente che la
quantità prodotta di cibo potesse aumentare solo in amaniera lineare, incrementando la quantità
di terra destinata all’agricoltura a parità di produttività. Ma lo sviluppo delle conoscenze
dell’uomo ha più che compensato la crescita della popolazione. Malthus, quindi, non ha tenuto
conto di eventuali progressi tecnologici.
- la diluzione dello stock del capitale: secondo le teorie di alcuni economisti, un’elevata crescita
della popolazione ridurrebbe il PIL per occupato perché all’aumentare del numero di lavoratori
la quantità di capitale per occupato diminuisce. In altre parole, se la crescita della popolazione è
rapida, i lavoratori hanno una dotazione sempre più ridotta di capitale e, questa dimensione del
capitale per occupato, porta a una diminuzione della produttività e del Pil per occupato. Per
quanto la rapida crescita della popolazione non sia la causa principale della povertà dei paesi
meno sviluppati, alcuni analisti ritengono che una diminuzione della crescita demografica in
quei paesi potrebbe contribuire a elevare il tenore di vita. In alcuni di questi paesi tale obiettivo
è perseguito direttamente con leggi che regolano il numero di figli che ogni coppia può avere.
- la promozione del processo tecnologico: una rapida crescita della popolazione può presentare
anche dei benefici. Alcuni economisti hanno suggerito che la crescita della popolazione mondia-
le possa aver dato impulso al progresso tecnologico e alla prospettiva economica. Il meccanismo
è semplice: se ci sono più persone, ci sono anche più scienziati, inventori e tecnici che contribui-
scono al progresso tecnologico da cui tutti traggono benefici.
N.B. La funzione di produzione
Spesso gli economisti descrivono la relazione tra la quantità di fattori utilizzati nella produzione e la
quantità di prodotto che se ne ricava con la funzione di produzione. Supponiamo che Y indichi la
quantità di prodotto, L la quantità di lavoro, K la quantità di capitale fisico, H quella di capitale
umano e N quella di risorse naturali, si avrà Y = AF(L,K,H,N) dove F è una funzione che illustra
come i fattori sono combinati per realizzare il prodotto e A è una variabile che riflette la tecnologia
disponibile per la produzione. Se la tecnologia migliora, A aumenta e l’economia attinge a un livello
di produzione superiore per ogni data combinazione di fattori. Molte funzioni di produzione godono
di una proprietà detta rendimenti di scala costanti; in questo caso se si raddoppia la quantità di tutti
i fattori di produzione, anche la produzione raddoppia.
CAPITOLO 28: LA DISOCCUPAZIONE
Sebbene un certo grado di disoccupazione sia inevitabile in un sistema economico complesso in cui
operano migliaia di imprese e milioni di lavoratori, la quantità di disoccupazione varia sostanzial-
mente nel tempo e tra paesi diversi. Il problema della disoccupazione può essere diviso in due parti:
il problema di lungo periodo e quello di breve periodo. Il tasso naturale di disoccupazione dell’eco-
nomia si riferisce alla quantità di disoccupazione che un sistema economico sperimenta normalmen-
te. La disoccupazione ciclica si riferisce alle variazioni annuali della disoccupazione intorno al suo
tasso naturale, in risposta alle fluttuazioni dell’attività economica. Il numero di disoccupati nell’eco-
nomia è dato dal numero di individui in età lavorativa che, essendo abili e disponibili a lavorare al
saggio di salario corrente, non hanno un impiego. Normalmente gli economisti trovano più conveni-
ente parlare di tasso di disoccupazione pari al numero di disoccupati espresso in percentuale della
forza lavoro, che a sua volta può essere definita come il numero totale di persone che potrebbero es-
sere occupate nel sistema economico in un dato istante di tempo – questo deve essere pari al nume-
ro totale di persone occupate più il numero totale di persone disoccupate. In che modo gli uffici di
statistica e gli enti pubblici misurano il tasso di disoccupazione del sistema economico? Gli approc-
ci prevalenti sono essenzialmente sue:
1. il conteggio dei richiedenti sussidio (o il cosiddetto claimant count): poiché il governo dispone
già di tutti i dati necessario per calcolare il tasso di disoccupazione sulla base del conteggio dei
richiedenti sussidio, tale calcolo è relativamente poco costoso e semplice. Sfortunatamente,
questo metodo presenta una serie di gravi limiti. Un problema evidente è che risente dei cambia-
menti della normativa che stabilisce chi ha diritto a percepire il sussidio di disoccupazione.
54
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
2. i sondaggi sulla forza lavoro: consiste nell’intervistare un campione di persone sulla base di una
definizione accettata di disoccupazione. Sulla base delle risposte date alla domanda, il governo
colloca ciascun adulto maggiore di 16 anni appartenente a ogni famiglia del campione in una
delle seguenti tre categorie:
• occupato: una persona è detta occupata se ha trascorso almeno una parte della settimana
precedente impiegata in un’occupazione retribuita
• disoccupato: individuo senza lavoro, disposto a iniziare a lavorare nelle due settimane suc-
cessive e che ha cercato lavoro nelle quattro settimane precedenti oppure è in attesa di ini-
ziare a lavorare
• non appartenente alla forza lavoro (o economicamente inattivo): un individuo che non rica-
de nelle due categorie precedenti e che non appartiene alla forza lavoro
Dopo aver classificato ciascun individuo del campione in una delle tre categorie descritte, il gover-
no computa diverse statistiche per riassumere lo stato del mercato del lavoro. Si definisce forza la-
voro la somma di occupati e disoccupati:
Forza lavoro = numero degli occupati + numero dei disoccupati
Il tasso di disoccupazione può essere misurato come la percentuale della forza lavoro che è disoc-
cupata:
Numero di disocupati
Tasso di disoccupazione = Forza lavoro
x 100
Il governo ricorre ai risultati del medesimo sondaggio per produrre stime sul tasso di partecipazio-
ne ala forza lavoro, cioè la percentuale della popolazione adulta che fa parte della forza lavoro:
Forza lavoro
Tasso di partecipazione alla forza lavoro = Popolazione adulta x 100
Il tasso medio di disoccupazione intorno al quale oscillano le osservazioni annuali è detto tasso na-
turale di disoccupazione; la deviazione della disoccupazione rilevata annualmente dal livello natu-
rale è detta disoccupazione ciclica. Il tasso di disoccupazione non è mai nullo, ma oscilla in un
intorno del suo tasso naturale. La disoccupazione che risulta dal processo di collocamento al lavoro
viene detta disoccupazione frazionale e si ritiene che possa contribuire a spiegare la disoccupazio-
ne di breve periodo mentre, quando la quantità offerta di lavoro eccede la quantità domandata si ha
una disoccupazione strutturale. Esaminiamo ora quattro possibili spiegazioni del tasso naturale di
disoccupazione:
1. Collocamento al lavoro: una delle ragioni per cui i sistemi economici non possono eliminare del
tutto la disoccupazione è il collocamento al lavoro, ovvero il processo attraverso il quale i
lavoratori si inseriscono nei posti di lavoro disponibili. Se tutti i lavoratori e tutti i posti di
lavoro fossero uguali, ogni lavoratore sarebbe adatto a ogni posto di lavoro e il collocamento
non rappresenterebbe un problema. I disoccupati troverebbero presto un novo posto di lavoro
adatto alle proprie caratteristiche. Ma nella realtà i lavoratori sono diversi per capacità e
preferenze e i posti di lavoro si differenziano per caratteristiche. I lavoratori talvolta lasciano il
posto di lavoro perché ritengono che la propria occupazione non sia conforme ad aspettative, ca-
pacità e desideri e sperano di trovarne una migliore. Molti di questi lavoratori, soprattutto i gio-
vani, trovano rapidamente una nuova occupazione a un salario più elevato; tuttavia, dati gli
enormi progressi compiuti dalla tecnologia informatica negli ultimi anni, è probabile che molte
persone cerchino un nuovo impiego senza prima aver abbandonato il vecchio posto di lavoro.
Questo continuo rimescolamento della forza lavoro è normale in un sistema economico sano e
dinamico, ma la sua immediata conseguenza è la disoccupazione frizionale. Alcuni programmi
statali cercano di facilitare la ricerca di lavoro in modi diversi: una modalità è costituita dagli uf-
fici di collocamento pubblici che offrono informazioni sulle posizioni vacanti in modo da far
55
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
trovare al lavoratore il posto più adatto nel più breve tempo possibile. Una seconda modalità è
costituita dei programmi di formazione finanziati dallo Stato che hanno l'obiettivo di facilitare la
transizione dei lavoratori dai settori in declino verso i settori in crescita e di aiutare le compo-
nenti sociali più svantaggiate a sfuggire alla povertà. I sostenitori di questo genere di provvedi-
menti ritengono che possano contribuire un funzionamento più efficiente dell'economia, favo-
rendo la piena occupazione e riducendo l’iniquità generata da un contesto in continua evoluzio-
ne. I critici di questi programmi obiettano che il governo non dovrebbe essere coinvolto nel pro-
cesso di ricerca di lavoro e sostegno che sia meglio lasciare al mercato il compito di far coinci-
dere domanda e offerta di lavoro anche in senso qualitativo. Un provvedimento diffuso che con-
tribuisce, anche se involontariamente, ad aumentare la disoccupazione frizionale è il sussidio di
disoccupazione. Tale provvedimento è stato pensato per offrire ai lavoratori una parziale prote-
zione in caso di perdita del posto di lavoro; il sussidio viene corrisposto solo a coloro che sono
stati licenziati perché le loro competenze non ero più necessarie. Anche se il sussidio di disoccu-
pazione riduce l'incentivo a cercare lavoro e accresce la disoccupazione, non bisogna necessa-
riamente concludere che il sussidio di disoccupazione sia un male. Tale programma ha, infatti,
l'obiettivo primario di assistere finanziariamente individui i cui redditi sono diventati incerti;
inoltre, offrire a un lavoratore la possibilità di rifiutare un'offerta scarsamente qualificata signifi-
ca dargli l'occasione di trovare un posto più consono alle sue competenze e aspirazioni. Alcuni
economisti sostengono che il sussidio di disoccupazione aiuta a fare in modo che nel sistema
economico a ogni lavoratore corrisponda l'impiego più appropriato.
2. Leggi sul salario minimo: abbiamo visto che la disoccupazione frizionale è conseguenza inevita-
bile del processo di collocamento al lavoro. Passiamo adesso a esaminare come la disoccupazio-
ne strutturale sia provocata dall’insufficienza del numero dei posti di lavoro rispetto a quello dei
lavoratori. Le leggi sul salario minimo spesso sono vincolanti per i lavoratori meno qualificati e
per i membri più giovani della forza lavoro, e quindi meno esperti, come gli adolescenti. È solo
tra queste categorie di lavoratori che la legge sul salario minimo contribuisce a spiegare l'esi-
stenza della disoccupazione; se il salario viene mantenuto al di sopra del livello di equilibrio,
per qualsiasi ragione, il risultato è la disoccupazione. A questo punto, però, è necessario sottoli-
neare come la disoccupazione strutturale che deriva da salari superiori al livello di equilibrio sia
diversa della disoccupazione frizionale che discende dal processo di collocamento. Le distorsio-
ni del processo di collocamento nulla hanno a che vedere con l'incapacità dei salari di equilibra-
re domanda e offerta di lavoro: nei casi in cui la situazione della disoccupazione può essere fatta
risalire al collocamento, i lavoratori sono alla ricerca di un'occupazione che soddisfi le loro as-
pettative e sia adeguata alle loro competenze; al contrario, quando i salari sono al di sopra del
livello di equilibrio, la quantità di lavoro offerta è superiore a quella domandata e i lavoratori
sono disoccupati in attesa che si liberino dei posti lavoro.
3. Potere contrattuale dei sindacati: un sindacato è un’associazione di lavoratori che contratta con i
datori di lavoro salari e condizioni lavorative. La densità sindacale misura la proporzione della
forza lavoro iscritta a un sindacato, con l'esclusione di coloro che, per ragioni legali o de altra
natura, non possono farlo. In termini generali, ciò equivale a esprimere il numero di membri del
sindacato come percentuale della popolazione civile occupata più i disoccupati. I lavoratori is-
critti a un sindacato negoziano collettivamente il salario, i benefici accessori e le condizioni di
lavoro con il proprio datore di lavoro. Il processo attraverso il quale sindacati e imprese raggiun-
gono un accordo sulle condizioni di occupazione viene detto contrattazione collettiva. Nel
contrattare un'impresa, un sindacato chiede salari più elevati, benefici accessori migliori e mi-
gliori condizioni di lavoro di quanto l'impresa stessa sarebbe disposta ad offrire in assenza del
sindacato. Se il sindacato e l'impresa non raggiungano un accordo, il sindacato può prendere di-
versi provvedimenti per fare pressione sui datori di lavoro e convincerli a scendere a patti, per
esempio può dichiarare uno sciopero. Poiché lo sciopero riduce la produzione, le vendite e i pro-
fitti, sotto la minaccia di uno sciopero prolungato un'impresa può rassegnarsi a concessioni so-
stanziose. Secondo gli economisti che studiano gli effetti dell'azione dei sindacati, mediamente
un lavoratore iscritto al sindacato può guadagnare molto più di un collega non sindacalizzato
altrettanto qualificato ed esperto. Se l’azione del sindacato fa salire le retribuzione al di sopra
del livello di equilibrio, la quantità di lavoro offerta aumenta e quella domanda diminuisce, pro-
56
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
lOMoARcPSD|5870648
ducendo disoccupazione: i lavoratori che riesco a mantenere l'impiego ne traggono beneficio
ma, quelli che perdono il posto ne vengono danneggiati. In effetti, l'azione dei sindacati è spesso
causa di conflitto tra diversi gruppi di lavoratori: tra gli iscritti che beneficiano delle retribuzioni
sindacali più elevate e i non iscritti che non ottengono i posti di lavoro. I lavoratori non iscritti
ai sindacati possono seguire due linee di condotta: rimanere disoccupati e aspettare l'opportunità
di trovare un’occupazione a retribuzione elevata oppure offrire la propria opera in imprese non
sindacalizzate. Così, quando sindacato fa aumentare le retribuzioni in un comparto dell'econo-
mia, l’offerta di lavoro aumenta anche negli altri e, per questa ragione, i salari non sindacali di-
minuiscono. In altre parole, i lavoratori sindacalizzati scaricano sulle spalle di altri lavoratori il
costo dei benefici che ottengono attraverso la contrattazione collettiva.
Gli economisti hanno idee diverse sul fatto che l’azione dei sindacati sia un bene o un male per
l’economia. Il sindacato è criticato soprattutto sulla base del fatto che costituisce una forma di
cartello. Quando il sindacato fa aumentare le retribuzioni al di sopra del livello che si determine-
rebbe in un mercato concorrenziale, riduce la quantità domandata di lavoro e provoca disoccu-
pazione: l’allocazione del lavoro che ne risulta è inefficiente e iniqua. È inefficiente perché l'oc-
cupazione nelle imprese sindacalizzate è più bassa del livello concorrenziale ed efficiente ed è
iniqua perché il vantaggio di alcuni lavoratori è pagato da altri lavoratori. Chi invece sestine
l'opera del sindacato ne considera il potere di mercato come un necessario antidoto al potere di
mercato delle imprese che assumono lavoratori. I sostenitori dei sindacati, inoltre, affermano
anche che i sindacati sono importanti per costringere le imprese a rispondere in modo efficiente
alle istanze dei lavoratori. Anche se i sindacati hanno l'effetto negativo di innalzare artificial-
mente le retribuzioni, l’azione del sindacato contribuisce a soddisfare le istanze della forza lavo-
ro e quindi alla produttività.
4. Salario di efficienza: secondo la teoria del salario di efficienza, le imprese che operano con
maggiore efficienza se le retribuzioni sono superiori al livello di equilibrio; perciò per le impre-
se potrebbe essere profittevole mantenere le retribuzioni artificiosamente elevate, anche presen-
za di un eccesso di offerta di lavoro. Ci sono diverse interpretazioni della teoria del salario di ef-
ficienza, ciascuna delle quali spiega in modo diverso perché le imprese possono appoggiarsi pa-
gando salari superiori a livello di equilibrio; prendiamone in considerazione quattro:
- la salute del lavoratore: i lavoratori meglio pagati hanno un regime alimentare migliore e chi
mangia meglio è più sano e produttivo; un'impresa, dunque, può trovare più vantaggioso pagare
salari levati e avere lavoratori più sani e produttivi che pagare salari più bassi e avere, di conse-
guenza, lavoratori meno sani e produttivi
- il turnover dei lavoratori: quanto più un impresa paga i propri lavoratori, tanto meno di fre-
quente essi decidono, in media, di lasciare lavoro; dunque un'impresa può ridurre il turnover dei
lavoratori corrispondendo retribuzioni più elevate
- l’impegno dei lavoratori: se i salari sono più elevati, i lavoratori hanno un forte incentivo a
conservare la propria occupazione e, perciò, a impegnarsi al meglio delle proprie capacità
- la qualità dei lavoratori: quando un'impresa assume nuovi lavoratori, non può valutare perfet-
tamente la qualità dei singoli candidati; pagando un salario più elevato, le imprese attraggono un
miglior bacino di potenziali dipendenti.
57
Downloaded by Beatrice Papa (beatrice.papa25@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Dispensa Di MacroeconomiaDocumento146 pagineDispensa Di MacroeconomiaRepazzo100% (1)
- Appunti Di Economia Industriale - CorrettoDocumento197 pagineAppunti Di Economia Industriale - CorrettoDenis Hoxha100% (1)
- Matematica FinanziariaDocumento11 pagineMatematica FinanziariaSilvia GrigolettoNessuna valutazione finora
- Macroeconomia - Blanchard Cap 1 2 3 4 5Documento45 pagineMacroeconomia - Blanchard Cap 1 2 3 4 5charlieNessuna valutazione finora
- Domande MacroeconomiaDocumento2 pagineDomande MacroeconomiaGianmarco AltieriNessuna valutazione finora
- Economia PoliticaDocumento18 pagineEconomia PoliticaLe RodriguezNessuna valutazione finora
- Economia e Organizzazione IndustrialeDocumento60 pagineEconomia e Organizzazione IndustrialeBetty MarrasNessuna valutazione finora
- Riassunto MicroeconomiaDocumento143 pagineRiassunto MicroeconomiaIlaria BaisiNessuna valutazione finora
- Mercati Finanziari: Scopri Tutti i Segreti del Mercato. La guida Completa per Capire la Finanza, Sviluppare la tua Economia e Puntare ai Giusti Investimenti.Da EverandMercati Finanziari: Scopri Tutti i Segreti del Mercato. La guida Completa per Capire la Finanza, Sviluppare la tua Economia e Puntare ai Giusti Investimenti.Nessuna valutazione finora
- Appunti Mat FinanzaDocumento166 pagineAppunti Mat FinanzaEnrico100% (1)
- Microeconomia RosenDocumento56 pagineMicroeconomia RosenSara CostantinoNessuna valutazione finora
- Economia Monetaria Internazionale-2002 PDFDocumento283 pagineEconomia Monetaria Internazionale-2002 PDFAloisia DavìNessuna valutazione finora
- Capitolo 12 Il Monopolio: Robert H. Frank Microeconomia - 4Documento37 pagineCapitolo 12 Il Monopolio: Robert H. Frank Microeconomia - 4Umberto Maria LupoNessuna valutazione finora
- Diritto e Diritti RiassuntoDocumento34 pagineDiritto e Diritti RiassuntoSilvio GiovanniniNessuna valutazione finora
- Riassunti Scoprire La Macroeconomia BlanchardDocumento21 pagineRiassunti Scoprire La Macroeconomia Blanchardsaretta__1990100% (1)
- Riassunti Scienza Delle FinanzeDocumento53 pagineRiassunti Scienza Delle FinanzegabrieleNessuna valutazione finora
- Esame MicroeconomiaDocumento128 pagineEsame MicroeconomiaFrancesco Romanelli100% (1)
- Elementi Di Economia AziendaleDocumento33 pagineElementi Di Economia AziendaleDavid Ricardo100% (1)
- Riassunto Macroeconomia - Imbriani, LopesDocumento52 pagineRiassunto Macroeconomia - Imbriani, LopesDaniela Cori100% (3)
- Economia Aziendale 2Documento83 pagineEconomia Aziendale 2Giulia CaputoNessuna valutazione finora
- Capitolo-6 MicroDocumento34 pagineCapitolo-6 MicroManueloPetraccoNessuna valutazione finora
- Fiscalità Internazionale - I sistemi antievasione tra gli Stati dell’Unione EuropeaDa EverandFiscalità Internazionale - I sistemi antievasione tra gli Stati dell’Unione EuropeaNessuna valutazione finora
- Riassunto IntermediariDocumento82 pagineRiassunto IntermediariAntonioAlbertoCocco100% (3)
- Tematiche TesiDocumento9 pagineTematiche TesiwhitequeenNessuna valutazione finora
- Contabilita e Bilanci Imprese - Rilevazioni in PD PDFDocumento219 pagineContabilita e Bilanci Imprese - Rilevazioni in PD PDFGiuseppe Cafasso100% (1)
- Economia AziendaleDocumento87 pagineEconomia AziendalesaraNessuna valutazione finora
- Riassunto Macroeconomia BlanchardDocumento35 pagineRiassunto Macroeconomia BlanchardSara Costantino0% (1)
- Riassunto Di Microeconomia - Concetti-Fondamentali - Pindyck-RubinfeldDocumento18 pagineRiassunto Di Microeconomia - Concetti-Fondamentali - Pindyck-Rubinfeldunkarmapesante50% (2)
- Pensare Da Economisti Vi Principi Di Economia 4ed Robert H Frank Ben SDocumento426 paginePensare Da Economisti Vi Principi Di Economia 4ed Robert H Frank Ben SCosimo CapacchioneNessuna valutazione finora
- Capitolo 15 Equilibrio Generale Ed Efficienza Dei Mercati: Robert H. Frank Microeconomia - 4Documento31 pagineCapitolo 15 Equilibrio Generale Ed Efficienza Dei Mercati: Robert H. Frank Microeconomia - 4Umberto Maria LupoNessuna valutazione finora
- Macroeconomia - Riassunti CompletiDocumento40 pagineMacroeconomia - Riassunti CompletiIlaria TranquilloNessuna valutazione finora
- Scienza Delle Finanze PDFDocumento30 pagineScienza Delle Finanze PDFRobert Dickerson100% (1)
- Economia Politica A-D E-N Proff. P. Parravicini e A. GraffiDocumento3 pagineEconomia Politica A-D E-N Proff. P. Parravicini e A. GraffiTauredonNessuna valutazione finora
- L'essenziale Di Economia, Mankiw, Capitoli 1,2,3,4,5Documento9 pagineL'essenziale Di Economia, Mankiw, Capitoli 1,2,3,4,5SaraNessuna valutazione finora
- Economia Politica RiassuntiDocumento68 pagineEconomia Politica RiassuntiTommaso LucchiniNessuna valutazione finora
- Caso Shuman Automobiles Inc Gruppo 12Documento25 pagineCaso Shuman Automobiles Inc Gruppo 12andreea21nistor5715Nessuna valutazione finora
- Riassunto Del Libro Economia SamuelsonDocumento79 pagineRiassunto Del Libro Economia SamuelsonPiergiorgio100% (3)
- Appunti Politica EconomicaDocumento47 pagineAppunti Politica Economicatangled91Nessuna valutazione finora
- Scienza Delle Finanze (Completo)Documento115 pagineScienza Delle Finanze (Completo)roberto frisennaNessuna valutazione finora
- Economia-Samuelson RiassuntiDocumento79 pagineEconomia-Samuelson RiassuntiLuca Di BariNessuna valutazione finora
- Economia Aziendale - Teoria (formato breve)Da EverandEconomia Aziendale - Teoria (formato breve)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Concorso Funzionari Agenzia Entrate - Strumenti e tecniche estimaliDa EverandConcorso Funzionari Agenzia Entrate - Strumenti e tecniche estimaliNessuna valutazione finora
- Appunti Di MacroeconomiaDocumento42 pagineAppunti Di MacroeconomiaValentinaNessuna valutazione finora
- La Scienza Delle FinanzeDocumento30 pagineLa Scienza Delle FinanzeGiovanniRana100% (2)
- Economia e Gestione Delle ImpreseDocumento43 pagineEconomia e Gestione Delle Impresemitxael83Nessuna valutazione finora
- Macroeconomia Riassunto Completo LibroDocumento61 pagineMacroeconomia Riassunto Completo LibroFabio GerminarioNessuna valutazione finora
- Economia e Gestione Delle ImpreseDocumento36 pagineEconomia e Gestione Delle ImpreseFrancesco Soprano100% (1)
- Libro Matematica Finanziaria PDFDocumento129 pagineLibro Matematica Finanziaria PDFmarcoNessuna valutazione finora
- Introduzione Alla MacroeconomiaDocumento30 pagineIntroduzione Alla MacroeconomiaAndrea CentonzeNessuna valutazione finora
- Dispense Di Matematica FinanziariaDocumento31 pagineDispense Di Matematica FinanziariaMarco MartinozzoNessuna valutazione finora
- Teoria Del Consumatore UtilitàDocumento5 pagineTeoria Del Consumatore Utilitàkrotox96Nessuna valutazione finora
- Diritto Tributario Boria Riassunti PDFDocumento183 pagineDiritto Tributario Boria Riassunti PDFAlessia Bianchini0% (1)
- Intermediari FinanziariDocumento106 pagineIntermediari FinanziariGregorio GalatiNessuna valutazione finora
- Microeconomia PindyckDocumento37 pagineMicroeconomia PindyckChiara Di GaetanoNessuna valutazione finora
- MacroeconomiaDocumento28 pagineMacroeconomiaCR AppaltiNessuna valutazione finora
- Economia Politica GlossarioDocumento2 pagineEconomia Politica Glossarioapi-3737657100% (1)
- Riassunti Scienza Delle FinanzeDocumento55 pagineRiassunti Scienza Delle FinanzeEle MosinaNessuna valutazione finora
- Scienze Delle FinanzeDocumento93 pagineScienze Delle FinanzeGiuseppe FumarolaNessuna valutazione finora
- Scienza Delle Finanze 21Documento3 pagineScienza Delle Finanze 21Alessia MaglianoNessuna valutazione finora
- Economia Del LavoroDocumento77 pagineEconomia Del LavoroninaNessuna valutazione finora
- Esercizi Scienza Delle FinanzeDocumento19 pagineEsercizi Scienza Delle FinanzeAssan AchibatNessuna valutazione finora
- Finanza AziendaleDocumento26 pagineFinanza AziendaleganadorfNessuna valutazione finora
- Le grandi teorie per investire nelle opzioni binarie. La teoria di Dow, Fibonacci e Elliott e la loro applicazione pratica nelle Opzioni bnarieDa EverandLe grandi teorie per investire nelle opzioni binarie. La teoria di Dow, Fibonacci e Elliott e la loro applicazione pratica nelle Opzioni bnarieNessuna valutazione finora
- La Politica Come ProfessioneDocumento4 pagineLa Politica Come ProfessioneGiuseppe MagistroNessuna valutazione finora
- ADAM SMITH - Teoria Del Vantaggio AssolutoDocumento9 pagineADAM SMITH - Teoria Del Vantaggio AssolutoSergiu DamianNessuna valutazione finora