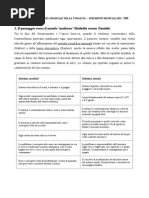28/12/2010
Musica greca
Si distinguono diverse fasi di sviluppo:
1. Il periodo arcaico (fine VIII – primi VII sec. aC): progressi nella costruzione della lira
e nell’arte di suonarla. La figura più importante è quella di Terpandro di Lesbo,
grande citaredo.
2. Fine VI secolo: spicca la figura di Laos di Ermione che forse coniò la parola mousiké.
Egli introdusse nella musica una complessità, una forza espressiva e un
intellettualismo ignoti fino a quel momento. E’ un’epoca di preparazione al periodo
successivo
3. Nuova Musica (tardo V secolo): si intensifica l’attività teorica da parte di autori come
Damone ed Eratocle. La Nuova Musica è caratterizzata da modulazioni e
molteplicità di note. Fu un periodo di grandi esecutori professionisti, di citaredi e
auleti virtuosi. Critici conservatori come Platone e Aristosseno deploravano la Nuova
Musica anche se questa godeva del favore popolare. Fra i musici più importanti si
ricordano Timoteo di Mileto (ca. 450– 360) e Filosseno di Citera (ca. 435– 380).
4. Fra il I secolo aC e il I secolo dC secolo si registra una lacuna nella documentazione
disponibile. Infatti i documenti successivi si attestano attorno al I secolo dC: in
questo periodo lo stile musicale risulta meno ambizioso ed elaborato, il genere
diatonico aveva trionfato sul cromatico, l’intervallo di quarta perde importanza
rispetto al passato mentre prevale la terza. Una delle più tarde composizioni
appartenenti a questo stile è un inno cristiano del III secolo dC (si tratta del celebre
Papiro di Ossirinco)
1
� 28/12/2010
L’importanza delle musica presso gli antichi greci
2
� 28/12/2010
Alcuni frammenti di musica greca giunti sino a noi (circa 60):
- un frammento del primo stasimo (canto corale) della tragedia Oreste di
Euripide, su papiro (V sec. a C )
- un frammento, forse di tragedia, su papiro, conservato al Cairo (fine del III
sec. a.C.)
- 2 inni delfici in onore di Apollo, il primo in notazione vocale, il secondo
strumentale, appartenenti al tempio chiamato il Tesoro degli Ateniesi di
Delfi, incisi su pietra (ca 150 a C.)
- L’Epitaffio di Sìcilo, inciso su un cippo funerario scoperto a Tralles,
nell’Asia minore (II o I sec a C.)- Peana sul suicidio di Aiace, su papiro
conservato a Berlino (ca. 160 d.C.);
- 3 inni: alla musa Calliope, al Sole, a Nemesi, di Mesomede di Creta,
musico dell’imperatore Adriano (I sec. d.C. pubblicati nel Dialogo della
musica antica et della moderna del Galilei che però non li seppe
trascrivere).
- 3 frammenti vocali e 2 strumentali di Contrapollinopolis (1 sec. d.C.). È
probabilmente falso il frammento della prima Ode pitica di Pindaro
pubblicato nella Musurgia universalis (1650) di padre Attanasio Kircher
La notazione
L’esistenza della notazione, che risale solo al IV secolo a.C.,
non contraddice la condizione di documento orale comune al
patrimonio di canti della Grecia antica. La scrittura musicale
greca non aveva, si ritiene, il valore di mezzo di comunicazione
che ebbe, a partire dalla fine del primo millennio dell’era
volgare, la notazione neumatica, ma serviva solo ai musicisti
professionisti per loro uso privato.
C’erano due tipi di notazione: vocale e strumentale. La
notazione vocale impiegava, con poche varianti, i segni
dell’alfabeto greco maiuscolo; la notazione strumentale segni
derivati forse dall’alfabeto fenicio e usati diritti, inclinati o
capovolti. Il significato della notazione greca ci è stato
tramandato da Alipio (IV sec. dC) nella sua Introduzione alla
musica.
3
� 28/12/2010
notazione vocale
notazione strumentale
epitaffio di Sicilo (audio)
4
� 28/12/2010
Strumenti musicali
Famiglia della lira
5
� 28/12/2010
lira
cetra
6
� 28/12/2010
Phormynx
Famiglia dell’arpa
7
� 28/12/2010
Arpa eolica
Strumenti a fiato
8
� 28/12/2010
aulos
Nomos M per aulos solo
9
� 28/12/2010
famiglia della syrinx
(flauto di Pan)
crotali (di legno o metallo)
tamburello
sistri
cimbali
campane
10
� 28/12/2010
La teoria musicale
I trattati
I trattati greci sulla musica non sono trattati di musica secondo il
significato che noi diamo oggi al termine. Essi sviluppavano soprattutto
il problema della suddivisione dell’ottava e la teoria degli intervalli.
L’approccio era prevalentemente matematico.
Una tradizione millenaria pone all’origine della trattatistica greca il
nome del filosofo e matematico Pitagora di Samo (sec. VI a.C.).
Dopo essere stato in Egitto e in Mesopotamia, si stabilì nella Magna
Grecia e a Crotone fondò una scuola filosofica. A lui e ai suoi seguaci si
è fatta risalire l’adozione del monocordo per definire i rapporti degli
intervalli consonanti mediante le suddivisioni d’una corda. Il sistema
pitagorico però ci è noto solo indirettamente (Pitagora non lasciò
scritti), attraverso una tradizione che fu formulata in trattati - di epoca
molto più tarda - di Gaudenzio, di Nicomaco e soprattutto nel De
institutione musica di Boezio.
11
� 28/12/2010
Storicamente la trattatistica greca ebbe origine più tarda e se ne
considera il più autorevole esponente Aristosseno di Taranto, discepolo di
Aristotele (sec. III a.C.), autore dei fondamentali Elementa harmonica ed
Elementa rhytmica. La nostra conoscenza della teoria musicale greca si
basa soprattutto sull’opera di Aristosseno, ripresa e integrata dagli
apporti dei suoi seguaci, gli “armonisti”.
Nelle epoche ellenistica e romana i trattatisti furono numerosi.
Ricordiamo: il matematico Euclide (IV-III sec. a.C.) - il dialogo De musica
attribuito a Plutarco (I-II sec. d.C.); - il geografo alessandrino Claudio
Tolomeo (Il sec. d.C.); - Aristide Quintiliano (II sec. d.C.), autore di un De
musica, importante per l’approfondita trattazione della materia; - Alipio
(IV sec. d.C.) la cui Introduzione alla musica contiene delle Tavole che
hanno fornito la chiave per trascrivere le musiche greche a noi pervenute.
II. Generi, modi, armonie, sistema perfetto
La base del sistema musicale greco era costituita dal tetracordo, una successione
di quattro suoni discendenti compresi nell’ambito di un intervallo di quarta giusta.
I suoni estremi di un tetracordo erano fissi; quelli interni erano mobili.
L’ampiezza degli intervalli di un tetracordo caratterizzava i 3 generi della musica
greca: diatonico, cromatico, enarmonico:
12
� 28/12/2010
Sistema teleion o perfetto
a) si parte dall’esacordo mi– re– do–si; b) si aggiungono un tetracordo congiunto all’acuto, un tetracordo
disgiunto al grave seguito da un secondo tetracordo congiunto ancora più grave
A
sez
diatonica
B
sez
cromatica
13
� 28/12/2010
Audio
14
� 28/12/2010
Audio
La musica nella tragedia greca
Origini della tragedia
In epoca di civiltà agricola, le feste campestri in onore di Dioniso assumono via via
importanza sempre maggiore: piccole e grandi dionisiache. In queste feste s’intona il
«ditirambo», l’inno in onore del nume. Questo prende il nome di tragodía (dal greco
) ossia «canto del capro», da quando ad esso s’accompagna il sacrificio di
un capretto, particolarmente sacro a Dioniso, forse perché è il guastatore della vigna.
Come sorse il dramma?
Un giorno il coro si divise in due semicori uno dei quali rispondeva all’altro; e,
siccome ciascun semicoro era guidato da un corifeo, questi corifei cominciarono a
dialogare fra loro. Ai canti dei due corifei e dei loro semicori celebranti le gesta del
nume, qualcuno – un risponditore, un hypocritès (attore) – rispose le parole di
Dioniso in persona. Da quel momento si ebbe un embrione di rappresentazione
teatrale. Quando poi, oltre a Dioniso, si cominciano a invocare altri dèi, o eroi, con cui
egli s’incontra, o quando, messo da parte Dioniso, si incomincia a invocare qualsiasi
eroe, e a farlo apparire durante il canto che lo celebra, la Tragedia ha già conquistato
le sue essenziali libertà.
15
� 28/12/2010
Nascita della tragedia
skenè
hypocritès
coro
Altare
semicoro A
corifeo A corifeo B
pubblico
Maschera di
Dioniso. II sec. a.c.
16
� 28/12/2010
La tradizione attribuisce la prima rappresentazione tragica a
Tepsi (534 a.C.) autore delle Grandi Dionisiache. Tuttavia,
spetta a Frinico e ancor più a Eschilo, Sofocle ed Euripide il
compito di aver condotto ad altissimo livello artistico e
drammatico la tragedia. Dopo che l’unico attore
(protagonista) della primitiva Tragedia, Eschilo ebbe
aggiunto il secondo (deuteragonista) e Sofocle il terzo
(tritagonista), la cifra di tre, nella Tragedia, non fu superata:
sempre intendendosi che ciascun attore poteva fare
successivamente più parti. Tuttavia fu ammesso un quarto
personaggio muto, o che dicesse pochissime parole; come
pure si ammisero, oltre i tre attori, personaggi infantili, e,
oltre il Coro, gruppi di popolo, servi, ancelle, guardie ecc.
La Tragedia è dunque nata attorno alla thymele: all’ara del dio, su cui gli
sarà offerto il sacrificio. Nel ditirambo i coreuti si disponevano in circolo
attorno a questa. Ma sopravvenuto il risponditore, l’hypocrites, l’attore,
i coreuti si tirano un po’ da parte, a circa due terzi di cerchio, lasciando
l’altro terzo per la tenda da cui l’attore esce e dove rientra, a celarsi e a
travestirsi. Quella povera tenda si chiama skenè: è la scena! (più tardi
sarà un edificio in muratura).
Qui il racconto delle origini della Tragedia fatto da Aristotele, dà la più
ovvia e seducente spiegazione della nascita della Tragedia. Per
consentire al pubblico di vedere quanto avveniva attorno alla thymele
c’erano due possibilità: o alzare gli attori verso l’alto o alzare il pubblico.
Secondo la tradizione adottarono questa seconda soluzione: cercarono
il declivio di una collina e vi collocarono gli spettatori in apposite
scalinate di legno, disposte a semicerchio dietro il Coro.
Dopo una serie di adattamenti e trasformazioni successive, il teatro
greco assunse infine questi elementi (attorno alla fine del I sec. a. C. e il
II d. C.):
17
� 28/12/2010
1. il Kòilon ossia gradinate divise in settori;
2. l’Orchestra, sede del Coro, con la thymele in mezzo;
3. le due pàrodoi, ingressi del Coro, ai limiti estremi, desto e
sinistro, delle gradinate;
4. il proskènion, o palcoscenico, dove prima o poi agirono gli
attori, e che taluno ritiene fosse in comunicazione con
l’orchestra mediante scala di legno;
5. la skenè, edificio in pietra rappresentante un palazzo regale
con tre porte e talvolta cinque;
6. dietro alla skenè, i camerini per gli attori, e i ripostigli per gli
attrezzi e i meccanismi.
pàrodoi skenè
proskènion
Kòilon
Orchestra
thymele
18
� 28/12/2010
il teatro di Epidauro
19
� 28/12/2010
La messinscena
Da principio il regista è lo stesso poeta. Gli attori greci, tutti uomini anche per le
parti femminili, dovevano apparire come enormi fantocci, a raffigurare eroi al di
sopra della comune umanità. E perciò, nella Tragedia, elevati nella statura e
ingranditi: grazie ai coturni, calzature con una suola spropositamente alta;
all’onkos che era un’acconciatura dei capelli straordinariamente rialzata,
torreggiante; alle imbottiture di tutta la persona; e alle grosse maschere (nella
Tragedia piange sempre, nella commedia, al contrario, ride). S’aggiunga che nella
bocca della maschera c’era un megafono; ciò non tanto per ragioni di acustica,
ma per moltiplicare la voce dell’eroe, come s’era fatto con la sua figura.
Ai tempi di Eschilo, lo spettacolo tragico consisteva non in una sola ma in una
trilogia ossia in un seguito di tre tragedie, aventi il carattere di un poema ciclico,
nel quale ciascun dramma svolgeva una parte del soggetto comune. La prima
tragedia doveva parlare all’animo dello spettatore, e cioè essere
prevalentemente drammatica; la seconda all’orecchio, essere cioè
essenzialmente lirica; la terza all’occhio, e cioè offrirgli un grande spettacolo
visivo.
20
� 28/12/2010
Maschere greche per la tragedia e la commedia
Gli spettacoli prevedevano la presenza della musica, ma in maniera dissimile al
nostro melodramma poiché nella Tragedia greca la musica, composta dallo
stesso poeta, non era che un commento alla poesia, la quale aveva il primo
posto.
Le parti della Tragedia sono:
1. Il prologo (scena preliminare);
1a. La pàrodos (canto del coro che entra a ritmo di danza);
2. Gli episodi (noi diremo gli atti, di solito 3; ma non divisi da sipario, bensì
dagli stasimi);
2a. gli stasimi (i canti che il Coro leva negli intermezzi fra un episodio
e l’altro, stando in orchestra);
3. L’esodo (il canto corale di uscita; oppure scena finale).
Come si vede la musica riveste un’importanza fondamentale negli stasimi. Qui
va osservato che il coro greco assolve ad uffici pratici: espone gli antefatti, fa
conoscere quanto avviene tra un episodio e l’altro fuor della vista degli
spettatori; commenta. È, in definitiva, «la voce del poeta» e lo «spettatore
ideale».
21
� 28/12/2010
schema della tragedia
22
� 28/12/2010
Audio
23
� 28/12/2010
La dottrina dell’ethos
Era opinione comunemente accettata che ogni harmonia causasse
infallibilmente un ethos (pl. ethe), cioè un particolare effetto sull'animo e sul
corpo umano. L'harmonia dorica ad esempio, quella più strettamente legata
alla lyra, era considerata la più grave e la più virile, e determinava nell'animo
compostezza e moderazione; l’armonia frigia, al contrario, inseparabile dal
dionisiaco aulós, suscitava necessariamente un ethos 'entusiastico'
(enthusiasmós significava 'avere il dio in sé, ma anche 'perdersi nel dio') ed
emozioni sfrenate.
Un esempio fra tanti è il seguente aneddoto, tramandato in varie versioni:
alcuni giovani ubriachi, eccitati dal suono frigio dell'aulós, volevano
abbattere la porta della casa di una ragazza per violentarla. Il filosofo
Pitagora, che era presente, non sapendo come fare per fermarli da solo, si
rivolse allo strumentista, pregandolo di suonare nel modo dorico (l'harmonia
del dominio di sé, severa e pacata). Immediatamente gli assalitori si
risvegliarono dall'ebbrezza e, pentiti, si allontanarono.
24
� 28/12/2010
La teoria dell'ethos pervadeva completamente la visione
greca della musica: alla musica veniva attribuito un
potentissimo effetto non solo sull'animo, ma anche sul corpo
umano (ad esempio, abbiamo prescrizioni terapeutiche di
melodie frigie per guarire la sciatica; e narra il mito che
Taleta salvò gli Spartani dalla peste proprio per mezzo della
musica), sugli animali (il mitico Orfeo ammansiva le belve
feroci con il suo canto) e sugli esseri inanimati (Anfione
costruì le mura di Tebe muovendo le pietre con il suono della
lyra). Il canto di Orfeo avrebbe avuto addirittura la possibilità
di vincere l'Invincibile per eccellenza: la morte; ma ciò che
alla musica sarebbe stato concesso restò pur sempre
inaccessibile alla debolezza degli esseri umani, ed Euridice
venne inghiottita di nuovo dalle tenebre degli Inferi.
Orfeo incanta le bestie feroci
25
� 28/12/2010
Tenendo presente che il termine greco musiké, pur se
generalmente tradotto con la parola 'musica', implicava in realtà
tutta l'arte ispirata dalle Muse (non solo musica, dunque, ma
anche poesia e danza, da essa inscindibili), si può allora
comprendere facilmente perché tra il V e il IV secolo si accese un
grande dibattito sullo sfruttamento a fini politici di un mezzo così
potente per la manipolazione del consenso. Attribuendo queste
opinioni a Socrate e a Damone (il filosofo maestro di Pende),
Platone affermò perfino che non s'introducono mai cambiamenti
nei modi della musica senza che se ne introducano nelle più
importanti leggi dello Stato, e che la trasgressione in campo
musicale può riuscire ad infiltrarsi dolcemente e subdolamente
nei caratteri e nelle abitudini finendo col sovvertire ogni cosa,
nella vita privata come in quella pubblica.
Calliope (poesia epica), Clio
(storia), Polimnia
(pantomima), Euterpe
(musica: flauto), Tersicore
(danza), Erato (lirica
corale), Melpomene
(tragedia), Talia
(commedia), Urania
(astronomia).
26
� 28/12/2010
Nella polis ideale di Platone, dunque, la presenza della musica doveva
essere accuratamente regolamentata, per indirizzare i suoi effetti
dirompenti esclusivamente verso uno scopo di educazione morale della
futura classe dirigente. Il concetto platonico della musica è stato definito
'catarsi allopatica' : una musica appropriata può infondere una determinata
virtù a chi ne è privo o a chi è in preda al vizio opposto, purificandolo. Solo
utilità, dunque, e non piacere; era questo il criterio che dettava le rigide
norme del filosofo ateniese, e in base al quale egli eliminava esplicitamente
dalla sua utopica città perfino la poesia che, a suo avviso, non sarebbe stata
'utile' a nulla. In campo propriamente musicale, allora, egli permetteva solo
le harmonìai dorica e frigia (quest'ultima è qui intesa come spontanea,
persuasiva e non violenta); conseguentemente venivano banditi tutti gli
strumenti (e i relativi costruttori) in grado di suonare anche le altre
harmonìai, quali gli strumenti a molte corde e, soprattutto, l'aulós, «lo
strumento più ricco di suoni».
L’unico repertorio ammesso, poi, era quello delle melodie tradizionali, quelle
che non a caso venivano dette nómoi, cioè leggi: Platone respingeva con
sdegno le innovazioni della musica più moderna, qual era quella di Euripide e
del suo amico Timoteo. La nuova musica, infatti, cercava di svincolarsi da un
rapporto troppo stretto con la dizione narrativa del testo e con la sua metrica,
cercando piuttosto di esplicitarne i contenuti emotivi attraverso una maggiore
libertà e autonomia dei mezzi musicali.
Più aperto e permissivo era invece Aristotele, che si basava su un concetto
definibile come 'catarsi omeopatica' : anche un ethos negativo è accettabile
perché, attraverso un perturbamento controllato, l'animo può espellere fuori
di sé le proprie negatività e ritornare allo stato normale, come dopo una cura
medica.
Ma ambedue i filosofi erano pienamente d'accordo nel vietare ai giovani ogni
professionismo musicale: la musica doveva sempre rimanere un'utile
occupazione per il tempo libero di un giovane colto, e mai scadere al livello di
un'attività lavorativa (e quindi, in una società schiavista, riservata alla
condizione servile).
27
� 28/12/2010
La musica a Roma
28
�28/12/2010
29
� 28/12/2010
Buccina
Tuba
30