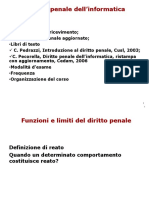Fiandaca Musco Riassunto Completo Diritto Penale Parte Generale
Caricato da
hdcx27ydwqFiandaca Musco Riassunto Completo Diritto Penale Parte Generale
Caricato da
hdcx27ydwqlOMoARcPSD|7662442
Fiandaca Musco - riassunto completo - Diritto penale Parte
speciale
Diritto dell'Unione Europea (Università degli Studi di Foggia)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
DIRITTO PENALE
PARTE GENERALE
FIANDACA-MUSCO
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE PRIMA
DIRITTO PENALE E LEGGE PENALE
CAPITOLO UNO
CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL DIRITTO PENALE
La necessità di ricorrere al diritto penale si spiega in base al fatto che i mezzi di protezione degli altri
settori dell’ordinamento non risultano sempre idonei a prevenire la commissione di fatti socialmente
dannosi, specie la sanzione per antonomasia, la pena detentiva, risulta molto scoraggiante per coloro
che volessero commettere un reato. Questa attitudine preventiva di manifesta in una duplice forma:
Prevenzione generale: la minaccia della sanzione penale tende a distogliere la generalità dei
consociati dal commettere reati
Prevenzione speciale: l’inflizione della pena mira ad impedire che il singolo autore del reato
torni a delinquere
Si definisce REATO ogni fatto Nel nostro ordinamento, le
Il DIRITTO PENALE è quella umano alla cui realizzazione SANZIONI PENALI sono la pena e
parte del diritto pubblico la legge riconnette la misura di sicurezza, in
che disciplina i fatti sanzioni penali. quanto entrambe mirano a
costituenti reato. difendere la società e a
risocializzare il delinquente.
Il reato ruota tendenzialmente attorno a tre principi cardine:
1. Principio di materialità: non può esservi reato se la volontà criminosa non si traduce in un
comportamento esterno
2. Principio di necessaria lesività o offensività: è necessario che il comportamento esterno
leda o ponga in pericolo beni giuridici
3. Principio di colpevolezza: un fatto materiale lesivo di beni giuridici può essere penalmente
attribuito all’autore a condizione che allo stesso si possa muovere un rimprovero per averlo
commesso
LA PROTEZIONE DEI BENI GIURIDICI
La paternità del concetto di bene giuridico si fa facilmente determinabile) e bene giuridico,
risalire al tedesco Birnbaum, che criticò la vecchia portando alla completa annullazione della funzione
concezione del reato come violazione di un diritto limitativa della teoria del bene giuridico.
soggettivo. Liszt evidenziò l’importanza della teoria I teorici nazional-socialisti tentano di superare
del bene giuridico come tecnica per limitare la completamente il concetto di bene giuridico,
potestà punitiva dello stato, inserendosi all’interno innestando al centro del reato la violazione del
della teoria di Jhering per cui il diritto penale ha dovere di fedeltà nei confronti dello stato etico.
come scopo la soddisfazione di bisogni sociali, Vi è quindi l’assorbimento della sfera del diritto in
preesistenti alla disciplina giuridica. quella dell’etica.
Di conseguenza, Liszt proponeva come beni
giuridici gli interessi preesistenti all’interno della
società, non riuscendo tuttavia a fornire criteri
idonei ad identificarli concretamente.
L’accoglimento della teoria del bene giuridico in
Italia si fa risalire all’elaborazione di Arturo Rocco,
secondo cui il concetto di bene giuridico non può
prescindere dalle valutazioni normative già
compiute dal legislatore, perdendo però così quella
funzione di delimitazione al potere punitivo statale.
Secondo la concezione c.d. metodologica, che
esclude ogni rilevanza al significato pre-giuridico
dei beni, il concetto stesso di bene giuridico va
ridimensionato, diventando una formula riassuntiva
dello scopo della norma penale. Questa concezione
fa quindi coincidere ratio legis (che non sempre è
3
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Secondo la concezione ad oggi dominante, il diritto penale contribuisce ad assicurare le condizioni
essenziali della convivenza, predisponendo la sanzione più drastica a difesa dei beni giuridici, ovvero
i beni socialmente rilevanti, meritevoli di tutela in ragione della loro importanza.
In sede di concreta definizione del bene giuridico, si riscontrano tuttavia difficoltà. Infatti, la sola
definizione di bene giuridico non può costituire la linea di demarcazione fra oggetti meritevoli o meno
di protezione penale, risultando decisive le scelte operate dal legislatore al riguardo.
La dottrina più recente ha posto l’accento sul carattere dinamico degli oggetti della tutela penale.
Questo significa che bene giuridico non equivale ad una semplice cosa od interesse dotato di valore di
per sé; piuttosto, i beni giuridici esistono soltanto se, e nella misura in cui, producono effetti utili nella
vita sociale. I beni, quindi, non sono entità intangibili che pretendono una tutela assoluta, dal momento
che in determinati casi può risultare utile sacrificarne qualcuno, in vista del perseguimento di altri
vantaggi sociali.
La definizione più appropriata di bene giuridico è quella che lo individua come unità di funzione,
ponendo in evidenza la specifica funzione strumentale nel processo di interazione sociale, dato che è
bene giuridico soltanto quell’interesse idoneo a realizzare un determinato scopo utile per il sistema
sociale. Anche questa definizione sconta comunque il prezzo di non rendere sempre agevole la
concreta individuazione dei beni.
L’idea della protezione dei beni giuridici è di origine illuminista, evidenziando la razionalità
strumentale dell’ordinamento penale. Questo vuol dire che il diritto penale non ha come scopo la
realizzazione di un ideale scopo di giustizia, ma il perseguimento di un obiettivo pratico e socialmente
utile: proteggere quei beni/interessi dalla cui tutela dipende la garanzia di una convivenza pacifica.
Nella dottrina più recente, a partire dagli anni sessanta in Germania e dagli anni settanta in Italia, sulla
scia del mutamento del rapporto autorità-libertà e Stato-cittadino, che ha imposto un ripensamento
critico dei criteri di legittimazione dell’intervento punitivo nell’ambito di un moderno Stato di diritto
caratterizzato da maggiori libertà. Si è, così, avviato un procedimento di rivalutazione del bene
giuridico, proponendo un ritorno ad un concetto pre-positivo, ovvero preesistente al riconoscimento
normativo, e critico, ovvero limitativo della potestà punitiva statale, dello stesso (una sorta di
recupero della concezione di Liszt). Questa più recente teorizzazione in chiave liberale è sollecitata dal
proposito di emancipare il più possibile il diritto penale dalla tradizionale subordinazione alla morale
corrente. Coerentemente, si ritiene che possano formare oggetto di tutela soltanto entità dotate di
sostrato reale, come tale materialmente ledibili e corrispondenti a valori suscettivi di consenso diffuso.
Il limite di tale teoria consiste nell’incapacità di fornire criteri di individuazione.
COSTITUZIONE COME CRITERIO DI RIFERIMENTO
L’esigenza di prospettare criteri atti ad impedire rischi di arbitrio da parte del legislatore ha indotto la
dottrina post-costituzionale ad assumere la costituzione a criterio di riferimento nella scelta di ciò
che può legittimamente costituire reato. Si sono così poste le basi per una teoria costituzionalmente
orientata del bene giuridico, con il duplice obiettivo di elaborare un concetto di bene giuridico
preesistente alle valutazioni del legislatore ordinario e criteri di determinazione del bene stesso
effettivi e vincolanti.
La teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico opera una rilettura delle disposizioni
costituzionali nell’ottica del diritto penale, il cui richiamo conferma la costituzionalizzazione del
principio che ammette il ricorso allo strumento penale nei soli casi di stretta necessità:
Artt. 2 e 3 Cost.: la pena sacrifica valori primari quali la dignità sociale e frustra una piena
estrinsecazione della personalità umana
Art. 13 Cost.: la pena sacrifica la libertà personale, di conseguenza il suo uso va limitato a quei
casi che lasciano apparire come inevitabile un sacrificio della libertà personale
Art. 25 c.2 Cost.: affida in tutto al parlamento o al governo il potere di legiferare in ambito
penale, postulando l’esigenza di riduzione del campo dell’illiceità penale
Art. 27 c.1 Cost.: sancisce il principio del carattere personale della responsabilità penale,
ponendo dei limiti strutturali alla tecnica normativa penalistica negli ambiti in cui risulti più
4
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
funzionale il ricorso ad altri tipi di tutela
Art. 27 c.3 Cost.: attribuisce una funzione rieducativa alla pena, delimitando l’applicazione di
una pena a quei casi che possono portare alla conclusione di un processo di rieducazione del
condannato
Di conseguenza, il criterio di legittimazione dello strumento penalistico nella teoria costituzionalmente
orientata è: il ricorso alla pena è giustificato soltanto se diretto a tutelare beni socialmente
apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale.
La tutela penale è, poi, legittimamente estendibile anche a beni che hanno un riconoscimento
costituzionale anche solo implicito, in un duplice senso:
Può accadere che più beni siano legati da un nesso funzionale di tutela, per cui la tutela di un
bene privo di rilievo costituzionale esplicito risulta finalizzata alla tutela di un bene
esplicitamente contemplato; ad es. la fede pubblica è tutelata in quanto strumentale ad altri
beni costituzionali, quali il patrimonio, l’economia, etc.
Alternativamente, esistono beni che, pur non costituzionalmente previsti, rientrano nel
sistema dei valori che fa da sfondo alla dimensione dell’ordinamento costituzionale; ad es. il
bene della pietà dei defunti.
Questo permette di estendere la tutela penale anche ad esigenze scaturenti dall’evolversi della realtà
sociale, anche se non previsti esplicitamente dalla costituzione; spesso, infatti, di fronte ad esigenze di
tutela di un nuovo bene, in realtà si è di fronte ad una nuova forma di aggressione a un bene già
tutelato, in quanto l’evolversi dei beni richiede secoli. In questo modo, si risponde alle critiche di
quanti sostengono che la concezione costituzionalmente orientata di bene giuridico sia incapace di
tutelare le nuove esigenze.
Il riferimento alla rilevanza costituzionale offre soltanto un criterio di legittimazione negativa
dell’intervento punitivo, nel senso che risulta delimitata l’area di ciò che non potrebbe mai costituire
reato, senza porre l’obbligo di creare fattispecie penali finalizzate alla sua salvaguardia.
Invece, la scelta del se e come punire è condizionata da:
1. Criterio di sussidiarietà: se la tutela del bene sia assicurabile mediante tecniche
sanzionatorie extrapenali
2. Criterio di meritevolezza della pena: se il grado di aggressione raggiunga una soglia tale da
far apparire inevitabile il ricorso alla sanzione punitiva
La decisione ultima spetta comunque al legislatore.
Ad ogni modo, la concezione del diritto penale come finalizzato alla tutela di beni giuridici non
corrisponde perfettamente alle attuali caratteristiche del diritto penale italiano, il quale non soddisfa
pienamente le rigorose pretese di tale teoria: da un lato, infatti, non poche fattispecie sono poste a
tutela di beni di dubbia identificazione e di incerta consistenza, e dall’altro, è necessaria una
valutazione concernente le tecniche di tutela adottate dal legislatore.
Reati senza bene giuridico: in questa categoria dottrinale vengono raggruppati diversi ed
eterogenei tipi di reato, accomunati dalla tutela ad un bene non sufficientemente definito o non
in armonia con la costituzione:
1. È controverso se al diritto penale spetti di salvaguardare valori attinenti alla sfera etica, la
questione va affrontata verificando se il diritto penale di uno stato costituzionale
pluralistico sia legittimato ad imporre una determinata concezione morale (ad es. i reati di
pornografia). La risposta è negativa.
2. L’individuazione del bene giuridico, se è agevole rispetto a quelle fattispecie poste a tutela
dei classici beni individuali (vita, patrimonio), diventa sempre meno facile rispetto a quelle
finalizzate alla protezione di interessi superindividuali (es. economia pubblica,
ambiente), in quanto l’oggetto della protezione penale perde in concretezza e tangibilità. In
questo senso, il diritto penale non tutelerebbe più tradizionali beni giuridici, quanto
funzioni amministrative o assetti di disciplina volti a garantire l’esercizio regolare di
determinate attività. Tuttavia, tra gli stessi beni superindividuali, ve ne sono alcuni,
5
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
caratterizzati da un minor grado di indeterminatezza, recepiti da tempo nei codici penali
(es. regolare esercizio dell’attività giudiziaria o il buon funzionamento della pubblica
amministrazione).
Occorre tuttavia non fermarsi alla mera prospettiva materiale, quello che conta è la
corretta tecnica normativa di strutturazione delle fattispecie incriminatrici, la quale
garantusce tutela anche ai cd, interessi diffusi.
3. Problematici possono apparire i delitti omissivi c.d. propri, consistenti nella mera
inosservanza di un obbligo di condotta, penalmente sanzionato, quando tendono a
promuovere l’acquisizione di un bene futuro, non ancora venuto ad esistenza
Alcune tecniche di tutela legislative non sono sempre conformi a costituzione, sotto il profilo
dell’offensività:
1. Reati di sospetto: il modello di fattispecie che maggiormente si discosta dal principio di
offensività, in quanto il legislatore incrimina fatti che non ledono né pongono in pericolo il
bene protetto. La repressione di siffatti comportamenti ha una giustificazione preventiva,
facendo però leva sulla presunta pericolosità soggettiva dell’agente che sull’idoneità
offensiva della condotta (ad es. contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi false o
di grimaldelli)
2. Reati c.d. ostativi: il legislatore incrimina condotte prodromiche alla realizzazione dei
comportamenti che ledono o pongono in pericolo il bene protetto (ad es. mero possesso di
sostanze stupefacenti). Si parla in questo caso di delitti-ostacolo, in quanto la funzione
delle relative norme è quella di frapporre un impedimento al compimento dei fatti
concretamente offensivi.
L’ammissibilità di tali figure dovrebbe essere subordinata a una duplice condizione,
circoscrivendola a casi eccezionalissimi:
A. l’idoneità preventiva della fattispecie sia empiricamente comprovata
B. il bene salvaguardato sia di rango elevato
3. Reati di pericolo presunto (in senso stretto): tipicizza fatti che, secondo una regola di
esperienza, è presumibile provochino il pericolo del bene protetto. Tuttavia, può acadere
che alla realizzazione del comportamento vietato non si accompagni quella esposizione a
pericolo che la norma tende a prevenire.
4. Delitti di attentato: colpisce già gli atti preparatori di condotte destinate ad offendere
interessi attinenti alla personalità dello stato. Da un lato si dubita circa la necessità di
mantenere questa figura, dall’altro, sul piano del diritto positivo, si registra la tendenza
all’assimilazione strutturale, ricavata in via interpretativa, col delitto strutturale.
5. Reati a dolo specifico con condotta neutra: puniscono una condotta che può addirittura
costituire esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che tuttavia assume
rilevanza penale in virtù del fine soggettivamente perseguito, cd. dolo specifico (es. il reato
di associazione sovversiva). Il ricorso al dolo specifico è inammissibile tutte le volte in cui
esso si riduca ad una finalità meramente psicologica, che non riesce ad incrementare
l’idoneità lesiva del fatto materiale.
SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E RILEVANZA COSTITUZIONALE DEL BENE
Rientrando il processo di selezione dei beni nell’ambito della discrezionalità valutativa del legislatore
penale, un controllo della Corte troppo nel merito, rischierebbe di tradursi in una inammissibile
ingerenza nelle scelte politiche del parlamento.
Tuttavia, il criterio della rilevanza costituzionale del bene giuridico non è sempre così univoco e
stringente da consentire un rigoroso sindacato, da parte della corte costituzionale, specie nei casi di
rilevanza c.d. implicita. L’ambito di applicazione di tale rilevanza si riduce, così, ai soli casi di
6
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
macroscopica o manifesta inconsistenza dell’interesse protetto.
Ad oggi, comunque, non risultano casi di espressa ricezione, da parte della corte, della teoria
costituzionale dei beni giuridici. I controlli sinora effettuati, infatti, fanno leva sui parametri di
riferimento tipici del giudizio di costituzionalità.
Il modello di controllo prevalentemente adottato si focalizza principalmente sul rapporto tra la norma
censurata e l’esercizio di libertà costituzionali, secondo un triplice ordine di pronunce:
Sentenze di rigetto: sono la maggior parte. La corte opera il salvataggio di norme, contrastanti
con fondamentali diritti, affermando che sarebbero finalizzate alla tutela di altri beni,
costituzionalmente rilevanti
Sentenze manipolative del bene protetto: la corte riformula l’oggetto della tutela. La
ridefinizione è ammissibile quando:
1. discende in modo univoco dall’applicazione delle norme costituzionali, per cui in questo
senso la riformulazione del bene protetto non è altro che il risultato di una
reinterpretazione costituzionalmente orientata
2. rispetta il tenore letterale della norma censurata, nel senso che la riformulazione del bene
protetto deve pur sempre risultare compatibile con lo schema formale del fato di reato.
Ad es. delitti di religione, il cui oggetto è stato ridefinito dalla corte nel sentimento religioso del
singolo credente.
Ad es. delitti di sciopero, il cui oggetto è stato ridefinito dalla corte nell’ordine costituzionale
Sentenze di questo tipo danno luogo a gravi perplessità, tra cui la preoccupazione di dar lluogo
a vuoti di tutela, in conseguenza di radicali pronunce di incostituzionalità.
Sentenze di accoglimento: la minor parte; la ritenuta illegittimità della norma penale in
questione viene fatta dipendere dalla sua attitudine a comprimere diritti di libertà
costituzionalmente garantiti, senza che tale incidenza possa considerarsi giustificata dalla
esigenza di tutelare altri beni o interessi costituzionalmente rilevanti (es. reato di eccitamento
all’emigrazione, dichiarato incostituzionale in quanto in contrasto con la libertà costituzionale
ex art. 35 comma 4 Cost).
DIRETTIVE PROGRAMMATICHE DI TUTELA
La teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico vuole anche fornire direttive di tutela, in un
duplice senso:
1. con l’obiettivo di circoscrivere l’area del penalmente rilevante: non possono essere elevati
a reato fatti che corrispondono all’esercizio di libertà fondamentali, a meno che non siano
incriminazioni poste a tutela di interessi limite, di rilevanza costituzionale. Inoltre, il legislatore
non è legittimato ad incriminare l’immoralità in sé, stante il carattere pluralistico dello stato
delineato dalla costituzione (es. decriminalizzazione dei reati bagellari)
2. con l’obiettivo di apportare nuove tutele: va rafforzata la salvaguardia di quei valori collettivi
che la stessa coscienza sociale vorrebbe più incisivamente protetti. Tuttavia, il diritto penale
non si configura come strumento di trasformazione sociale o strumento per garantire
l’acquisizione di beni futuri, ma tende a garantire e rafforzare la tutela di beni già venuti ad
esistenza.
I PRINCIPI
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
L’esistenza di un bene meritevole di tutela non basta a giustificare la creazione di una fattispecie
penale finalizzata alla sua salvaguardia.
Il principio di sussidiarietà del diritto penale esprime l’idea dello strumento penale come extrema
ratio, giustificato quando risulta, oltre che necessario, nel senso che gli altri strumenti di tutela
sarebbe insufficienti, anche conforme allo scopo.
Per valutare l’efficienza dello strumento penale, ovvero la sua attitudine a conseguire l’obiettivo
prefissato, è necessario che il legislatore si avvalga il più possibile del contributo del sapere socio-
criminologico attinente alla dannosità sociale dei comportamenti da incriminare e circa la reale
7
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
efficacia degli strumenti sanzionatori adottabili.
Il principio di sussidiarietà costituisce una specificazione del più generale principio di proporzione,
per cui si ricorra all’adozione di misure restrittive solo nei casi di stretta necessità. Tale teroia è stata
ripresa anche al di fuori della dottrina (es. circolare della Presidenza dl Consiglio dei Ministri 1983)
Il criterio della sussidiarietà può essere concepito in due accezioni diverse:
secondo una concezione ristretta: il ricorso allo strumento penale è ingiustificato quando la
tutela del bene sia già ottenibile mediante sanzioni di natura extrapenale.
Il legislatore, infatti, dovrebbe optare per lo strumento che comprime meno i diritti del singolo,
cd. jure est civiliter utendum. Questa concezione consente meglio di raccordare le varie tecniche
di tutela dell’ordinamento.
secondo una concezione ampia: la sanzione penale sarebbe comunque da preferire in quei
casi in cui la funzione stigmatizzante della pena generi una forte riprovazione per il
comportamento e, di conseguenza, apporti una più energica tutela del bene.
Tuttavia, la valorizzazione del ruolo simbolico del diritto penale non deve sfociare in un nesso
di implicazione necessaria tra sanzione penale e rango del bene tutelato.
PRINCIPIO DI MERITEVOLEZZA DELLA PENA
Il principio di meritevolezza di pena esprime l’idea che la sanzione penale deve essere applicata nei
soli casi in cui l’aggressione al bene tutelato raggiunga un tale livello di gravità da risultare
intollerabile. Nonostante, in quest’ambito, il legislatore goda di più ampia discrezionalità, in linea di
principio si può affermare che quanto più alto è il livello del bene nella gerarchia costituzionale, tanto
più risulterà giustificata la pena per comportamenti che ledono o pongono in pericolo tale bene, e
viceversa.
PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETÀ
Il diritto penale ha carattere frammentario, tale incompletezza è giustificata dallo stesso modo di
concepire il diritto penale, la cui prima teorizzazione risale a Karl Binding.
Il principio di frammentarietà opera su tre livelli:
1. La tutela del bene non è contro ogni aggressione proveniente da terzi, ma soltanto contro
specifiche forme di aggressione (es. nei delitti contro il patrimonio, non vengono sanzionate
penalmente le semplici violazioni contrattuali)
2. L’ambito del penalmente rilevante è molto più limitato rispetto a ciò che è qualificato come
antigiuridico nell’intero ordinamento (es. violazioni contrattuali)
3. L’area del penalmente rilevante non coincide col moralmente riprovevole (es.
omosessualità)
Questo triplice modo di operare è riconducibile allo stesso processo genetico delle fattispecie
incriminatrici, il quale associa a determinati comportamenti umani (cd. forme tipiche di aggressione ai
beni socialmente rilevanti) a corrispondenti tipi di autore, costruendo un collegamento tra fatto e
soggetto. Il principio di frammentarietà permette, quindi, di focalizzare il diritto penale più sul fatto
che sull’autore; infatti, la limitazione della sanzione a specifici comportamenti impedisce di incentrare
la valutazione penalistica tutta sulla personalità del soggetto.
Contro l’assunto del carattere frammentario del diritto penale, si sono mosse obiezioni:
Prospettiva di prevenzione generale: la frammentarietà della tutela contrasterebbe con
l’esigenza di reprimere tutti i comportamenti lesivi del bene, ma si perde di vista che la tutela
penale è il frutto del bilanciamento tra diversi beni, e non di una assolutizzazione degli stessi.
Prospettiva di prevenzione speciale: si è obiettato che la frammentarietà contrasta con
l’esigenza di risocializzazione, per cui sarebbe più coerente penalizzare tutte le condotte lesive
dei beni assunti a punto di riferimento del processo rieducativo, ma si dimentica che il
disvalore penale di un comportamento deriva proprio dalle modalità di aggressione al bene
protetto e che tale processo ha lo scopo di favorire nel reo la riacquisizione dell’integrale
rispetto di tali valori, in modo da evitare ogni futuro comportamento offensivo.
8
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Il principio di frammentarietà, quindi, rappresenta anch’esso un’ulteriore proiezone della concezione
dello strumento penale come ultima ratio.
PRINCIPIO DI AUTONOMIA
Secondo un orientamento, funzione specifica del diritto penale consisterebbe nel rafforzare le sanzioni
degli altri rami del diritto (cd. funzione secondaria o accessoria e sanzionatoria per Karl Binding).
Secondo questa teoria, riformulata successivamente da Grispigni, la sanzione penale sarebbe di
completamento e rafforzamento di altra sanzione non penale. La tesi del carattere accessorio-
sanzionatorio del diritto penale è oggi respinta, pur evidenziando una parziale verità sotto il profilo
politico-criminale: secondo la logica del diritto penale come extrema ratio, la sanzione penale può
intervenire solo successivamente agli altri settori dell’ordinamento, secondo quanto affermato dal
principio di sussidiarietà.
È quindi errato subordinare, nozionalmente e funzionalmente, il diritto penale alle altre branche del
diritto, in quanto, oggi, disciplina vari settori autonomamente ed è inconfutabile che il giudice penale
di regola non è vincolato a precedenti valutazioni di altri giudizi o autorità amministrative, per cui è
indifferente che la sanzione penale sia o meno preceduta da altri tipi di sanzione.
Tuttavia, anche se un evento lesivo fa contemporaneamente da presupposto a illeciti extrapenali, il
principio di autonomia può venire in considerazione sotto due profili:
1. Spesso l’illecito penale, a differenza di quello civile, considera solo specifiche forme di
aggressione al bene tutelato tipizzate dalla fattispecie incriminatrice (cd. illecito di modalità di
lesione)
2. Anche quando il diritto penale richiama concetti e categorie di altri settori dell’ordinamento, le
esigenze del diritto penale possono condurre ad un’autonoma ricostruzione degli stessi (ad es.
nell’ambito dei delitti contro il patrimonio)
Infine, non è escluso che la norma penale possa limitarsi a sanzionare un precetto posto da altra
norma (es. incriminazione indebito acquisto di azione proprie per cui si incriminano le fattispecie
civili).
CARATTERISTICHE DEL CODICE ROCCO
Il codice penale (cd. Codice Rocco per il nome del Guardasigilli del tempo) attualmente vigente è
costituito da:
PARTE GENERALE – LIBRO I: comprende la disciplina dei criteri, oggettivi e soggettivi, di imputazione
del fatto delittuoso al suo autore, delle conseguenze giuridiche del reato e di ogni altro
elemento condizionante la punibilità. Costituisce il risultato di un processo di astrazione
teorica delle caratteristiche comuni ai singoli delitti e del consolidamento di alcuni
fondamentali principi politico-ideologici relativi ala garanzia del sistema delle libertà del
singolo nei confronti dell’autorità statale. I principi generali hanno per loro natura confini
elastici, per cui vengono tradotti, nella prassi, all’interno della parte speciale.
PARTE SPECIALE – LIBRI II E III: contiene il catalogo delle fattispecie che descrivono i singoli
comportamenti illeciti. È organizzata secondo un criterio sistematico che fa a capo al concetto
di bene giuridico di categoria, per cui vengono raggruppati nel medesimo titolo i reati che
offendono un medesimo bene. I raggruppamenti sono poi ordinati secondo un ordine che
riflette l’importanza del bene nel sistema dello stato fascista:
A. Libro II: Delitti
TITOLO I: Delitti contro la personalità dello stato
TITOLO II: Delitti contro la pubblica amministrazione
TITOLO III: Delitti contro l’amministrazione della giustizia
TITOLO IV: Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
TITOLO V: Delitti contro l’ordine pubblico
TITOLO VI: Delitti contro l’incolumità pubblica
9
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
TITOLO VI BIS: Delitti contro l’ambiente
TITOLO VII: Delitti contro la fede pubblica
TITOLO VIII: Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
TITOLO IX: Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
TITOLO IX BIS: Delitti contro il sentimento per gli animali
TITOLO X: Delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe
TITOLO XI: Delitti contro la famiglia
TITOLO XII: Delitti contro la persona
TITOLO XIII: Delitti contro il patrimonio
B. Libro III: Contravvenzioni
Tra le due parti vige un rapporto di integrazione, dal momento che la parte generale vive solo in virtù
di quella speciale, la suddivisione infatti risponde unicamente ad esigenze di razionalizzazione,
completezza e semplificazione. Solo la parte speciale del codice risultava influenzata dalle concezioni
politiche-fasciste. La parte generale, invece, riprendeva l’insieme di principi di origine liberale.
La parte speciale del codice non contiene tutta l’area di ciò che risulta penalmente sanzionato, infatti
leggi penali speciali o complementari prevedono maggiori fattispecie, sia da un punto di vista
quantitativo, sia da un punto di vista qualitativo. Di qui l’esigenza, sempre più sottolineata, di riportare
all’interno del codice penale la tutela di tutti i beni giuridici di rango più elevato, potenziando così
anche la funzione di orientamento culturale del codice e contrastando la decodificazione.
In ogni caso, il codice, ad oggi, non riflette adeguatamente il sistema dei valori suscettivi di tutela
penale in uno stato democratico, di qui l’esigenza di riforma.
Il codice Rocco fa comunque propri i principi della scuola classica, confluiti nel codice Zanardelli, sul
reato come ente di ragione, ovvero come limite al potere punitivo. Fa quindi proprio il principio di
legalità e il principio di colpevolezza.
RIFORME
Per quanto attiene alla parte speciale:
1. Interventi del 1944: riforme concernenti l’abrogazione del rigido sistema fascista, in un’ottica
maggiormente garantista. Abolizione della pena di morte.
2. Depenalizzazione: una delle riforme più incisive, è stata quella operata dalla l. 689/1981,
secondo la necessità di rendere più funzionale ed efficiente la macchina giudiziaria, tanto più
da quando è entrato in vigore il nuovo processo di stampo accusatorio
3. Novella del 1974: destinata a mitigare i perduranti residui rigoristici del Codice Rocco,
tuttavia l’intervento mal si sovrappone al precedente impianto e dilata a dismisura il potere
discrezionale del giudice
4. Riforma dell’ordinamento penitenziario (l. 354/1975): con l’obiettivo di disciplinare
l’esecuzione della pena in armonia col principio costituzionale della rieducazione e di
potenziare le garanzie dei diritti del condannato (cd. sanzioni alternative). Inoltre, nel 1981,
sono state introdotte le cd. sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
Con riferimento alla parte speciale i maggiori interventi legislativi si sono avuti in relazione alla
legislazione dell’emergenza, ovvero quella emanata per fronteggiare il fenomeno terroristico e
quello mafioso con l’introduzione di nuovi reati (es. associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis).
10
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO DUE
LA FUNZIONE DI GARANZIA DELLA LEGGE PENALE
PRINCIPIO DI LEGALITÀ
La genesi del principio di legalità risale alla dottrina del contratto sociale, in base all’esigenza di
vincolare l’esercizio di ogni potere dello stato alla legge, la genesi, quindi, è strettamente politica. La
traduzione in termini giuridico-penali ad opera di Feuerbach avviene con la formula nulla poena sine
lege, in ragione della concezione del fondamento della pena nella prevenzione generale: se la minaccia
di pena deve funzionare da deterrente psicologico nel distogliere dal commettere reati, è necessario
che i cittadini conoscano prima quali sono i fatti che comportano l’irrogazione di una sanzione (cd.
coazione psicologica). Successivamente tale teoria è stata abbandonata, e il divieto ha ritrovato
riconoscimento formale nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.
Il principio di legalità quindi ha sì una giustificazione tecnica, ma soprattutto un fondamento
ideologico-politico.
Il principio di legalità si esprime principalmente nel divieto di retroattività della legge penale.
La riprova del fondamento non soltanto tecnico del principio è data dalla circostanza che esso ha
trovato espresso riconoscimento:
nell’art. 25.2 Cost.: nessuno può essere punito se non in forza di una legge, che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso
nell’art. 1 c.p.: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite
Dal raffronto tra disposizione costituzionale e quella codicistica, sorge il problema di stabilire se il
principio di legalità abbia la medesima estensione ad entrambi i livelli. La diversa formulazione
letterale non deve trarre in inganno: infatti, muovendo dalla sua ratio, la disposizione costituzionale
non può non avere un contenuto corrispondente a quello codicistico, dato che il legislatore costituente
si proponeva di reintrodurre tutte le garanzie dei diritti di libertà.
Il principio di legalità ha come destinatari sia il legislatore, sia il giudice. Si articola in quattro sotto-
principi:
1. la riserva di legge
2. la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale
3. l’irretroattività della legge penale
4. il divieto di analogia in materia penale
1. PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE
Il principio di riserva di legge esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una
legge preesistente che lo configuri come reato. Esso tende a sottrarre la competenza in materia
penale al potere esecutivo, giustificandosi quindi con esigenze di garanzia sia formali, che sostanziali.
Nell’attuale momento storico, infatti, solo lo strumento legislativo sembra sufficientemente adeguato a
rispettare il bene della libertà personale, consentendo la tutela di minoranze e forze politiche
dell’opposizione ed evita abusi sia del potere esecutivo che giudiziario. È fondato presumere che
l’organo rappresentativo della volontà popolare ricorra alla coercizione penale soltanto in vista della
tutela di interessi rilevanti della collettività e la cui protezione valga il sacrificio della libertà
personale connesso all’inflizione della pena.
Questa ratio democratica della riserva di legge abbisogna tuttavia che non vi sia un accentuato
squilibrio di forze tra maggioranza e opposizione e che vi sia un sufficiente dialogo fra forze politiche,
in un clima di generale dibattito pubblico. Tuttavia, queste condizioni sono ultimamente mancate nel
nostro paese, come dimostra la criticabilissima normativa penale ad personam.
Negli anni cinquanta prevalsero interpretazioni ispirate alla preoccupazione di conservare buona
parte dell’ordinamento penale esistente, integrando precetti penali primari con fonti normative
11
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
secondarie, e degradando, quindi, la riserva di legge a relativa.
Tuttavia, tale concezione non può essere accolta, in quanto la riserva di legge va intesa come riserva
assoluta, sono quindi da escludere quegli orientamenti che volevano attribuirle una portata relativa,
tale da conservare l’ereditato diritto penale, spesso integrato da norme secondarie.
Esistono tuttavia divergenze sulla portata ed i limiti della riserva di legge:
Secondo una concezione elastica, la riserva di legge assoluta non implica l’esclusione del
potere normativo secondario nella configurazione del modello di reato. Si sostiene che il rinvio
legislativo ad un regolamento fa degradare quest’ultimo a mero presupposto di fatto. Questa
concezione è oggi respinta, in quanto svuota la ratio garantista del principio e non è spiegabile
questa degradazione del regolamento a presupposto di fatto
Secondo un’altra concezione, la riserva di legge esclude che il legislatore possa attribuire il
potere normativo penale ad una fonte di grado inferiore.
Si obietta tuttavia che tale concezione, seppur ideologicamente corretta, non è più compatibile
con le caratteristiche dell’odierno diritto penale: infatti, stante l’espansione in ogni settore del
diritto penale, appare opportuno concedere al potere regolamentare un limitato spazio di
intervento normativo. Un tale apporto delle fonti secondarie è indispensabile in settori della
legislazione speciale caratterizzati da complessità tecnica e bisognosi di continuo
aggiornamento (ad es. decreto del ministero della sanità che aggiorna le tabelle delle sostanze
stupefacenti). Inoltre, l’apporto delle fonti secondarie permette di evitare l’attività
concretizzatrice della giurisprudenza.
Di qui l’esigenza di concedere al potere regolamentare uno spazio di intervento normativo limitato, da
quale esulino valutazioni di tipo politico nella scelta dei comportamenti da penalizzare, ma nel quale
siano consentiti accertamenti di indole tecnica o specificazioni di dati.
Le scelte di fondo relative alla incriminazione rimangono monopolio del legislatore, mentre è
affidata alla normativa secondaria la possibilità di specificare dal punto di vista tecnico il contenuto
di elementi di fattispecie già delineati in sede legislativa, rinvenendo così un punto di equilibrio tra il
profilo della riserva e il profilo della tassatività. Va considerato che il confine tra discrezionalità tecnica
e valutativa rimane incerto, ma sicuramente è il modello che oggi, in un momento storico
contrassegnato da gravi crisi e disfunzioni del parlamento, garantisce meglio di fatto la sostanza
ideologica del principio della riserva di legge.
IL CONCETTO DI LEGGE
Il concetto di legge rinvia immediatamente alla legge in senso formale, come atto normativo emanato
dal parlamento (artt. 70-74 Cost.).
Facendo leva su un approccio giuridico-formale, la dottrina dominante annovera senza difficoltà,
anche le leggi in senso materiale, e quindi sia il decreto delegato, sia il decreto-legge tra le legittime
fonti di produzione delle norme penali.
Tuttavia, proprio le caratteristiche del [Link]. e del d.l. appaiono poco compatibili con la ratio garantista
sottesa al principio di riserva di legge:
Decreto legge: il diritto di controllo delle minoranze è di fatto disconosciuto almeno per tutto il
tempo necessario alla sua conversione da parte delle assemblee parlamentari. Inoltre, le
condizioni di necessità ed urgenza, entro le quali viene emanato, cozzano con le esigenze di
ponderazione intrinseche nella criminalizzazione di condotte umane.
Decreto legislativo: risultano attenuate le garanzie implicite nella riserva penale al Parlamento,
consistenti anche nel permettere effettivamente alle minoranze di sindacare le scelte di
criminalizzazione operate dal legislatore.
Dottrina dominante e giurisprudenza costituzionale escludono dal novero delle fonti la legge
regionale, sia nelle ipotesi di competenza esclusiva, sia nei casi di competenza concorrente. Questo
perché la scelta punitiva è così impegnativa che non può non essere pertinenza dello stato, anche in
ragione della necessità che su tutto lo stato vi sia uguaglianza nella fruizione della libertà personale.
Come affermato in Corte Cost. 487/1989, la criminalizzazione comporta una scelta tra tutti i beni e
valori emergenti nell’intera società; tale scelta non può essere realizzata dai consigli regionali, per la
mancanza di una visione generale dei bisogni ed esigenze dell’intera società.
12
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Appare invece ammissibile un intervento di una legge regionale scriminante, che può avere come
effetto di giustificare alcuni dei comportamenti concreti capaci di rientrare nella previsione generale
ed astratta del precetto penale, ampliando la sfera della liceità penale e venendo, così, meno le ragioni
sostanziali tradizionalmente sottese alla riserva di legge statale in materia penale.
RAPPORTO LEGGE-FONTE SUBORDINATA: I DIVERSI MODELLI
I differenti modelli di integrazione tra legge e fonte normativa subordinata sono:
1. LA LEGGE AFFIDA ALLA FONTE SECONDARIA LA DETERMINAZIONE DELLE CONDOTTE CONCRETAMENTE PUNIBILI (C.D.
NORMA PENALE IN BIANCO)
Il contenuto concreto della regola di condotta da osservare non è conoscibile prima che la fonte
secondaria determini il fatto costituente reato, in quanto la fattispecie corrispondente è molto
generica (es. art. 650 c.p. che incrimina l’inosservanza del provvedimento dell’autorità).
Tuttavia, Corte Cost. 168/1971 ha dichiarato costituzionalmente legittimo l’art. 650 c.p.,
affermando che le norme penali in bianco non violano il principio di legalità quando sia una
legge dello stato (anche diversa dalla norma incriminatrice) ad indicare i caratteri, i
presupposti, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell’autorità amministrativa, alla cui
trasgressione l’art. 650 riconnette una sanzione penale. Tuttavia, in casi come questo, la fonte
secondaria si spinge a determinare essa stessa le regola di comportamento.
2. LA FONTE SECONDARIA DISCIPLINA UNO O PIÙ ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA DESCRIZIONE DELL’ILLECITO PENALE
Ad esempio l’art. 659 c.p., contravvenzione commessa esercitando un mestiere rumoroso
contro le prescrizioni dell’autorità locale, nel cui caso la fonte normativa secondaria
contribuisce a delineare le modalità del fatto vietato, incidendo sul suo disvalore penale. Si
deve ritenere legittimo, pur con qualche riserva, in quanto è realistico attribuire un simile
ruolo alla normativa secondaria, a costo, altrimenti, di ledere beni intrecciati con quelli oggetto
di tutela della norma incriminatrice. La premessa di tale orientamento si basa sulla realistica
presa d’atto che l’articolazione della tutela penale si raccorda spesso a discipline extrapenali di
fonte secondaria.
3. LA FONTE SECONDARIA SPECIFICA, IN VIA TECNICA, ELEMENTI DI FATTISPECIE LEGISLATIVAMENTE PREDETERMINATI
NEL NUCLEO SIGNIFICATIVO ESSENZIALE
Non vi è alcun problema di violazione della riserva di legge, dato che tale contributo appare
essenziale nei settori della legislazione speciale caratterizzati da complessità tecnica e
bisognosi di continuo aggiornamento (es. decreti del ministro della sanità che aggiornano gli
elenchi degli additivi chimici vietati e delle sostanze stupefacenti)
4. LA LEGGE CONSENTE ALLA FONTE SECONDARIA DI SCEGLIERE I COMPORTAMENTI PUNIBILI TRA QUELLI DA
QUEST’ULTIMA DISCIPLINATI
Certamente illegittimo, il legislatore infatti delegherebbe la sua funzione al potere
regolamentare
RAPPORTO LEGGE-CONSUETUDINE
Si definisce consuetudine la ripetizione generale, uniforme e costante di un comportamento,
accompagnata dalla convinzione della sua corrispondenza ad un precetto giuridico.
La consuetudine assume una rilevanza diversa a seconda della materia e solo nel codice civile è
contenuta una disposizione specifica (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) per cui la consuetudine
assurge da fonte primaria solo in assenza di leggi e regolamenti.
In diritto penale, è pacifico che:
1. La consuetudine non può svolgere funzione incriminatrice, aggravatrice o abrogatrice
della pena.
2. Funzione abrogatrice o desuetudine: è ben possibile che una norma penale resti di fatto
inapplicato per lungo tempo, quando ritenuta non più conforme alle nuove concezioni; si tratta
tuttavia di disapplicazione fattuale, che funge da indice rivelatore della necessità di un esplicito
intervento abrogativo.
3. Funzione integratrice: Parte della dottrina ammette una funzione integratrice della
13
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
consuetudine, ma se già dubbi si nutrono al riguardo delle fonti normative secondarie, a
maggior ragione deve essere escluso un possibile apporto della fonte consuetudinaria.
4. Funzione scriminante: è invece ammissibile il ricorso alla consuetudine in funzione
scriminante, in quanto le norme che configurano cause di giustificazione non sono
necessariamente subordinate al principio della riserva di legge.
LA LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA
La legalità penale non può rimanere confinata alla prospettiva nazionale; numerose sono infatti le
interferenze che il principio di legalità subisce per riflesso diretto o indiretto dell’ordinamento
giuridico europeo. Nello spazio giuridico europeo, il principio di legalità assume un nuovo volto: da un
lato, la legalità europea non è incentrata sul primato della legge parlamentare, ma risulta da una
pluralità di fonti normative; dall’altro, si riconosce più apertamente alla giurisprudenza il ruolo di
fonte del diritto che contribuisce a fissare i presupposti e i limiti dei fatti punibili. Infatti, non di rado,
principi e regole originariamente elaborati dalle corti, hanno trovato in un momento successivo
espresso accoglimento in testi normativi scritti (es. trattati).
Le disposizioni costituzionali rilevanti sono:
Art. 10 Cost.: che stabilisce che l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute
Art. 11 Cost.: che consente, in condizioni di parità, limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni
Art. 117.1 Cost.: che stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni
nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali. In particolare tale articolo giustifica la vincolatività delle norme
CEDU rispetto all’ordinamento interno.
PICCOLA EUROPA: UNIONE EUROPEA E CORTE DI GIUSTIZIA DI LUSSEMBURGO
Con riguardo a queste istituzioni si pone un duplice problema:
1. Riconoscimento in capo agli organi europei di una competenza a creare norme incriminatrici
direttamente applicabili nei diversi stati membri
In base all’art. 83 TFUE vi è una espressa, seppur indiretta, competenza penale dell’UE,
nelle due direzioni seguenti:
A. Rispetto a sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione
transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare
necessità di combatterli su basi comuni (es. terrorismo).
B. Per il riavvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati Membri in materia penale a
condizione che l’esercizio di tale competenza si riveli indispensabile per garantire
l’attuazione efficace di una politica unitaria.
Questa competenza è esercitabile tramite direttiva, che deve stabilire le norme minime in
relazione alla definizione del reato e delle sanzioni. La competenza europea è quindi indiretta
perché la sua messa in atto necessita di strumenti legislativi nazionali, che recepiscano la
direttiva.
La compatibilità di questa competenza con il principio della riserva di legge va valutata con
riguardo al livello di democraticità delle scelte di politica criminale; a livello europeo vi è un
grave deficit democratico e il principio di riserva di legge risulta rispettato solo formalmente,
in quanto una legge di attuazione è comunque sempre richiesta. Tuttavia, questo pregiudizio
alla riserva di legge può essere accettato come contributo all’integrazione degli ordinamenti
giuridici nel contesto europeo
2. Effetti che le fonti normative europee possono produrre sull’applicazione giudiziale del diritto
penale nazionale.
Questi effetti si producono in virtù del primato del diritto dell’UE. Se è pacifico che tale
14
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
primato concerne sia le norme contenute nei trattati, che quelle dei regolamenti, altrettanto
non è per le direttive, per le quali bisogna distinguere:
A. le direttive generali: vincolano gli stati membri al raggiungimento di determinati scopi
B. le direttive auto-applicative: contengono disposizioni chiare, precise e incondizionate
In casi di incompatibilità evidente tra norma europea, contenuta in regolamento o direttiva
auto-applicativa, e norma penale italiana, il giudice italiano è tenuto a non applicare
quest’ultima. Spesso questa incompatibilità deriva da norme europee che introducono nuove
libertà di circolazione o di esercizio di attività economiche, per cui la disposizione UE ha
effetto limitativo sul diritto penale italiano.
In casi in cui la normativa europea contribuisce a delineare i presupposti di applicazione di
reati interni, ciò è indubbiamente legittimo qualora la norma europea specifichi in via
tecnica elementi di fattispecie, già definiti dal legislatore nazionale.
Più problematico è il caso di una norma UE che integri elementi normativi della fattispecie
(es. l’introduzione di una nuova regola cautelare europea, la cui violazione integri il concetto
normativo di colpa), se simili forme di integrazione vengono considerate legittime, la
disposizione UE ha effetto espansivo sul diritto penale italiano.
Nei casi in cui il giudice nazionale è tenuto ad esperire un tentativo di interpretazione
conforme al diritto europeo, tale operazione è legittima se ne derivano esiti riduttivi della
punibilità, quindi a favore dell’imputato. Più problematici appaiono i casi in cui si hanno effetti
espansivi sulla punibilità, quindi a svantaggio dell’imputato
GRANDE EUROPA: CONSIGLIO D’EUROPA E CORTE EDU DI STRASBURGO
Le norme della CEDU sono norme pattizie rientranti nell’ambito del diritto internazionale, ma questi
obblighi hanno un peso differente all’interno dell’ordinamento nazionale rispetto a quelle dell’UE:
esse, infatti, non possono avere effetto diretto con conseguente non applicazione ad opera del giudice
in caso di contrasto.
In base alle c.d. sentenze gemelle, Corte Cost. 348-349/2007, le norme CEDU non sono coperte dall’art.
11 Cost., quanto piuttosto dall’ art. 117 c.1 Cost., secondo cui la potestà legislativa deve avvenire nel
rispetto, tra gli altri, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Le norme CEDU finiscono così
per assumere il ruolo di norme parametro interposte nel giudizio di costituzionalità. Di conseguenza,
tali obblighi internazionali non devono contrastare con le norme della costituzione, cd. controlimiti.
Di conseguenza, il giudice nazionale è innanzitutto tenuto ad esperire un tentativo di interpretazione
conforme alla CEDU delle norme penali interne. Ma nel caso in cui una simile interpretazione risulti
impossibile, il giudice dovrà sollevare una questione di legittimità costituzionale, avente come
parametro l’art. 117 c.1 e come norma interposta la disposizione CEDU che si asserisce violata.
Il primo importante effetto sulla legislazione penale italiana da parte della CEDU è un innalzamento
degli standard di garanzia, specie sotto il profilo del processo penale. Questo comporta effetti
riduttivi dell’area del penalmente rilevante.
La CorteEDU intende la nozione di legalità in materia penale in modo non ancorato alla legge stessa,
esigendo come presupposto solo la conoscibilità della fonte, giungendo a considerare anche il diritto
giurisprudenziale (con conseguenza applicabilità anche a quest’ultimo del divieto di retroattività).
Quanto alla nozione stessa di materia penale, la corte di Strasburgo adotta un criterio
antiformalistico, che prescinde dalla qualificazione formale che l’illecito riceve nell’ordinamento
nazionale. Quel che veramente conta per la corte è il carattere effettivamente punitivo e afflittivo della
sanzione (con conseguenza problemi sotto il profilo del ne bis in idem).
Tuttavia, a livello europeo è diffusa la tendenza ad individuare nel diritto penale un efficace strumento
di protezione dei diritti fondamentali; da limite della tutela essi diventano, invece, oggetto della stessa.
Sotto questo punto di vista, le norme CEDU hanno anche effetti espansivi sulla punibilità. La
mancanza di legittimazione democratica di questi effetti giustifica la resistenza al riconoscimento degli
stessi.
15
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLA PENA (NULLA POENA SINE LEGE)
La legge penale che si limitasse a prevedere il fatto, ma rimettesse al giudice la scelta del tipo e della
durata della sanzione, contraddirebbe le esigenze garantistiche del principio di legalità (es. omissione
di ogni riferimento alla sanzione penale nell’art. 25.2 Cost.).
Il principio di legalità della pena non può non rientrare tra i fondamentali principi di uno stato
democratico.
Predeterminazione legale della sanzione non significa, tuttavia, esclusione di ogni potere
discrezionale del giudice. Al contrario, una certa estensione dello spazio edittale, nonché la
possibilità di scegliere tra più tipi di sanzione legalmente predeterminate, sono imposte dall’esigenza
di adattare la pena al disvalore del reato e dalla necessità di rispettare i principi costituzionali della
individualizzazione della pena e del finalismo rieducativo.
Inoltre, il principio di legalità della pena è veramente rispettato soltanto se lo spazio edittale oscilli
entro minimi e massimi ragionevoli, in relazione al rango del bene e alla gravità dell’offesa.
Anche in questo caso, si tratta di riserva di legge assoluta, cioè soltanto la legge o un atto ad essa
equiparato possono stabilire con quale sanzione ed in quale misura debba essere represso il
comportamento criminoso, che concerne sia le pene principali, sia le pene accessori, sia gli effetti
penali della condanna.
Infine, la garanzia della legalità deve intendersi estesa alla fase di esecuzione della pena.
2. PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ
Il principio di legalità sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza, se la legge penale
configurasse il reato in termini così generici da non lasciare individuare precisamente il
comportamento sanzionato. Il principio di tassatività appartiene alla stessa ragione ispiratrice del
principio di legalità, riguarda la tecnica di formulazione delle fattispecie penali e tende a
salvaguardare i cittadini da eventuali abusi del potere giudiziario, al contrario del principio di riserva
di legge che riguarda la gerarchia tra le fonti in materia penale.
Si pone in stretta correlazione con il principio di frammentarietà e rappresenta una condizione
perché la norma penale possa fungere da guida del comportamento del cittadino, accrescendo il
rapporto di fiducia partecipativa nei confronti dello Stato. La violazione di questo principio
pregiudicherebbe quello dell’obbligatorietà dell’azione penale e frustrerebbe il diritto alla difesa.
Tra il principio di tassatività e l’ordinamento penale vigente esiste una sensibile divaricazione. La corte
costituzionale ha quasi sempre considerato legittimi i casi di violazione della tassatività prospettatele,
non volendo creare vuoti di tutela o entrare in conflitto con il legislatore, manifestando un
atteggiamento di chiusura da parte della Corte.
In aggiunta, è difficile stabilire con precisione il confine tra sufficiente e insufficiente determinazione
della fattispecie.
La frequente ambiguità delle norme penali deriva anche dalla tendenza compromissoria dell’attività
legislativa, per cui nel bilanciare interessi confliggenti e beni, riduce la redazione delle norme penali a
fattispecie incerte che, non di rado, celano l’intento di scaricare sul potere giudiziario il compito di
mediare tra opposte esigenze di tutela difficilmente compatibili in sede più propriamente politica.
Tuttavia, un maggior rispetto del principio di tassatività eviterebbe eventuali interventi suppletivi da
parte della giurisprudenza, consentendo un miglior rapporto tra i poteri dello stato e garantendo la
certezza del diritto.
Le modifiche apportate con la c.d. riforma Orlando all’art. 618 c.p.p. impongono ad una sezione
semplice della cassazione, che non condivida il precedente principio di diritto espresso dalle sezioni
unite, di rimettere la questione alle sezioni unite stesse, accentuando così la funzione nomofilattica
16
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
della suprema corte.
Probabilmente quest’intervento è ispirato alla volontà di garantire una maggiore uniformità e
conseguente tassatività nell’applicazione del precetto penale.
TECNICHE DI REDAZIONE DELLA FATTISPECIE PENALE
Le principali tecniche di legislazione sono:
1. Normazione descrittiva: descrive il fatto criminoso mediante l’impiego di termini che
alludono a dati della realtà empirica.
Si avvale dei c.d. elementi descrittivi, che traggono il loro significato direttamente dalla realtà
dell’esperienza sensibile (ad es. omicidio, lesione, danneggiamento). In alcuni casi, il carattere
descrittivo è più apparente che reale: ciò avviene quando la formula legislativa impiega
elementi descrittivi privi di obiettivo riscontro nella realtà, risultando quindi indeterminati (ad
es. il delitto di plagio non identifica in modo chiaro la fattispecie).
2. Normazione sintetica: adotta una qualificazione di sintesi mediante l’impiego di elementi
normativi, rinviando ad una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da
applicare nel caso concreto.
Si avvale dei c.d. elementi normativi, che necessitano di una etero-integrazione mediante il
rinvio ad una norma diversa da quella incriminatrice. Si distinguono:
A. Elementi normativi giuridici: l’esigenza di tassatività è rispettata poiché la norma giuridica
richiamata è generalmente individuabile senza incertezze
B. Elementi normativi extragiuridici: rinviano a norme sociali o di costume, di conseguenza il
parametro di riferimento diventa incerto. Si sconfina nell’indeterminatezza tutte le volte
che l’elemento normativo non riesce a connotare il parametro o non trova riscontro
univoco nel contesto sociale.
La determinazione legislativa e/o giudiziale di parametri valutativi di fonte sociale sarà tanto più
univoca, quanto più potrà avvalersi del contributo delle scienze empiriche e sociali.
3. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ
Il principio di irretroattività fa divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua
entrata in vigore. Il principio in esame è previsto da:
Art. 11 preleggi: stabilisce che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto
retroattiva (stabilito in modo univoco per tutte le leggi)
Art. 25.2 Cost.: il riconoscimento di questo principio a livello costituzionale vale solo per il
diritto penale, infatti, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Art. 2 c.p.: contiene una disciplina più articolata per cui mentre al primo comma sancisce il
principio dell’irretroattività della norma incriminatrice, al secondo e terzo comma sancisce il
principio di retroattività di una norma più favorevole, successivamente emanata.
Questa disposizione non si pone in contrasto con quella costituzionale, dato che la ratio sottesa
in entrambe è quella di garantire al singolo la libertà, per cui il conflitto sussiste solo sul piano
formale.
Il principio di retroattività di una norma favorevole può assumere rilevanza sotto la luce
dell’art. 3 Cost.: non sarebbe infatti ragionevole continuare a punire un soggetto per un fatto
che chiunque altro può ormai impunemente commettere (ipotesi valorizzata dalla corte
costituzionale, anche se più di recente si tende a ricondurre tale principio nell’ambito dell’art.7
CEDU).
Il divieto di retroattività ex art. 2 riguarda il solo diritto penale sostanziale, non anche il
diritto processuale penale, anche se un orientamento dottrinale ritiene che riguardi anche
quest’ultimo, poiché le modalità del procedimento influiscono sulle modalità di irrogazione e
applicazione della pena. Infine, il divieto di retroattività concerne tutti gli elementi
dell’illecito penale.
17
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Tale disciplina, di matrice liberal-garantistica, è posta a garanzia della libertà personale del
cittadino nei confronti dei detentori del potere legislativo
LA DISCIPLINA DELL’ART. 2 C.P.
L’art. 2 comma 1 c.p. stabilisce nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge
del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Questo divieto di nuova incriminazione non soddisfa solo un’esigenza di giustizia, in quanto in caso
contrario i cittadini sarebbero sempre esposti al rischio di arbitri e rappresaglie da parte del potere
politico, ma si salda con il principio di legalità. Tuttavia, è accaduto in passato (es. costituzione di
valuta all’estero) che la retroattività si verificasse in forma occulta, ovvero attraverso l’escamotage di
configurare una fattispecie in forma omissiva, incentrata sulla violazione di un obbligo attuale di
denuncia.
L’art. 2 comma 2 c.p. stabilisce nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
È il fenomeno dell’abolizione di incriminazioni prima esistenti (es. abrogazione dei delitti di offesa
e libertà): sarebbe contraddittorio e irragionevole continuare a punire l’autore di un fatto ormai
tollerato dall’ordinamento, per cui cessa l’esecuzione della condanna e tutti i connessi effetti penali.
Può tuttavia accadere che una legge penale successiva riformuli il contenuto mediante la sostituzione
o l’aggiunta di elementi della fattispecie, si pone il problema di stabilire se permanga la rilevanza del
comportamento in questione, salvo ne sussistano i presupposti, l’applicabilità della disposizione più
favorevole al reo:
Secondo un orientamento di origine tedesca, si ha successione di leggi penali nel tempo se
permane la continuità del tipo di illecito (relativamente a interesse protetto, modalità di
aggressione). A questo proposito, le Sezioni Unite, hanno affermato che sussista un nesso di
continuità e omogeneità tra la fattispecie abrogata e il nuovo reato. Tuttavia, il fenomeno si
presta ad un doppio rilievo critico:
1. intendendolo in senso stretto, la continuità si verificherebbe solo in caso di perfetta
identità del fatto di reato, vanificando il principio
2. intendendolo in senso largo, il criterio diverrebbe di incerta applicazione perché fondata
non solo su apprezzamenti di valore opinabile, ma anche sull’indeterminatezza del peso
rispettivamente attribuibile al criterio del bene e a quello delle modalità aggressive del
fatto
Un altro criterio è quello che fa leva su un rapporto di continenza tra nuova e vecchia
fattispecie: occorre un rapporto strutturale tra le fattispecie astrattamente considerate, tale
per cui tra le stesse si possa instaurare una relazione di genere a specie.
Ciò si verifica quando la fattispecie successiva sia pienamente contenuta nella precedente, ma
parte della dottrina lo ammette anche nel caso contrario, ovvero nel caso in cui
successivamente all’abrogazione di una norma speciale, si riespanda quella generica (es.
infanticidio, contenuto nella fattispecie più generica dell’omicidio).
Tuttavia, la giurisprudenza, sebbene prediliga il criterio della continenza, non ha mostrato negli
anni un orientamento univoco. La preferenza è oggi accordata ([Link]. 119/2009) al criterio del
raffronto strutturale.
L’art. 2 comma 3 c.p., introdotto dall’art. 14 l. 85/2006, disciplina l’ipotesi della modifica del
trattamento sanzionatorio intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Stabilisce che se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la
pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena
pecuniaria, ai sensi dell’art. 135.
Innova, quindi, rispetto al principio di intangibilità del giudicato previsto nell’originaria formulazione
dell’art. 2, per cui se è vero che il fatto continua a rimanere penalmente illecito, la modifica del
trattamento sanzionatorio non può rimanere priva di effetti anche dopo il giudicato, pena la
irragionevolezza manifesta della disciplina medesima.
Appare tuttavia problematica la mancata previsione della limitazione della pena convertita entro il
18
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
nuovo massimo della pena pecuniaria.
L’art. 2 comma 4 c.p. stabilisce se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori
sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile.
Questa disposizione introduce il principio della retroattività della norma più favorevole al reo, a
cui fondamento vi è la garanzia a favore del favor libertatis, che assicura al cittadino il trattamento
penale più mite tra quello previsto dalla legge al momento della realizzazione del fatto e quello
previsto da leggi successive anteriormente alla sentenza definitiva di condanna.
Trova, inoltre, giustificazione nell’art. 3 Cost., in base al quale sarebbe irragionevole una disciplina di
medesimi fatti differenziata solo per essere stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore di una
legge più favorevole.
Proprio in relazione all’art. 3 Cost., questo principio trova il suo limite: eventuali deroghe alla
retroattività possono risultare legittime se ragionevoli, nel senso di rispondere all’esigenza di
salvaguardare valori o principio di rango analogo a quello a cui si intende derogare, quale ad esempio
il rispetto del giudicato.
In CorteEDU Scoppola c. Italia 2009, la corte europea ha affermato che il principio di retroattività è
implicitamente contenuto nell’art. 7 CEDU, con l’effetto di elevare tale principio a diritto fondamentale
dell’uomo. Anche in questo caso, il limite all’operatività è dato dal rispetto del giudicato ed è
subordinata alla presenza di casi di successione tra fattispecie incriminatrici, accertabile in base al
criterio del rapporto di continenza.
Inoltre, il principio di retroattività concerne tutti gli elementi dell’illecito penale, quali ad esempio
le condizioni di procedibilità.
Il raffronto tra disciplina prevista da vecchia e nuova norma va effettuato in concreto, mettendo a
confronto i rispettivi risultati generati dall’applicazione delle stesse alla medesima situazione oggetto
di giudizio.
Ad esempio, se la vecchia legge prevede un massimo più elevato e un minimo più ridotto e la nuova il
contrario, si applicherà la prima o le seconda, a seconda che il giudice intende applicare al caso
concreto una pena edittale minima o massima.
È problematico stabilire se la disciplina dell’art. 2 sia applicabile alle modifiche normative che non
incidono direttamente sugli elementi costitutivi del reato, ma che vi incidono in maniera soltanto
indiretta o mediata (norme che integrano il contenuto o che disciplinano elementi normativi). Si
registrano, in dottrina e giurisprudenza, tre orientamenti:
Secondo un orientamento restrittivo, prevalente in dottrina, la disciplina ex art. 2 c. 2
sarebbe inapplicabile al caso di abrogazione di norme integratrici di elementi normativi, in
quanto eliminerebbe dall’ordinamento disposizioni penale o extrapenali che si limitano ad
influire nel singolo caso sulla concreta applicabilità della norma incriminatrice stessa.
Secondo un orientamento mediano, per cui occorre distinguere a seconda che l’elemento
normativo in questione sia o meno in grado di incidere sulla portata e sul disvalore astratto
della fattispecie incriminatrice, condizionandone l’ampiezza con riferimento sia alla
descrizione del tipo di reato, sia ai soggetti attivi.
Secondo un orientamento estensivo, si fa leva sulla tesi dell’incorporazione della
disposizione integratrice dell’elemento normativo nella stessa norma incriminatrice, ovvero la
disposizione integratrice, nella misura in cui contribuisce ad integrare i presupposti normativi
della rilevanza penale del fatto, finisce col far corpo con a norma incriminatrice per cui è
giocoforza invocare il principio ex art. 2.2 c.p.
La disciplina ex art. 2 riguarda anche la variazione di una norma integratrice di origine
extragiuridica.
L’art. 2 comma 5 c.p. stabilisce che il principio di retroattività non opera rispetto alle leggi
temporanee ed alle leggi eccezionali.
Sono leggi eccezionali quelle leggi, il cui ambito di operatività temporale è determinato dal persistere
di uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dall’ordinario (ad es. guerre, epidemie,
19
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
terremoti). Sono leggi temporanee quelle leggi, rispetto alle quali lo stesso legislatore prefissa un
termine di durata.
L’inoperatività dei commi 2° e 4° connaturata alla stessa natura di queste leggi l’inapplicabilità della
retroattività, altrimenti si potrebbero commettere fatti illeciti con la certezza di una futura impunità.
Si può anche considerare il caso di una legge eccezionale o temporanea che preveda una disciplina più
favorevole al reo rispetto ad una precedente legge, sempre eccezionale o temporanea; anche in questo
caso, ai fatti commessi sotto il vigore della seconda, andrà applicata la corrispondente disciplina, non
già quella prevista successivamente, ancor che più favorevole.
I due commi, successivamente all’abrogazione dell’art. 24 [Link]. n. 507/99, si applicano anche nel caso
di successione di leggi penali finanziarie.
L’art. 2 comma 6 c.p. stabilisce che la disciplina della successione di legge si applica anche nei
casi di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge o nel caso di un decreto-legge
convertito in legge con emendamenti.
Questa disciplina era stata prevista con riguardo all’ordinamento vigente al tempo dell’emanazione del
codice: era infatti previsto che il decreto-legge perdesse efficacia ex nunc, non ex tunc come
nell’ordinamento costituzionale odierno (art. 77 Cost.), per cui erano fatti salvi gli effetti prodotti
durante la sua vigenza, al contrario, quindi, di quanto oggi previsto.
Seguendo il dettato costituzionale, poiché il d.l. perderebbe di efficacia ab origine, non avrebbe senso
parlare di successione di leggi, in quanto non configurabile. Questo potrebbe portare tuttavia a gravi
conseguenze sfavorevoli per il reo.
Ad esempio, un fatto preveduto come lecito o sanzionato in modo minore da un d.l. potrebbe diventare
reato o tornare ad essere sanzionato gravemente in caso di decadenza del d.l., con applicazione della
disciplina più sfavorevole al reo che avesse commesso il fatto durante la vigenza del decreto-legge.
Tuttavia, il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo non può mai essere
derogato; di conseguenza, anche le esigenze di cui è espressione l’art. 77 Cost. devono essere
subordinate, in una prospettiva di bilanciamento, a quelle ex art. 25 c.2 Cost., con conseguente
applicabilità delle disposizioni del decreto decaduto, se più favorevoli.
LEGGI DICHIARATE INCOSTITUZIONALI
L’art. 136 comma 1 Cost. stabilisce che quando la corte [costituzionale] dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Tuttavia, tale disposizione dava luogo ad
un grave inconveniente, ovvero sarebbe venuto meno l’interesse ad adire alla Corte Costituzionale se
la invalidazione di una legge dichiarata incostituzionale non ne avesse fatto cessare gli effetti anche
rispetto ai rapporti maturati antecedentemente alla sentenza di accoglimento.
In aggiunta, quindi, l’art. 30 commi 3 e 4 l. 87/1953 (legge sul funzionamento della corte) dispone
che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione. Quando, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali.
In forza di queste disposizioni, contrariamente a quanto la dottrina post-costituzionale aveva
inizialmente ritenuto, si ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità abbia efficacia ex tunc. Di
conseguenza non è possibile ravvisare un fenomeno successorio tra una legge preesistente e una,
successiva, dichiarata incostituzionale.
Tuttavia, come nel caso del decreto legge, si dovrà procedere all’applicazione della norma dichiarata
incostituzionale se questa risulterà più favorevole al reo.
Il rispetto del principio di irretroattività pone dei problemi circa il sindacato delle c.d. leggi penali di
favore, ovvero quelle che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penale più
favorevole rispetto a quello che risulterebbe dall’applicazione delle norme generali o comuni.
Infatti, una dichiarazione di incostituzionalità comporterebbe l’applicazione di una precedente norma,
più sfavorevole al reo.
tuttavia, altro è la garanzia del favor libertatis assicurata dall’art. 25.2 Cost., altro è il sindacato di
costituzionalità sulle leggi penali anche di favore, che non può essere sottratto alla corte a pena di
20
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
istituire zone franche dell’ordinamento all’interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe
incontrollabile. Occorre tuttavia evitare il rischio che il sindacato della corte vada a sovrapporsi con le
valutazioni operate dal legislatore. Di conseguenza, un sindacato della corte è ammissibile soltanto ad
alcune condizioni:
1. quando la legge appaia palesemente arbitraria, alla stregua del principio di uguaglianza
2. con discriminazione nel trattamento punitivo di condotte appartenenti allo stesso tipo
TEMPO DEL COMMESSO REATO
Ai fini dell’individuazione della legge penale applicabile, è decisiva la determinazione del tempo in
cui fu commesso il delitto. A tal fine, la dottrina ha elaborato tre criteri:
1. Teoria della condotta: considera il reato commesso nel momento in cui si è realizzata l’azione
o l’omissione
2. Teoria dell’evento: considera il reato commesso nel momento in cui si verifica il risultato
lesivo riconducibile causalmente alla condotta e necessario ai fini della configurazione
dell’illecito
3. Teoria mista: considera il reato commesso nel momento in cui si verifica o la condotta o
l’evento
La soluzione non può essere univoca ma va fornita con riguardo ai singoli istituti:
Successione di leggi penali: teoria della condotta, in quanto è il momento nel quale il soggetto
mette in atto il proposito criminoso.
Infatti, la teoria dell’evento porterebbe all’applicazione retroattiva della legge penale in tutti i
casi in cui la condotta si sia svolta sotto il vigore di una legge e l’evento sotto la vigenza di una
successiva norma incriminatrice; la teoria mista non porterebbe ad una ragionevole soluzione,
considerando il reato commesso indifferentemente al realizzarsi della condotta o dell’evento
Reati causalmente orientati a c.d. forma libera: teoria della condotta, ma problematici,
poiché il legislatore non tipizza le specifiche modalità di realizzazione dell’evento lesivo.
Se si tratta di reati dolosi, il tempo del commesso reato corrisponde con la realizzazione
dell’ultimo atto sorretto da volontà colpevole.
Se si tratta di reati colposi, il tempo del commesso reato corrisponde con la realizzazione
dell’atto che dà luogo ad una situazione di contrarietà a regola di diligenza, prudenza
Reato permanente: teoria della condotta, il reato permanente è quello contraddistinto dal
perdurare di una situazione illecita volontariamente rimovibile dal reo.
Secondo l’orientamento maggioritario, il tempo del reato corrisponde all’ultimo momento di
mantenimento della condotta antigiuridica. Tuttavia, reca l’inconveniente di rendere
applicabile un’eventuale legge successiva più sfavorevole al reo, per cui appare preferibile
l’orientamento minoritario che fissa il tempo al primo atto che da avvio alla consumazione del
reato permanente
Reato abituale: teoria della condotta, il reato abituale è quello caratterizzato dalla
reiterazione nel tempo di condotte della stessa specie.
Parte della dottrina individua il tempo del reato nell’ultima condotta, ma valgono le stesse
obiezioni del reato permanente, per cui sarebbe più corretto individuare il tempo nel primo
atto.
Reato continuato: esso non rappresenta, nell’ottica di successione delle leggi, un fatto
unitario, per cui ci si trova piuttosto in presenza di un concorso materiale di reati, ciascuno dei
quali presenta un proprio tempus commissi delicti (art. 81.2 c.p.)
Reati omissivi: occorre fare riferimento al momento in cui scade il termine, esplicito o
implicito, utile per realizzare la condotta doverosa
21
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
4. DIVIETO DI ANALOGIA
L’analogia consiste in un processo di integrazione dell’ordinamento, attuato tramite una regola di
giudizio ricavata dall’applicazione al caso concreto di disposizioni regolanti casi o materie simili; il suo
presupposto è costituito dall’identità di ratio.
L’art. 14 preleggi esclude il procedimento analogico con riferimento alle leggi penali. Inoltre, in via
implicita, tale divieto può essere dedotto dagli artt. 1 e 199 c.p., che vietano pene e misure di sicurezza
se non nei casi espressi di legge. Nonostante il silenzio del legislatore costituente, si deve ritenere che
il divieto di analogia sia costituzionalizzato, in virtù della medesima ratio garantistica della libertà del
cittadino.
La problematica concernente il divieto di analogia risiede nella difficoltà di distinzione tra la medesima
e l’interpretazione estensiva.
Si rientra nell’ambito dell’interpretazione estensiva ogni qual volta la soluzione rientri comunque
all’interno dei possibili significati letterali della disposizione, la quale nonostante sia operazione
formalmente lecita, l’interpretazione estensiva suscita alcune riserve:
1. Il rispetto del carattere frammentario del diritto penale impedisce che, in omaggio ad una più
completa tutela del bene in questione, si forzino i limiti di tipicità prefissati dal legislatore
2. L’interpretazione estensiva, nel porre in relazione un comportamento con il significato di una
norma procede per somiglianze, parziali concordanze o discordanze, per cui è sempre latente il
rischio di ricadere in un giudizio analogico mascherato
Vi è analogia se la soluzione va al di là della massima estendibilità interpretativa del testo di legge,
considerato sia nelle singole parti costitutive, sia nel suo significato unitario.
Il divieto di analogia è violato anche nel caso in cui la disposizione legislativa sia formulata con un
criterio casistico e contenga formule di chiusura, quali in casi simili, analoghi.
Secondo un indirizzo minoritario, questo divieto avrebbe carattere assoluto, riguardando sia le norme
incriminatrici, che quelle a favore, adducendo il primato delle esigenze di certezza. Secondo l’indirizzo
maggioritario, invece, il divieto di analogia ha carattere relativo, nel senso che è ben lecita, e
conforme alla ratio dell’art. 25 Cost., un’interpretazione analogica di norme favorevoli al reo.
L’ammissibilità di un siffatto procedimento analogico, potrebbe trovare ostacolo nell’art. 14 preleggi il
quale afferma che le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i
casi e i tempi in esse considerati.
Le situazioni generali sono quelle in cui può versare chiunque al ricorrere di determinati presupposti,
mentre sono da considerare norme eccezionali quelle che introducono una disciplina che deroga,
rispetto a particolari casi, alla efficacia potenzialmente generale di una o più disposizione. Ed anche
rispetto a norme favorevoli al reo, ma eccezionali, dovrà affermarsi il divieto di analogia.
Ad esempio, le cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza sono suscettibili di
applicazione analogica, determinando i presupposti generali di applicazione delle norme
incriminatrici.
Il ricorso al procedimento analogico è, invece, precluso rispetto a quelle cause di non punibilità che
fanno riferimento a situazioni particolari o riflettono motivazioni politico-criminali specifiche:
1. Immunità: derogano al principio generale della obbligatorietà della legge penale rispetto a
tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato
2. Cause di estinzione del reato e della pena: derogano alla normale disciplina dell’illecito
penale e delle conseguenze sanzionatorie
3. Cause speciali di non punibilità: rispecchiano valutazioni polito-criminali legate alle
caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e perciò non estensibili ad
altri casi
Infine, rispetto alle circostanze attenuanti, il problema dell’applicabilità del principio di analogia
appare privo di rilevanza pratica in seguito all’introduzione delle cd. attenuanti generiche (art. 62 bis
c.p.).
22
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO TRE
L’INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI PENALI
L’applicazione delle norme penali implica un passaggio dall’astratto al concreto, tramite la selezione
delle caratteristiche giuridicamente rilevanti del fatto e l’individuazione del significato e della portata
della legge da applicare.
L’interpretazione della legge penale consiste nel complesso di operazioni finalizzate all’individuazione
del significato delle norme da applicare al caso concreto.
Generalmente si distingue tra:
INTERPRETAZIONE INTERPRETAZIONE INTERPRETAZIONE INTERPRETAZIONE
AUTENTICA UFFICIALE GIUDIZIALE DOTTRINALE
Quella fornita dallo Quella fornita dai Quella effettuata Quella fornita da
stesso organo che pubblici funzionari dai giudici parte degli studiosi
ha prodotto la dello stato nello nell’emanare del diritto nelle loro
norma da svolgimento delle sentenze opere
interpretare loro competenze
istituzionali
Espressa o meno, l’idea di origine illuminista-positivista di giudice mero esecutore della volontà
legislativa continua a far parte del bagaglio culturale. Essa costituisce tuttavia un’illusione, dato che
anche la formula legislativa più chiara ha bisogno di interpretazione, rilevando non il semplice
significato, quanto l’obiettivo di tutela che con la legge si è inteso perseguire.
È un dato di fatto che la tecnica legislativa va incontro agli stessi limiti del linguaggio, con conseguente
scarto rispetto alla realtà. L’interpretazione diventa fondamentale per scegliere il significato più
congruo alla volontà legislativa.
Inoltre, l’esigenza di un’indagine ermeneutica deriva dal procedimento di sussunzione del caso
concreto nella norma, generale ed astratta; i casi concreti presentano spesso caratteristiche diverse o
inedite, questo comporta una continua interpretazione delle norme per verificare se la loro portata
può estendersi fino a ricomprendervi anche tali fatti.
Nello scegliere il possibile significato, l’operatore giuridico è inevitabilmente influenzato da una serie
di fattori che vanno al di là del tenore letterale della disposizione, compromettendo anche, specie in
casi in cui le scelte politico-legislative si rivelano inefficaci, il principio del vincolo alla legge del
giudice.
L’art. 12 preleggi dispone che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione
del legislatore.
Questa disposizione, che include i c.d. criteri semantico e storico, non è efficace, in quanto non prevede
un espresso ordine gerarchico tra i due criteri.
L’elaborazione tradizionale ha portato ad enucleare i seguenti canoni interpretativi:
Criterio semantico: tende ad individuare il significato della norma in base al significato
lessicale dei termini utilizzati nella formula legislativo. Il significato proprio ex art. 12 preleggi
sarebbe il significato comune che le parole possiedono nel lessico quotidiano; tuttavia, spesso
le parole presentano uno spazio semantico aperto, oppure il linguaggio legislativo utilizza
tecnico-giuridici, per i quali non si può fare riferimento al significato comune
Criterio storico: tende ad individuare il significato della norma in base alla volontà espressa
dal legislatore al momento dell’emanazione delle norme. Questo canone rispetta
maggiormente il principio della separazione dei poteri.
Può essere inteso come volontà soggettiva del legislatore del tempo; ma la figura unitaria del
legislatore è più una figura retorica, non ipotizzabile realmente.
Oppure, può essere intesa come volontà storica obiettivata nella legge, ha ad oggetto il contesto
storico d’emanazione, i motivi e il modello disciplina. Se questa è operazione facile per norme
emanate in periodi caratterizzati da una forte omogeneità ideologica, altrettanto non è per le
norme moderne, spesso frutto di compromessi e bilanciamenti, solo in parte ricostruibili dai
23
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
lavori preparatori
Criterio logico-sistematico: tende ad individuare il significato della norma in base alle
connessioni concettuali tra la norma da applicare e le restanti norme, sia del solo sistema
penale, sia dell’intero ordinamento giuridico.
Tale nesso è facilmente individuabile qualora la fattispecie incriminatrice contenga elementi
normativi. È fondamentale per risolvere le situazioni di conflitto normativo determinate dalla
presenza di cause di giustificazione
Criterio teleologico: tende ad individuare il significato della norma in base al più congruo
scopo di tutela che può essere assegnato alla norma.
In tal senso, assume rilevanza centrale il bene o interesse protetto, considerato tuttavia
dinamicamente. In questo procedimento tuttavia, possono infiltrarsi le preferenze ideologiche
e le vedute personali dei singoli interpreti, potendo essere quindi utilizzato come espediente
retorico per legittimare ex post scelte. Se in origine questo criterio serviva a diminuire l’area
del penalmente rilevante, il suo utilizzo nella prassi ha invece portato a dilatare l’ambito della
punibilità.
Si inserisce in quest’ambito anche l’interpretazione orientata secondo le conseguenze, tesa a
scegliere la soluzione che provoca l’impatto più favorevole sul reo.
I più recenti sviluppi della teoria dell’interpretazione concordano nella negazione dell’automaticità
del meccanismo di sussunzione.
Un primo ostacolo è la natura stessa del linguaggio dei termini generali, avente una struttura aperta,
con un nucleo centrale di significato certo e con incertezza ai margini. Per risolvere quest’ultimi, il
giudice opera un ragionamento sostanzialmente analogico: valuta se il caso incerto è sufficientemente
simile ai casi tipici che certamente rientrano nel nucleo centrale di significato; in questo senso, il
tertium comparationis sarà costituito dallo scopo di tutela della norma. Tuttavia, quest’ultimo il più
delle volte sarà meglio definito proprio dal riferimento al caso concreto.
Il processo di interpretazione si atteggia quindi come processo circolare, in cui si insinuano
inevitabilmente le scelte valutative del giudice.
Il vincolo del giudice alla legge circoscrive lo spazio dell’interpretazione entro i limiti del significato
letterale del testo di legge.
I generali principi e caratteristiche del diritto penale non possono non riverberarsi sul processo
interpretativo, per cui:
1. bisogna escludere dall’area del penalmente rilevante comportamenti che non raggiungono una
soglia minima di offensività
2. escludere la tutela nei confronti di forme di aggressione non espressamente tipizzata
3. scegliere comunque l’interpretazione più conforme alla concezione di diritto penale come
extrema ratio
24
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO QUATTRO
AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LEGGE PENALE
AMBITO DI VALIDITÀ SPAZIALE
Per delimitare i limiti spaziali di applicabilità della legge penale sono prospettabili quattro principi:
1. Principio di territorialità: la legge nazionale si applica a chiunque delinque nel territorio
dello stato
2. Principio di difesa: la legge nazionale si applica a chi offenda beni appartenenti allo stato o a
chi ne è cittadino
3. Principio di universalità: la legge nazionale si applica a tutti i delitti, dovunque e da chiunque
commessi
4. Principio di personalità: si applica la legge dello stato di appartenenza del reo
Nel nostro ordinamento, nessuno di questi principi predomina in modo assoluto, si assiste piuttosto ad
una combinazione di principi diversi.
In particolare il principio di territorialità è andato nel tempo perdendo d’importanza, a fronte
dell’esigenza di combattere nuove forme di criminalità con carattere transnazionale. Coadiuvato dal
processo di armonizzazione europea, anche l’ordinamento penale italiano tende a concedere crescente
spazio al principio di universalità, con incremento dei casi di punibilità di delitti commessi all’estero.
REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO
L’art. 6 comma 1 c.p. sancisce il principio di territorialità, affermando che chiunque commette un
reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
La nozione di territorio è fornita dall’art. 4 c.p.: è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, e
ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati
come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto
internazionale, a una legge territoriale straniera. Al riguardo è necessario precisare che il territorio
dello statoè costituito dalla superficie terrestre compresa nei suoi confini politico-geografici, nonché
dal mare costiero e dallo spazio aereo.
L’applicabilità del c.d. principio della bandiera a navi ed aeromobili è incondizionata per quelle di
Stato, mentre per quelli privati è limitata alle ipotesi in cui essi si trovino in alto mare o che i fatti
verificatesi a bordo non producano alcuna conseguenza per lo stato rivierasco.
L’art. 6 comma 2 c.p. sancisce il principio dell’ubiquità, affermando che il reato si considera
commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in
tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Agli effetti di questa disposizione, la parte di azione o omissione non deve integrare gli estremi del
tentativo punibile, quanto rappresentare un anello essenziale della condotte conforme al modello
criminoso, secondo un giudizio a posteriori e in concreto.
In caso di concorso di persone, il reato si considera commesso nel territorio sia qualora l’azione venga
iniziata all’estero e proseguita in Italia, sia nel caso in cui un qualsiasi atto di partecipazione sia
compiuto in Italia.
Infine, per il reato continuato verificatosi all’estero, in dottrina si è sostenuta l’applicabilità dell’art. 6
alle ipotesi in esame, tutte le volte in cui ne derivi un concreto vantaggio all’imputato.
REATI COMUNI COMMESSI ALL’ESTERO
L’art. 7 c.p. elenca una serie di reati, commessi in territorio estero indipendentemente da un
cittadino o da uno straniero, che vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana.
Questi sono:
delitti contro la personalità dello Stato italiano (per il principio di difesa che rende applicabile
la legge dello stato cui appartengono i beni)
delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto
delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in
carte di pubblico credito italiano
25
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i
doveri inerenti alle loro funzioni (per il principio di difesa che rende applicabile la legge dello
stato cui appartengono i beni)
ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali
stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (per il principio di universalità, di difesa e
su ragioni di opportunità)
L’art. 9 c.p., fuori dai casi previsti dall’art. 7, disciplina la punibilità del cittadino per delitti comuni
commessi all’estero, subordinandola a due condizioni:
1. che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni o che sussistano le altre condizioni di cui ai commi 2 e 3.
In caso di durata inferiore, il reo è punito a richiesta del ministro della giustizia o su querela
della persona offesa.
Qualora si tratti di delitto commesso all’estero a danno di uno stato estero o straniero, il
colpevole è punito su richiesta del ministro della giustizia, se l’estradizione non è stata
concessa o accettata
2. che il cittadino si trovi nel territorio dello stato
C’è chi ravvisa la ratio di tale disciplina nel principio di personalità, chi nel principio di difesa. È
controverso se il fatto debba costituire reato anche nel diritto penale dello stato straniero.
L’art. 9.3 c.p. ha riguardo a quei delitti in cui lo stato assume la posizione di soggetto passivo specifico.
L’art. 10 c.p. disciplina il caso dello straniero che commette all’estero delitti comuni a danno dello
stato o cittadino italiano (1° comma), oppure a danno di stato o cittadino straniero (2° comma):
Se il reato è commesso a danno dello stato o cittadino italiano, occorre che:
A. Si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno
B. Il reo si trovi nel territorio dello stato
C. Vi sia richiesta del ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa
Se il reato è commesso a danno di stato o cittadino straniero, occorre che:
A. Il reo si trovi nel territorio dello stato
B. Vi sia richiesta del ministro della giustizia e l’estradizione non sia stata concessa o accettata
C. Si tratti di delitto punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre
anni
DELITTO POLITICO COMMESSO ALL’ESTERO
L’art. 8 comma 3 c.p. definisce delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello
Stato, ovvero un diritto politico del cittadino [delitto politico in senso oggettivo]. È altresì considerato
delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici [delitto politico in
senso soggettivo].
Tale ampia definizione risale all’ideologia fascista dominante nell’epoca in cui il codice è stato emanato
e tendente a reprimere ogni fatto potenzialmente aggressivo dell’ordine costituito.
Generalmente, il delitto politico in senso oggettivo offende un interesse politico dello stato, ovvero
l’interesso che è proprio dello stato considerato nella sua essenza unitaria (ad es. delitti contro la
personalità dello stato). Rientra all’interno della fattispecie, la lesione di un diritto politico del
cittadino, ovvero il diritto a partecipare alla vita dello stato e contribuire alla formazione della sua
volontà.
Per quanto attiene al delitto politico in senso soggettivo, desta difficoltà discernere tra motivo
politico e motivo sociale. Il primo è quel motivo che determina la condotta in funzione di una
concezione ideologica relativa alla struttura dei poteri dello stato e sui rapporti fra stato e cittadino.
Motivo sociale, invece, è quel motivo che determina la condotta in funzione di una concezione della
società che non necessariamente si riflette in maniera immediata sulla forma politica.
Criterio discretivo della natura politica del reato è il tipo di rapporto intercorrente fra il fratto
commesso e le libertà democratiche garantite dalla costituzione (es. non è delitto politico il reato
commesso all’estero al fine di lottare contro un regime autoritario o per far valere dei diritti
26
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
fondamentali il cui esercizio viene di fatto impedito).
Infine, la maggioritaria tesi autonomistica, oggi esclude la costituzionalizzazione implicita dell’art. 8,
per cui nella fonte primaria rimangono solo richiami al delitto politico all’interno degli artt. 10 e 26
Cost.
AMBITO DI VALIDITÀ PERSONALE
L’art. 3 c.p. sancisce il principio di obbligatorietà della legge penale, in base a cui la legge penale
italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri:
si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni [immunità] stabilite dal diritto pubblico
interno o dal diritto internazionale
si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto
internazionale
È considerato cittadino colui che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisto della
cittadinanza. È considerato straniero colui che è legato da rapporto di cittadinanza con altro stato,
oppure l’apolide residente all’estero.
IMMUNITÀ E FONTE GIURIDICA DELLA STESSA
Le immunità non costituiscono deroghe al principio di obbligatorietà, ma hanno il comune effetto di
sottrarre un soggetto all’applicabilità di una sanzione. Tale definizione unifica un complesso di
situazioni profondamente disomogenee sia per ratio che per contenuto, ma di cui l’effetto sia il
medesimo.
Si distingue tra:
Immunità a carattere assoluto: si estendono a tutti reati
Immunità a carattere relativo: sono riconosciute in costanza di carica e richiedono
un’autorizzazione a procedere da parte di organi diversi dal giudice ordinario.
Immunità sostanziali: sono riferite agli atti compiuti, alle opinioni espresse ed ai voti dati
nell’esercizio di funzioni
Immunità processuali: sono riferite agli atti compiuti fuori dall’esercizio delle funzioni e
perseguibili una volta cessata la carica.
Il riconoscimento di un’immunità penale deriva spesso dal bilanciamento di due interessi confliggenti:
da un lato, che l’autorità giudiziaria non rimanga inerte di fronte agli illeciti; dall’altro, l’esigenza di
tutela di particolari funzioni costituzionali o delle relazioni internazionali.
Le immunità derivanti dal diritto pubblico interno mirano a garantire e proteggere l’espletamento di
determinate funzioni o uffici di particolare importanza per il corretto funzionamento del nostro
sistema politico. Si tratta quindi di prerogative riguardanti le funzioni esercitate. Sono:
1. Presidente della repubblica: ex art. 90 Cost., esso non è responsabile per gli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento o per attentato alla costituzione.
Per gli atti compiuti fuori dalle sue funzioni, è equiparato ad un comune cittadino (salvo
eventuali valutazioni politiche o di correttezza costituzionale)
2. Presidente del senato: qualora eserciti le funzioni del presidente della repubblica, gode delle
stesse immunità
3. Membri del parlamento: ex art. 68 Cost., non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È questa un’immunità assoluta,
che esclude ogni tipo di responsabilità per le attività, anche atipiche e al di fuori dalle camere,
compiute in relazione alla carica. Con la riforma del 2003 è stata resa immediatamente e
direttamente operativo sul piano processuale.
I parlamentari gofono di ulteriori prerogative, ovvero alcune garanzie sul piano della libertà
27
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
personale e all’introduzione di nuovi limiti all’attività di indagine. Infatti, ex art. 68 comma 2 e
3 Cost., senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell’atto
di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Il fondamento di tali prerogative risiede nella necessità di salvaguardare l’indipendenza del
parlamento, nell’ottica della separazione dei poteri e in vista dell’esigenza di sottrarre i
parlamentari a procedimenti oggettivamente prosecutori.
La richiesta di autorizzazione per atti tipicamente a sorpresa appare poco giustificabile
4. Giudici della corte costituzionale: godono delle medesime prerogative dei parlamentari,
tranne quelle previste al terzo comma (l. Cost. 1/1948)
5. Membri consigli regionali: ex art. 122 comma 4 Cost., godono della garanzia
dell’irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni
6. Membri del CSM: godono della garanzia dell’irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti
dati nell’esercizio delle loro funzioni (l. 1/1981)
Le immunità derivanti dal diritto internazionale sono riconosciute nell’ordinamento italiano in forza
di trattati, convenzioni o accordi internazionali, oppure in forza dell’art. 10 comma 1 Cost. (anche se il
meccanismo automatico di adeguamento non deve violare i principi fondamentali dell’ordinamento):
Tali immunità sono così riassumibili:
1. La persona del Sommo Pontefice è considerata sacra e inviolabile
2. I capi di stato esteri ed i reggenti che si trovano in tempo di pace nel territorio dello stato
beneficiano di un’immunità totale, che si estende anche al seguito e ai familiari che li
accompagnano
3. Il presidente del consiglio e i ministri per gli affari esteri godono di un’immunità per tutti i fatti
commessi nell’esercizio delle loro funzioni
4. Gli agenti diplomatici godono dell’immunità penale assoluta dello stato accreditato e
dell’esenzione da qualsiasi misura esecutiva
5. I funzionari internazionali godono di immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro
funzioni
6. I parlamentari europei godono sia della garanzia dell’irresponsabilità, sia delle immunità
riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, nonché, sul territorio di ogni stato
membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da procedimenti giudiziali, per
la durata delle sessioni dell’assemblea
7. I consoli e gli agenti consolari godono dell’immunità se stabilito dai trattati internazionali con
gli altri stati
8. Gli agenti diplomatici e gli inviati dei governi presso la Santa Sede godono delle stesse
immunità degli agenti diplomatici presso lo stato italiano
9. Giudici della corte dell’Aja e Giudici della CorteEDU
10. Membri e le persone al seguito delle forze armate della NATO
11. Militari stranieri che si trovano nel territorio dello stato, previa autorizzazione
Secondo la dottrina dominante, tutti i fenomeni di immunità sono espressione di una medesima natura
giuridica, in quanto riconducibili alla categoria delle cause di esclusione della pena.
Questa tesi, tuttavia, non coglie la ratio dell’esenzione da pena, registrandone solo l’effetto finale:
trascura le diversità intercorrenti sul piano processuale e sostanziale delle diverse immunità.
Per determinare la natura giuridica delle immunità, occorre individuare l’effetto tipico
dell’immunità di volta in volta esaminata, nonché il contesto in cui essa opera.
In relazione all’effetto tipico, in tutti i casi in cui l’immunità è conseguenza dell’esercizio di funzioni, si
è in presenza di una causa di giustificazione.
28
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
In altri casi, va invece spiegata con il ricorso alla categoria dell’incapacità penale o processuale.
Con riferimento al contesto, nelle immunità di diritto interno la tutela delle funzioni attiene ad
interessi funzionali all’integrità del sistema e quindi prevalenti rispetto ad altri interessi.
Nel caso di immunità di diritto internazionale, il riconoscimento delle stesse discende dalla necessità
di mantenere relazioni diplomatiche con stati esteri; in questo senso, esse si atteggiando come mero
limite all’esercizio del potere giurisdizionale.
29
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO CINQUE
NOZIONI DI TEORIA GENERALE DEL REATO
DEFINIZIONE DI REATO
DEFINIZIONE FORMALE
Tradizionalmente si definisce reato ogni fatto umano a cui la legge ricollega una sanzione penale.
È questa una definizione di natura formale, che indica i fatti che costituiscono reato per
l’ordinamento positivo, quindi in funzione delle conseguenze giuridiche dei fatti, e non fa leva sulla
natura dei fatti assunti ad oggetto della disciplina.
La definizione di reato non può tuttavia prescindere dall’insieme di caratteristiche e principi che sono
ricavabili dalla costituzione, il reato è quindi:
Di creazione legislativa, dato che solo una legge in senso stretto può disciplinarne gli
elementi costitutivi ex art. 25 comma 2 Cost., mentre le fonti di livello secondario possono
soltanto contribuire a specificare elementi già legislativamente predeterminati nel nucleo
significativo essenziale
Di formulazione tassativa, poiché la legge deve fissare con la maggior determinatezza
possibile i fatti costituenti reato
Ha carattere personale, nel senso che non solo è vietata ogni forma di responsabilità per fatto
altrui, ma anche che il reato deve atteggiarsi a fatto colpevole, ex art. 27 comma 1 Cost.
Le predette caratteristiche sono sufficienti a differenziare l’illecito penale dall’illecito civile, per il
quale non vale la riserva di legge, il principio di tassatività e presenta forme di responsabilità indiretta
o oggettiva.
Le differenze con l’illecito amministrativo, specie dopo l’avvento dell’illecito c.d. depenalizzato, sono
sostanzialmente due: la natura della sanzione principale prescelta dal legislatore (sanzione
amministrativa), la natura amministrativa del procedimento e dell’organo competente ad infliggere la
sanzione.
DEFINIZIONE SOSTANZIALE
L’affermazione per la quale reato sarebbe ogni comportamento umano che rende impossibile o mette
in pericolo l’esistenza e la conservazione della società è dotata di una buona consapevolezza
sociologica. Ciononostante, non sembra che tale definizione serva ad indicare ciò che il legislatore deve
punire o meno. In generale, una definizione sociologica di reato non sembra adatta, dato che i fatti
criminosi non presentano una costante sociologica.
Un’acquisizione sembra pacifica: il reato costituisce la lesione di un bene giuridico degno di tutela in
quanto corrispondente ad un valore costituzionale.
Tuttavia, la definizione va integrata con i principi di sussidiarietà e meritevolezza di pena, per cui:
il reato è una lesione o messa in pericolo di un bene giuridico, che appaia meritevole di tutela
penalistica in base alle direttive di tutela potenzialmente vincolanti desumibili dalla costituzione, a
condizione che la misura dell’aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso alla pena e
sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire un’efficace tutela.
È tuttavia problematica la portata del principio di offensività, ovvero l’assunto centrale della
definizione di reato che consisterebbe nella lesione di un bene giuridico.
Al giorno d’oggi, manca una disposizione che espliciti il principio di offensività come principio
generale del diritto penale; esso viene il più delle volte ritenuto come criterio implicito o immanente al
sistema, grazie al seguente processo evolutivo:
1. Parte della dottrina tentò di individuare tale principio nella rilettura dell’art. 49 c.2 c.p., ma
questa lettura ermeneutica è contestata.
2. A partire dagli anni settanta, la fonte leggittimatrice del principio di offensività è rinvenuta
negli artt. 25 c.2 e 27 c.1 e 3 Cost.; in base al combinato disposto di queste disposizioni, la
dottrina maggioritaria afferma che il reato deve consistere in un fatto socialmente dannoso,
30
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
quindi oggettivamente lesivo di beni o interessi meritevoli di tutela.
Se si ritiene il principio di offensività implicitamente costituzionalizzato, si possono distinguere due
livelli sul quale esso opera (concezione riconosciuta anche dalla corte costituzionale):
Esso funge da criterio di conformazione legislativa dei fatti punibili, a livello di fattispecie
incriminatrici astratte, vincolando il legislatore a strutturare i reati come fatti che ledono beni
giuridici.
Tale vincolo non è sempre facile da rispettare, specie quando il bene o interesse da proteggere
è ad ampio spettro
Inoltre, funge da criterio giudiziario interpretativo, impegnando il giudice in sede applicativa a
qualificare come reati soltanto fatti che siano idonei in concreto a offendere beni giuridici.
Anche questo vincolo risulta di difficile applicazione, qualora il giudice sia costretto a ricercare
elementi di offensività in valutazioni extralegali di tipo sociopolitico o equitativo
La corte costituzionale ha tuttavia ridimensionato l’assolutezza del principio di offensività, affermando
la legittimità di anticipazioni di tutela, seppur a determinate condizioni.
DELITTI E CONTRAVVENZIONI
Il codice Rocco distingue i reati in delitti e contravvenzioni, secondo lo schema della summa divisio.
In linea di principio, i primi dovrebbero rappresentare le forme più gravi di illecito penale, mentre le
seconde, invece, le forme meno gravi, recepenti quelli che erano i c.d. illeciti di polizia, affidati durante
il periodo illuminista alla autorità amministrativa.
Per lungo tempo la dottrina si è sforzata di rinvenire un criterio sostanziale di differenziazione tra le
due fattispecie con scarsi risultati. Oggi, infatti, ci si basa sul criterio formale per cui la differenza fra le
due specie di reato poggia quindi su un criterio quantitativo, distinte quindi solo in ragione della
maggiore o minore gravità e delle conseguenti pene irrogate:
Art. 39 c.p.: afferma che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa
specie delle pene per essi rispettivamente stabilite.
Art. 17 c.p.: dispone che le pene principali stabilite sono:
A. Delitti: ergastolo, reclusione, multa
B. Contravvenzioni: arresto, ammenda
Con l’introduzione dell’illecito amministrativo depenalizzato, sono state proposte iniziative volte a
trasferirvi all’interno tutte le contravvenzioni. Tuttavia, una simile scelta sarebbe sconsigliabile, in
quanto esistono illeciti posti in una zona intermedia, che cioè non integrano i requisiti per essere
delitti, ma non tollererebbero di essere ridotti a meri illeciti amministrativa (poiché la sola sanzione
amministrativa apparirebbe poco proporzionata oppure perché garantirebbe un’efficacia preventiva
minore).
Il criterio formale, della diversità delle sanzioni, risulta di più incerta applicazione nella legislazione
penale speciale, soprattutto considerando che nelle leggi speciali anteriori all’emanazione del codice le
sanzioni ricevevano una diversa denominazione.
La distinzione fra delitti e contravvenzioni ha poi un’importante rilevanza sotto il profilo
dell’elemento soggettivo del reato e al tentativo.
REATO (ART. 39 C.P.) SANZIONE (ART. 17 C.P.) ELEMENTO SOGGETTIVO TENTATIVO
(ART. 42 C.P.)
DELITTI Ergastolo, reclusione, Dolo regola Configurabile
multa Colpa eccezione
CONTRAVVENZIONI Arresto, ammenda Indifferentemente Non configurabile
dolo o colpa (salvo
caratteristiche proprie
della singola
fattispecie)
31
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
SOGGETTO ATTIVO DEL REATO
È soggetto attivo o autore o reo o agente o colpevole colui il quale realizza un fatto conforme ad una
fattispecie astratta di reato.
Autore di un reato può essere solo una persona umana, chiunque essa sia, a prescindere dal sesso,
dall’età o da altri requisiti. La dottrina parla, in questo senso, di capacità penale per alludere
all’attitudine di tutte le persone a porre in essere un reato.
Si differenziano diverse specie di capacità, in funzione dei requisiti che incidono sull’idoneità a
diventare destinatari di conseguenze giuridiche in generale o di un determinato tipo: si parla così di:
Capacità alla pena: imputabilità
Capacità alle misure di sicurezza: pericolosità sociale
Immunità: incapacità ad essere assoggettati a conseguenze penali
Lo sforzo di distinguere diverse forme di capacità risponde, comunque, ad un’astratta esigenza
dogmatica, nel senso che è manifesta la suggestione di trapiantare anche in diritto penale categorie
originariamente elaborate nel settore civilistico, di cui il diritto penale può fare a meno.
Si parla di reati comuni quando soggetto attivo può essere chiunque (es. omicidio)
Si parla di reati propri quando la fattispecie incriminatrice richiede il possesso di particolari requisiti
o qualità in capo al soggetto attivo. Questi possono essere requisiti naturalistici (ad es. essere madre
nel delitto di infanticidio) o giuridici (ad es. qualifica dei pubblici ufficiali nei delitti contro la p.a.).
la definizione di reato proprio sottolinea lo streto rapporto intercorrente tra la speciale qualifica
soggettiva rivestita dal soggetto e il bene giuridico assunto ad oggetto di protezione penale.
Al loro interno, i reati propri sono ulteriormente distinguibili in:
Reati propri esclusivi, in cui la qualifica soggettiva rileva ai fini della stessa qualificazione del
fatto come reato (ad es. la condizione di ascendente o fratello nell’incesto)
Reati propri non esclusivi, in cui la qualifica soggettiva determina un mutamento del titolo
del reato (ad es. la qualifica di pubblico ufficiale trasforma un’appropriazione indebita ai danni
della p.a. in peculato).
RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE
Nel nostro ordinamento non vi è responsabilità penale per le persone giuridiche, e continua dunque a
vigere il principio individualistico del societas delinquere non potest. La responsabilità penale delle
persone giuridiche non viene in realtà esplicitamente esclusa dalla legge, e dunque questa esclusione,
argomentando a contrario, viene solitamente dedotta dall’art. 197 c.p., che prevede un’obbligazione
civile di garanzia della persona giuridica per il caso in cui chi ne ha rappresentanza o amministrazione
commetta un reato o in violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita o nell’interesse della
persona giuridica, e versi in condizioni di insolvibilità (l’attribuzione all’ente di questo obbligo di
garanzia non si spiegherebbe se l’ente stesso potesse considerarsi soggetto attivo del reato). Tuttavia,
la crescente presa d’atto che alcune tra le più gravi forme di criminalità economica sono veri e propri
reati di impresa o di criminalità societaria, ha messo in dubbio l’esclusione della responsabilità
penale delle persone giuridiche nel nostro Paese, posto che altri Stati conoscono invece questo tipo di
responsabilità (nei paesi anglosassoni vi è il corporate crime, e nel nuovo codice penale francese si è
ammessa la responsabilità delle persone giuridiche sia a titolo di concorso delle persone fisiche che
agiscono per essa, sia a titolo di responsabilità autonoma).
Problematica è comunque la scelta dei meccanismi sanzionatori da applicare in questi casi, nonché la
dimostrazione della compatibilità di questa responsabilità con i principi costituzionali in materia
penale. Secondo una parte della dottrina, infatti, il principio societas delinquere non potest
discenderebbe dal principio del carattere personale della responsabilità penale disposto dall’art. 27
Cost. Si è replicato a queste obiezioni facendo leva sulla teoria organicistica della persona giuridica, la
quale riconosce soggettività reale e non funzionistica all’ente collettivo in virtù di un ritenuto rapporto
di rappresentanza organica tra l’ente e le persone fisiche che ne determinano la volontà, e in questo
modo l’attività degli organi diventa automaticamente imputabile alla persona giuridica. In questo
modo si supera così l’ostacolo tra la responsabilità delle persone giuridiche e il principio costituzionale
di personalità inteso nell’accezione minima di divieto di responsabilità per fatto altrui; tuttavia, il
32
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
problema persiste se si aderisce alla tesi che intende questo principio di personalità come inclusivo del
requisito della colpevolezza come presupposto del reato. Per superare anche questo nodo, si è
proposto di configurare a carico della persona giuridica sanzioni aventi più il carattere della misura di
sicurezza che non di pena, sulla base del presupposto che la misura di sicurezza implica una
pericolosità sociale, e non una colpevolezza. Tuttavia, va detto che anche in questo caso l’ostacolo non
è completamente superato, in quanto il requisito della pericolosità sociale non può prescindere
dall’atteggiamento psicologico dell’autore del fatto, e, inoltre, il concetto di pericolosità è strettamente
legato a quello di risocializzazione, ma questo risulterebbe difficile nei confronti di una persona
giuridica.
Tutte queste difficoltà spiegano perché una parte della dottrina propenda, per le persone giuridiche,
per modelli sanzionatori alternativi di tipo amministrativo o civilistico.
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI COLLETTIVI
Un nuovo modello di responsabilità per prevenire la commissione di reati all’interno degli enti
collettivi e delle persone giuridiche è stato inserito nel nostro ordinamento con la riforma che ha
introdotto la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per i reati commessi dai loro organi
o sottoposti.
La responsabilità è stata definita amministrativa e non penale per la necessità di allentare le
consistenti tensioni del mondo imprenditoriale, il quale era preoccupato per le ricadute economiche
della riforma. Tuttavia, sembra che la responsabilità sia stata definita formalmente come
amministrativa, ma presenti in realtà un carattere penalistico, infatti la responsabilità dell’ente è
strettamente agganciata alla commissione di un fatto di reato, e la sede in cui viene accertata è
comunque il processo penale. La stessa Corte di cassazione ha stabilito che questa responsabilità
presenti il nome di responsabilità amministrativa ma dissimuli la sua natura sostanzialmente penale,
creando in questo modo un tertium genus ove il presupposto è dato dalla commissione del reato.
Questo modello è stato criticato in quanto, nella realtà economica odierna, non riesce a raggiungere
pienamente il suo obiettivo, poiché è ormai sfumata l’immagine dell’ente come un organismo i cui
meccanismi interni, pur invisibili, sono razionalmente dominanti dalla convergenza delle singole
volontà versato la realizzazione dello scopo sociale. Si denuncia al contrario la sussistenza di differenti
anomalie, le principali delle quali si concentrano nel comportamento della media dirigenza, che per
conservare il posto di lavoro o per raggiungere i vertici non esita a tenere comportamenti ai margini
della legalità.
Il modello di disciplina introdotto con il decreto legislativo n. 231 del 2001 e successivamente
ampliato, presenta una serie di caratteristiche fondamentali e di presupposti applicativi:
A. le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti si applicano non solo agli enti
forniti di personalità giuridica ma anche alle società e associazioni che ne sono prive (ma non
si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale);
B. la fattispecie obiettiva costitutiva dell’illecito amministrativo dipendente da reato va desunta
diverse disposizioni del decreto legislativo, che subordina il giudizio di responsabilità alla
presenza di alcuni requisiti:
1. la commissione da parte di una persona fisica di un determinato reato - consumato o
tentato - espressamente previsto dalla legge ai fini della responsabilità dell’ente
2. l’esistenza di un rapporto qualificato tra l’autore del reato e l’ente, ossia una posizione
apicale del soggetto nella società (amministratore, rappresentante, direttore, ecc.), oppure
un rapporto di dipendenza dell’autore del reato da persone in posizione apicale
3. l’interesse o il vantaggio dell’ente
4. il carattere non territoriale, non pubblico o non di rilievo costituzionale dell’ente;
5. l’inesistenza di un provvedimento di amnistia per il reato da cui dipende l’illecito
amministrativo;
C. per quanto riguarda i criteri di imputazione soggettiva, è stato normativamente configurato un
33
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
modello di colpevolezza sui generis ritagliato sulle caratteristiche strutturali dell’ente, e il
quale prevede una colpevolezza concepita come rimproverabilità soggettiva, ma peculiarmente
connessa al fatto, infatti il reato deve costituire anche espressione della politica aziendale o
derivare da una colpa di organizzazione. Dunque, la colpevolezza della persona giuridica si
configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione
imprenditoriale o quando è conseguenza della mancata adozione di un modello organizzativo
idoneo a prevenire reati di questo tipo, o quando vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte degli organismi dotati di potere di controllo.
I criteri di imputazione soggettiva del reato vengono poi normativamente differenziati a
seconda che il reato sia commesso da:
Soggetti in posizione apicale: nel cui caso si prevede un’inversione dell’onere della
prova, e dunque l’ente per esimersi da responsabilità deve dimostrare che gli apicali
hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di
gestione, e che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte
dell’organismo di vigilanza
Persone sottoposte alla direzione di questi ultimi: nel cui caso l’ente è responsabile
solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi
di direzione e vigilanza, ma è comunque esclusa se l’ente aveva adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo inidoneo a
prevenire reati come quello verificatosi
D. viene espressamente introdotto il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente, e
dunque esso risponde anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è
imputabile, e quando il reato di estingue per una causa diversa dall’amnistia
E. la responsabilità degli enti non ha portata generale, ma viene circoscritta a figure di reato
espressamente previste (le quali, come già accennato, sono state negli anni ampliate). Nel
novero oggi previsto, sono presenti i reati contro la pubblica amministrazione, i reati contro la
fede pubblica, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, i reati
contro l’ordine pubblico, i reati contro la persona, i reati contro la personalità individuale, i
reati informatici, quelli contro il patrimonio e quelli contro l’industria e il commercio; sono
inoltre elevati, fuori dal codice, a presupposto di responsabilità degli enti figure di reato
tipicamente suscettibili di coinvolgimento delle imprese, come i reati societari, gli abusi di
mercato, i delitti in materia di violazione del diritto d’autore, e diversi altri
F. risulta infine variegato il novero delle misure sanzionatorie, che per l’ente prevede sanzioni
pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, e infine pubblicazione della sentenza di condanna.
IL PROBLEMA DEI SOGGETTI RESPONABILI NEGLI ENTI E NELLE IMPRESE
Nell’ambito degli enti collettivi o delle imprese non è sempre agevole individuare il soggetto-persona
fisica suscettibile di essere chiamato a rispondere di resati commessi nello svolgimento dell’attività
che fa capo all’ente collettivo o all’impresa. Questa complicazione deriva dal fatto che all’interno delle
grandi imprese il soggetto che formalmente è titolare di obblighi di condotta penalmente sanzionati
non è sempre in grado di adempiervi personalmente, delegando così il compito a dei collaboratori, ma
sorge così il problema del determinare se e quando la delega possa assumere rilevanza penale.
Prima dell’intervento legislativo del 2008 in tema di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro, questa questione è stata oggetto di una lunga elaborazione in giurisprudenza e dottrina. La
giurisprudenza prevalente condizionava la rilevanza penale della delega alla presenza di quattro
presupposti:
1. che l’impresa sia grande (anche se alcuni non consideravano che questo presupposto fosse
necessario)
2. che la ripartizione delle funzioni non sia fraudolenta
3. che i collaboratori delegati siano dotati dei poteri e dei mezzi necessari per svolgere
34
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
efficacemente i compiti loro affidati
4. che essi possiedano una provata competenza tecnica. In presenza di questi presupposti,
dunque, la giurisprudenza prevalente ammetteva che la delega esonerasse da responsabilità
penale il delegante, trasferendo la responsabilità sul delegato.
Una parte della dottrina propendeva invece per un orientamento funzionalistico, sulla base del
quale l’individuazione del soggetto responsabile doveva essere effettuata sulla base della funzione di
fatto esercitata all’interno dell’ente collettivo, e questo in omaggio al principio della corrispondenza
tra poteri e funzioni ed obblighi e responsabilità. A questo orientamento si oppongono però due
critiche:
l’assunto secondo il quale il diritto penale considera realisticamente prevalenti le funzioni di
fatto svolte rispetto alla titolarità delle qualifiche formali, rischiava di confliggere con il
principio di legalità
la possibilità che l’imprenditore strumentalizzasse la propria preposizione in fatto di un
collaboratore per liberarsi dalla responsabilità, trasferendola indebitamente sui subordinati.
Proprio per evitare il rischio di un trasferimento "verso il basso" della responsabilità, una parte
della dottrina riteneva che la delega non liberasse il titolare originario da responsabilità, ma
mantenesse un obbligo di vigilanza sull’adempimento delle incombenze affidate al
collaboratore o preposto; tuttavia questo orientamento è stato criticato perché rischiava di
portare all’inconveniente opposto, ossia di trasferire troppo "verso l’alto" la responsabilità
penale, poiché in questo modo i titolari devono rispondere in base al ruolo rivestito, anche in
assenza della concreta possibilità di adempimento, con una conseguente violazione della
responsabilità penale personale.
Tuttavia, una parte rilevante dell’elaborazione giurisprudenziale ha trovato un esplicito avallo
legislativo con l’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che stabilisce che la delega di
funzioni da parte del datore di lavoro, se non viene espressamente esclusa, è ammessa, ma con alcuni
limiti, ossia:
1. che essa risulti da un atto scritto recante data certa
2. che il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle
funzioni delegate
3. che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla natura delle funzioni delegate
4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni
5. che, infine, la delega sia accettata per iscritto dal delegato.
Il decreto legislativo dispone inoltre che alla delega venga data adeguata e tempestiva pubblicità. Il
legislatore ha inoltre recepito dalla giurisprudenza i principi che vogliono la delega come non
fraudolenta, nonché scritta ed accettata espressamente dal delegato, e il fatto che essa venga attribuita
ad una persona tecnicamente competente rispetto alla natura delle funzioni delegate. Discostandosi
però dalla giurisprudenza, il decreto non considera la dimensione dell’impresa come presupposto di
legittimità della delega. Nel decreto legislativo viene inoltre espressamente disposto che sui deleganti
incombe comunque un obbligo di vigilanza, il quale non viene escluso a seguito della delega ad altri
soggetti di alcune funzioni.
SOGGETTO PASSIVO DEL REATO
È soggetto passivo il titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale;
coincide con quello che nel codice viene definito la persona offesa dal reato (art. 120 c.p.).
Tale concetto si differenzia da quello di oggetto materiale, che allude invece alla persona o cosa sulla
quale materialmente ricade l’attività delittuosa, in alcune fattispecie coincidono (es. nei delitti di
omicidio o lesioni), mentre in altre non coincidono (es. mutilazione fraudolenta della propria persona).
Non coincide neppure con il concetto di danneggiato del reato, ovvero il soggetto che subisce un
danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile e che è legittimato a costituirsi parte civile
(coincidono nel delitto di lesioni, ma non coincidono nel delitto di omicidio nel caso esistano familiari).
35
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Purché la struttura del reato lo consenta, soggetto passivo può essere anche lo stato (es. delitti dagli
artt. 241 e ss.) o persone giuridiche (es. reati societari) o le collettività non personificate, cd. reati
vaghi o vaganti che affliggono una cerchia indeterminata di persone (ad es. reati contro l’incolumità
pubblica). Può esservi anche pluralità di soggetti passivi, nel caso in cui la medesima offesa coinvolga
più titolari del medesimo bene (es. violazione di domicilio).
Le caratteristiche del soggetto passivo possono assumere rilevanza penale:
Ai fini della configurabilità stessa del reato (es. la qualità di minore è essenziale per la
realizzazione del delitto di corruzione di minorenne)
Ai fini del mutamento del titolo di reato (es. la qualità di pubblico ufficiale trasforma il delitto
di violenza privata in violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale)
Le relazioni che legano soggetto attivo e soggetto passivo possono:
1. Conferire rilevanza al fatto (es. la qualità di figlio del soggetto passivo è essenzialmente per
il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare)
2. Determinare la non punibilità del fatto (es. la qualità di figlio del soggetto passivo esclude
la punibilità del furto commesso ai suoi danni dal padre)
3. Rendere applicabile una circostanza aggravante (es. la qualità di ascendente del soggetto
attivo costituisce circostanza aggravante dell’omicidio)
Può assumere rilevanza anche la condotta tenuta:
A. Anteriormente (es. attenuante della provocazione)
B. Contemporaneamente (es. concorso del fatto doloso della persona offesa)
C. Successivamente (es. iniziativa del soggetto passivo necessaria per consentire all’offensore
la prova della verità dell’addebito nei delitti contro l’onore)
Di recente si è parlato di due figure peculiari per quanto attiene al soggetto passivo del reato:
1. Reati senza soggetto passivo o vittima: ipotesi di incriminazione dietro le quali non è facile
individuare l’offesa ad un bene giuridico afferrabile (es. delitto di pubblicazioni oscene)
2. Reati ostativi: figure di illecito a pericolo astratto che incriminano atti che rappresentano
soltanto il presupposto di una concreta aggressione ad un bene definito bene oggetto di
protezione
L’individuazione del soggetto passivo assume rilevanza pratica ai fini della presentazione della
querela e dell’ammissibilità del consenso scriminante della persona offesa:
Querela: è sufficiente, in base al principio dell’indivisibilità, che la presenti uno solo ei soggetti
passivi (art. 122 e ss.)
Consenso: subordinato all’esistenza di una concorde volontà di tutti i titolari dell’interesse
protetto
Il riferimento alle caratteristiche del soggetto passivo viene utilizzato come criterio atto a ricostruire
particolari settori del diritto penale in conformità al principio del diritto penale come ultima ratio (es.
l’ambito di operatività della truffa si dilata o restringe in funzione dell’attitudine autodifensiva della
vittima).
STRUTTURA DEL REATO
Anche se nella pratica il reato viene percepito nella realtà sociale come una singola figura delittuosa,
ciò non ha impedito alla dottrina di elaborare una teoria generale del reato che unifichi tutti gli
elementi comuni alle varie tipologie delittuose. Tutto ciò si è reso necessario non soltanto per
un’esigenza logico-conoscitiva, ma anche per aspettative di certezza giuridica, in quanto, in mancanza
di categorie concettuali rigorose, il giudice non avrebbe punti di riferimento sicuri per orientare la
decisione dei casi concreti secondo criteri di razionalità e imparzialità.
L’elaborazione dogmatica della materia penalistica ha per tempo avuto come obiettivo il rinvenire il
36
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
maggior numero di elementi comuni a tutte le forme di reato, ma per fare ciò si sono più volte
prospettate soluzioni artificiose, tanto che una parte della dottrina, soprattutto a partire dal secondo
dopoguerra, si è impegnata nella ricerca e nella verifica degli abusi di generalizzazione compiuti
dalle dottrine generali del reato.
Le dottrine generali del reato possono da un lato essere ricostruite secondo differenti modelli di
scomposizione analitica dell’illecito penale, e dall’altro la crescente sottolineatura delle peculiarità
strutturale dei diversi tipi delittuosi tende a sfociare nell’elaborazione di più sotto-teorie generali
destinate a sistematizzare gli elementi comuni ai diversi modelli di reato. Inoltre, il rifiuto di una
dogmatica astrattamente concettualistica e la conseguente adesione ad una prospettiva teleologica,
sollecitano un costante raccordo tra l’elaborazione della teoria generale del reato e le indagini di parte
speciale, poiché è dalle singole figure criminose che le categorie generali traggono vita e
giustificazione.
ANALISI DELLA STRUTTURA DEL REATO
Le concezioni del reato nella dottrina italiana sono:
Concezione tripartita del reato che consiste in un fatto umano:
1. Tipico: il fatto umano corrisponde alla fattispecie obiettiva di una figura criminosa, vi è
quindi un giudizio di corrispondenza tra fatto e schema legale
2. Antigiuridico: vi è effettivo contrasto tra fatto tipico ed ordinamento (contra ius); infatti,
non sempre un fatto tipico contrasta con i dettami dell’ordinamento: ci possono essere
situazioni, in presenza delle quali è consentita la realizzazione di un fatto altrimenti
punibile
3. Colpevole: è necessario che il fatto umano sia riconducibile alla responsabilità di un
soggetto che ne risulta autore
La concezione tripartita sarebbe da preferire poiché le categorie sistematiche in cui scompone
il reato assolvono funzioni specifiche, non intercambiabili, corrispondenti ciascuna ad un
particolare aspetto della tutela penalistica. Essa inoltre scandisce i passaggi in cui
normalmente si snoda il processo mentale del giudice in sede di accertamento del fatto di
reato.
Concezione bipartita del reato che è composto di:
1. Elemento oggettivo: fatto materiale, evento, se presente, rapporto di causalità
2. Elemento soggettivo: colpevolezza
È questa la concezione finora prevalente in giurisprudenza. Le resistenze circa l’adozione della
concezione tripartita derivano dalla controversa collocazione sistematica delle cause di
giustificazione, che tradizionalmente vengono escluse dalla struttura del reato per qualificarle
come cause esterne, impeditive della punibilità. Tuttavia, tale dubbio non dovrebbe più
persistere alla luce del nuovo art. 530.3 c.p.p., per cui il giudice dovrà comunque pronunciare
sentenza di assoluzione piena anche ove vi sia dubbio sull’esistenza di case di giustificazione.
1. TIPICITÀ
In diritto penale, il concetto di fatto tipico o fattispecie o tipo delittuoso comprende il complesso
degli elementi oggettivi e soggettivi che delineano il volto di uno specifico reato. Di conseguenza, il
fatto comprende solo quegli elementi in presenza dei quali si può dire compiute un particolare
modello delittuoso, e non una altro.
Questa categoria assolve la funzione garantista di indicare ai cittadini i fatti che essi devono astenersi
dal compiere per non incorrere in una sanzione penale, in funzione del principio di legalità. Ma il
fatto tipico ha anche il compito di circoscrivere la sanzione penale a specifiche forme di aggressione ai
beni penalmente tutelati, in quanto la categoria della tipicità segna al medesimo tempo i limiti o
confini della tutela che il diritto penale accorda ai beni giuridici considerati meritevoli di protezione.
La categoria del fatto tipico dovrebbe rispettare il più possibile il principio di materialità, è
necessario quindi che il legislatore crei fattispecie aventi un preciso riscontro nella realtà concreta; se
37
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
invece l’illecito penale è privo di referenti empirici, non solo sarà difficile ricostruirne la fisionomia, ma
il giudice non sarà neanche in grade di accertare il fatto materiale in cui dovrebbe concretizzarsi.
Nell’ambito di un diritto penale veramente rispettoso dei principi di legalità, materialità e tassatività,
la categoria del fatto tipico dovrebbe assolvere l’ulteriore funzione di ancorare i modelli delittuosi a
tipi di comportamenti basati a loro volta su ben definite tipologie empirico-criminologiche.
La tipicità del fatto si riconnette alla lesione del bene giuridico: infatti, il riferimento al bene tutelato
svolge una funzione essenziale ai fini della determinazione del concetto di tipicità, oltre che ad essere
criterio legislativo di criminalizzazione e criterio ermeneutico.
La qui considerata funzione dogmatica del bene giuridico consisterebbe nel suo riverberassi nella
determinazione delle componenti costitutive del reato posto a sua tutela, ovvero nel far si che la
tipicità stessa concettualmente includa la lesione del bene giuridico. Tuttavia, questo principio può
subire deroghe per effetto della difettosa formulazione tecnica delle fattispecie incriminatrici.
Un eventuale contrasto tra tipicità e offensività è apparente: un fatto che non sia capace di offendere il
bene tutelato dalla norma è solo apparentemente conforme al tipo di reato, in realtà tale conformità
manca (es. furto di un acino d’uva).
2. ANTIGIURIDICITÀ
La tipicità costituisce un indizio del carattere antigiuridico del fatto, dal momento che i modelli di
reato della parte speciale configurano fatti normalmente illeciti. Tuttavia, in alcuni casi, il fatto
conforme risulta giustificato o consentito in base ad una valutazione effettuata alla stregua dell’intero
ordinamento giuridico.
Questo secondo filtro del carattere illecito è imposto dal principio di unità del sistema giuridico: se
un’azione consentita in un settore dell’ordinamento ne deriva che occorre accertare se questa stessa
azione non sia lecita per norme non penali (es. l’ufficiale giudiziario, all’atto del pignoramento,
commette un fatto conforme al delitto di furto, ma non realizza certo un furto punibile, dato che nel
c.p.c. gli si fa obbligo di compiere tale atto).
La rilevanza del giudizio di antigiuridicità in seno all’intero ordinamento è comprovata dalle norme
processuali che regolano i rapporti tra processo penale, civile ed amministrativo:
Art. 652 c.p.p.: nel disciplinare i rapporti tra giudizio penale di assoluzione e azione civile
riparatoria stabilisce che la sentenza penale ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento
che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà
legittima nel giudizio civile o amministrativo. Tale disposizione si esplica in base al principio di
non contraddizione dell’ordinamento, nel senso che l’esistenza di una qualsiasi norma atta a
facoltizzare o rendere doveroso un determinato comportamento, basta a renderlo lecito in
tutto l’ordinamento giuridico.
Art. 651 c.p.p.: vincola il giudice civile e amministrativo al giudicato penale di condanna, a
riprova che l’antigiuridicità del fatto costituisce requisito unitario accertabile una volta per
tutte con riguardo a tutte le branche del diritto.
L’esame congiunto di tipicità e antigiuridicità circoscrive con precisione l’ambito di tutela della
norma penale, pone in relazione la norma penale con le altre norme e ne chiarisce il reciproco
condizionamento. Soltanto l’intero ordinamento giuridico è in grado in indicare ad un soggetto la
regola di condotta da adottare al caso singolo.
Il giudizio di antigiuridicità consiste nella verifica che il fatto tipico non è coperto da alcuna causa di
giustificazione/esimente (questa è la c.d. antigiuridicità formale, basata sul contrasto tra condotta
umana e norme di un dato ordinamento).
All’interno della concezione tripartita del reato, l’antigiuridicità ha carattere oggettivo, nel senso che
costituisce una qualità oggettiva del fatto tipico, che quindi prescinde ed è distinta dalla
colpevolezza. Infatti, l’art. 59 c.p. fissa la regola della rilevanza obiettiva delle cause di giustificazione,
38
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
nel senso che rilevano anche se non conosciute dall’agente. Tale teoria è suffragata in tutti quei settori
in cui il giudizio di contraddizione tra fatto e diritto tende sempre più a prescindere dall’esistenza di
requisiti soggettivi di imputazione con conseguente progressivo incremento delle ipotesi di
responsabilità cd. obiettiva.
Parte della dottrina nega invece che l’antigiuridicità costituisca elemento autonomo del reato: essi
fanno ricorso al concetto di elementi negativi del fatto, cioè elementi che devono mancare perché
l’illecito penale si configuri. Questa collocazione delle esimenti sul piano del fatto risulta inopportuna
in base ad una valutazione teleologica, attenta a cogliere le rispettive funzioni.
Questa teoria degli elementi negativi del fatto o della fattispecie ha avuto origine per ricercare
espedienti concettuali che consentissero di risolvere il problema dell’errore sull’esistenza di cause di
giustificazione nell’ambito di ordinamenti (come quello tedesco-occidentale) privi di una norma ad
hoc, e dunque questa teoria non sempre utile in ordinamenti che presentano una disciplina esplicita
dell’errore sulle scriminanti, come l’ordinamento italiano. Inoltre, la collocazione delle scriminanti
sullo stesso piano del fatto, la quale è ammissibile da un punto di vista logico-astratto, risulta invece
inopportuna ad una considerazione teleologica attenta a cogliere la rispettiva funzione del fatto e delle
scriminanti nel sistema penale.
La categoria del fatto presenta come funzione quella di selezionare le forme di offesa meritevoli di
sanzione penale, e dunque la categoria stessa assume una connotazione prettamente penalistica,
mentre la categoria delle cause di giustificazione non ha una funzione prettamente giuridico-
penale, e infatti le scriminanti servono ad integrare il diritto penale nell’ordinamento giuridico
generale.
Inoltre, dal carattere non specificamente penale delle norme che configurano le cause di
giustificazione derivano importanti conseguenze, ossia da un lato il fatto che la disciplina delle
situazioni che integrano scriminanti non è necessariamente subordinata, e dall’altro lato il fatto che,
essendo le norme sulle scriminanti autonome norme extrapenali desumibili da tutto l’ordinamento, di
conseguenza la si può dedurre che sia possibile la loro estensione analogica.
Va, infine, puntualizzato che la verifica dell’esistenza o assenza di cause di giustificazione poggia su
criteri più formali che sostanziali, infatti le situazioni che integrano le esimenti non sono liberamente
individuabili dal giudice, ma costituiscono oggetto di esplicita previsione normativa.
A questo concetto di antigiuridicità parte della dottrina affianca anche un concetto di antigiuridicità
materiale, che darebbe conto delle ragioni sostanziali che stanno alla base dell’incriminazione, ragioni
che la dottrina meno recente individuava nell’antisocialità del fatto, e che la dottrina più recente
individua nella lesione del bene penalmente protetto. Una tale nozione di antigiuridicità materiale è
superflua e fuorviante, infatti il profilo dell’incidenza lesiva del fatto sul bene protetto viene già
assorbito dal giudizio di tipicità, e inoltre le scelte sostanziali che stanno alla base della scelta
legislativa di penalizzare un certo comportamento vanno ben al di là di quelle riconducibili
all’antigiuridicità materiale.
In un ordinamento penale ispirato ai principi garantistici del moderno Stato di diritto il giudizio di
antigiuridicità non può che essere rapportato a precise norme giuridiche, suscettive al massimo di
applicazione analogica ai casi simili non espressamente regolati.
Nel linguaggio penalistico si parla solitamente di antigiuridicità o illiceità speciale riguardo a casi in
cui la stessa condotta tipica è contraddistinta da una nota di illiceità desumibile da una norma diversa
da quella incriminatrice, e questa nota di illiceità costituisce un elemento diverso e ulteriore rispetto
alla normale antigiuridicità oggettiva intesa come assenza di cause di giustificazione. La presenza di
questa speciale antigiuridicità si può solitamente vedere quando si incontrano espressioni come
"illegittimamente", "abusivamente", "arbitrariamente", ecc.
La presenza del requisito di antigiuridicità speciale nella maggior parte dei casi viene espressamente
evidenziata dal legislatore stesso mediante queste espressioni, ma può anche accadere che l’uso di una
di queste forme linguistiche non corrisponda ad un requisito di illiceità speciale.
La distinzione tra illiceità speciale effettiva e illiceità speciale apparente è in realtà una questione
interpretativa, che, come tale, viene rimessa all’attenta analisi delle varie fattispecie, ma esistono - per
questo motivo - ampi margini di incertezza.
39
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
3. COLPEVOLEZZA
La colpevolezza riassume le condizioni psicologiche che consentono l’imputazione personale del
fatto di reato all’autore. Nel giudizio di colpevolezza rientra così la valutazione del legame psicologico
o del rapporto di appartenenza tra fatto e autore, e la valutazione delle circostanze, di natura
personale e non, che incidono sulle capacità di autodeterminazione del soggetto (anche se questo non
significa che la colpevolezza presupponga il requisito di libero arbitrio in senso filosofico, infatti, anche
se si trattasse di una finzione, il diritto penale fa proprio il principio della responsabilità umana come
presupposto necessario alla vita pratica).
Al giorno d’oggi la colpevolezza si è spogliata di implicazioni eticizzanti, perdendo di conseguenza il
tradizionale ruolo di fondamento della pena stessa. Infatti, la ratio che la giustifica va oggi piuttosto
individuata nell’ambito di una prospettiva idonea a contemperare l’efficienza preventiva del sistema
penale con la garanzia delle fondamentali libertà del singolo. La legge penale, cioè, garantisce la libertà
di scelta individuale nella misura in cui rifiuta la responsabilità oggettiva, basata sul nesso di causalità
materiale, e subordina invece la punibilità alla sussistenza dei coefficienti soggettivi del dolo e della
colpa.
La colpevolezza così intesa assume innanzitutto il ruolo di un principio di civiltà, ricco di implicazioni
politico-ideologiche, costituzionali e politico-criminali, assurgendo così a criterio-cardine cui
commisurare la conformità alla Costituzione della disciplina dei presupposti della responsabilità
penale, sia sul terreno del diritto vigente sia in una prospettiva de iure condendo. La stessa Corte
costituzionale (sent. 364/88) ha chiarito che la colpevolezza è un principio costituzionale e garantista
che limita la discrezionalità del legislatore nell’incriminazione, in quanto vengono indicati dalla
Costituzione i necessari requisiti minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può
essere punito.
Non vi è un orientamento omogeneo per quanto concerne la determinazione del contenuto della
colpevolezza come categoria dogmatica, infatti, mentre non si discute sul fatto che essa comprenda
dolo e colpa come requisito minimi, è dibattuto se vi rientrino elementi ulteriori e di quale natura essi
siano.
TIPI DI REATO
L’elaborazione delle dottrine generali del reato si è sviluppata assumendo a modello l’illecito
commissivo doloso e in particolare il delitto di omicidio. Per lungo tempo gli ordinamenti penali si
sono tendenzialmente limitati a sanzionare la violazione di divieti di compiere azioni criminose
volontarie. Ma in seguito all’evoluzione del progresso tecnologico si è avuto un progressivo aumento di
fattispecie penali incentrate sull’inosservanza di obblighi positivi di condotta con contenuto di
prestazione di un contributo diretto a garantire una più ampia salvaguardia di beni esistenti o
l’espansione di beni suscettivi di incremento, e si ha dunque l’aumento di reati colposi e omissivi.
La dottrina ha dunque approfondito lo studio delle fattispecie colpose e omissive, fino a prospettare
una nuova sistematica del reato intesa a meglio valorizzarne in piena autonomia le relative peculiarità
strutturali. Questo processo ha avuto l’effetto di un’inversione di tendenza rispetto all’orientamento
tradizionalmente dominante in sede di teoria generale del reato, passando dalla costruzione unitaria
dell’illecito penale alla costruzione separata delle rispettive tipologie delittuose del delitto doloso, del
delitto colposo, del delitto commissivo e di quello omissivo.
Le tipologie di reato possono suddividersi in varie categorie sulla base della struttura. Vi sono anche
altre suddivisioni, connesse all’applicazione di una particolare disciplina, mentre altre ancora
riguardano tipologie delittuose che presentano problemi dogmatici e politico-criminali.
REATI DI EVENTO
Nei reati di evento la fattispecie incriminatrice tipizza un evento esteriore come risultato
concettualmente e fenomenicamente separabile dall’azione e a questa legato in base ad un nesso di
40
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
causalità. I reati di evento si possono ulteriormente distinguere in:
1. Reati di evento a forma vincolata: se le modalità di produzione del risultato lesivo siano dal
legislatore state specificate
2. Reati di evento a forma libera (o reati causali puri): se non siano state specificate, e in
questo modo il legislatore assicura una tutela più ampia al bene protetto, in quanto viene
punita ogni forma di lesione di quest’ultimo.
La distinzione tra reati di evento a forma vincolata e a forma libera assume rilevanza nell’ambito
del procedimento di conversione di un’ipotesi commissiva di reato in caso di mancato
impedimento dell’evento ex art. 40 cpv., infatti sono suscettibili di conversione soltanto le
fattispecie causali pure.
REATI DI AZIONE
I reati, in base alle due forme tipiche della condotta umana, si distinguono in reati commissivi o di
azione e reati omissivi o di omissione, a seconda che la condotta tipica sia rappresentata da un agire
positivo o da un’omissione.
I reati di azione consistono nel semplice compimento dell’azione vietata senza che sia necessario
attendere il verificarsi di un evento causalmente connesso alla condotta medesima.
REATI OMISSIVI
I reati omissivi si suddividono a loro volta in:
1. Reati omissivi impropri: quando l’evento lesivo dipende dalla mancata realizzazione di
un’azione doverosa (es. omicidio colposo per mancata sorveglianza di un bambino). Ex art. 40
cpv., infatti, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo.
2. Reati omissivi propri: consistono nel mancato compimento di un’azione imposta da una
norma penale di comando, a prescindere dalla verificazione di un evento come conseguenza
della condotta omissiva (es. omissione di soccorso o omessa denuncia di reato).
REATI ISTANTANEI E PERMANENTI
Nei reati istantanei la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l’offesa, poiché è impossibile
che la lesione del bene persista nel tempo.
Vi sono invece beni che l’azione delittuosa riesce soltanto a comprimere, come ad esempio la libertà
personale nel caso di sequestro di personale. In questi casi l’agente ha il potere non solo di instaurare
la situazione antigiuridica, ma anche di rimuoverla, in modo da riespandere il bene compresso, ed i
reati permanenti sono dunque quelli in cui il protrarsi dell’offesa dipende dalla volontà dell’autore.
Rientrano in questa categoria sia i reati che offendono beni immateriali, sia quelli che ledono beni
materiali, purchè suscettibili di compressione. Nei reati permanenti ciò che acquista rilevanza
giuridica è dunque non soltanto l’attività del soggetto che realizza la lesione del bene, ma anche quella
successiva di mantenimento.
La dottrina oggi tende a respingere la concezione bifasica del reato permanente, che sostiene che la
fase dell’instaurazione si realizzi con un’azione e quella del mantenimento con un’omissione, infatti
entrambe le fasi potrebbero realizzarsi con un’azione dell’altro tipo. Il reato permanente cessa quando
si pone fine alla condotta volontaria di mantenimento dello stato antigiuridico, o quando è oramai
divenuto impossibile porvi fine, ad esempio perché l’agente viene arrestato.
È dibattuta, all’interno di dottrina e giurisprudenza, la natura istantanea o permanente dei reati
omissivi propri. Nella prassi applicativa è diffuso il criterio che vede il reato omissivo come
permanente tutte le volte in cui per l’adempimento dell’azione doverosa sia previsto un termine
puramente ordinatorio, nel cui caso la permanenza si avrebbe fino a che il soggetto non adempia
all’obbligo di agire, mentre si avrebbe reato istantaneo quando ai fini dell’adempimento sia previsto un
termine di scadenza perentorio decorso il quale l’obbligato non sia più in grado di far cessare lo stato
di antigiuridicità determinato dalla condotta illecita.
Tuttavia, si può facilmente obiettare che il termine di adempimento, che assume rilevanza penale,
non può che essere quello perentorio, poiché in caso di termine ordinatorio viene concessa al soggetto
la facoltà di decidere il momento dell’adempimento, ed entro questo spazio di tempo non si può
41
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
parlare di obbligo penalmente sanzionato.
È invece più diffusa in dottrina la tesi che sostiene che i reati omissivi possano eccezionalmente
assumere natura permanente se il potere di agire imposto dalla norma persista nel tempo anche dopo
il primo manifestarsi della situazione da cui esso si origina (ad esempio l’obbligo di soccorso sarebbe
istantaneo, mentre sarebbe perdurante l’obbligo per il proprietario di riparare un edificio pericolante,
e dunque il reato derivante dalla sua inosservanza sarebbe permanente). Tuttavia, anche questo
criterio non è esente da critiche.
Sono invece prive di reale autonomia i reati eventualmente permanenti (nei quali l’offesa viene fatta
durare nel tempo dall’agente, come nel caso di un’ingiuria realizzata con numerose offese o ne caso di
usurpazione di funzioni pubbliche), e dei reati istantanei con effetti permanenti (nei quali le
conseguenze durano nel tempo, come nel caso dell’omicidio). Queste categorie non costituiscono reati
a sé stanti poiché si limitano a registrare un mero dato fenomenico.
Questa distinzione è importante sotto diversi profili:
1. al momento della cessazione della permanenza la legge fa riferimento ai fini della decorrenza
del termine della prescrizione, dell’applicabilità dell’amnistia, del termine per proporre
querela o della flagranza di reato
2. per la competenza territoriale viene invece indicato il luogo in cui ha avuto inizio la
consumazione.
REATI ABITUALI
I reati abituali sono invece gli illeciti penali per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel
tempo di più condotte dello stesso tipo intervallate nel tempo (e non perduranti, come nel reato
permanente), ed un esempio ne è il reato di maltrattamenti in famiglia, o il delitto di sfruttamento
della prostituzione. Il reato abituale si distinguono in
Reati abituali propri: in cui le singole condotte autonomamente considerate sono penalmente
irrilevanti, come nello sfruttamento della prostituzione
Reati abituali impropri: in cui ciascun atto è di per sé una figura di reato, come nella
relazione incestuosa.
I reati abituali possono sollevare obiezioni in quanto alcune fattispecie finiscono in qualche modo con
il risentire di categorie penalistiche tendenzialmente illiberali come la “responsabilità per la condotta
di vita” o la “colpa d’autore”, punendo così non le singole condotte, ma il complessivo stile di vita
dell’autore del fatto. Importante è comunque notare che le condotte non devono discendere dal
medesimo dolo unitario, ma è sufficiente una coscienza e volontà di volta in volta rapportata alle
singole condotte.
I reati abituali hanno delle particolarità anche in ambito processuale penale:
A. la prescrizione comincia a decorrere dall’ultima condotta integrante il reato
B. il termine per proporre querela inizia a decorrere dalla realizzazione di condotte già sufficienti
ad assumere rilievo penale
C. è possibile scindere in più parti il reato abituale per l’amnistia e l’indulto, purché le singole
parti possano integrare i presupposti minimi della punibilità
REATI COMUNI E PROPRI
Si distinguono:
1. Reati comuni: che possono essere commessi da chiunque
2. Reati propri: che possono essere commessi soltanto da soggetti qualificati, ossia da soggetti
che rivestono una particolare posizione, idonea a porre il soggetto in una speciale relazione
con l’interesse tutelato, come ad esempio la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio per i reati contro la p.a.
I reati propri sono poi ulteriormente differenziabili in:
A. Reati propri in senso puro: in cui il possesso della qualifica determina la punibilità del
fatto (come per l’omissione di atti d’ufficio)
B. Reati propri in senso lato: in cui il possesso della qualifica comporta un mutamento del
42
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
titolo del reato (come per l’appropriazione indebita, che, se commessa da pubblico ufficiale
a danni della p.a., diventa peculato)
La distinzione tra reati propri e comuni assume rilevanza in particolare per la determinazione del
dolo, poiché è controverso se la volontà criminosa presupponga la conoscenza della qualifica, e in sede
di concorso di persone, poiché si discute se un soggetto estraneo possa concorrere nel reato proprio
REATI DI DANNO
Gli illeciti si distinguono poi in reati di danno, se la condotta criminosa comporta l’effettiva lesone del
bene giuridico protetto, e reati di pericolo, se la condotta mette soltanto in pericolo o prospetta una
lesione potenziale del bene giuridico. La differenza tra queste due tipologie è quella che intercorre tra
il delitto di omicidio e il delitto di incendio, poiché il secondo illecito è punito non per i fatti che
derivano dalla condotta, ma per quelli che possono derivare da essa a carico di una determinata
cerchia di persone, anche nel caso in cui nessuno subisca un effettivo danno alla vita o all’integrità
fisica.
REATI DI PERICOLO
I reati di pericolo, una vita meno presenti, stanno oggi subendo una forte espansione per effetto
dell’evoluzione tecnologica, la quale ha ampliato il numero delle attività pericolose, che necessitano di
norme cautelari penalmente sanzionate per impedire la trasformazione del rischio in danno.
L’espansione è inoltre dovuta alla progressiva assunzione da parte dello Stato di compiti solidaristici,
la quale ha indotto il legislatore penale ad anticipare al livello della messa in pericolo la tutela di beni
particolarmente importanti per la collettività. Questa espansione ha però sollevato problemi sul piano
dogmatico, politico-criminale, e costituzionale.
I reati di pericolo si distinguono ulteriormente in:
1. Reati di pericolo concreto (o effettivo): in cui il pericolo è un elemento costitutivo della
fattispecie incriminatrice, e spetta dunque al giudice accertarne l’esistenza nel caso concreto
2. Reati di pericolo presunto (o astratto): in cui si presume che al compimento di determinate
azioni si accompagni l’insorgere di un pericolo, e dunque una volta accertata la condotta il
giudice è dispensato dall’accertare la messa in pericolo del bene, perché essa si presume (come
nel caso dell’incendio di cosa altrui)
Negli ultimi anni si è però cercato di mettere in evidenza il carattere di relatività della
contrapposizione tra pericolo astratto e pericolo concreto, rilevando come decisivo non sia solo il
coinvolgimento o meno del giudice per l’accertamento, infatti il grado di concretezza o astrattezza del
pericolo dipende anche dalla sua collocazione nella struttura del delitto e dai criteri di accertamento
adottati per verificarne l’esistenza, nonché dal momento del giudizio. Dunque il pericolo concreto può
essere in realtà considerato più o meno concreto a seconda che il giudice debba verificare che uno o
più soggetti passivi determinati abbiano subito una reale minaccia, o che l’azione realizzata sia
generalmente idonea a ledere, a prescindere dalla circostanza che qualcuno dei soggetti titolari del
bene protetto sia stata di fatto leso.
Di conseguenza, anche se il legislatore prevede dei requisiti che il giudice deve accertare, non
necessariamente la tipologia di illecito va ricondotta alla categoria dei reati di pericolo concreto, in
quanto esso potrebbe avvicinarsi di più ad un reato di pericolo presunto.
Per quanto riguarda i reati a pericolo astratto, essi presentano un problema soprattutto relativamente
all’illecito di pericolo presunto strettamente inteso, in quanto se questo modello di illecito si
caratterizza per il fatto di tipizzare una condotta assunta come pericolosa in base ad una regola di
esperienza, non è escluso che si verifichino casi in cui quel giudizio fondato sull’esperienza si rivela
falso. I reati di pericolo presunto rischiano così di reprimere la mera disobbedienza ad un precetto
penale, senza che vi sia anche una reale messa in pericolo del bene protetto, e dunque parte della
dottrina mette in dubbio la legittimità costituzionale di questi reati (poiché non verrebbe rispettato il
principio di necessaria lesività).
Bisogna però tenere sempre a mente che vi sono ormai settori (come i nuovi processi tecnologici
complessi legati alla produzione di massa) nei quali è irrinunciabile il ricorso al modello del reato di
43
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
pericolo astratto, con i vantaggi di porre un argine all diffusivi del pericolo insito nelle condotte, ed
evitare la probatio diabolica dell’attitudine del fatto, dal momento che spesso è scientificamente ignoto
lo specifico meccanismo che conduce alla verificazione dell’evento dannoso. Inoltre vi sono beni
collettivi o super-individuali (es. ambiente, economia pubblica, ecc.) per il cui danneggiamento sono
necessarie condotte cumulative, e questo rende impossibile provare che una singola condotta tipica sia
in idonea in concreto a danneggiarli.
A tutto ciò si collega il problema della possibile rilevanza penale del principio di precauzione, il quale
è un principio invocabile nei settori in cui non si possa scientificamente verificare la dannosità o
pericolosità di alcuni fenomeni, ed è un principio riconosciuto a livello normativo all’art. 174 del
Trattato istitutivo della Comunità europea relativo alle politiche ambientali, nel quale si dispone che il
principio venga utilizzato “quando un’oggettiva e preliminare valutazione scientifica stabilisca che è
ragionevole temere che gli effetti potenzialmente pericolosi per l’ambiente o la salute degli uomini,
animali o vegetali siano incompatibili con l’alto livello di protezione scelto dalla Comunità”. Questo
principio non può però essere considerato criterio sostanziale capace di imporre automaticamente il
ricorso a forme di tutela penale, ma ha piuttosto una funzione orientativa sul piano politico-criminale,
in grado di contribuire alla possibile legittimazione di forme anticipate di tutela. Va comunque
sottolineato che i rischi o pericoli non devono essere frutto di un mero sospetto o congettura, e deve in
ogni caso esserci un’adeguata proporzione tra il rango dei beni da proteggere e i costi conseguenti
all’anticipazione della tutela al livello del pericolo astratto.
L’esigenza di attribuire al reato un contenuto concretamente pericoloso diventa invece meno eludibile
quanto più l’incriminazione interferisca con l’esercizio di libertà politiche. Esempi si trovano nei reati
di opinione, quelli a carattere ideologico, ma anche l’associazione o l’istigazione a delinquere, tutti
reati per i quali l’adozione in chiave interpretativa della categoria del pericolo presunto crea il rischio
che la repressione penale si risolva in una inammissibile limitazione delle libertà ideologico-politiche
costituzionalmente garantite.
ULTERIORI FIGURE
La dottrina penalistica ha creato ulteriori distinzioni con differenti rilevanze pratiche. Vi è ad esempio
la figura dei reati aggravati dall’evento, per cui è previsto un aumento di pena se dalla realizzazione
del delitto-base deriva un evento (non voluto) ulteriore, come nel caso di omissione di soccorso
aggravata dalla morte della persona.
Vi sono inoltre i delitti di attentato, i quali sono illeciti consistenti nel compiere atti o usare mezzi
diretti ad offendere un bene giuridico, e la legge in questi casi considera consumato il delitto anche in
assenza di atti tipici rispetto ad una fattispecie di delitto tentato, come nel caso di attentato contro
l’integrità dello Stato.
44
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE SECONDA
REATO COMMISSIVO DOLOSO
CAPITOLO UNO
TIPICITÀ
ELEMENTI COSTITUTIVI
La fattispecie di reato è il complesso degli elementi che contraddistinguono ogni singolo illecito
penale, e dunque gli elementi costitutivi della fattispecie variano in funzione delle diverse tipologie di
reato. La fattispecie ha una funzione di garanzia, poiché ciò che non rientra nella fattispecie non può
costituire materia di divieto e non può quindi integrare un illecito penale.
La fattispecie comprende tutti gli elementi che condizionano la punibilità, e comprende dunque anche
il criterio di imputazione soggettiva, ossia dolo e colpa, e tutti gli altri requisiti in grado di influire sulle
conseguenze giuridico-penali. La fattispecie può essere intesa anche in senso più ristretto, facendola
coincidere con il concetto di fatto tipico, come categoria distinta dall’antigiuridicità e dalla
colpevolezza.
Secondo una concezione classica (di Beling, dei primi anni del ’900) la fattispecie intesa come
fattispecie obiettiva designerebbe soltanto gli elementi descrittivi (cosa, uomo, animale, ecc.) e
obiettivi del reato, i quali sono elementi definiti oggettivi perché coincidono con i requisiti relativi alla
realizzazione materiale del fatto di reato, e sono così distinti dall’elemento soggettivo. Questi elementi
sono la condotta e gli eventuali presupposti e note che la caratterizzano, nonché il rapporto causale e
l’evento lesivo.
La concezione oggi dominante ritiene che il concetto di fatto tipico vada inteso in una accezione più
ampia, e sono soltanto perché il fatto oltre che elementi descrittivi può comprendere anche elementi a
carattere normativo, ma anche perché il fatto in senso oggettivo o materiale non esaurisce
completamente la tipicità, per la quale bisogna tenere conto anche di componenti soggettive, che
assolvono funzioni integratrici della tipicità in senso rigidamente materiale. Tutto questo è
particolarmente evidente in quei reati soggettivamente pregnanti come il vilipendio, l’ingiuria e la
diffamazione, per i quali l’offesa tipica non si può separare dal contenuto della volontà colpevole.
Il contributo dell’elemento soggettivo alla ricostruzione del fatto tipico si ritrova anche più in
generale, infatti esso risalta in particolare modo nell’ambito dell’orientamento che prospetta una
costruzione separata delle diverse tipologie di reato. Le differenze tra reati colposi e dolosi iniziano
infatti ad emergere già a livello del fatto tipico, e dunque dolo e colpa finiscono con assumere rilevanza
sia nella sfera della tipicità, sia in quella della colpevolezza.
La categoria del fatto tipico può dunque ricomprendere sia elementi obiettivi di natura descrittiva o
normativa, sia elementi soggettivi, anche se non vi sono sempre rigide delimitazioni tra queste
tipologie di elementi.
CONCETTO DI AZIONE
L’azione umana è la base su cui poggia la costruzione dogmatica del reato commissivo doloso, ma non
bisogna comunque sopravvalutarne il ruolo, anche se, fino a quaranta anni fa circa, dominava la teoria
che considerava che il problema definitori dell’azione penalmente rilevante fosse il tema centrale della
teoria del reato. La dottrina del tempo sosteneva infatti che l’azione avesse due compiti, ossia quello di
fornire una nozione superiore unitaria capace di adattarsi tanto all’azione dolosa e all’azione colposa,
quanto all’azione e all’omissione, e quello di orientare la collocazione dogmatica degli elementi
costitutivi del reato.
La dottrina aveva dunque prospettato:
Teoria causale: la dottrina, sotto l’impulso del positivismo naturalistico, ha elaborato la teoria
45
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
causale, secondo la quale l’azione è una modificazione del mondo esterno cagionata dalla
volontà umana, e in questa concezione il dolo non rappresenta anche un elemento costitutivo
dell’azione, ma solo una forma di colpevolezza. A questo teoria si obietta il fatto che questa
definizione di azione non si adatta all’omissione come forma di condotta priva di substrato
naturalistico, e il fatto che il dolo non ha un ruolo solo nella colpevolezza, ma è
necessariamente anche componente dell’azione, in quanto talvolta soltanto la direzione della
volontà colpevole decide della stessa tipicità di un certo comportamento.
Teoria finalistica: Hans Welzel ha invece elaborato la teoria finalistica, secondo la quale
l’azione umana consiste nell’esercizio di una attività orientata verso uno scopo. La teoria
finalistica considera dunque il dolo come elemento costitutivo dell’azione e dunque del fatto
tipico, negando che esso sia una forma di colpevolezza. Tuttavia, le obiezioni si basano sul fatto
che non è sempre vero che le azioni volontarie sono esercizio di attività rigorosamente
programmate secondo lo schema della predeterminazione del rapporto mezzo-scopo (vi sono
ad esempio azioni impulsive o automatiche), e inoltre sul fatto che nei reati colposi e omissivi
alla finalità reale si sostituisce una finalità soltanto potenziale, nel senso che il rimprovero
penale deriva dal mancato esercizio di azioni dirette agli obiettivi di tutela.
Teoria sociale: Secondo la teoria sociale il comportamento penalmente rilevante consiste in
“ogni risposta dell’uomo ad una pretesa nascente da una situazione riconosciuta o almeno
riconoscibile attuata grazie alla messa in atto di una possibilità di reazione liberamente scelta
tra quelle disponibili”. Questa teoria, a differenza delle altre due, non desume dalle sue
premesse di fondo dirette implicazioni dogmatiche, e si adatta a tutte le forme delittuose.
Questa concezione, proprio perché di contenuto generico, finisce però con il rivelarsi priva di
contenuto informativo rispetto alle caratteristiche che il comportamento assume in ciascuna
delle principali categorie criminose. Dunque l’unità raggiunta dal concetto sociale di azione è
solo terminologica, e la sua sola funzione sembra quella di escludere dalla sfera del penalmente
rilevante le azioni compiute in condizione di piena inconsapevolezza.
Tutte queste teorie non hanno dunque raggiunto il loro obiettivo, poiché hanno trascurato una verità
incontestabile, ossia che “i dadi della dogmatica penalistica non si giocano nella dottrina dell’azione,
ma al più presto nella dottrina della tipicità e dell’antigiuridicità”. Dunque la premessa della
costruzione del reato non può essere fornita da una aprioristica o sedicente ontologica concezione
dell’azione, e dunque i criteri che presiedono alla determinazione del concetto di azione si uniformano
ai principi dell’imputazione penale, e non viceversa.
Di conseguenza, il punto di partenza è sempre la verificazione di un accadimento che lede o mette in
pericolo un bene giuridico, e solo in un secondo momento si stabilisce se e come esso sia riconducibile
al comportamento di qualcuno, e quali siano i criteri per la responsabilità è l’ordinamento penale a
stabilirlo.
La condotta criminosa del reato commissivo assume la forma di un’azione in senso stretto, ossia, in
termini semplicistici, un movimento corporeo dell’uomo, cosciente e volontario (art. 42.1 c.p.).
Tuttavia, solo nel reato comissivo doloso l’azione è sempre caratterizzata dalla partecipazione effettiva
della coscienza e della volontà, e anzi in questi casi azione dolosa e azione cosciente e volontaria
finiscono per coincidere, in quanto la coscienza e la volontà sono richieste per la configurazione del
dolo.
Il legislatore ha tipizzato delle situazioni in cui non può mai raggiungersi un giudizio di colpevolezza,
perché manca in partenza la precondizione per l’addebito di dolo o colpa, ossia la condizione
rappresentata dalla possibilità di considerare l’azione criminosa come opera propria di un
determinato soggetto. Queste situazioni sono la forza maggiore, il costringimento fisico e il caso
fortuito.
Forza maggiore: l’art. 45 c.p. dispone che non è punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore, la quale viene tradizionalmente definita come qualsiasi energia esterna contro la
quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe necessariamente ad agire.
Se vi è un sufficiente margine di scelta per l’agente, allora non vi è forza maggiore, poiché la
46
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
coazione ad agire è soltanto relativa.
Costringimento fisico: l’art. 46 c.p. stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato da altri costretto con violenza fisica alla quale non poteva resistere o sottrarsi (e
del fatto dispone l’autore della violenza). Il costringimento fisico non è dunque altro che una
specificazione della forza maggiore, in quanto è una forza irresistibile esercitata non dalla
natura, ma dall’uomo, e in questo caso se vi è sufficiente margine di scelta si ricade nella
coazione morale ex art. 54.
Caso fortuito: l’art. 45 c.p. stabilisce anche un altro caso di esenzione da responsabilità,
stabilendo che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito. Tuttavia, a differenza
della forza maggiore, il caso fortuito non sempre esclude l’esistenza dell’azione, infatti esso
risulta dall’incrocio di un accadimento naturale e di una condotta umana dal quale risulta
l’imprevedibile verificarsi di un evento lesivo (come nel caso di chi viene ferito da un terzo e
muore dopo il ricovero per un incendio scoppiato fortuitamente in ospedale), ma esso
impedisce comunque all’agente di essere chiamato a rispondere dell’evento cagionato con il
concorso di fattori che esulano dal normale ordine delle cose.
Il caso fortuito è polivalente, nel senso che in alcuni casi esso può essere valutato nell’ambito
dell’elemento soggettivo perché si presta ad esemplificare una di quelle circostanze che
rendono impossibile l’osservanza del dovere di diligenza richiesto nella situazione concreta
(ad esempio nel caso del malore che impedisce di rispettare le regole del traffico), e in altri casi
invece il caso fortuito può assumere rilevanza come fattore di esclusione del nesso causale tra
condotta ed evento (come nel caso del ferito che muore per un incendio fortuito dell’ospedale).
La categoria dei presupposti dell’azione o del fatto è stata talvolta utilizzata in un’accezione tanto
ampia da risultare fuorviante, coincidente con l’insieme dei presupposti del reato (sono così
presupposti la norma penale, il bene giuridico, il soggetto attivo e quello passivo, ecc.). Questa
concezione dei presupposti del reato è evidentemente inutile ed errata, e questo perché è ovvio che la
configurabilità di qualsiasi reato presuppone sempre l’esistenza dei requisiti giuridici necessari per la
qualificazione del fatto in termini di illecito penale. Il concetto di presupposti dell’azione o del fatto è
invece utile in una prospettiva di scomposizione analitica dell’illecito, se circoscritto alle circostanze
che devono in certi casi preesistere o essere concomitanti alla condotta perché questa assuma un
significato criminoso (anche se queste circostanze, pur essendo estranee alla condotta illecita in sé,
fanno comunque parte del fatto tipico come suoi elementi costitutivi; un esempio è il precedente
matrimonio per il delitto di bigamia).
Questi presupposti possono riferirsi al soggetto attivo specificandone un ruolo o una qualità, oppure
all’oggetto materiale della condotta, o al contesto che deve preesistere alla condotta, o infine al
soggetto passivo. L’utilità pratica dei presupposti dell’azione emerge in particolare per il dolo, poiché,
essendo essi elementi che precedono l’azione criminosa, il reo può soltanto conoscerli, ma non volerli.
L’oggetto materiale dell’azione è la persona o la cosa sulla quale ricade l’attività fisica del reo,
differentemente dall’oggetto giuridico, il quale è il bene penalmente protetto, e dal soggetto passivo
(anche se vi sono casi, come l’omicidio, le lesioni personali, ecc., nei quali questi due soggetti possono
coincidere). L’oggetto materiale della condotta può inoltre essere uno solo o molteplici, e per questo
secondo caso si può fare l’esempio del delitto di rapina, in cui l’azione tipica ricade sia su una persona
sua su una cosa.
La separazione concettuale tra oggetto dell’azione e oggetto della tutela penale (il quale è il bene
giuridico) si accentua quanto più il bene giuridico è “idealizzato” o “spiritualizzato”, come nel caso dei
delitti di falso, in cui l’oggetto di tutela è di natura ideale, ed è infatti la fede pubblica. Oggetto
dell’azione e oggetto della tutela tendono invece ad immedesimarsi quando il bene protetto è più
concreto e può essere dunque concretamente danneggiato, come nel caso del corpo umano
nell’omicidio.
L’oggetto materiale è rilevante per la determinazione e specificazione del fatto tipico, infatti molte
47
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
fattispecie si individuano in funzione delle caratteristiche dell’oggetto materiale (ad esempio il furto è
solo per le cose mobili, e l’invasione per le cose immobili, ecc.). Dunque le caratteristiche dell’oggetto
materiale assumono ulteriore rilevanza come elementi che possono riflettersi nell’aspetto conoscitivo
del dolo.
EVENTO
Nei reati di evento figura un evento concepito come risultato esteriore causalmente riconducibile
all’azione umana. In questo senso l’evento non è dunque un qualsiasi accadimento della realtà esterna,
ma è inteso in senso più ristretto, detto evento in senso naturalistico.
L’evento naturalistico può anche consistere in un risultato esteriore che concretizza non l’effettiva
lesione, ma la messa in pericolo di un bene protetto, ma questo è possibile solo per le figure di reato
che la dottrina tradizionale definisce "a pericolo concreto”, ossia quelle in cui spetta al giudice
verificare se vi sia un effettivo pericolo come conseguenza dell’azione.
Questa categoria è importante soprattutto per il rapporto di causalità, infatti l’evento naturalistico
costituisce il secondo polo del nesso causale, e dunque un requisito del fatto tipico nell’ambito dei reati
che lo contemplano nella loro struttura. Nella struttura dell’illecito penale la presenza di un evento
naturalistico può anche assolvere ad altre funzioni, come essere una circostanza aggravante di un
reato già perfetto o essere condizione obiettiva di punibilità (come il pubblico scandalo nell’incesto).
L’elaborazione della categoria dell’evento ha suscitato un lungo dibattito all’interno della dottrina
italiana, finendo con il coinvolgere problematiche di fondo del diritto penale. La disputa trae spunto
dalla lettura degli artt. 40, 41, 43 e 49 c.p., che riconnettono ad ogni reato un evento dannoso o
pericoloso come risultato dell’azione criminosa, basandosi sull’idea mutuata dalla dottrina tedesca per
la quale ogni reato consiste nella lesione o messa in pericolo di un bene giuridico. Il legislatore ha però
espresso questa idea sostenendo che la lesione del bene protetto è un risultato che sempre si aggiunge
all’azione delittuosa, e viene di qui l’identificazione del concetto di offesa con quello di evento. L’evento
viene però ritenuto comunque a tutti i reati, e non solo a quelli che hanno un evento naturalistico, e
dunque l’evento assume qui un significato diverso detto evento in senso giuridico, il quale consistete
nell’offesa all’interesse protetto dalla norma penale.
Bisogna allora preoccuparsi di distinguere gli aspetti dogmaticamente deteriori e fuorvianti della
tradizionale disputa sul concetto di evento da quelli che sottendono problematiche che superano i
limiti di una semplice scomposizione strutturale dell’illecito penale.
Nell’ambito dei reati di mera condotta, privi di evento naturalistico, non è necessario ipotizzare un
evento giuridico come risultato che consegue o si aggiunge alla condotta, poiché l’offesa all’interesse
protetto non è un’entità materiale che si somma all’azione, ma la stessa azione considerata come
confliggente con la norma posta a tutela del bene. Se si ragionasse come i sostenitori dell’evento
giuridico, nonostante l’avvenuta realizzazione della condotta tipica, il giudice dovrebbe comunque
verificare l’impatto effettivo della condotta sul bene, ma in questo modo vi sarebbe un accertamento
che si sovrappone al giudizio di lesività espresso dal legislatore, infatti un’azione tipica è tale se lede il
bene oggetto di protezione penale. tuttavia questo è incontestabile solo a livello astratto, senza trovare
sempre un’esatta conferma nella realtà, infatti l’ordinamento penale vigente contiene anche reati
strutturati in modo difettoso, e di conseguenza viene messo in crisi l’asserto della necessaria
compenetrazione tra tipicità e offesa al bene.
Tuttavia, nel tentativo di una parte della dottrina di valorizzare il concetto di evento giuridico per
porre rimedio all’insufficiente tipizzazione legislativa di alcuni illeciti, si annida anche il rischio di
sovrapporre opzioni interpretative arbitraria del giudice alle scelte legislative, e dunque il problema di
una maggiore compenetrazione tra tipicità e offesa al bene può in questo caso risolversi solo in sede di
redazione legislativa del reato (ed è perciò auspicabile una riforma del sistema penale in questo
senso).
Dunque, dal punto di vista tecnico bisogna mantenere la sola nozione di evento naturalistico, ossia
conseguenza dell’azione consistente in una modificazione fisica della realtà esterna. Va sottolineato
48
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
che non importa né che l’evento si verifichi contestualmente all’azione (si può essere accusati di
omicidio anche se la persona non muore subito) né che l’evento si verifichi in luogo diverso da quello
in cui viene realizzata l’azione (cd. reati a distanza).
RAPPORTO DI CAUSALITÀ
La fattispecie obiettiva di reato commissivo di evento tra gli elementi costitutivi comprende anche il
nesso di causalità che lega l’azione all’evento. La causalità, che nell’ambito giuridico è indispensabile
per l’attribuzione della responsabilità, ha in realtà implicazioni anche in altri ambiti, quali la filosofia e
la scienza. La causalità nel nostro ambito è dunque criterio di imputazione (oggettiva) del fatto al
soggetto, e infatti il nesso causale tra condotta ed evento comprova di regola che non soltanto l’azione,
ma anche il risultato lesivo è opera dell’agente, ed egli può dunque, stanti gli altri presupposti
psicologici, risponderne penalmente.
Il compito dell’interprete in questa sede sembra apparentemente agevolato dal codice Rocco, che
contiene una disciplina esplicita del nesso causale agli artt. 40 e 41. Tuttavia, il richiamo a questi due
articoli non ha impedito agli interpreti di assumere la disciplina codicistica come elemento di
conferma di soluzioni ricavate in via “aprioristica”, e la ragione di questo è il fatto che i due articoli si
prestano a letture diverse, poiché non indicano un modello ben definito e univoco di causalità.
La dottrina ha cercato (spesso con vani risultati) di ricostruire in modo storico-dogmatico le più
diffuse teorie causali elaborate nel corso del tempo, cercando di capire quale fosse quella recepita dal
legislatore.
TRADIZIONALE TEORIA CONDIZIONALISTICA
L’esigenza di un legame causale tra azione ed evento è esplicitamente riconosciuta dal primo comma
dell’art. 40 c.p., che richiede che l’evento dannoso o pericoloso, dal quale dipende l’esistenza del
reato, sia conseguenza dell’azione del reo. Il codice non dice, però, a quali condizioni l’evento lesivo
possa essere considerato conseguenza dell’azione, ma è verosimile che i suoi compilatori abbiano
voluto richiamare la teoria condizionalistica nella formulazione dominante nella dottrina di quel
periodo. Secondo la teoria condizionalistica è causa ogni condizione dell’evento, ogni antecedente
senza il quale l’evento non si sarebbe verificato. Per accertare questo nesso condizionalistico la
dottrina solitamente ricorre al procedimento di eliminazione mentale, in base al quale un’azione è
condicio sine qua non di un evento se non può essere mentalmente eliminata senza che l’evento stesso
venga meno.
Anche se in alcuni casi l’applicazione di questo procedimento porta a risultati inconfutabili, vi sono
altri casi nei quali l’adozione della formula della condicio sine qua non non riesce a dare indicazioni
probanti in merito all’esistenza del nesso eziologico. Si può infatti dire che la formula della condicio ha
un’efficacia euristica limitata, e la sua universalità può essere contestata dove non si conoscano in
anticipo le leggi causali che presiedono ai rapporti tra determinati fenomeni, e in questi casi finisce con
l’equivalere ad una formula vuota.
Inoltre, poiché considera equivalenti tutte le condizioni che concorrono alla produzione dell’evento
lesivo, la teoria in esame condurrebbe a considerare causali anche i remoti antecedenti dell’evento
delittuoso, e dunque si potrebbe paradossalmente attribuire la responsabilità di un omicidio anche ai
genitori dell’omicida poiché hanno messo al mondo quest’ultimo (poiché è comunque vero l’assunto
“se i genitori non avessero creato l’omicida, la vittima non sarebbe stata uccisa da lui”).
Tuttavia, tale obiezione si ridimensiona quando si osserva che sul terreno dell’imputazione penalistica
si selezionano come antecedenti causali solo le condotte che assumono rilevanza rispetto alla
fattispecie incriminatrice di volta in volta considerata (non succederà mai infatti che un giudice
condanni i genitori per il solo fatto di avere messo al mondo un omicida).
Inoltre, la teoria condizionalistica sembra presentare ulteriori inconvenienti nelle ipotesi di causalità
49
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
alternativa ipotetica e di causalità addizionale.
Causalità alternativa ipotetica: si può supporre che in mancanza dell’azione del reo l’evento
sarebbe stato egualmente prodotto da un’altra causa intervenuta circa nello stesso momento,
ossia una causalità, appunto, alternativa ipotetica. Se ad esempio una persona facesse
esplodere una casa, ma nel frattempo scoppiasse un incendio in quell’area, si potrebbe dire che
l’effetto (la casa andata a fuoco) si sarebbe avuto comunque, ma non si può certo concludere
che l’agente non vada per questo essere punito.
Tale obiezione è superabile dal momento che l’evento come secondo polo del nesso di
condizionamento va concepito non come genere di evento, ma come evento in concreto, e
dunque ciò che importa è che una catena causale sussista tra l’azione dell’autore e questo
evento concreto, mentre è irrilevante il fatto che potrebbero verificarsi eventi analoghi dovuti
ad altre cause (dunque nel caso succitato non importa che la casa avrebbe potuto essere
distrutta anche dall’incendio, ma importa che la casa è stata distrutta a causa dell’esplosione).
Causalità addizionale: se l’evento viene prodotto dal concorso di più condizioni, ciascuna
capace di produrre un suo risultato, anche in questo caso il ricorso al procedimento di
eliminazione mentale potrebbe portare a risultati aberranti. Se ad esempio due persone
avvelenassero mortalmente la stessa persona, si potrebbe dire che anche senza il
comportamento di uno dei due si sarebbe avuto comunque l’effetto, ma non per questo non
bisogna punire uno degli agenti o addirittura entrambi.
Critica superabile considerando che hanno efficacia causale quelle condizioni dell’evento che,
cumulandosi, ne costituiscono un presupposto necessario e che lo sarebbero se l’altra
condizione mancasse. Soltanto un uso acritico della formula della condicio sine qua non
potrebbe condurre ad un evento senza causa e un fatto senza autore, poiché, in realtà, in
questo caso entrambi gli agenti vanno ritenuti responsabili.
Causa sopravvenuta da sola sufficiente: un’ultima obiezione è quella relativa al
sopraggiungere di una causa successiva idonea da sola a determinare l’evento, infatti in queste
ipotesi l’evento - anche supponendo non realizzata la seconda azione - permarrebbe come
conseguenza della prima azione, con la paradossale conseguenza di considerare priva di
efficacia eziologica proprio l’azione direttamente produttiva dell’evento.
LA TEORIA CONDIZIONALISTICA ORIENTATA SECONDO IL MODELLO DELLA “SUSSUNZIONE
SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE”
Il limite della teoria condizionalistica è l’incapacità della formula della condicio sine qua non di
spiegare da sola perché in assenza dell’azione l’evento non si sarebbe verificato, e questo significa che
il metodo dev’eliminazione mentale non funziona se non si sa in anticipo se esistono rapporti di
derivazione tra determinati antecedenti e determinati conseguenti (come nel caso del talidomide,
preparato assunto da donne che hanno partorito in seguito figli con malformazioni, fenomeno del
quale non si conosce, tuttavia, il meccanismo di produzione con esattezza).
In riferimento a questi casi problematici si profilano due possibili modelli alternativi di ricostruzione
del rapporto di causalità:
1. Metodo individualizzante: l’accertamento del rapporto di causalità si svolge tra accadimenti
singoli e concreti, e il giudice dovrebbe quindi comportarsi come lo storico, ricostruendo le
vicende limitandosi ad individuare le connessioni tra eventi determinati e circoscritti, senza
preoccuparsi di rinvenire leggi universali in cui sussumere il rapporto tra i singoli accadimenti.
Questo metodo finisce però con il fare del magistrato penale più un produttore che un
consumatore di leggi causali, in quanto, a differenza della spiegazione scientifica della
causalità, il metodo si affida alla semplice intuizione del giudice, che sarebbe così libero di
scoprire le connessioni causali tra i singoli fatti oggetto di giudizio
2. Metodo generalizzante: di spiegazione causale, invece, è in una prima fase ancorato a leggi
50
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
generali che individuano rapporti di successione regolare tra l’azione criminosa e l’evento
considerati non come accadimenti singoli e unici, ma come “ripetibili”.
In particolare è in omaggio al principio della tassatività che il criterio della condicio sine qua
non va intesa in senso generalizzante e non individualizzante, ossia il giudizio causale deve
fornire una spiegazione adeguata dell’evento concreto, e in questa prospettiva la spiegazione
del nesso causale può correttamente effettuarsi solo con il modello della sussunzione sotto
leggi scientifiche.
Secondo questo modello, dunque, un antecedente può essere una condizione necessaria solo se
fa parte di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una
legge dotata di validità scientifica (legge generale di copertura), portano ad eventi come quello
verificatosi. In una seconda fase bisognerà poi passare al piano della causalità individuale,
ossia dimostrare sulla base di un ragionamento induttivo che la legge scientifica di copertura
trova applicazione anche nel caso concreto, e che essa possa dunque fornirne la spiegazione
causale.
In base a queste premesse metodologiche diventa fondamentale precisare quali leggi generali di
copertura siano al giudice davvero accessibili ai fini del processo penale. Le leggi scientifiche che sono
in grado di spiegare le relazioni tra accadimenti vengono solitamente distinte in leggi universali e leggi
statistiche:
Leggi universali: sono quelle che affermano che la verificazione di un evento è
invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, e queste leggi, poiché
asseriscono un rapporto di regolarità tra fenomeni senza eccezioni, soddisfano al massimo
livello le esigenze di rigore scientifico e di certezza
Leggi statistiche: sono invece quelle che affermano che il verificarsi di un evento è
accompagnato dal verificarsi di un altro evento solo in una percentuale di casi, e queste leggi
sono dunque tanto più valide quanto più alto è il numero di casi in cui l’evento si verifica, e
quanto più queste leggi possono essere verificate e provate.
L’accertamento giudiziale della causalità non può certo uniformarsi sempre al rigore scientifico dato
dalle leggi universali, e questo innanzitutto perché raramente si possono spiegare tutte le condizioni
necessarie di un evento alla stregua di altrettante leggi scientifiche, infatti spesso si ricorre a delle
assunzioni cd. tacite (clausola ceteris paribus). In questo modo la spiegazione causale ha come oggetti
solo alcune delle condizioni necessarie dell’evento, mentre le altre condizioni vengono supposte per
date. Inoltre, il giudice è ancor più limitato dal fatto che egli non possiede la stessa competenza dello
scienziato, e, ancora, il caso oggetto di giudizio spesso è preceduto da vari antecedenti, e dunque la
pretesa di massimo rigore scientifico diventa sempre più irrealistica. Per questi motivi, in sede di
accertamento giudiziale della causalità bisogna accontentarsi di una misura di certezza inferiore a
quella garantita dall’applicazione di leggi universali, e dunque il giudice sarà soltanto in grado di
asserire che è probabile che la condotta dell’agente sia una condizione necessaria dell’evento. A
conferire carattere probabilistico all’accertamento contribuisce anche il fatto che le relazioni causali
sottese ai fatti criminosi spesso sono ricostruibili solo alla stregua di leggi statistiche, che affermano
che la relazione di certi eventi sussiste solo in una data percentuali di casi.
In conclusione, ai fini dell’accertamento giudiziale della causalità non occorre che il giudice disponga
di leggi universali, ma è sufficiente che egli faccia ricorso a leggi statistiche, e anzi nella maggior parte
dei casi sono proprio queste ultime a fare da criterio-guida dell’accertamento processuale.
Tuttavia, proprio il fatto che il ricorso in sede processuale a leggi statistiche sia irrinunciabile, solleva il
problema delle loro corrette condizioni d’impiego, del quale si sono occupate dottrina e
giurisprudenza. Nell’affrontare questo problema é utile la distinzione concettuale tra:
Probabilità statistica (o frequentista o empirica): riferibile alla causalità generale, ossia
riferita al tipo di evento
Probabilità logica: riferibile alla causalità individuale, ossia riferita al singolo evento concreto
Uno dei punti più controversi a questo proposito é quale sia il livello di probabilità sufficiente per
considerare attendibile la ricostruzione giudiziaria del nesso causale. La risposta a questo quesito non
é stata sempre coerente e costante, ma si può comunque dire che sarebbe sbagliato pensare di potere
51
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
risolvere il problema cercando di stabilire un livello minimo generale è sempre valido di probabilità di
verificazione dell’evento sufficiente si fini del riconoscimento del nesso causale, in quanto essa varierà
da caso a caso, mentre ciò che conta é che il grado di conferma della spiegazione ipotizzata sia
comunque alto, alla stregua di un giudizio dato con l’applicazione delle regole relative alla
formulazione dell’ipotesi causale e all’individuazione dei fattori rilevanti, ai criteri sperimentali di
sostegno probatorio della spiegazione, alle scelte tra spiegazioni causali rivali, ecc.
La teoria condizionalistica secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche ha finito con il
trovare un accoglimento sempre maggiore nella prassi della giurisprudenza, ed é a questo proposito
importante la sentenza della Cassazione a sezioni unite del 12 luglio 2002 con riferimento specifico
ad un caso di responsabilità colposa del medico per decesso del paziente. Questa sentenza é
importante per il tentativo di fornire una risposta ben ponderata al problema delle corrette condizioni
d’impiego delle leggi statistiche nel processo penale, sia sotto il profilo della probabilità empirica, sia
sotto quello della probabilità logica. In base all’orientamento della Cassazione, ai fini della prova
giudiziaria della causalità, non é decisivo il coefficiente percentuale più o meno elevato di probabilità
frequentista desumibile dalla legge di copertura usata, ma il potere ragionevolmente confidare nel
fatto che la legge statistica trovi applicazione anche nel caso concreto oggetto di giudizio data l’alta
probabilità logica che fattori causali alternativi vadano esclusi. Dunque, più elevata é la credibilità
razionale dell’ipotesi di spiegazione causale privilegiata, più dovrebbe essere consentito usare leggi e
criteri probabilistico-statistici con coefficienti percentuali anche medio-bassi, e viceversa.
Questo metodo, tuttavia, é comunque difficile da applicare con autentico rigore metodologico nei casi
concreti, e continua infatti a persistere il rischio che i giudici, pur dichiarando formalmente di aderire
ai principi della causalità condizionalistica orientata in senso nomologico, non ne facciano poi una
reale e coerente applicazione, lasciandosi piuttosto influenzare da valutazioni sulla necessità o meno
di punire.
Riprendendo il caso del talidomide, bisogna ricordare che il giudice aveva affermato l’esistenza del
rapporto causale facendo leva sulle sue certezze soggettive, ma senza soddisfare le condizioni logiche
imposte da una spiegazione scientifica della causalità. Situazione analoga si é presenta nel caso delle
"macchie blu", ossia il caso degli abitanti di una zona in cui era stata posta una fabbrica di alluminio, i
quali avevano presentato manifestazioni cutanee e lamentato danni ad animali e colture, anche se per
questo fenomeno non si erano riuscite ad individuarne con certezza le cause.
Nel caso del talidomide l’ipotesi della teratogeneticità del farmaco sembrava in partenza dotata di un
sufficiente sostegno teorico, dato dalla denuncia di diversi scienziati che già da dieci anni prima della
comparsa di questo farmaco avevano denunciato la dannosità per i feti di non meno di 25 preparati, e
dato inoltre dai test sugli animali che avevano dimostrato la dannosità del farmaco su di essi. La
presunzione della dannosità per l’uomo era stata inoltre sostenuta sulla base di rapporti medici
provenienti da tutto il mondo, ed era ulteriormente confermata da altre circostanze quali l’aumento
delle malformazioni dei feti dopo la libera vendita del talidomide e la loro repentina diminuzione dopo
il ritiro del farmaco, il fatto che l’area in cui le malformazioni si erano diffuse coincideva con l’area di
vendita del farmaco, ecc.
Tutti questi fatti hanno dunque portato a considerare razionalmente argomentabile una spiegazione
su base statistica degli effetti dannosi del talidomide.
Considerazioni analoghe valgono per il caso delle macchie blu, poiché anche qui sono state rinvenute
diverse significative connessioni, quali l’elevata diffusione delle macchie soltanto nei luoghi in cui
erano presenti fabbriche di alluminio, la coincidenza dei danni a persone, animali e colture nelle stesse
zone, la cessazione dei danni una volta fermati i fumi dannosi con un depuratore, ecc. Dunque, anche in
questo caso in mancanza di conoscenze esaurienti sul completo meccanismo di produzione del
fenomeno, solo una spiegazione statistica avrebbe potuto condurre al riconoscimento di un nesso
causale tra i fumi della fabbrica e la comparsa dei danni.
Tuttavia, per giungere credibilmente a questo risultato non basterebbe limitarsi ad enumerare le
connessioni, ma servirebbe anche verificarle con criteri di prova dotati a loro volta di un grado di
controllabilità empirica e idonei, dunque, a suffragare l’applicabilità di una legge statistica. Nel
52
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
passaggio, poi, dal piano della causalità generale a quello della causalità individuale, occorrerebbe pur
sempre verificare che la legge statistica possa trovare effettiva applicazione anche nel singolo caso
oggetto di giudizio, essendo da escludere spiegazioni causali alternative.
TEORIA DELLA CAUSALITÀ ADEGUATA
Un altro diffuso modello di spiegazione causale è la teoria della causalità adeguata, la quale si
prospetta all’origine come correttivo alla teoria condizionalistica nella sfera dei delitti aggravati
dall’evento. Essa, da questo punto di vista, non rinnega la teoria condizionalistica, ma tende, tra gli
antecedenti causali equivalenti, a selezionare quelli veramente rilevanti in sede giuridico-penale.
L’esigenza di questa selezione viene soprattutto avvertita nei casi di decorso causale atipico, ossia
quelli in cui la successione degli eventi si pone al di fuori degli schemi di un’ordinaria prevedibilità, e
questo è tanto più vero nei delitti aggravati dall’evento, dove l’aggravante viene addossato all’agente
su base meramente oggettiva, a prescindere da dolo e colpa. Su questi casi è necessario riflettere, ed un
esempio può essere il seguente: se un tossicodipendente muore dopo avere assunto una dose di eroina
che uno spacciatore l’ha spinto ad assumere, ma la dose non era di per sé mortale, tanto che la morte
viene causata dalla concomitanza di danni agli organi interni già esistenti, si potrebbe considerare la
morte come una conseguenza del reato di spaccio, aggravando così la pena dello spacciatore? Oppure,
se per esempio un nipote volesse ottenere l’eredità di un parente, e convincesse quest’ultimo ad
affrontare un viaggio rischioso sperando che egli muoia, e ciò succedesse, lo si potrebbe accusare e
ritenere responsabile?
Per attenuare il rigore di una rigida applicazione della teoria condizionalistica a casi come quelli
appena citati, la teoria dell’adeguatezza tende a selezionare come causali solo alcuni antecedenti, e
considerando dunque come causa soltanto la condizione tipicamente idonea o adeguata a produrre
l’evento in base ad un criterio di prevedibilità basato sull’id quod plaerumque accidit. Questa teoria
propone dunque un modello generalizzante di spiegazione della causalità, infatti considerare l’azione
come causa solo quando è tipicamente idonea a cagionare l’evento significa richiedere una generale
attitudine dell’azione a cagionare eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. I criteri di
accertamento della generale attitudine causale dell’azione sono costituiti dai giudizi di probabilità che
si emettono nella vita pratica, e dunque si può capire perché il diritto penale vieti e punisca solo le
azioni che sono soltanto siano condizioni di un evento dannoso, ma appaiano anche idonee a produrlo,
ossia aumentino sufficientemente le probabilità che esso si verifichi.
Per evitare di ricorrere a questa diversa teoria soltanto per il settore dei reati aggravati dall’evento, i
sostenitori della teoria della causalità adeguata hanno finito col proporla come teoria generale della
causalità penalmente rilevante. Secondo la migliore e più aggiornata formulazione della teoria, essa va
costruita in termini negativi, e dunque il rapporto di causalità va considerato esistente ogniqualvolta
non sia improbabile che l’azione produca l’evento.
I sostenitori, inoltre, concordano per lo più sul ritenere che il giudizio di probabilità vada effettuato
sulla base delle circostanze presenti al momento dell’azione e conoscibili ex ante da un osservatore
avveduto, oltre a quelle superiori eventualmente possedute dall’agretto concreto, cd. criterio della
prognosi postuma o ex ante in concreto. Sulla base di questo, si può dire che, in relazione ai due casi
citati, il vendere una dose non mortale di eroina e il convincere qualcuno a fare un viaggio non
possono essere considerate azioni tipicamente idonee ad uccidere, sempre che l’agente, nel caso dello
spaccio di eroina, non sia a conoscenza della pregressa situazione della persona cui ha venduto la dose.
Tuttavia, non sempre la teoria dell’adeguatezza riesce a delimitare la responsabilità: se ad esempio
una persona ne ferisse un’altra, e quest’ultima, dopo essere quasi guarita, morisse in seguito ad un
incendio dell’ospedale in cui era stata ricoverata, si può dire che la ferita potrebbe provocare la morte
del ferito, ma si può altresì dire che non sembrerebbe idonea l’attribuzione della responsabilità al
feritore per una morte avvenuta a causa dell’incendio. Non a caso, infatti, una delle principali critiche a
questa teoria è relativa alla sua incapacità a risolvere casi in cui l’azione criminosa appare ex ante
idonea a cagionare l’evento, ma quest’ultimo si verifica per il sopraggiungere di circostanze
53
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
imprevedibili. Si sostiene che questa incapacità derivi dal fallimento della teoria nella descrizione
dell’evento, ossia ci si chiede se l’evento lesivo vada considerato come evento astratto (semplice
“evento-morte”) o come concreto (“morte come conseguenza dell’incendio in ospedale”).
La dottrina ha consigliato, per superare l’ostacolo, di dividere il giudizio in due fasi:
1. Una anteriore al verificarsi dell’evento: ossia verificare in base ad un giudizio ex ante se non
sia improbabile che all’azione consegua un evento del genere di quello contemplato dalla
norma
2. Una posteriore al verificarsi dell’evento: ossia verificare in base ad un giudizio ex post se
l’evento concreto realizzi il pericolo tipicamente o generalmente connesso all’azione delittuosa
Nell’esempio precedente si dovrebbe dunque concludere che il grave ferimento sarebbe ex ante idoneo
a cagionare l’astratto evento-morte, ma che l’evento concreto della morte per incendio non
rappresenta una concretizzazione del rischio tipicamente connesso all’azione del ferire, e dunque va
escluso il nesso di causalità.
Tuttavia, alla teoria dell’adeguatezza come modello di spiegazione causale sono state rivolte altre tre
tipologie di obiezioni:
non è agevole conciliare il requisito della prevedibilità ex ante dell’evento con l’accertamento
della causalità, che dovrebbe invece basarsi su un giudizio ex post e di natura oggettiva
questa teoria finisce per includere nell’ambito della causalità considerazioni che appartengono
più propriamente alla sfera della colpevolezza
il concetto di adeguatezza è inevitabilmente soggetto ad applicazioni incerte, in quanto esso si
fonda su giudizi di probabilità propri della vita sociale
TEORIE MINORI
LA CAUSALITÀ UMANA
Tra le concezioni causali minori, la teoria della causalità umana è quella che ha avuto più diffusione
nella dottrina e nella giurisprudenza italiana. Essa si muove dalla premessa che possono considerarsi
causati dall’uomo solo i risultati che egli può dominare in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi, e
che rientrano cioè nella sua sfera di signoria, mentre non può causare quelli che sfuggono al suo
dominio. Ciò che sfugge alla signoria dell’uomo è il fatto che ha una minima ed insignificante
probabilità di verificarsi, ossia il fatto eccezionale, e dunque perché esista un rapporto di causalità
serve che l’uomo con la sua azione abbia creato una condizione dell’evento (elemento positivo), e che il
risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (elemento negativo).
Questa teoria, la quale appare come un mal riuscito tentativo di correzione della teoria
dell’adeguatezza, fallisce tuttavia nel non riuscire a fornire un reale criterio discretivo tra il concetto di
atipico e di eccezionale, infatti dire che è eccezionale il fatto che ha una probabilità minima di
verificarsi significa soltanto ribadire il criterio dell’adeguatezza. Inoltre, nel porre l’accento sul fattore
eccezionale come fattore in grado di interrompere il nesso causale, non ci si preoccupa di precisare a
quale elemento, evento astratto, concreto, o decorso causale, l’eccezionalità vada riferita, e dunque
l’eccezionalità si dimostra un concetto relativo, poiché risulta da un giudizio che muta a seconda
dell’angolo visuale da cui si osservano i fenomeni. L’incapacità di questa teoria viene ulteriormente
dimostrata dal fatto che i casi che essa dichiara di risolvere, sono risolvibili anche utilizzando la teoria
della causalità adeguata. Infine, il concetto di signoria del fatto attraverso i poteri conoscitivi o volitivi
dell’uomo richiama criteri di imputazione che coinvolgono più propriamente il problema della
colpevolezza.
LA TEORIA DELL’IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELL’EVENTO
L’esigenza di evitare le conseguenze di un’applicazione meccanica della formula della condicio sine qua
non ha recentemente indotto parte della dottrina a trattare i casi caratterizzati da un decorso causale
atipico alla stregua di paradigmi concettuali ulteriori rispetto al criterio causale, e ritenuti più adatti a
risolvere lo specifico problema penalistico dell’imputazione oggettiva dell’evento.
54
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
È ricomparsa così la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento, ramificata in filoni diversi, i quali
hanno in comune la premessa di partenza, la quale si fonda sul rilievo che il nesso causale costituisce
presupposto indispensabile della responsabilità, in quanto è ordinariamente in grado di riflettere la
signoria dell’uomo sul fatto.
Tuttavia, alla sussistenza di un nesso causale in senso condizionalistico non sempre segue la capacità
umana di controllare il decorso eziologico, si potrebbe rilevare un nesso tra la morte del ricco parente
e la volontà del nipote di farlo partire per un viaggio rischioso con la speranza che muoia, ma non si
può dire che egli avesse la capacità umana di controllare il decorso della sua azione. Si può dunque
dire che la teoria dell’imputazione obiettiva dell’evento si presenta come uno sviluppo aggiornato della
teoria della causalità adeguata, e finisce per certi aspetti con il ripresentarne gli assunti di fondo un
una differente formulazione concettuale. Nasce di qui lo sforzo di individuare parametri di
attribuzione giuridica ulteriori rispetto a quelli condizionalistici, ma di natura non strettamente
causale, atti a giustificare nei casi nevralgici l’imputazione oggettiva dell’evento lesivo. Il punto
d’arrivo dell’imputazione obiettiva è il fatto che un evento lesivo può essere obiettivamente imputato
all’agente solo se realizza il rischio giuridicamente non consentito o illecito creato dall’autore con la
sua condotta.
Se però il paradigma centrale dell’impostazione teorica è quello della creazione e realizzazione di un
rischio non consentito, è anche vero che l’applicabilità di questo paradigma si avvale di criteri
differenziati, due dei quali sono particolarmente importanti, ossia il criterio dell’aumento del rischio, e
quello dello scopo della norma violata.
Secondo la teoria dell’aumento del rischio, l’imputazione obiettiva dell’evento presuppone, oltre al
nesso condizionalistico, che l’azione abbia aumentato, di fatto, la probabilità che si verificasse l’evento
dannoso, e sarebbe per questo lecite le condotte che non comportassero un pericolo disapprovatile o
che non aumentassero le possibilità di eventi lesivi. Prendendo i due esempi fatti precedentemente, si
può dire che l’invito del nipote a fare un viaggio non può avere aumentato il rischio che il parente
morisse in un incidente aereo, mentre difficilmente si potrebbe dire che l’incitamento a riprendere
l’uso di eroina per un tossicodipendente non possa avere aumentato il rischio della sua morte.
Secondo il punto di vista dello scopo della norma violata, l’imputazione viene meno quando il fatto che
si verifica è causalmente riconducibile alla condotta dell’agente, ma non costituisce una
concretizzazione dello specifico rischio che la norma in questione tende a prevenire. Questo criterio
non dà però esiti applicativi univoci, infatti nell’esempio del tossicodipendente da un lato si potrebbe
dire che tra gli scopi della norma che punisce lo spaccio vi anche quello di tutela la vita di coloro che
assumono stupefacenti, dall’altro lo scopo precipuo della norma è in realtà quello di evitare
l’instaurarsi degli effetti connessi alla tossicodipendenza, mentre la tutela della vita è più uno scopo
indiretto.
Contro la teoria dell’imputazione obiettiva sono state mosse varie obiezioni:
la teoria è stata elaborata all’interno dell’ordinamento tedesco, che non ha un’esplicita
disciplina normativa della causalità, e dunque essa ha delle difficoltà nell’adattarsi al sistema
penale italiano, che disciplina la causalità in una modalità che non sempre collima con gli
assunti di questa teoria
applicando il criterio dell’aumento del rischio si ribalterebbe il principio in dubio pro reo, dal
momento che si avrebbe una trasformazione surrettizia degli illeciti di danno in ipotesi di
illecito di pericolo (anche se in realtà negli illeciti commissioni il criterio dell’aumento del
rischio integra l’accertamento della causalità in senso condizionalistico, onde il suo impiego fa
restringere l’ambito della punibilità).
Dunque, la teoria dell’imputazione non si è ad oggi tradotta in formulazioni talmente convinti da farle
assegnare un ruolo indiscusso nell’ambito dei criteri dell’accertamento causale, anche se non si
possono escludere futuri ed ulteriori sviluppi.
55
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CONCAUSE
Il nostro legislatore ha disposto una norma apposita, ossia l’art. 41 c.p., per il fenomeno delle
concause, ossia il concorso di più condizioni che possono essere a loro volta antecedenti, concomitanti
o successive rispetto alla condotta del reo. Questo fenomeno rispecchia ciò che normalmente avviene,
infatti di norma alla produzione di un evento concorrono più fattori causali, ed è invece raro che la
singola azione del reo causi da sola l’evento, e, affinché l’azione umana sia considerata “causa”, basta
che essa costituisca una delle condizioni necessarie che concorrono a determinare l’evento tipico.
L’art. 41 comma 1 c.p. stabilisce che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute,
anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra
l’azione e l’evento (e quindi, ad esempio, la responsabilità del feritore non viene meno se il ferito
decede durante l’intervento a causa di una preesistente cardiopatia).
All’art. 41 comma 3 c.p. si dispone invece che la causa concorrente può anche essere costituita da un
fatto illecito altrui, come nel caso in cui due persone uccidano la stessa vittima all’insaputa dell’altro.
Al comma 2 dell’art. 41, invece, si dispone che le cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre
l’evento escludono il rapporto di causalità, e questa formulazione risulta particolarmente infelice,
tanto da destare diversi problemi e contrasti interpretativi. Letteralmente, infatti, l’espressione
utilizzata dalla norma sembra riferirsi ad una serie casuale autonoma, ossia una causa che opera a
prescindere da qualsiasi legame con una precedente azione del soggetto. Tuttavia, il secondo comma
risulterebbe in questo senso superfluo, poiché l’esclusione di un nesso causale penalmente rilevante
dovrebbe già derivare dal principio condizionalistico dell’art. 40 comma 1 c.p. In base al principio
ermeneutico della conservazione delle norme è dunque necessario interpretare il comma in un modo
differente, il quale, secondo l’orientamento prevalente, lo intende come una norma che tende a
temperare gli eccessi punitivi che derivano da una rigorosa applicazione del criterio condizionalistico,
e il secondo comma dell’art. 41 risulta in questo senso l’unica sede normativa in grado di legittimare
teorie causali diverse dalla condicio sine qua non.
Questa esigenza di temperamento emerge in relazione ai casi che appaiono connotati da uno sviluppo
causale che si trova fuori dagli schemi di un’ordinaria prevedibilità, infatti la formula dell’art. 41.2 era
stata pensata con riferimento ai casi di “decorso causale atipico”. In forza di questo secondo comma un
nesso causale penalmente rilevante dovrebbe essere escluso nei casi in cui l’evento lesivo non sia in
quadrabile in una successione normale di eventi (come l’esempio dello zio spinto a fare un viaggio, o
del ferito che muore per un incendio dell’ospedale, ecc.).
56
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO DUE
ANTIGIURIDICITÀ E SINGOLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Alla realizzazione di una condotta tipica si accompagna normalmente il carattere antigiuridico del
fatto, ma l’antigiuridicità viene meno se una norma diversa da quella incriminatrice impone o
permette quel fatto che costituirebbe reato, e queste situazioni normative previste e in assenza delle
quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero
ordinamento giuridico, si chiamano cause di esclusione dell’antigiuridicità (o cause di
giustificazione). Poiché le cause di giustificazione sono desumibili da qualsiasi branca del sistema
giuridico, esse sono valide per tutti i rami dell’ordinamento, e non solo per quello penale (una causa di
giustificazione rende di norma inapplicabili anche le sanzioni civili o amministrative).
In realtà, va detto che l’espressione tecnica “cause di giustificazione” non fa parte del linguaggio del
codice, ed è una categoria di origine dottrinale, infatti il legislatore ha preferito parlare più in generale
di circostanze che escludono la pena all’art. 59 c.p., prescindendo dal prendere posizione sulla loro
specifica qualificazione dogmatica all’interno della teoria del reato. Ma la generica e ampia formula
delle circostanze o cause di esclusione della pena ha finito così con il trasformarsi in una sorte di
contenitore che ricomprende tutte le situazioni in presenza delle quali il codice dichiara un
determinato soggetto non punibile.
Le ragioni che spiegano l’esclusione della punibilità sono riconducibili ad almeno tre piani di
valutazione distinti, corrispondenti alle categorie delle:
1. Cause di giustificazione o esimenti: tra queste tre categorie, soltanto le cause di
giustificazione in senso stretto (es. in caso di legittima difesa o di esercizio di un diritto)
rendono qualsiasi sanzione inapplicabile, anche civile o amministrativa, (poiché viene
“rimossa” l’antigiuridicità o illiceità del fatto) e si estendono a tutti quelli che rendono
eventualmente parte alla commissione del fatto, e operano inoltre in forza della loro esistenza,
e dunque operano anche se non conosciute o se ritenute inesistenti erroneamente (es.
legittima difesa).
Va, comunque, sottolineato che le cause di giustificazione che verranno di seguito esaminate
sono esimenti di portata generalissima (art. 50 e ss.), applicabili a qualsiasi reato, e dette cause
di giustificazione comuni, differenti dalle cause di giustificazione speciali, che si applicano solo
ad alcuni specifici reati
2. Cause di esclusione della colpevolezza o scusanti: le esimenti (es. coazione morale
esercitato da altri), invece, lasciano integra l’antigiuridicità o illiceità oggettiva del fatto,
facendo venire meno solo la possibilità di ritenere colpevole l’autore. Ciò accade quando, ad
esempio, l’autore ha agito sotto la pressione di circostanze psicologiche coartanti che
rendevano difficilmente esigibile un comportamento diverso e conforme al diritto, o nei casi in
cui l’autore ha agito senza il richiesto elemento oggettivo. Queste cause, a differenza delle
precedenti, dal momento che riguardano l’elemento soggettivo, operano soltanto se l’agente le
conosceva e soltanto ai soggetti cui si riferiscono, senza estendersi ad eventuali concorrenti
(poiché l’illiceità del fatto rimane)
3. Cause di non punibilità in senso stretto: Esse consistono in circostanze (es. delitto contro
l’amministrazione della giustizia per evitare la condanna di un prossimo congiunto, o furto del
figlio ai danni di un genitore) che lasciano sussistere sia l’antigiuridicità, sia la colpevolezza, e
riguardano invece la necessità o meritevolezza della pena, ed esse non sono dunque estensibili
ad eventuali concorrenti.
SISTEMATICA DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Da tempo la dottrina si è sforzata di elaborare i principi generali delle cause di giustificazione, e questo
per una migliore interpretazione di queste ultime, e per una loro applicazione analogica ai casi non
57
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
espressamente previsti dalla norma. La dottrina ha allora elaborato due modelli esplicativi:
Modello monistico: tutte le esimenti vanno ricondotte ad uno stesso principio, ossia il criterio
del “mezzo adeguato per il raggiungimento di uno scopo approvato dall’ordinamento
giuridico”, o “prevalenza del vantaggio sul danno”, o “bilanciamento tra beni in conflitto”, ecc.
Anche se secondo alcuni le scriminanti possono essere tutto ricondotte ad uno stesso principio,
è comunque indiscutibile che esse abbiamo comunque ognuna elementi propri, e dunque
sarebbe opportuno tenere conto delle peculiarità di ciascuna.
Modello pluralistico: la dottrina dominante opta per questo motivo per un modello
esplicativo di tipo pluralistico che riconduca le esimenti a principi diversi, tra i quali i più
invocati sono il principio dell’interesse prevalente (legittima difesa, esercizio di un diritto, ecc.)
e dell’interesse mancante (consenso dell’avente diritto, stato di necessità).
Va in ogni caso notato che qualunque tipo di modello si voglia seguire, il rischio è comunque sempre
quello di non riuscire ad abbracciare tutta la materia, e di lasciare dunque qualcosa “fuori” dal sistema.
DISCIPLINA DELLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Le cause di giustificazione sono sottoposte a delle regole comuni previste dagli artt. 55 e 59 c.p.
1. Rilevanza puramente obiettiva: l’art. 59 comma 1 stabilisce che le circostanze che escludono
la pena vengono valutate in favore dell’agente anche se egli non le conosceva o le riteneva
inesistenti.
Sulla base di questa disposizione, la dottrina italiana prevalente ritiene che tutte le esimenti
contenute nella parte generale operino su un piano meramente oggettivo, includendo quindi
ad esempio anche lo stato di costrizione che la legge menziona nella legittima difesa o nello
stato di necessità (ad esempio se Tizio sparasse a Caio senza rendersi conto che anche Caio
stava per sparargli, Tizio non dovrebbe essere colpevole di omicidio).
Non è però da escludere che la struttura particolare delle singole scriminanti possa rendere
inevitabile la presa in considerazione di eventuali coefficienti soggettivi, ed individuare questi
casi è compito dell’interprete (e ciò avviene per lo più con le scriminanti speciali).
2. Rilevanza del putativo: l’art. 59 comma 4 stabilisce che se l’agente ritiene erroneamente che
esistano circostanze di esclusione della pena, esse vengono sempre valutate in suo favore. In
questo modo viene equiparata l’esimente putativa all’esimente realmente esistente. Tuttavia,
per avere efficacia scusante, l’errore deve investire i presupposti di fatto che integrano la causa
di giustificazione stessa (ad esempio Tizio credendo di essere aggredito da Caio si difende), o
investire una norma extrapenale integratrice di un elemento normativo della fattispecie
giudicante. Per il principio dell’ignorantia legis non excusat non viene invece considerato
scusante l’errore di diritto.
Questa regola, in base alla quale l’erronea supposizione di una causa di giustificazione fa venire
meno la punibilità, è un’estensione alle scriminanti della disciplina generale dell’errore di fatto
data dall’art. 47: chi commette un reato nell’erronea convinzione che sussistano circostanze, le
quali facoltizzano o impongono il comportamento che realizza quel reato, agisce senza dolo
allo stesso modo di chi erra sull’esistenza di un requisito positivo della figura criminosa che
viene in questione. La giurisprudenza tende comunque ad interpretare restrittivamente questa
disposizione, ritenendo necessario anche che l’errore dell’agente sia ragionevole e appaia
scusabile sulla base dei dati di fatto.
3. Errore colposo: l’art. 59 comma 4 dispone inoltre che se l’errore sulla presenza di una
scriminante è dovuto a colpa dell’agente, allora la punibilità non viene esclusa quando il fatto è
previsto dalla legge come delitto colposo.
Anche in questo caso la disciplina appena esposta è analoga a quella prevista dall’art. 47
comma 1 c.p., che dispone che l’erronea supposizione che manchino uno o più elementi
costitutivi di un reato fa sì che l’illecito sia un delitto colposo, e lo stesso accade nel caso
dell’erronea credenza che suscitano situazioni scriminanti.
Anche se l’art. 59 fa riferimento unicamente ai delitti, non v’è ragione per cui la disciplina
relativa all’errore colposo non debba applicarsi anche alle contravvenzioni.
58
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
4. Eccesso colposo: l’art. 55 dispone che quando nel commettere uno dei fatti previsti dagli
articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine
dell’autorità o imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,
se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Questo è l’eccesso colposo, che si ha
quando sussistono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione, ma l’agente per colpa
ne travalica i limiti. il giudizio relativo alla natura colposa del superamento dei limiti
dell’agire consentito, si effettua alla stregua dei parametri normativi contenuti nell’art. 43,
ovvero deve dipendere da un difetto inescusabile di conoscenza della situazione concreta da
parte dell’agente o da inosservanza delle regole di condotta relative all’uso dei mezzi o alle
modalità di realizzazione del comportamento. La dottrina distingue dunque:
A. Eccesso colposo dovuto alla valutazione erronea della situazione di fatto
B. Eccesso colposo dovuto ad una valutazione esatta, ma con un errore esecutivo che
porta ad un evento più grande di quello che era necessario
Nella pratica, quindi, si realizza un evento sproporzionato rispetto a quello che sarebbe stato
sufficiente produrre.
Si è invece al di fuori dei limiti dell’eccesso colposo se l’agente è a conoscenza della situazione e
dei mezzi necessari a raggiungere l’obiettivo, e supera volontariamente i limiti della
scriminante con un eccesso che non è più colposo, ma doloso.
Va inoltre ricordato che parte di dottrina e giurisprudenza considerano che la disposizione
sull’eccesso colposo sia applicabile anche ai casi in cui la scriminante non è reale, ma putativa.
Il delitto commesso con eccesso colposo è un vero e proprio delitto colposo, anche se a ben
vedere la volontarietà del fatto non è piena, ma viziata da errore, il quale è però inescusabile, e
dunque manca l’elemento conoscitivo del dolo, ma questo non rileva perché l’agente con
maggiore attenzione avrebbe potuto evitare il proprio errore di valutazione.
LE SINGOLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
L’art. 50 c.p. dispone che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della
persona che può validamente disporne, secondo il principio del volenti et consentienti non fit iniuria,
dal momento che lo Stato non tutela un interesse che nemmeno il titolare vuole salvaguardare.
Tuttavia, non vengono considerati giustificabili le ipotesi in cui il consenso costituisce un elemento la
cui presenza fa venire meno lo stesso fatto tipico (ad esempio la violenza sessuale è tale solo se non vi
è consenso, altrimenti “il fatto non sussiste”), come nel caso di violazione di domicilio, in cui il dissenso
dell’avente diritto è un elemento costitutivo del fatto illecito, e dunque l’eventuale consenso
dell’avente diritto impedisce che si integri la fattispecie oggettiva del reato.
L’ambito di operatività dell’art. 50 va dunque circoscritto ai casi in cui il giudice accerti un fatto
tipico al completo dei suoi elementi, e dunque nei quali il dissenso dell’avente diritto non costituisce
un esplicito requisito del fatto di reato. I casi dell’ambito di operatività sono quelli in cui il consenso
dell’offeso ha effetto di giustificare o rendere lecito un fatto che sarebbe altrimenti reato.
Il consenso non crea nessun vincolo obbligatorio a carico dell’avente diritto, infatti è sempre
revocabile, a meno che l’attività non possa essere interrotta, e non trasferisce alcun diritto
all’agente, infatti non è un negozio giuridico, bensì un semplice atto giuridico. La formula di
proscioglimento è qui “perché il fatto non costituisce reato”.
I requisiti di validità del consenso sono:
1. Il consenso, per giustificare il fatto, deve essere libero o spontaneo, e non è dunque
scriminante il consenso dato per violenza, errore o dolo.
2. Il consenso non ha però requisito di forma e può essere quindi reso con qualsiasi mezzo, fino
ad essere tacito, ossia desunto dal comportamento oggettivamente univoco dell’avente diritto
59
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
3. Il consenso deve in ogni caso sussistere al momento del fatto, e non vale perciò il consenso
successivo o ratifica.
Il consenso è:
Putativo: se il soggetto agisce supponendo, erroneamente, che esso esista, ma esso non
giustifica il fatto che in base alle circostanze sia da escludere la ragionevole
persuasione di operare con l’assenso della persona che può validamente disporre del
diritto.
Presunto: quando si può fondatamente ritenere che il titolare del bene lo avrebbe
concesso se fosse stato a conoscenza della situazione di fatto. La dottrina è per lo più
d’accordo nell’includere anche questa forma di consenso, mentre la giurisprudenza
mostra un atteggiamento più restrittivo.
4. I soggetti legittimati a prestare il consenso sono:
Titolare del bene penalmente protetto, se il bene a più titolari serve il consenso di tutti,
Rappresentante legale o volontario, a meno che la rappresentanza non risulti
incompatibile con la natura del diritto e dell’atto da consentire.
Per potere prestare il consenso si deve avere la capacità di agire, che finisce col risolversi con
la capacità naturale, ossia la capacità di intendere e di volere, poiché è un atto e non un
negozio giuridico, che deve essere accertata caso per caso dal giudice. Vi sono anche casi in cui
è il legislatore a fissare un’età minima, come quella di 14 anni per la corruzione di minorenne,
o quella di 18 per dare il consenso alla lesione di diritti patrimoniali.
L’art. 50 circoscrive la sfera di operatività della scriminante del consenso ai casi in cui esso riguardi
diritti disponibili, infatti l’interesse alla repressione viene meno solo se il consenso ha ad oggetto la
lesione di beni di pertinenza esclusiva o prevalente del privato che ne è titolare. L’art. 50 non precisa
però quali siano i diritti disponibili, e dunque sarà l’interprete a doverli individuare all’interno
dell’intero ordinamento giuridico e delle consuetudini.
Si ritengono disponibili i beni che non hanno un’immediata utilità sociale e che lo Stato riconosce solo
per garantirne al singolo il libero godimento. Vengono ad esempio ritenuto diritti disponibili:
Diritti patrimoniali
Attributi della personalità: come onore, libertà morale, personale, di domicilio, sessuale, ecc.,
ma il consenso per questi ultimi per essere efficace deve riguardare lesioni circoscritte che non
comportino il compito sacrificio del bene e che non siano contrarie alla legge, al buon costume
e all’ordine pubblico
Integrità fisica: l’opinione dominante considera che l’operatività del consenso scriminante
vada determinata attraverso il parametro dell’art. 5 c.c., che dispone che gli atti di disposizione
del proprio copro siano vietati se cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica
(anche se oggi questo viene ritenuto possibile, a patto che la diminuzione permanente che
siano funzionali al miglioramento complessivo della salute del disponente), e se sono contrari
alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Vengono invece di norma considerati indisponibili tutti gli interessi che fanno capo allo Stato, agli
enti pubblici e alla famiglia, e, secondo un orientamento costante della giurisprudenza, non ha efficacia
scriminante il consenso in ambito di reati contro la fede pubblica, inclusa la falsità di scrittura privata,
e in ambito di delitti di usura, di frode in commercio e di false comunicazioni sociali. Tra i beni
indisponibili vi è anche il bene della vita, infatti sono reati l’omicidio di consenziente e l’istigazione al
suicidio, anche se con alcune precisazioni.
ESERCIZIO DI UN DIRITTO
Secondo l’art. 51 c.p. l’esercizio di un diritto esclude la punibilità, e questo a causa della prevalenza
dell’interesse di chi agisce esercitando un diritto rispetto agli altri interessi eventualmente
confliggenti, ma anche per il principio di non contraddizione nell’ordinamento giuridico, poiché si
creerebbe altrimenti contrasto tra una norma che consente di esercitare un diritto e una che ne
sanziona l’esercizio.
60
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Ai fini dell’art. 51 il concetto di diritto va inteso nell’accezione più ampia, ossia come potere giuridico
di agire, sia esso diritto soggettivo, diritto potestativo, potestà, o facoltà giuridica, mentre non
vengono inclusi gli interessi legittimi e gli interessi semplici, poiché non sono suscettibili di esercizio.
La fonte del diritto può variare dalla legge, al regolamento, all’atto amministrativo, al provvedimento
giurisdizionale, al contratto, fino alla consuetudine.
L’art. 51 non dispone però quando la norma attributiva di un diritto sia da ritenere prevalente rispetto
alla norma incriminatrice, e dunque l’applicabilità dell’art. 51 presuppone già risolto l’apparente
conflitto tra la norma che autorizza l’esercizio del diritto e la norma incriminatrice a favore della
prima. Il problema nasce però dal fatto che non sempre il conflitto è risolto in questo modo, infatti vi
sono casi in cui è la norma penale a prevalere, e così ad esempio risponde penalmente chi incendia la
cosa propria con pericolo per la pubblica incolumità, anche se vi è una norma civile che attribuisce la
facoltà di disporre delle proprie cose. Per stabilire se la norma attributiva del diritto limiti o sia
limitata dalla norma penale, vi sono tre criteri:
1. Gerarchico: ex superior derogat legi inferiori
2. Cronologico: lex posterior derogat legi anteriori
3. Specialità: lex specialis derogat legi generali
Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto, va detto che l’attività realizzata deve
costituire una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, e se così non è
vengono superati i confini dell’esercizio scriminante, e subentra un’ipotesi di abuso del diritto non
inclusa nell’art. 51 c.p.
Vi sono comunque dei limiti all’esercizio del diritto, i quali si dividono in:
Limiti interni: desumibili dalla natura e dal fondamento del diritto esercitato
Limiti esterni: desumibili dal complesso delle norme di cui fa parte quella attributiva del diritto
I limiti dei diritti previsti da una legge ordinaria si desumono sia dalla fonte del diritto sia dalle altre
leggi dell’ordinamento, mentre i limiti dei diritti costituzionali non possono essere ricavati ovviamente
da norme di rango inferiore, e dunque limiti a questi diritti possono esservi soltanto in caso di
contrasto con un interesse di rango equivalente.
Gli esempi più significativi della scriminante dell’esercizio di un diritto sono i seguenti.
1. Diritto di cronaca giornalistica: pesso in questa attività vengono esposti fatti che ledono
l’onore e la reputazione di terzi, ma si esige un bilanciamento tra i due diritti poiché sia
manifestazione del pensiero sia onore godono di rango costituzionale. Dunque la
giurisprudenza dominante considera che i limiti al diritto di cronaca siano la verità o
verosimiglianza della notizia pubblicata, l’esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza
dei fatti, e l’obiettiva e serena esposizione della notizia.
2. Diritto di sciopero: l’esercizio del diritto di sciopero incontra limiti interni o coessenziali,
desumibili dalla natura e dalla ratio del diritto in questione, e limiti esterni, derivanti
dall’esigenza di tutelare altri diritti costituzionalmente rilevanti che con quello sciopero
entrano in conflitto
3. Jus corrigendi: rientra tradizionalmente nella scriminante dell’esercizio di un diritto il diritto
dei genitori con la potestà genitoriale di educare i figli, il cui esercizio sfocia talvolta in reati
quali le percosse, la limitazione della libertà personale, ecc. Lo jus corrigendi è soggetto però a
dei limiti, tanto che vi è il reato di abuso dei mezzi di correzione, ma, tuttavia, la disposizione
non esplicita quali siano i limiti, rinviando per la loro determinazione ai criteri di valutazione
diffusi nel contesto sociale considerato, rendendo così difficile determinare dei criteri che non
mutino nello spazio e nel tempo.
Va infine considerato che lo jus corrigendi può essere delegato ad altri soggetti quali maestri,
educatori, ecc. ma non può essere arbitrariamente esercitato da persone estranee.
4. Offendicula: la causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto viene anche invocata per
giustificare l’efficacia esimente del ricorso agli offendicula, ossia i mezzi di tutela della
61
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
proprietà che possono provocare offese a terzi, come ad esempio il filo spinato. L’efficacia
scriminante dell’offendiculum viene però subordinata all’esistenza di un rapporto di
proporzione tra mezzo usato e bene da difendere.
ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
L’art. 51 stabilisce anche che l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un
ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità. Questa scriminante trova origine
nell’esigenza di rispettare il principio di non contraddizione all’interno di uno stesso ordinamento
giuridico.
Il dovere può dunque trovare origine in due tipi di fonti
Dovere imposto da una norma giuridica: come nel caso di un poliziotto che esegua un
arresto, ma non sia colpevole di sequestro di persona, o di un testimone che riferisca fatti lesivi
dell’onore di un terzo, ma non sia colpevole di diffamazione. Se l’obbligo di agire deriva da una
legge o un atto normativo equiparato, allora la persona è certamente giustificata, mentre
possono sorgere dubbi sui doveri dati da regolamenti, poiché si potrebbe ritenere che la
riserva assoluta di legge devia estendersi anche alle cause di giustificazione (anche se questa
tesi è da alcuni ritenuta da respingere, e dunque l’indirizzo giurisprudenziale consolidato
ritiene che il “dovere imposto da una norma giuridica” sia da intendere in senso lato,
comprendendo anche i regolamenti).
Inoltre, il dovere scriminante può essere dato anche da una fonte straniera, a patto che
l’ordinamento internazionale, cui si conforma l’ordinamento italiano secondo l’art. 10 Cost.,
esiga che questo dovere sia riconosciuto come valido anche dallo Stato italiano.
Dovere imposto da un ordine della pubblica Autorità: ossia imposto da una manifestazione
di volontà che un superiore rivolge ad un subordinato, ma è necessario che il rapporto di
subordinazione sia un rapporto di diritto pubblico, e non privato. La “pubblica Autorità” può
essere intesa in senso restrittivo, ricomprendendo solo i pubblici ufficiali, o in senso estensivo,
includendo anche gli incaricati di pubblici servizi legati da un rapporto di subordinazione o i
soggetti esercenti servizi di pubblica necessità.
Un ulteriore requisito è il fatto che l’ordine sia legittimo, e dunque che presenti:
1. Presupposti formali di legittimità: che attengono alla competenza del superiore ad
emanare l’ordina, dell’inferiore ad eseguirlo, e alla forma prescritta
2. Presupposti sostanziali di legittimità: che riguardano l’esistenza dei presupposti
legali per l’emanazione dell’ordine
Dall’ultimo comma dell’art. 51 c.p. si può indirettamente ricavare il fatto che il subordinato ha
comunque il potere di sindacare la legittimità dell’ordine, poiché questo comma esclude la
punibilità dell’esecutore di un ordine illegittimo, quando la legge non gli consente di sindacare sulla
sua legittimità, in tutti gli altri casi, quindi, è la regola. La dottrina ritiene che normalmente sia compito
del subordinato controllare la conformità dell’ordine ai presupposti formali e sostanziali di legittimità.
Il potere di sindacato del subordinato può estendersi alla legittimità sostanziale dell’ordine entro certi
limiti, ossia finché la verifica dei presupposti di legittimità non coinvolga apprezzamenti di merito
riservati per legge al superiore. Per verificare i limiti del potere di sindacato del subordinato bisogna
considerare dunque la natura dell’ordine e il tipo di rapporto tra inferiore e superiore (maggiore è la
distanza tra le due posizioni gerarchiche, minore sarà il potere di sindacato).
Se il controllo di legittimità non viene fatto dai subordinati legittimati a farlo, allora secondo l’art. 51
comma 3 anche loro rispondono penalmente dell’eventuale reato commesso eseguendo l’ordine,
infatti del fatto commesso risponde sempre chi ha dato l’ordine (art. 51.2), e il legislatore dispone
altresì che risponda chi ha eseguito l’ordine (art. 51.3). La regola patisce, tuttavia, due eccezioni:
1. L’esecutore abbia per errore di fatto ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo: costituisce
un’applicazione di specie dei principi generali in tema di errore, per cui nel concetto di errore
di fatto deve farsi rientrare anche l’errore su legge extrapenale.
62
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
2. La legge non gli consentisse alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine, cd. ordini illegittimi
vincolanti. Si fa qui riferimento alle ipotesi di rapporti di subordinazione di natura militare o
assimilabile, in cui la legge impone all’inferiore più stretta e pronta obbedienza. La punibilità
dell’esecutore viene meno per ragioni di fondo che attengono al piano della colpevolezza, in
quanto in questi casi l’esecutore non gode della normale libertà di autodeterminazione
necessaria per esigere un comportamento diverso conforme al diritto. Sulla stessa scia, la Corte
Costituzionale ha negato (sent. 123/1972) che tale esenzioni integri una causa di
giustificazione, riconducendola, invece, ad una causa personale di esenzione da responsabilità.
In questa seconda ipotesi, l’insindacabilità dell’ordine vincolane è però in realtà soltanto
relativa, in quanto riguarda la loro legittimità sostanziale, mentre rimane sindacabile la
legalità esteriore dell’ordine.
Sia la dottrina che la giurisprudenza concordano, attualmente, nell’ammettere che vi è un
limite all’impossibilità di sindacare la legittimità sostanziale dell’ordine vincolante, e questo
limite è la manifesta criminosità dell’ordine, ricavato per analogia da un limite che era
esplicitamente contenuto dall’abrogato arti. 40 del codice penale militare e ora previsto
dall’art. 4 delle nuove norme di principio sulla disciplina militare.
LEGITTIMA DIFESA
L’art. 52 comma 1 c.p. dispone che non è punibile chi ha commesso il fatto poiché costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre
che la difesa si proporzionata all’offesa.
La legittima difesa, quindi, ruota attorno ai due comportamenti dell’aggressione e della reazione.
La minaccia, e dunque l’aggressione, deve essere:
Una condotta umana, mentre può provenire da animali o cose solo se è individuabile un
soggetto tenuto ad esercitare su di essi una vigilanza. Il pericolo può anche derivare da una
condotta omissiva, come nel caso del rifiuto del proprietario di un cane di richiamarlo quando
aggredisce qualcuno, il quale è autorizzato per legittima difesa anche ad impugnare un’arma
per obbligare il padrone ad allontanare il cane.
L’aggressione giustifica la reazione difensiva anche se l’aggressore è un soggetto immune o non
imputabile, poiché l’antigiuridicità della condotta per l’applicazione dell’art. 52 rileva in
termini oggettivi, a prescindere che la specifica illiceità penale venga meno per difetto di
requisiti di natura soggettiva.
L’attacco delle inoltre riguardare un diritto (inteso come qualsiasi interesse giuridicamente
tutelato) altrui
Un ulteriore requisito è il fatto che l’aggressione deve provocare un pericolo di offesa attuale,
e dunque né passato né futuro, ma incombente. Deve farsi rientrare in tale nozione anche
l’ipotesi di pericolo perdurante, non solo per i reati permanenti, ma anche in quei casi nei quali,
non essendosi del tutto esaurita l’offesa, non si è ancora completato il trapasso della situazione
di pericolo a quella di danno effettivo.
La giurisprudenza e la dottrina ritengono, nel silenzio del legislatore, che la legittima difesa
non si possa invocare se la situazione di pericolo viene volontariamente cagionata dal soggetto
che reagisce (es. provocatore o chi raccoglie la sfida). Tale principio è desumibile dalla ratio
sottesa all’art. 52, ma non viene specificatamente inclusa nella lettera dell’articolo, cosa che
avviene unicamente per lo stato di necessità, di cui all’art. 54 c.p.
Offesa ingiusta è, secondo l’interpretazione prevalente, quella provocata contra jus, ossia
l’offesa antigiuridica, arrecata in violazione delle norme che tutelano l’interesse minacciato.
Tuttavia, va notato che l’estremo dell’antigiuridicità è già implicito nel concetto di offesa ad un
diritto o interesse protetto, e dunque se si vuole attribuire ad “ingiustizia” un significato
autonomo è meglio ritenere che l’offesa ingiusta sia un’offesa che oltre a minacciare un diritto
altrui, non è espressamente facoltizzata dall’ordinamento, e non può per questo invocare
63
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
legittima difesa chi pretende di reagire contro una persona che agisca a sua volta nell’esercizio
di una facoltà legittima espressamente stabilita dall’ordinamento o nell’adempimento di un
dovere.
La reazione è giustificata solo se presenta due requisiti:
La difesa deve essere necessaria per salvaguardare il bene in pericolo, e dunque la reazione
deve essere inevitabile (e non quindi sostituibile da un’altra meno grave). Il requisito della
necessità è un requisito non assoluto, ma relativo, perché si deve tenere conto delle circostanze
del caso concreto.
Ci si chiede se possa essere considerata legittima difesa anche quando la persona aggredita
possa mettersi in salvo con la fuga, e un’opinione diffusa soprattutto nel passato distingue tra
la fuga e il commodus discessus, e in questo senso si sarebbe tenuti a fuggire solo quando le
modalità della ritirata siano tali da non rendere vile il soggetto aggredito, mentre in caso
contrario l’aggressore dovrebbe sopportare le conseguenze della sua condotta illecita. Questa
interpretazione è però poco attuale, dal momento che al giorno d’oggi non vi è una sensibilità
per l’onore come quella che vi era in passato. Il rapporto con la fuga va piuttosto risolto
tenendo conto del bilanciamento degli interessi: il soggetto non è tenuto a fuggire quando la
fuga esporrebbe beni suoi personali o di terzi a rischi maggiori di quelli incombenti sui beni
propri del soggetto contro cui ci si difende.
La difesa deve inoltre essere proporzionata all’offesa. Tuttavia, un punto di vista oggi in via
di superamento considera che la proporzione debba intercorrere tra i mezzi difensivi a
disposizione dell’aggredito e quelli effettivamente impiegati, e dunque si potrebbe in questo
senso considerare legittima difesa una difesa che supera l’offesa, ma che è l’unica a
disposizione del minacciato. A questa teoria si oppone il fatto che è lo stesso articolo 52 a dire
che la proporzione è tra offesa e difesa, e per “offesa” non si può intendere quella operata per
difendersi. Inoltre, sarebbe particolarmente sbagliato ammettere che sia concesso difendersi
ledendo un diritto quale ad esempio la vita, anche se l’offesa subita è ad un diritto di rango
inferiore quale ad esempio un diritto patrimoniale, e dunque il punto di vista precedentemente
indicato viene dai più considerato da respingere.
Il raffronto tra i beni in conflitto non va operato considerando i beni stessi come entità astratte
e statiche, ma ava effettuato tenendo conto del rispettivo grado di messa in pericolo o di
lesione cui sono esposti gli interessi dinamicamente confliggenti nella situazione concreta (es.
può apparire lecito infliggere una ferita curabile per mettere al sicuro un patrimonio di rilevate
entità).
I criteri di valutazione invocabili richiamano:
1. Conflitto tra beni omogenei: si dovranno confrontare il rispettivo grado di lesività
dell’azione aggressiva e dell’azione difensiva
2. Conflitto tra beni eterogenei: bisognerà, a meno che il rapporto gerarchico non sia
particolarmente evidente, ricorrere ad indicatori come l’eventuale rilevanza
costituzionale del bene, la valutazione del legislatore penale con l’entità della sanzione
prevista in caso di sua violazione, ecc.
Tuttavia, bisogna sempre considerare anche il confronto tra i gradi di offesa.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 59 stabilisce la legittima difesa putativa, per cui se l’agente ritiene per
errore che sussista una causa di giustificazione, in assenza di colpa, questa è valutata a suo favore.
La legge n. 59 del 13 febbraio 2006 ha innovato la disciplina della legittima difesa, aggiungendo due
nuovi commi all’art. 52 per regolamentare il diritto all’autotutela in un privato domicilio per
aumentarne i presupposti della legittima difesa. Con questa legge è stata modificata la disciplina del
requisito della proporzione, nel senso che quando la difesa è nei confronti di una persona che si è
introdotta nella propria dimora privata, allora il giudice è dispensato dal verificare la proporzione tra
offesa e difesa, poiché essa viene presunta juris et de jure.
Questa riforma è stata da alcuni criticata sia per il rischio che il messaggio veicolato sia quello di una
64
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
concessione della “licenza di uccidere” ladri che si introducono nella propria casa o negozio, sia perché
la riforma rischia di incentivare l’aggressività dei ladri a causa della possibilità di maggiore
aggressività concessa alle potenziali vittime. La riforma risulta comunque fallimentare dal punto di
vista della tecnica normativa, poiché non riesce ad indicare precisamente come il padrone di casa o
negozio possa reagire legittimamente, ed ogni sua possibile interpretazione si espone a riserve
critiche.
Il nuovo art. 52 comma 2 dispone che nei casi previsti dall’art. 614 commi 1 e 2 sussiste il rapporto di
proporzione di cui all’art. 52 comma 1 se qualcuno legittimamente presente in una privata dimora o un
qualsiasi luogo in cui si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, usa un’arma
legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo, per difendere la propria o altrui incolumità, o i beni
propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Le particolarità qui sono:
il particolare ambiente in cui deve avvenire l’effrazione
il fatto che deve sussistere una violazione di domicilio ex art. 614 c.p.
il fatto che tra i requisiti non vi è la proporzionalità tra offesa e difesa
Il nuovo art. 52 comma 3, infine, aggiunge che la disposizione di cui al secondo comma si applica
anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale.
Continuano, quindi a sussistere, i presupposti della legittima difesa, quali la necessità di difendersi e il
pericolo attuale di una offesa ingiusta, ma viene meno la necessità di valutare la sussistenza di
proporzione, che si presume.
Quanto al contesto, occorre che a necessità di difesa sia provocata da un aggressore che commetta, nel
contempo, una violazione di domicilio ex art. 614: si deve trattare o di un estraneo che si introduce
arbitrariamente nell’abitazione altrui (o in altro luogo privato) o di una persona che vi si intrattiene
contro la volontà dell’avente diritto.
L’articolo dice che contro l’intruso è consentito usare un’arma o un altro mezzo idoneo alla difesa,
purché siano presenti le condizioni indicate alle lettere a) e b), ossia che l’arma venga usata per
difendere la propria o altrui incolumità, o i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è
pericolo di aggressione:
A. La difesa deve avere ad oggetto la propria o altrui incolumità, ossia i beni della vita e
dell’integrità fisica, poiché in questo caso vi è omogeneità quantitativa tra i beni personali che
l’aggredito difende e i beni che egli lede con l’uso delle armi, ma è importante e nuovo il fatto
che questa omogeneità non deve essere accertata dal giudice, poiché se ricorrono i presupposti
del secondo comma essa viene presunta. Questa proporzionalità presunta può però portare ai
rischi già esposti, e per evitare o attenuare la possibilità che ciò accada alcuni propongono di
controbilanciare la presunzione legislativa della proporzione con una scrupolosa ed adeguata
ricostruzione del requisito della necessità di difendersi, e sarebbe in questo senso
considerabile necessaria soltanto la difesa non sostituibile con una meno lesiva. In questo
modo, però, si eluderebbe la portata innovativa della riforma.
B. La difesa può anche avere ad oggetto i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi
è pericolo di aggressione: il senso di questa formula non è di concedere una licenza di
uccidere o ferire l’intruso che si limita ad aggredire beni patrimoniali, poiché ciò non
rispetterebbe i valori costituzionali. Il senso da trarre è differente in quanto la legittimità
dell’impiego dell’arma è subordinata alla presenza dei requisiti della non desistenza
dell’aggressore, e della sussistenza di un pericolo di aggressione. Sorgono però dubbi
sull’interpretazione della non desistenza: è infatti implicito che l’intruso non voglia desistere
dall’entrare in luogo privato, ma si richiede qualcosa di più, che da alcuni è stato identificato
con un avvertimento da parte dell’aggredito prima di difendersi, a seguito del quale, in caso di
desistenza, il ladro dovrebbe tollerare la risposta della persona offesa. Tuttavia, la proposta di
introdurre un vero e proprio invito a desistere è stata accantonata durante i lavori preparatori
per evitare di peggiorare la situazione della vittima dell’aggressione, che si sarebbe in questo
caso esposta a rischi maggiori.
65
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Perché l’aggredito possa legittimamente reagire con mezzi incisivi occorre inoltre il pericolo
di aggressione, e l’interpretazione più plausibile di questo requisito è che il pericolo debba
trascendere la sfera dei beni patrimoniali e riguardare la vita o l’integrità personale della
persona aggredita, secondo il principio di corrispondenza qualitativa tra beni offesi e difesi.
Tuttavia, rimane da chiedersi se il pericolo di aggressione debba essere attuale, e la risposta
privilegiata è quella affermativa poiché è l’interpretazione costituzionalmente più conforme. È
stato però obiettato che questa interpretazione finisce con il vanificare il significato pratico
dell’innovazione legislativa, poiché praticamente richiederebbe ciò che già prima della riforma
veniva richiesto per la legittima difesa, mentre si dovrebbe invece ritenere che la persona il cui
domicilio venga violato possa reagire già di fronte ad una situazione di aggressione attuale al
patrimonio che lascia però presagire un pericolo futuro alla propria persona o ad un’altra.
Tuttavia, questa interpretazione rischia a sua volta di vanificare la rilevanza pratica del
requisito del pericolo di aggressione, infatti nella maggior parte dei casi concreti non è in
astratto escludibile la possibilità che l’intruso, scoperto, aggredisca la persona, dunque se non
si può mai escludere il pericolo di aggressione come pericolo eventuale o futuro, allora con
l’interpretazione appena esposta si finisce con l’autorizzarsi quasi sempre l’aggredito a reagire
uccidendo o ferendo l’aggressore.
Vi è anche ci propone di controbilanciare l’interpretazione del pericolo di aggressione come
pericolo anche eventuale con una ricostruzione ristretta del requisito della necessità di
difendersi. Tuttavia, le obiezioni a questa proposta riguardano non soltanto la presunzione
normativa della proporzionalità, ma anche il fatto che non sembra plausibile pretendere
dall’aggredito la scelta del mezzo difensivo comparativamente meno lesivo.
In conclusione si può dunque dire che anche nell’ipotesi B una difesa violenta si considera
legittima se vi è un pericolo incombente ai beni personali del soggetto che si difende, e anche in
questo caso la presunzione legislativa di proporzione si riferisce solo al rapporto tra la
rispettiva entità dei danni ai beni oggetto dell’offesa e della difesa.
Va comunque ricordato che sia nell’ipotesi A sia nell’ipotesi B sono comunque richiesti i requisiti della
presenza legittima della persona che si difende all’interno del luogo chiuso in cui il malvivente si è
introdotto, e della legittima detenzione dell’arma utilizzata (se l’arma è illegittimamente detenuta
ma sussiste la proporzionalità, allora colui che si è difeso potrà comunque avvalersi della legittima
difesa sulla base dell’art. 52 comma 1).
USO LEGITTIMO DI ARMI
L’art. 53 comma 1 c.p. stabilisce che, ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non
è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio fa uso o ordina di
fare uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di
respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità, o comunque di impedire la
consumazione di una strage, naufragio, sommersione, disastro aereo o ferroviario, omicidio volontario,
rapina a mano armata e sequestro di persona.
Soltanto nel 1930 l’uso legittimo delle armi è diventato una autonoma causa di giustificazione, mentre
prima essa veniva ricompresa entro la legittima difesa, lo stato di necessità, o l’adempimento di un
dovere legale.
All’art. 53 si dice però anche “ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti”, e da questa
clausola di riserva si desume che la causa di giustificazione dell’uso delle armi ha natura sussidiaria,
nel senso che si applica solo quando non vi siano i presupposti per la legittima difesa o l’adempimento
del dovere.
È necessario, oggi, interpretare la causa di giustificazione in maniera restrittiva, cioè conforme ai
principi che caratterizzano il nuovo ordinamento democratico:
“Pubblico ufficiale”: anche se l’articolo potrebbe essere soggetto ad un’interpretazione che
ricomprenda tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione, l’interpretazione preferibile
66
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
è quella restrittiva, che considera questa causa esimente come valida soltanto per gli agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e per i militari in servizio di Pubblica sicurezza.
Il secondo comma stabilisce che la causa di giustificazione si possa applicare anche a chiunque
persona che presti assistenza al pubblico ufficiale perché richiesta legalmente da quest’ultimo.
Il fine perseguito deve essere quello di “adempiere un dovere del proprio ufficio”, quindi la
scriminante è esclusa in presenza di uno scopo di vendetta o di arbitraria sopraffazione.
“Necessità”: secondo questo articolo, dunque, la scriminante in esame deve essere l’extrema
ratio per il pubblico ufficiale, dal momento che può ricorrere alla coazione fisica solo di fronte
alla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità.
“Violenza”: la violenza deve comunque essere un comportamento attivo che ostacola
l’adempimento di un dovere d’ufficio, e deve inoltre essere un comportamento in atto in quel
momento. Inoltre, mentre può ritenersi che la “violenza” comprenda anche la minaccia (si
ritieme, infatti che ricomprenda anche la coercizione psichica), è più dubbio se la “resistenza”
debba necessariamente essere attiva, infatti non sempre la resistenza passiva (ad esempio
resistenza pacifica o fuga) deve escludere l’applicabilità dell’art. 53, infatti si dovrebbe
piuttosto richiedere un rapporto di proporzione tra i mezzi di coazione e il tipo di resistenza da
una parte, e i beni in conflitto dall’altra (es. non si spara alle donne sui binari).
Con l’art. 14 della legge n. 152 del 22 maggio 1975 sono state aggiunte all’art. 53 le parole “e
comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro
aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.
Tuttavia, va notato che nel concetto di “violenza” dovrebbero logicamente essere ricompresi anche i
delitti specificati, e dunque l’uso di armi del pubblico ufficiale sarebbe stato giustificato anche in
precedenza per questi delitti. Se si volesse invece attribuire una funzione autonoma a questa
innovazione, si dovrebbe ritenere che con essa si voglia autorizzare l’uso delle armi per impedire la
consumazione di questi delitti anche in una fase antecedente a quella in cui sono ravvisabili gli estremi
dell’idoneità e univocità degli atti come elementi del tentativo punibile. Da questa interpretazione
nascono però perplessità, in quanto consente l’uso delle armi anche senza un effettivo pericolo per i
beni presi di mira.
Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 53 si riferisce alle ulteriori ipotesi di uso legittimo della coazione
fisica previste dalla legislazione speciale.
STATO DI NECESSITÀ
L’art. 54 comma 1 c.p. stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona (pericolo
che non deve essere stato volontariamente da lui causato, e che deve essere non altrimenti evitabile),
sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo.
Lo stato di necessità è differente dalla legittima difesa:
1. la necessità vi è quando si reagisce per sottrarsi ad un pericolo di danno grave alla persona,
mentre la legittima difesa si ha quando vi è una minaccia di offesa di un nostro diritto
2. la difesa non ricade sull’aggressore ma su un terzo estraneo che non ha provocato il pericolo, il
quale viene nella maggior parte di questi casi provocato dalla natura
Lo stato di necessità è stato a lungo considerato una causa di esclusione della colpevolezza dalla
dottrina, dal momento che si considerava che non fosse possibile un comportamento diverso da quello
tenuto, quando qualcuno si trovasse minacciato da una situazione di pericolo. Tuttavia, va detto che
certamente non si potrebbe tenere un comportamento differente nel caso in cui ad essere minacciata
fosse la propria persona o un congiunto o una persona vicina, ma non si può dire lo stesso del caso in
cui ad essere minacciato fosse un estraneo, e non si vedrebbe dunque perché escludere la colpevolezza
di chi agisse per salvare una persona non a sé vicina.
La dottrina dominante ha dunque abbandonato il terreno della colpevolezza, rinvenendo la ratio dello
stato di necessità nella mancanza di interesse dello Stato a salvaguardare uno o l’altro dei beni in
67
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
conflitto, posto che nella situazione data uno dei beni soccomberà, ma in base al principio del
bilanciamento degli interessi il bene sacrificato sia di rango inferiore o equivalente o di poco superiore
a quello salvato.
Si possono comunque spiegare separatamente le ipotesi della messa in salvo dello stesso agente o una
persona vicina, e quella della messa in salvo di un estraneo, riconducendo e spiegando il fondamento
dell’esenzione della pena nel caso di soccorso di necessità (difesa di un bene di un terzo) con il
bilanciamento degli interessi, e ricercando invece la ratio dello stato di necessità cogente con
l’inesigibilità psicologica di una condotta diversa, con conseguente esclusione della colpevolezza.
I requisiti della scriminante dello stato di necessità sono:
Pericolo attuale: analogamente a quanto viene richiesto per la legittima difesa. Il pericolo non
va però sempre calcolato sulla base del criterio temporale, in quanto possono esservi
circostanze in cui è necessario agire anticipatamente. Il pericolo deve inoltre essere un
pericolo non volontariamente causato né altrimenti evitabile:
1. Volontariamente causato: si intende anche la situazione di pericolo dovute alla
semplice colpa, proprio perché si richiede che il pericolo sia involontario.
2. Non altrimenti evitabile: nell’ambito dello stato di necessità non solo può scrutinare
solo il comportamento che arreca il minore danno al terzo coinvolto senza colpa, ma
che la valutazione dell’inevitabilità va effettuata con criteri più rigorosi che non nella
legittima difesa (ad esempio la fuga è in questo caso sempre da preferire all’offesa ad
un innocente, a meno che essa non esponga a pericoli maggiori l’agente o terzi).
Nella giurisprudenza della Corte di cassazione, inoltre, si trova un’interpretazione
molto rigorosa del requisito della inevitabilità-altrimenti del pericolo, tanto che essa ha
per lo più ritenuto inapplicabile l’art. 54 c.p. in caso di bisogno economico, ritenendo
che in queste circostanze si possano comunque trovare delle alternative alla condotta
criminosa. Nella realtà ciò non sempre è possibile, e dunque è necessario procedere ad
un’analisi caso per caso.
Danno grave alla persona: a questo proposito una tesi minoritaria ritiene che per “persona”
si intendano i soli beni della vita e dell’integrità fisica, mentre la tesi maggioritaria tende ad
ampliare i beni di natura personale inclusi, fino ad arrivare a quelli relativi alla personalità
morale dell’uomo. Anche all’interno della tesi maggioritaria vi sono però delle discordanze, in
quanto non vi è uniformità nell’individuazione dei beni, tanto che alcuni escludono alcuni dei
beni della personalità morale come ad esempio l’onore, oppure il pudore. Poiché oggi ci si
aspetta una tutela della sfera della personalità umana il più ampia possibile, bisogna
probabilmente evitare restrizioni aprioristiche nell’interpretazione del danno alla persona,
poiché esso è idoneo a ricomprendere qualsiasi lesione minacciata ad un bene personale
giuridicamente rilevante.
Il danno deve essere grave, e la gravita si può determinare con:
1. Criterio qualitativo: considerando il rango del bene minacciato
2. Criterio quantitativo: considerando il grado di pericolo che incombe sul bene
Proporzionalità tra fatto e pericolo: per essere calcolata deve tenere conto del rapporto tra i
valori dei beni confliggenti, e dunque sussiste un rapporto di proporzione tra fatto e pericolo
se il bene minacciato prevale rispetto a quello sacrificato o gli equivale. Tuttavia, questa
interpretazione della proporzionalità rischia di risultare troppo restrittiva, infatti pretende di
ridurre il giudizio di equivalenza ad un raffronto tra i beni in conflitto concepiti come entità
statiche, escludendo dalla prospettiva della proporzione tutti gli altri significativi elementi che
contribuiscono a caratterizzare la situazione concreta, come la necessità o inevitabilità della
difesa, l’attualità del pericolo, ecc.
Per superare questo difetto è necessario allora integrare il raffronto del valore dei beni con
l’esame comparativo dei rischi per il bene da salvaguardare e quello del terzo che viene
aggredito, infatti se ad esempio il bene x è di rango superiore al bene y, ma il grado di offesa al
68
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
bene y è superiore a quello di x, allora si può integrare il confronto dei beni con quello dei
rischi è adottare il criterio in base al quale:
A. quando il rischio maggiore è quello gravante sull’interesse del terzo innocente, il
rapporto di valore tra i beni deve essere proporzionalmente a vantaggio di quello da
salvaguardare
B. quando invece il bene di maggior peso è quello aggredito, il rapporto tra i rischi deve
essere proporzionalmente a vantaggio di quello salvaguardato
Ci si potrebbe chiedere se lo stato di necessità dell’art. 54 possa essere invocato anche dagli organi
pubblici per giustificare interventi autoritativi che esulano dai poteri loro formalmente attribuiti, e la
risposta deve essere in linea di massima negativa, in quanto il conflitto di interessi tra Stato e cittadini
viene regolato dal diritto pubblico, e concedere spazio allo stato di necessità significherebbe dunque
rinunciare al rispetto del principio di legalità nell’operato degli organi pubblici.
Il soccorso di necessità viene contemplato dall’art. 54 comma 1, ed esso sussiste quando l’azione
necessitata viene compiuta non dal soggetto minacciato, ma dal soccorritore. Non sempre però il
soccorso di necessità rientra nello stato di necessità, infatti può talvolta essere ricompresi nella
scriminante dell’adempimento di un dovere (come per l’obbligo di soccorso dell’art. 593).
L’art. 54 comma 2 stabilisce che la scriminante dello stato di necessità non si applica a chi ha un
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo, come per i vigili del fuoco. Tuttavia, si deve
comunque ritenere che lo stato di necessità possa applicarsi se chi ha un particolare dovere di esporsi
al pericolo realizza un’azione necessitata per salvare non sé stesso ma un terzo.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 54 estende la causa di giustificazione anche ai casi in cui lo stato di
necessità è determinato dalla minaccia di un terzo, e dispone anche che in questo caso a rispondere
del fatto commesso dalla persona minacciata è la persona che l’ha costretta a commetterlo, e questo
poiché ci si trova all’interno dell’ipotesi della coazione morale. Si considera, nonostante il codice non lo
espliciti, che anche per l’effetto scriminante della coazione morale siano necessari tutti i requisiti dello
stato di necessità.
Va infine precisato che ai sensi dell’art. 2045 c.c. le conseguenze sanzionatorie di stato di necessità e
legittima difesa sono diverse, in quanto in caso di stato di necessità al danneggiato è dovuta
un’indennità (a differenza di quanto avviene per la legittima difesa) stabilita con equo apprezzamento
dal giudice, e questo perché l’azione necessitata danneggia un soggetto innocente, mentre la situazione
della legittima difesa è differente.
ART. 131 BIS: PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
L’art. 131 bis c.p. afferma che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è
esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai
sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non
abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha
agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,
ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della
stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute,
la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Questo istituto si presenta come una causa di esclusione della punibilità in senso stretto, poiché
presuppone la sussistenza di un reato, integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.
La ragion d’essere di questa esclusione di pena risiede nella non opportunità di punire fatti non
meritevoli di sanzione penale, nel rispetto dei principi di proporzione e sussidiarietà della sanzione
penale e del principio di offensività.
Si ritiene che l’istituto sia applicabile anche al delitto tentato, con riferimento al massimo edittale
proprio del delitto tentato.
69
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Poiché la tenuità del fatto va valutata con riferimento a tutti i criteri ex art. 133 comma 1 c.p., questa
potrà risultare esclusa dall’intensità del solo elemento soggettivo, stante il fatto che l’art. 133
menziona, al primo comma, l’intensità del dolo e il grado della colpa.
Proprio perché l’istituto impone valutazioni sulla singola persona, in giurisprudenza si ritiene che
questa causa di esclusione della punibilità abbia natura mista, riflettendo principalmente l’opportunità
di non punire la singola persona, non risultando perciò estendibile ai concorrenti, in forza
dell’applicazione dell’art. 119 primo comma.
70
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO TRE
COLPEVOLEZZA
Il fatto commissivo, per essere punibile, deve essere non soltanto tipico e antigiuridico, ma anche
colpevole, e per questo la colpevolezza è il terzo elemento costitutivo fondamentale del reato.
Il principio di colpevolezza assume un ruolo centrale nel nostro ordinamento, tanto che esso viene
desunto dall’art. 27 Cost. secondo un’interpretazione molto seguita che vede nel principio della
responsabilità penale non il semplice significato di divieto di responsabilità per fatto altrui, ma quello
di responsabilità soltanto per fatto proprio colpevole. A questa interpretazione aderisce anche la Corte
costituzionale (sent. 364/88)f, che ha chiarito che il reato si può imputare all’agente soltanto se egli
può essere considerato colpevole, e ove anche un solo elemento sia sganciato dal concetto di colpa o di
dolo, allora viene meno il carattere personale dell’addebito, ed un’eventuale attribuzione di
responsabilità penale contrasterebbe in questo caso con l’art. 27 comma 1 Cost.
Il ruolo della colpevolezza viene inoltre confermato in Costituzione dall’art. 27 comma 3 che dispone
la finalità rieducativa della pena: una persona deve essere rieducata soltanto se si è dimostrata
colpevole di un atto penalmente sanzionato, altrimenti non vi sarebbe un motivo per cui doverla
rieducare. Nel nostro ordinamento, dunque, non viene punita una persona anche per casi fortuiti (cosa
che implicherebbe l’accettazione dell’idea della responsabilità oggettiva, o responsabilità per evento),
ma la si punisce soltanto quando la si considera colpevole, ossia quando è presente il dolo
(volontarietà del fatto) o la colpa (involontarietà del fatto). Va infatti chiarito che in un diritto penale
come il nostro, ispirato ai principi oggettivi di materialità e lesività, la colpevolezza può soltanto
significare colpevolezza per il fatto lesivo di un bene penalmente protetto, e non può dunque essere
accettata la colpa d’autore, ossia la colpevolezza per il carattere e/o per la condotta di vita.
Il concetto di colpevolezza di contrapporne tradizionalmente a quello di pericolosità sociale, e
mentre la colpevolezza riguarda solo i soggetti capaci di intendere e di volere ed esprime un
rimprovero per la commissione di un fatto delittuoso, la pericolosità sociale riguarda la personalità
dell’autore e fa riferimento piuttosto alla probabilità che egli commetta un reato in futuro, e questo
giustifica una misura di sicurezza. Questa distinzione è facile in astratto, ma sul piano concreto rischia
di essere di più difficile applicazione, e questo per vari motivi: la prassi giurisprudenziale è spesso
quella di dare giudizi sintetici ed unitari che non distinguono tra l’atteggiamento psicologico riferito al
singolo reato commesso e la complessiva personalità dell’autore, e inoltre esistono istituti nel nostro
ordinamento che presentano una natura ibrida o bifronte, come quello della capacità a delinquere che
il giudice deve valutare per commisurare la pena.
CONCEZIONI DELLA COLPEVOLEZZA
CONCEZIONE PSICOLOGICA
Le concezioni della colpevolezza vengono storicamente influenzate non solo da ragioni dogmatiche
interne alla costruzione sistematica del reato, ma anche da presupposti di fondo desunti sia dal
generale contesto politico-ideologico di riferimento, sia dal modo di intendere gli scopi e le funzioni
del diritto penale.
La prima concezione della colpevolezza è la concezione psicologica, la quale risulta manifestamente
influenzata dal liberalismo dominante nel secondo ottocento e viene propugnata dai penalistici classici
italiani, che la caricano di una valenza garantistica. Secondo la concezione psicologica della
colpevolezza quest’ultima consiste in una relazione psicologica tra fatto e autore, esprimendo così
da un lato l’idea che la responsabilità penale richiede il presupposto di una partecipazione psicologica
alla commissione del fatto, ed esprimendo dall’altro l’esigenza di circoscrivere la colpevolezza all’atto
di volontà relativo al singolo reato, a prescindere da qualsiasi valutazione della personalità
complessiva dell’agente e del processo motivazionale che sorregge la condotta. Si può dunque vedere
l’origine illuministico-liberale della concezione psicologica, per la quale la colpevolezza non ammette
di per sé graduazioni in funzione delle caratteristiche personali del reo, perché tutti gli individui vanno
71
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
astrattamente considerati come uguali, e vanno dunque giudicati in base a criteri oggettivi, ossia
facendo leva più sull’identità del danno che sulla loro personalità.
La concezione psicologica della colpevolezza è stata criticata perché:
1. sul piano dogmatico non riesce a fornire un concetto superiore davvero in grado di
comprendere dolo e colpa, poiché il dolo consiste in coscienza e volontà come atteggiamenti
psicologici effettivi, mentre per la colpa bastano anche atteggiamenti psicologici potenziali
2. sul piano funzionale non valorizza tutte le potenzialità della colpevolezza come elemento di
graduazione della responsabilità penale, poiché non considera le diverse motivazione che
possono spingere il reo a delinquere
CONCEZIONE NORMATIVA
La concezione normativa della colpevolezza è nata per superare le obiezioni a quella psicologica e per
soddisfare pressanti esigenze pratiche imposte al diritto penale anche dalla progressiva entrata in crisi
dell’impostazione retributiva vetero-liberale rigidamente legata al solo disvalore obiettivo del fatto
commesso. Con questa concezione si mira a ridare peso alle motivazioni e alle circostanze dell’azione,
dal momento che non tutte le azioni volontarie meritano una punizione, e non tutte le azioni
involontarie meritano di essere lasciate impunite. La concezione normativa pare dunque adatta a
fornire un concetto di colpevolezza idoneo a fungere anche da criterio di commisurazione
giudiziale della pena.
La colpevolezza seconda la concezione normativa consiste nella valutazione “normativa” di un
elemento psicologico, e cioè nella rimproverabilità dell’atteggiamento psicologico dell’autore.
L’idea di colpevolezza in senso penalistico non rappresenta più un fondamento teorico della
concezione retributiva della pena, ma essa finisce piuttosto con l’assolvere una funzione “limitativa”
delle istanze preventive, ossia la funzione di argine garantistico delle libertà del singolo.
La concezione normativa della colpevolezza, pur con qualche discordanze, viene oggi accolta dalla
dottrina dominante, in particolare quella tedesca.
ORIENTAMENTI ATTUALI
Mentre in passato la colpevolezza era legata alla teoria retributiva della pena perché la retribuzione
presuppone una colpevolezza da correggere, oggi questa teoria e l’idea di colpevolezza hanno subito
un’insuperabile frattura. Questa frattura ha richiesto una nuova giustificazione della categoria della
colpevolezza, la quale non può prescindere dallo scopo che viene assegnato oggi alla sanzione punitiva,
ossia la protezione dei beni giuridici garantita attraverso la prevenzione generale e speciale.
Dunque, bisogna individuare la funzione della colpevolezza all’interno di un ordinamento penale
orientato verso la prevenzione: quello che si chiede è però, se la concreta inflizione della pena è
condizionata da esigenze preventive che si aggiungono all’accertamento della colpevolezza, quale sia la
vera ragion d’essere della categoria della colpevolezza in un diritto penale della prevenzione, o se per
caso essa sia sopravvissuta grazie ad una sorta di compromesso con il vecchio diritto penale
retributivo. Per rispondere a questo interrogativo bisogna prima distinguere se il discorso riguardi la
colpevolezza come presupposto della punibilità; ossia come elemento costitutivo del reato, o come
criterio di misura della pena.
Secondo una parte della dottrina contemporanea la colpevolezza come presupposto del reato
ha oggi una nuova legittimazione in virtù del suo rapporto di strumentalità rispetto alla
funzione preventiva della pena. Vi è infatti un evidente nesso di funzionalità che intercorre
tra la categoria della colpevolezza e la prevenzione sociale rieducatrice, come si è già detto in
precedenza. Inoltre, il fatto che il legislatore penale subordini la punibilità alla presenta di una
colpevolezza può in parte spiegarsi anche nell’ambito della prevenzione generale o deterrenza,
infatti la minaccia della pena deve fungere da appello rivolto alla coscienza del potenziale
delinquente per indurlo a desistere dal commettere reati, ma per fare ciò la commissione del
reato deve necessariamente rientrare nei poteri di controllo del soggetto, e dunque l’azione
criminosa deve avvenire con dolo o colpa del reo. Se infatti il legislatore punisse anche la
72
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
produzione di eventi lesivi dovuti al concorso di fattori inevitabili e imprevedibili, allora la
commissione del reato non sarebbe più nel controllo del soggetto, e la minaccia della sanzione
potrebbe così non avere più la sua efficacia deterrente (anche se va detto che questo potrebbe
in alcuni casi avere l’effetto contrario, nel senso che sapendo di poter essere incriminati anche
per fatti che non dipendono da sé stessi, si potrebbe essere indotti ad elevare i propri
standards di diligenza).
Se però il ricorso a forme di responsabilità oggettiva è idoneo a rafforzare la funzione general-
preventiva della pena, allora ne deriva che la prevenzione generale non implica la colpevolezza
quale presupposto del reato come condizione indefettibile; in questo caso la scelta di non
derogare mai al principio di colpevolezza deve basarsi su altre motivazioni di fondo, autonome
rispetto al piano dell’efficacia general-preventiva del sistema penale. Bisogna dunque
concludere che il principio di colpevolezza è inderogabile perché ha la funzione di argine
garantistico a presidio della certezza di libere scelte d’azione del privato, ossia per
circoscrivere la responsabilità a ciò che rientra nel potere di controllo del singolo.
La funzione individual-garantistica della colpevolezza risalta ancora di più nell’ambito della
commisurazione giudiziale della pena, ossia nella fase in cui il giudice stabilisce il concreto
trattamento punitivo da infliggere al condannato. Anche la scelta della sanzione per il caso
concreto non può non essere influenzata dagli stessi scopi di prevenzione generale e/o
speciale cui la pena è finalizzata nel nostro ordinamento, ma ci si chiede se la prospettiva della
prevenzione possa essere l’unico criterio- guida del giudice, e non sia cioè da considerare la
proporzionalità tra l’entità della pena e il grado di colpevolezza dell’illecito commesso.
Potrebbe infatti accadere che la pena inflitta superi il limite corrispondente all’entità della
colpevolezza individuale, ad esempio per aumentare la funzione deterrente della pena o per
massimizzare la funzione rieducativa, ma ci si deve chiedere se ciò sia legittimo. Se si
considerasse legittima questa pratica, allora la prevalenza accordata alle esigenze di
prevenzione sarebbe così netta da far passare ingiustificatamente in secondo piano
l’importantissima esigenza di proteggere il singolo da interventi dello Stato che superano il
grado di colpevolezza del reo, ledendo così l’autonomia e la dignità del singolo, la cui pena
verrebbe strumentalizzata per fini di politica criminale. Si capisce dunque che il principio di
colpevolezza ha una funzione limitativa della punibilità, perché il suo rispetto evita l’inflizione
di pene superiori al limite massimo corrispondente all’entità della colpevolezza individuale
La disputa odierna concerne anche la portata e i limiti della possibilità di agire diversamente come
presupposto di rimprovero di colpevolezza, e ci si chiede infatti se il giudice debba accertare il potere
individuale di agire altrimenti del soggetto concreto o se la possibilità di agire altrimenti vada invece
valutata sulla base del potere di un uomo medio. Sostengono vada valutata sulla base dell’uomo medio
coloro che pensano che il processo penale non sia in grado di accertare con esattezza la possibilità di
autodeterminazione dell’agente concreto, mentre insistono sulla necessità di valutare la capacità
individuale di agire diversamente quelli che temono che il riferimento all’uomo medio sottragga al
giudizio di colpevolezza ogni fondamento reale.
STRUTTURA DELLA COLPEVOLEZZA
La concezione normativa dominante afferma che è colpevole un soggetto imputabile che ha realizzato
con colpa o dolo la fattispecie obiettiva di un reato in assenza da circostanze tali da rendere
necessitata l’azione illecita.
I presupposti della colpevolezza sono dunque:
1. l’imputabilità
2. il dolo o la colpa
3. la conoscibilità del divieto penale
4. l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza
73
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Un problema su cui persiste controversia è la collocazione sistematica dell’imputabilità, intesa
come capacità di intendere e di volere, all’interno del reato. Tradizionalmente si è sostenuto che
l’imputabilità costituisca una qualificazione soggettiva estranea alla teoria del reato e rientrante
piuttosto nella teoria del reo (vi è chi la vede come uno status necessario per essere assoggettati alla
pena, chi come un aspetto della capacità giuridica penale, ecc.). Questa tesi deriva dal fatto che le
norme del codice penale che ricollegano i minimi di durata delle misure di sicurezza dell’ospedale
psichiatrico giudiziario e del riformatorio giudiziario alla gravità dei reati commessi (art. 222 e 224),
contengono un implicito riferimento all’intensità del dolo e al grado della colpa, e dunque ne deriva
che il legislatore ritiene dolo e colpa riferibili anche ai non imputabili; se le cose stanno così, allora la
dottrina che sostiene la tesi sopra citata ne deduce che l’imputabilità non può essere considerata
presupposto della colpevolezza, ma soltanto uno stato soggettivo che decide della sola assoggettabilità
a pena in senso stretto.
Questa tesi è però riduttiva, e pecca infatti di formalismo nel perdere di vista la relazione intima che
intercorre tra imputabilità e illecito penale, e per questo motivo una parte della dottrina italiana ha
recuperato la differente prospettiva che considera l’imputabilità ricompresa nell’ambito concettuale
della colpevolezza, e in questa prospettiva è proprio l’imputabilità intesa come maturità psicologica a
consentire di muovere un rimprovero al reo. Il fatto che l’imputabilità venga intesa come maturità
psicologica non impedisce che dolo e colpa possano essere considerati anche per gli incapaci di
intendere e di volere (ossia gli “inimputabili”), poiché dolo e colpa di questi soggetti non possono
coincidere con quelli del soggetto capace di intendere e di volere, infatti essi sono, a ben vedere, meri
stati psichici, e dunque, ad esempio, il dolo come volontarietà del fatto potrebbe non ricomprendere la
consapevolezza del suo significato offensivo.
1. IMPUTABILITÀ
L’imputabilità costituisce il primo presupposto del rimprovero di colpevolezza, costituendo la
condizione per esprimere la disapprovazione soggettiva del fatto tipico e antigiuridico commesso
dall’agente, e l’art. 85 c.p. la definisce come capacità di intendere e di volere.
La concezione che più corrisponde al senso comune non è quella di libertà del volere in senso
filosofico, ma quella di libertà del volere come libertà relativa, infatti il carattere “condizionato” della
libertà umana si rivela il più funzionale in una prospettiva penalistica poiché se le decisioni umane non
fossero codeterminate da cause che operano secondo leggi psicologiche, ma venissero dal semplice
arbitrio della volontà, allora non avrebbe più senso pretendere di influenzare la condotta dell’uomo
con la minaccia di pena, e dunque per il carattere deterrente del diritto penale è necessario che il
timore della punizione condizioni il soggetto a mantenere una condotta corretta.
L’imputabilità come categoria penalistica ha giustificazioni diverse, tra le quali non vi è soltanto lo
stretto rapporto con la colpevolezza, ma anche il fatto che essa è strettamente connessa anche alla
funzione della pena: se infatti la pena ha scopo rieducativo (prevenzione speciale), allora per essere
rieducato il soggetto deve necessariamente essere in grado di comprendere il significato della
sanzione punitiva, e se la minaccia della pena deve avere lo scopo di distogliere da delinquere gli altri
soggetti (prevenzione generale), allora i destinatari devono essere psicologicamente in grado di
lasciarsi motivare da questa minaccia. È proprio per questo motivo che non tutte le persone vengono
considerate in grado di avere questa attitudine a recepire l’appello della norma penale, e che per
questo non vengono considerate imputabili (minori fino ad un certo limite di età, infermi di mente,
ecc.).
Tuttavia, è da ricordare anche il fatto che negli ultimi decenni è diventato sempre più complicato
effettuare una distinzione netta tra i soggetti imputabili e quelli inimputabili. Negli ultimi trent’anni
circa è infatti da alcuni stato sostenuta l’equiparazione di infermi psichici agli altri soggetti, e dunque
l’eliminazione della categoria degli inimputabili (con, naturalmente, l’introduzione delle adeguate
misure ad assistenze medico- psichiatriche in carcere per gli infermi). Nonostante l’arcaico
trattamento riservato oggi agli infermi di mente, questa tesi va incontro all’obiezione che sostiene che
74
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
sì possa essere sbagliato supporre che il malato di mente sia sempre e totalmente privo della capacità
di avvertire il significato della pena strettamente intesa, ma che l’operazione che i soggetti sopra citati
si auspicano implica invece l’eccesso di presunzione opposto, ossia il presupporre che il malato di
mente abbia sempre questa capacità, mentre così non può naturalmente essere.
Non è dunque auspicabile una netta eliminazione del concetto di imputabilità, ma piuttosto una sua
ridefinizione attraverso la valorizzazione delle più aggiornate acquisizioni scientifiche, anche se ciò è
particolarmente complicato, anche per il dubbio sui limiti della legittimità di una nozione autonoma di
imputabilità che, senza essere rigidamente vincolata ai parametri di altre discipline, tenda soprattutto
a soddisfare le specifiche esigenze del diritto penale.
CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE
Il concetto di imputabilità è sia empirico, sia normativo, e dunque spetta innanzitutto alle scienze del
comportamento umano individuare i presupposti empirici richiesti perché un soggetto si possa
considerare capace di recepire il messaggio della sanzione, e ed è in un secondo momento compito del
legislatore fissare le condizioni di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle scienze empirico-sociali.
L’art. 85 c.p. fissa i presupposti dell’imputabilità nella capacità di intendere e di volere, che deve
sussistere nel momento in cui viene commesso il reato. Il legislatore fissa anche alcuni parametri
legalmente prederminati per l’imputabilità, come l’età del soggetto (artt. 97 e 98), l’assenza di
infermità mentale (art. 88), e altre condizioni che possono incidere sull’autodeterminazione
responsabile dell’agente quali sordismo, intossicazione alcolica cronica, ecc. (artt. 95 e 96).
Tuttavia, le cause di esclusione dell’imputabilità del codice penale non sono tassative, e dunque la
capacità di intendere e di volere può essere esclusa anche da fattori diversi da quelli previsti.
La capacità di intendere e di volere è comunque considerato un requisito unico, e dunque
l’imputabilità difetta anche se manca soltanto una sola delle capacità (anche se va detto che questa
separazione suscita le obiezioni di quanti sostengono che la psiche umana sia unitaria e le sue funzioni
si influenzino vicendevolmente). In ogni caso, considerandole separatamente:
Capacità di intendere: l’attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione
non distorta della realtà, ed è dunque la capacità di comprendere il significato delle proprie
azioni e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative sui terzi
Capacità di volere: viene invece tradizionalmente definita come il potere di controllare gli
impulsi di agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile
sulla base di una concezione di valore e dunque la capacità di volere presuppone dunque anche
quella di intendere il significato dei propri atti
ACTIO LIBERA IN CAUSA
L’art. 87 nel disciplinare lo stato preordinato di incapacità di intendere e di volere, stabilisce che la
disposizione secondo cui l’imputabilità deve sussistere al momento della commissione del reato (art.
85 c.p.) non si applichi a chi si è messo in stato di incapacità di intendere e di volere per commettere il
reato e per prepararsi una scusa (come nell’esemplificazione dell’ubriachezza preordinata).
L’affermazione di responsabilità in queste circostanze viene giustificata con il paradigma dell’actio
libera in causa, paradigma elaborato dalla teologia morale a riguardo delle condotte peccaminose
poste in essere senza libera volontà al momento della loro realizzazione ma pur sempre riconducibili
ad un precedente atto di volontà del soggetto stesso.
La dottrina, per tentare di giustificare questa deroga all’art. 85 (infatti il soggetto viene considerato
imputabile anche se, al momento della commissione del fatto, era nella condizione di inimputabile), ha
adottato giustificazioni differenti:
alcuni hanno sostenuto che l’esecuzione del reato inizi già nel momento in cui si rende
volontariamente incapace, ma a questa tesi si obietta che essa estende eccessivamente il
concetto di esecuzione del reato fino a farvi rientrare una condotta che è in realtà precedente
altri hanno invece rinvenuto il fondamento della responsabilità nel semplice nesso causale
75
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
(causa causae est causa causati), e dunque chi è responsabile della situazione da cui deriva
l’evento lesivo, è responsabile anche dell’evento stesso, anche se a questa tesi si obietta il suo
mal adattarsi al principio della colpevolezza
altri ancora, ed è questa soluzione più appagante, hanno ricondotto nell’alveo della
colpevolezza anche le ipotesi di incapacità procurata, ossia sostenendo che al soggetto possa
essere rimproverato per essersi liberamente posto in quella condizione di incapacità che gli ha
reso possibile o più agevole la commissione del reato preordinato. Per punire il soggetto per
questo occorre che il reato consumato sia dello stesso tipo di quello programmato, poiché si
avrebbe altrimenti una frattura che romperebbe il legame della necessaria corrispondenza tra
fatto e colpevolezza.
MINORE DI ETÀ
L’art. 97 c.p. stabilisce che non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto quattordici anni, e da questo articolo si trae dunque una presunzione di incapacità di
natura assoluta, poiché non è in alcun caso ammessa prova contraria.
L’art. 98 comma 1 c.p. stabilisce poi che è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto,
aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere,
ma la pena viene diminuita. In questo caso non vi è dunque una presunzione legale, poiché
dev’essere il giudice a valutare in concreto se il minore possa essere imputabile o no, anche in
relazione alla natura del reato commesso (per i reati più gravi, ad esempio, come quelli contro la
persona, per l’imputabilità si richiede un minimo sviluppo mentale ed etico, o anche la semplice
mancanza di tare psichiche suscettive di influire negativamente sui processi intellettivi e volitivi).
Secondo l’orientamento consolidato, l’incapacità minorile non presuppone necessariamente l’infermità
mentale, perché si fonda su di una condizione più lata identificabile con la situazione di immaturità.
Dal diciottesimo anno di età in poi, invece, il legislatore presume la capacità di intendere e di
volere, anche se questa presunzione è relativa, in quanto la capacità viene esclusa o diminuita in caso
di vizio totale o parziale di mente o delle altre cause previste dal codice.
INFERMITÀ DI MENTE
L’art. 88 c.p. stabilisce che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per
infermità in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere o di volere.
Non è dunque sufficiente la presenza di una malattia per dedurne un’automatica inimputabilità del
soggetto, ma è necessario anche accertare se e quanto la malattia ne comprometta la capacità di
intendere e di volere, secondo l’accolto indirizzo biopsicologico. Questo ulteriore accertamento
complica il compito del giudice, aggravato anche dal fatto che la stessa scienza psichiatrica è oggi
attraversata da una “crisi d’identità”, che rende il concetto di malattia mentale non univoco e di
difficile individuazione.
Un primo problema consiste infatti nello stabilire se la “infermità” dell’art. 88 corrisponda al concetto
di malattia, infatti la parola usata dal legislatore comprende solitamente anche disturbi psichici di
carattere non strettamente patologico: questo porta ad allargare l’istituto dell’inimputabilità, ma ciò in
realtà corrisponde allo scopo sotteso alle norme sull’inimputabilità, infatti non interessa tanto che la
condizione possa essere considerata una malattia secondo la medicina, ma piuttosto che essa possa in
concreto alterare la capacità di percepire il significato dell’azione commessa e il significato della
punizione. Dunque, aggiungendovi anche il fatto che vi sono anche malattie fisiche che possono
portare ad un’alterazione della capacità di intendere e di volere (come confusione mentale data da
un’intossicazione, o delirio dato dalla febbre, ecc.), si deve concludere che gli articolo 88 e 89 del
codice con “infermità” non intenda soltanto quella mentale intesa in senso stretto, ma un’infermità
più generale.
Un indirizzo ancora oggi diffuso in giurisprudenza, detto indirizzo medico, tende a ricostruire il
76
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
concetto di malattia mentale secondo un modello medico, considerando tale solo il disturbo psichico
che poggia su una base organica e/o possiede caratteri patologici che lo possano ricondurre ad un
preciso quadro clinico. In questo modo, però, si avrebbe sì una maggiore garanzia della certezza
giuridica, ma verrebbe impedita un’eccessiva dilatazione dei casi di inimputabilità, escludendo infatti
le semplici anomalie psichiche.
Vi è invece un indirizzo giurisprudenziale minoritario che allarga l’inimputabilità anche a disturbi
psichici non precisamente clinicamente inquadrati (cd. classificazione medico-nosografica), purché
essi compromettano in concreto la capacità di intendere e di volere dell’imputato. A differenza
dell’indirizzo medico, questo indirizzo minoritario consente di attribuire significato patologico anche
alle alterazioni mentali atipiche, come le psicopatie, le quali sono disarmonia della personalità che, se
gravi, bloccano le controspinte inibitorie del soggetto non permettendogli una risposta critica agli
stimoli (es. reazioni a corto circuito). Dunque, se colui che giudica sarà maggiormente spinto dalla
preoccupazione di rafforzare la difesa sociale, allora egli considererà che l’equiparazione tra psicopatia
e malattia mentale contrasti con gli obiettivi del diritto penale, mentre se egli è maggiormente spinto
dalla preoccupazione di rispettare la ratio delle norme sull’imputabilità, allora ammetterà che anche le
psicopatie possono incidere, a anche escludere, la capacità di intendere e di volere.
L’art. 90 c.p. stabilisce che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono
l’imputabilità, ma l’eccessivo rigore di questa disposizione ha portato a pesanti critiche per la norma,
tanto che la disposizione è stata di recente in parte rivalutata, sul presupposto che il legislatore penale
deve pretendere da parte di ciascun soggetto una misura di controllo sulle spinte emozionali tale da
inibire le pulsioni antisociali. Per evitare però un’eccessiva indulgenza, gli stati emotivi e passionali
possono essere ritenuti una scusante solo se lo stato di coinvolgimento emozionali si manifesta in una
personalità già di per sé debole, e se lo stato emotivo o passionale assume significato e valore di
infermità, anche per un periodo transitorio.
Il codice penale distingue diversi gradi del vizio mentale, il cui più alto livello è quello dell’infermità
totale, che si ha se il vizio di mente di cui soffre il soggetto al momento del fatto è tale da escludere del
tutto la sua capacità di intendere e di volere.
L’infermità può essere anche infermità transitoria, se il vizio di mente di cui soffre il soggetto al
momento del fatto è un vizio transitorio, ma va comunque ricordato che anche il vizio transitorio può
essere capace di escludere del tutto la capacità di intendere e di volere del soggetto. Quando invece è
accertabile uno stato di lucidità sufficientemente avulso dalle influenze che la malattia può esercitare
sulla psiche complessiva dell’individuo, allora nella prassi giudiziale si propende per un’affermazione
di responsabilità nei cosiddetti intervalli di lucidità.
All’imputato prosciolto per vizio totale di mente si può applicare la misura di sicurezza del ricovero
in un ospedale psichiatrico giudiziario soltanto previo accertamento concreto della sua pericolosità
sociale.
La capacità di intendere e di volere è diminuita in caso di infermità parziale, infatti l’art. 89 dispone
che chi nel momento in cui ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare
grandemente la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è
diminuita. La differenza tra infermità totale e parziale non è data da un criterio qualitativo, ma
quantitativo, poiché la legge non prende in considerazione l’estensione della malattia mentale, ma il
suo grado. L’apprezzamento quantitativo dell’infermità deve essere effettuato in concreto tenendo
conto delle caratteristiche della malattia e dell’esperienza del reo nei confronti del delitto commesso.
La giurisprudenza ritiene che la semi-infermità mentale sia compatibile con le aggravanti della
premeditazione, a meno che essa non derivi dalla malattia stessa, e dei motivi abietti e futili, nonché
l’attenuante della provocazione e le circostanze attenuanti generiche.
La sanzione per il semi-infermo mentale giudicato colpevole sarà una pena ridotta rispetto a quella
ordinaria, e se egli verrà anche considerato socialmente pericoloso si potrà aggiungere la misura di
sicurezza dell’assegnazione a una casa di cura e di custodia.
77
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
UBRIACHEZZA E INTOSSICAZIONE DA STUPEFACENTI
Il codice penale si preoccupa della rilevanza penale dell’ubriachezza e dell’intossicazione da
stupefacenti, ma ne prevede un trattamento articolato che si differenza in base alla causa
dell’ubriachezza/intossicazione:
Ubriachezza accidentale: l’ubriachezza esclude l’imputabilità solo se dovuta a caso fortuito o
forza maggiore, e fa sì che la pena venga diminuita nel caso in cui l’ubriachezza dovuta a tali
cause faccia scemare la capacità di intendere e di volere senza annullarla del tutto. Vale la
stessa disciplina per l’intossicazione da stupefacenti accidentale.
Ubriachezza volontaria o colposa: non fa scemare né esclude l’imputabilità l’ubriachezza e
l’intossicazione volontaria o colposa, e questa disciplina rigorosa si deve alla considerazione
che un soggetto che volontariamente si è reso incapace di intendere e di volere non può essere
giustificato per le sue successive azioni. In questo modo, tuttavia, si trascura il fatto che,
indipendentemente dalla causa, al momento della commissione del fatto il soggetto era
comunque un soggetto incapace.
Una parte della dottrina meno recente sosteneva che per accertare l’elemento psicologico del
reato commesso dall’ubriaco si dovesse risalire al momento in cui si era ubriacato, e il reato si
sarebbe dunque dovuto considerare doloso o colposo a seconda che l’ubriaco prima di
commetterlo si fosse ubriacato volontariamente o involontariamente (e dunque secondo
questa tesi dovrebbe essere omicidio colposo anche quello di un soggetto che ha bevuto troppo
e si è, suo malgrado, ubriacato, e abbia ucciso per uno scatto d’ira un’altra persona che ad
esempio l’ha preso in giro). In questo modo si rischia però di confondere lo stato psicologico
che provoca la condizione di ubriachezza con quello che accompagna la successiva
commissione del reato, e dunque si corre il rischio di punire come colposi delitti commessi
volontariamente e come dolosi delitti involontari che seguono ad uno stato di ubriachezza
volontaria.
Per questo motivo, infatti, l’orientamento dominante ritiene che dolo e colpa dell’ubriaco
vadano accertati con riferimento al momento in cui il reato viene commesso. Anche questo
orientamento si espone però ad una critica, ossia al fatto che essa produce una “finzione di
imputabilità”, poiché considera imputabile un soggetto che commette comunque un reato
mentre non è capace di intendere e di volere.
Un terzo orientamento sostiene che il soggetto debba rispondere per dolo eventuale se si è
ubriacato nonostante la previsione della commissione del reato ed accettandone il rischio, e a
titolo di colpa se al momento dell’ubriacamento il reato era stato da lui previsto ma non
accettato, oppure era prevedibile ed evitabile come conseguenze dell’ubriachezza, sempre che
si tratti di un reato previsto dalla legge anche come reato colposo. L’obiezione che viene fatta a
questa impostazione è il fatto che è dubbio se sia possibile accertare in giudizio un dolo
eventuale o una colpa rispetto alla futura commissione di fatti criminosi.
Dal momento che ogni interpretazione si espone a critiche, si può concludere che sia a questo
proposito auspicabile una riforma che renda la disciplina più compatibile con il principio di
colpevolezza.
Ubriachezza preordinata: l’ubriachezza è preordinata, e comporta un aumento di pena,
quando viene provocata per commettere il reato o per prepararsi una scusa. L’ubriachezza
preordinata, che viene prevista dall’art. 92 comma 2 c.p., è quella che viene preparata dal reo
proprio per commettere un reato.
All’art. 93 viene prevista una disciplina analoga per l’uso preordinato di stupefacenti.
Ubriachezza abituale: l’ubriachezza e l’intossicazione da stupefacenti abituale non esclude né
diminuisce l’imputabilità, e anzi, secondo l’art. 94 commi 10 e 30, essa aumenta la pena, e
comporta anche la possibilità di applicare la misura di sicurezza della casa di cura e di
custodia, oppure della libertà vigilata. Per essere abituale l’ubriachezza o intossicazione
78
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
devono presentare i due requisiti di:
1. dedizione all’uso eccessivo di alcool/droghe
2. frequente stato di ubriachezza/intossicazione
Si potrebbe auspicare che questa disciplina venga in futuro abolita, in quanto essa risponde ad
una motivazione politico-criminale che oggi appare ampiamente discutibile, ossia la
concezione contraddittoria dell’ubriaco abituale in parte come vizioso responsabile e colpevole
della sua condotta di vita, e in parte come soggetto bisognoso.
Cronica intossicazione: il legislatore considera che sia l’alcolismo sia la tossicomania possano
arrivare ad escludere o scemare ampiamente la capacità di intendere e di volere soltanto nel
caso estremo di cronica intossicazione regolato dall’art. 95 c.p. Si definisce intossicazione
cronica da alcool quella che provoca alterazioni patologiche permanenti che fanno sembrare
indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica, ma nella prassi la
distinzione tra questa e l’ubriachezza abituale (che non esclude l’imputabilità ma anzi aumenta
la pena) non è agevole.
È poco convincente l’equiparazione tra intossicazione cronica da alcool e da stupefacenti,
poiché esse non presentano le stesse caratteristiche: in quella da sostanze stupefacenti manca
un’alterazione patologica di tipo “permanente”, infatti le ricerche hanno dimostrato che la
capacità di intendere e di volere del tossicodipendente è già gravemente compromessa nella
situazione di dipendenza psico-fisica da sostanza stupefacente che si ha con la sindrome di
astinenza.
SORDISMO (presenza contemporanea di sordità e mutismo)
Sul presupposto che la mancanza di udito e di parola pregiudichi la capacità di autodeterminazione
responsabile dell’individuo, all’art. 96 viene disposta un’apposita disciplina del sordismo. Da questo
articolo viene stabilito il principio per cui la capacità e l’incapacità devono essere oggetto di concreto
accertamento in giudizio, e dunque non vengono introdotte presunzioni a proposito.
Il sordismo può essere:
Congenito o precocemente acquisito: il quale ostacola gravemente lo sviluppo psichico
Sordismo tardivamente acquisito: il quale insorge dopo l’apprendimento del linguaggio e
può dunque non intaccare quest’ultimo
La disposizione citata non distingue tra queste tipologie, ma si può supporre che essa si riferisca
soprattutto alla prima tipologia di sordismo.
2. DOLO E COLPA
Il delitto doloso è il modello fondamentale dell’illecito penale, poiché il dolo rappresenta il normale
criterio di imputazione soggettiva, infatti l’art. 42 comma 2 c.p. stabilisce che nessuno può essere
punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo. Il legislatore,
infatti, presuppone sempre implicitamente il dolo quando elenca le varie fattispecie di illecito penale.
Gli altri criteri di imputazione soggettiva della responsabilità sono invece la colpa e la
preterintenzione, ed essi operano soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Nel processo di imputazione penale il dolo svolge varie funzioni in rapporto ai diversi piani in cui si
articola la struttura dell’illecito:
Elemento costitutivo del fatto tipico: la volontà criminosa assume rilevanza non in wuanto tale,
ma in quanto si traduca in realizzazione
Forma più grave di colpevolezza: chi agisce con dolo aggredisce il bene protetto in maniera più
intensa di chi agisce con colpa
L’art. 43 comma 1 stabilisce che il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso che è
risultato dall’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, viene previsto
dall’agente e voluto come conseguenza della propria azione od missione. Il dolo è dunque incentrato
su tre elementi:
79
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Previsione
Volontà
Evento dannoso o pericoloso.
I primi due elementi sono di natura strutturale, in quanto indicano le componenti che caratterizzano il
dolo come fenomeno psicologico, mentre il terzo elemento attiene all’oggetto che deve riflettersi nella
rappresentazione e nella volizione.
L’intenzione viene scissa nelle due componenti di previsione e volontà è il risultato dello sforzo di
compromesso tra le teorie della rappresentazione e della volontà, presenti al momento della redazione
del codice Rocco.:
Teoria della rappresentazione: concepiva la volontà e la rappresentazione/previsione come
fenomeni psichici distinti, tanto che la volontà poteva avere ad oggetto soltanto il movimento
corporeo dell’uomo (ad esempio premere il grilletto di una pistola per uccidere qualcuno),
mentre era la rappresentazione mentale anticipata la sola a potere avere ad oggetto le
modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta (ad esempio la morte causata dallo
sparo).
Teoria della volontà: privilegiava invece l’elemento volitivo del dolo, e considerava che
potessero essere oggetto di volontà anche i risultati della condotta, e che la rappresentazione
fosse un presupposto implicito della volontà
La definizione del dolo dell’art. 43 è comunque parziale, poiché la disciplina di esso va ricavata dal
complesso delle disposizioni che attribuiscono rilevanza alla conoscenza di determinati elementi
costitutivi di fattispecie.
Al pari di ogni elemento costitutivo della fattispecie, il dolo deve essere provato, tuttavia questa
prova è difficile, riguardano un processo psicologico interno. Il giudice deve quindi tener conto di tutte
le circostanze che possono costituire indice rivelatore della volontà colpevole, a partire dalla modalità
della condotta, fino al comportamento tenuto successivamente alla commissione del fatto.
Soccorre spesso il ricorso a regole di esperienza, la conformità alle quali fa ritenere dimostrato il fatto
psicologico da provare, in mancanza di dati da cui sia possibile affermare che i fatti si sono svolti
diversamente.
Inammissibile invece è il ricorso a schemi presuntivi. Nonostante alcune fattispecie sembrano ritenere
la volontà colpevole implicita nella stessa realizzazione del fatto materiale, il dolo va sempre e
comunque provato.
STRUTTURA DEL DOLO
La struttura del dolo, secondo una concezione ormai consolidata, è formata dalle due componenti
psicologiche della rappresentazione e della volontà, le quali sono distinte ma comunque in rapporto
tra loro, poiché una volontà senza l’elemento intellettivo sarebbe “cieca”.
1. L’elemento intellettivo del dolo consiste nella rappresentazione o conoscenza degli elementi
che integrano la fattispecie oggettiva, infatti la punibilità è esclusa per mancanza di dolo se il
soggetto non conosce o si rappresenta erroneamente un requisito del fatto tipico. L’elemento
intellettivo del dolo, più precisamente, si atteggia diversamente a seconda che abbia come
punto di riferimento elementi descrittivi o elementi normativi di fattispecie:
Elementi descrittivi: è sufficiente che il soggetto sia a conoscenza degli elementi del
mondo esterno così come appaiono nella loro dimensione naturalistica, come uomo,
morte, ecc. (se ad esempio un ladro ruba un pollo senza ritenere che esso sia una cosa
mobile nel senso della fattispecie del furto, il dolo permane comunque).
Elementi normativi: come altruità, documento, ecc. allora per l’esistenza del dolo non
basta che il soggetto conosca meri dati di fatto, ma deve rappresentarsi anche gli
aspetti che fondano la rilevanza giuridica delle situazioni di fatto richiamate dalla
fattispecie, ma questo non significa che egli debba conoscere l’esatto significato
80
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
giuridico dell’elemento normativo in questione, ma basta che ne abbia, per Mezger, una
“conoscenza parallela nella sfera laica” (ad esempio il ladro non deve necessariamente
conoscere le norme civile che disciplinano la proprietà, ma basta che sappia quando,
secondo il senso comune, la cosa è di altri).
La rappresentazione è una previsione degli accadimenti futuri che si prospettano come
conseguenza o risultato dell’azione criminosa, e ai fini del dolo la rappresentazione sufficiente
è compatibile con uno stato di dubbio in ordine ad uno o più elementi di fattispecie (se
qualcuno prende una cosa avendo il dubbio che possa essere di qualcun altro, allora accetta il
rischio che la cosa sia veramente altrui e che egli stia commettendo un furto, e questo
giustificata un’imputazione a titolo di dolo). Viene però esclusa la sufficienza dello stato di
dubbio per il dolo quando la particolare struttura della fattispecie incriminatrice esige la piena
conoscenza di uno o più elementi del fatto di reato.
La rappresentazione assume rilevanza attuale o potenziale a seconda delle circostanze del caso
concreto.
2. Il dolo non è una semplice rappresentazione degli elementi costitutivi della fattispecie
delittuosa, ma la volontà consapevole di realizzare il fatto tipico. Si è già detto che la
volontà in senso ampio investe l’azione come movimento corporeo, e il fatto complessivo nella
sua unità significativa, e dunque la volontà finisce per abbracciare anche tutti gli altri elementi
del fatto diversi dalla [Link] dolo come volontà del fatto è da non confondere con il motivo
o movente del delitto, infatti questo è l’impulso di natura affettiva che spinge il soggetto ad
agire.
L’imputazione a titolo di dolo presuppone che la volontà si traduca in realizzazione,
quantomeno nello stadio del tentativo punibile, e non è dunque punibile il dolo antecedente, né
lo è il dolo susseguente, ma soltanto il dolo che sussiste al momento del fatto, e che deve
perdurare fino all’ultimo atto in cui la volontà dell’agente può incidere sull’accadimento
(questo significa ad esempio che se una persona posiziona una bomba con l’intento di fare una
strage, ma al momento in cui la bomba scoppia egli si pente, il delitto sarà comunque doloso
perché egli aveva la volontà al momento del posizionamento dell’ordigno). Dolo antecedente e
susseguente, infatti, non hanno rilevanza. Di conseguenza, il venire meno della volontà in senso
strettamente psicologico è privo di rilevanza, ove l’agente non sia più in grado di incidere sullo
svolgimento degli accadimenti.
Il dolo può avere intensità diversa in relazione al grado di consistenza della rappresentazione e/o
della volontà, e di questa graduazione il giudice deve tenere conto per la commisurazione della pena.
La graduabilità della componente conoscitiva dipende dal livello di chiarezza e certezza con cui il
soggetto si rappresenta gli elementi del fatto di reato (la colpevolezza piena e certa è quella dotata di
intensità maggiore, mentre avrà un’intensità minore la rappresentazione dubitativa).
L’intensità del momento volitiva va invece rapportata:
1. al grado di adesione psicologica del soggetto al fatto
2. alla complessità
3. alla durata del processo deliberativo
Si ritiene allora che la volontà criminosa sia meno grave quando si traduce immediatamente e
improvvisamene in azione, ossia il dolo d’impeto, e sarebbe invece più grave e pericoloso il dolo di
proposito, in cui vi è uno stacco di tempo rilevante tra la decisione e l’esecuzione (una sottospecie
aggravata ne é la premeditazione).
OGGETTO DEL DOLO
Secondo l’art. 43 comma 1, l’oggetto del dolo, dunque della volontà colpevole, è l’evento dannoso o
pericoloso, ma questa scelta lessicale è infelice in quanto il concetto di evento e la sua nozione sono
particolarmente controversi:
81
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Se si sostiene che l’art. 43 alluda all’evento in senso naturalistico, come risultato lesivo
causalmente riconducibile all’azione tipica, allora si perviene alla conseguenza inaccettabile di
dovere ritenere che la definizione legislativa di dolo non ricomprenda i reati di mera condotta.
Se si accoglie invece la tesi che sostiene che la disposizione concerna l’evento in senso
giuridico, come lesione o messa in pericolo di un bene protetto, allora si incorre nell’obiezione
che la consapevolezza del carattere lesivo dell’azione non può prescindere dalla conoscenza
effettiva del divieto penale, ma si frappone in proposito l’ostacolo insuperabile dell’ignorantia
legis non excusat stabilito dall’art. 5 c.p.
L’oggetto del dolo non è però a ben vedere né l’evento naturalistico né quello in senso giuridico, ma
piuttosto il fatto tipico, infatti solo questa tesi consente di ricostruire l’oggetto del dolo tenendo
contemporaneamente presenti le diverse caratteristiche strutturali dei reati di azioni e dei reati di
evento. La ricostruzione dell’oggetto della volontà colpevole finisce in questo modo per riflettere le
caratteristiche di struttura dei diversi tipi delittuosi, e dunque in conclusione l’oggetto del dolo è
costituito da tutti gli elementi obiettivi positivamente richiesti per l’integrazione delle singole figure di
reato. Questo trova un riscontro all’art. 47, che, stabilendo che il dolo è escluso dall’errore sul fatto che
costituisce reato, conferma l’assunto che la rappresentazione e la volontà devono avere ad oggetto il
fatto tipico.
L’oggetto del dolo deve quindi comprendere le diverse componenti in cui il fatto tipico può articolarsi,
ossia:
1. la condotta
2. le circostanze antecedenti o concomitanti all’azione
3. l’evento naturalistico
Perchè l’azione sia imputabile a titolo è di dolo occorre in particolare distinguere a seconda che si
tratti di reati a forma vincolata o a forma libera, poiché nei primi coscienza e volontà devono avere ad
oggetto proprio le specifiche modalità di realizzazione del fatto tipizzate dalla fattispecie dell’illecito,
mentre nei secondi il dolo deve accompagnare normalmente l’ultimo atto compiuto prima che il
decorso causale sfugga alla capacità di dominio personale dell’agente.
Per quanto attiene al nesso causale, basta che di regola si prefiguri lo svolgimento nei tratti essenziali
rilevanti ai fini della valutazione penalistica, per cui non è necessario che la corrispondenza tra
decorso causale preveduto e decorso causale effettivo abbracci anche i dettagli secondari. Le specifiche
modalità di causazione dell’evento acquistano, invece, rilevanza nei casi in cui siano legislativaente
predeterminate.
Il dolo deve dunque investire anche gli elementi normativi della fattispecie, ossia quelli la cui
determinazione presuppone il rinvio ad una norma diversa da quella incriminatrice (ad esempio non
si può configurare un furto se l’agente non si rende conto che la cosa sottratta è una cosa “altrui”),
infatti è rilevante l’esatta rappresentazione degli elementi normativi della fattispecie, e questa
rilevanza si desume dall’art. 47 c.p., che all’ultimo comma dispone che l’errore su una legge diversa
dalla legge penale esclude la punibilità se cagiona un errore sul fatto che costituisce il reato.
La disciplina è analoga anche per l’antigiuridicità/illiceità speciale, che si ha quando la norma
incriminatrice per la configurazione dell’illecito esige che il fatto si verifichi con modalità particolari,
come “abusivamente”, “illegittimamente”, ecc. In questi casi la modalità abusiva, illegittima, ecc. sono
elementi normativi della fattispecie, e dunque il dolo si configura solo se l’agente è a conoscenza
dell’illiceità speciale extapenale del fatto commesso. Si discute però se rientrino nell’oggetto del dolo
anche le qualifiche soggettive che ineriscono all’autore dei reati propri: si può in linea di massimo dire
che nei casi in cui la qualifica soggettiva non sia totalmente scissa dal fatto di reato, ma si ripercuota su
di esso contribuendo a caratterizzarne lo specifico disvalore penale, l’ignoranza o erronea conoscenza
della qualifica impedisce all’agente di cogliere il significato criminoso della sua azione. Nel dolo non
rientra però la qualifica considerata nella sua astratta configurazione giuridico-penale, perché
significherebbe esigere la conoscenza della norma incriminatrice, e ciò andrebbe contro l’art. 5 c.p.; ciò
che rientra nel dolo sono invece i substrati di fatto su cui si basano le qualifiche soggettive.
82
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
DOLO E COSCIENZA DELL’OFFESA
Ci si chiede se il dolo includa la coscienza dell’offesa, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale.
L’offesa come oggetto del dolo può essere intesa come:
antigiuridicità o illiceità penale del fatto
come l’incidenza negativa del fatto su interessi meritevoli di protezione e/o la sua idoneità a
danneggiare o porre in pericolo beni meritevoli di tutela
Dopo anni di rigorismo sul punto dovuto all’altrettanto vigore dell’ignorantia legis non excusat dell’art.
5 c.p., una parte della dottrina ha dagli anni sessanta pensato di privilegiare una nozione di offesa
scissa dall’antigiuridicità penale in senso stretto ed identificata con la lesione dell’interesse protetto
considerato nella sua dimensione pregiuridica e fattuale, in modo tale che il dolo potesse
ricomprendere nel suo oggetto la consapevolezza che il fatto commesso è dannoso perché lede
interessi o beni socialmente rilevanti.
L’offesa, dunque, intesa come antigiuridicità o illiceità penale del fatto, esula dall’oggetto del dolo,
infatti dire che la volontà colpevole presuppone la conoscenza effettiva dell’illiceità del fatto si scontra
con l’art. 5 c.p., che stabilisce che nessuno può essere giustificato dalla sua ignoranza della norma
penale (esclusi i casi di ignoranza inevitabile-inescusabile, che interessano però la colpevolezza).
L’offesa come oggetto del dolo, dunque, può venire in questione solo in senso fattuale o sostanziale,
ossia come pregiudizio ad interessi protetti percepiti non nella loro dimensione giuridica, ma piuttosto
sociale. Questa concezione appare la più coerente con l’ordinamento anche per il fatto che il dolo è la
forma più grave di colpevolezza, e dunque esso non si può ridurre ad un requisito psicologico del tutto
neutro, ossia ad una coscienza e volontà di un fatto materiale senza la percezione della lesività del fatto
nei confronti di beni o interessi tutelati.
Ci si chiede però in che misura l’inerenza al dolo della coscienza dell’offesa risulta compatibile con il
sistema delle incriminazioni. In casi come i reati con evento naturalistico (es. omicidio, lesioni
personali, ecc.) la compenetrazione tra fatto materiale e lesione del bene tutelato è così evidente che il
disvalore del fatto difficilmente può sfuggire alla coscienza di chi agisce. Nei casi invece di reati di pura
creazione legislativa la consapevolezza della lesione dell’interesse protetto può non aversi se non si ha
conoscenza della disposizione incriminatrice, ma in questo modo non si è scusati a causa dell’art. 5 c.p.
Quella che ne deriva è dunque il fatto che una piena affermazione del principio secondo cui al dolo
inerisce la coscienza dell’offesa, presupporrebbe una grande riforma dell’ordinamento penale vigente
per circoscrivere l’ambito della rilevanza penale ai soli fatti il cui disvalore sia percepibile in una
dimensione fattuale-concreta.
FORME DEL DOLO
L’elaborazione dogmatica ha individuato diverse forme del dolo:
Dolo intenzionale: il dolo intenzionale o dolo diretto di primo grado si ha quando il soggetto
mira a realizzare la condotta illecita, reato di azione, o a causare l’evento, reato di evento.
Questo è il grado massimo di dolo in quanto in questo caso la volontà raggiunge l’intensità
massima.
Dolo diretto: il dolo diretto o dolo di secondo grado si ha quando l’agente si rappresenta con
certezza gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice e si rende conto che la sua
condotta sicuramente li integrerà. Si configura dunque quando la realizzazione del reato non è
l’obiettivo che dà causa alla condotta, ma è solo uno strumento necessario per realizzare lo
scopo dell’agente (es. una persona che per rapire un personaggio politico spara alla sua
scorta). In questo caso, a differenza del dolo intenzionale, il ruolo predominante non è quello
della volontà, ma quello della rappresentazione.
Dolo eventuale: il dolo eventuale o indiretto presenta una struttura controversa, dovuta alla
non chiarissima distinzione tra esso e la colpa con previsione o cosciente, che comporta un
aggravamento di pena. Si configura dolo eventuale quando l’agente non ha agito per
commettere il reato, ma quando egli si è rappresentato la commissione di un reato solo come
83
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
possibile conseguenza di una condotta diretta ad altri scopi (es. un uomo disturbato da dei
ragazzi rumorosi in strada lancia dalla finestra una bottiglia di vetro, sapendo che sarebbe
stato possibile ferire qualcuno, e ciò avviene).
Secondo la teoria della possibilità, agisce dolosamente chi prevede la possibilità concreta di
provocare la lesione di un bene giuridico e agisce ugualmente nonostante la previsione;
secondo la teoria della probabilità invece non basta che l’agente considerasse possibile
l’evento, ma serve che egli lo considerasse probabile.
Punto di vista differente ha invece la teoria del consenso, che richiede un quid pluris, ossia
l’approvazione interiore della realizzazione dell’evento previsto come possibile, anche se a
questa teoria si obietta che il nostro diritto penale è orientato alla protezione dei beni giuridici,
e dunque non si può dare rilevanza decisiva al semplice atteggiamento interiore dell’agente.
L’orientamento dominante in giurisprudenza e dottrina è quello, infatti, della teoria
dell’accettazione del rischio, secondo la quale il soggetto agisce con dolo eventuale non
perché si è semplicemente rappresentato mentalmente la possibilità che si verificasse l’evento,
ma perché ha seriamente “fatto i conti” con questa possibilità e ha deciso comunque di agire
anche a costo di provocare l’evento illecito. Infatti secondo questo orientamento, se l’agente si
è rappresentato la possibilità ma ha confidato nella sua concreta non verificazione, allora si
avrà colpa cosciente o con previsione.
L’accertamento del dolo eventuale è comunque difficile e complesso in sede processuale,
poiché il giudice non deve valutare dati di fatto concretamente verificabili, ma piuttosto i
complicati processi psicologici interiori dell’agente; proprio per questo motivo si ricorre
spesso a generali regole di esperienza, e dunque il dolo eventuale sarà di regola da escludere
nel caso di rischi lievi e ordinari, e sarà da affermare in presenza di rischi gravi e tipici. Anche
se di difficile applicazione, il dolo eventuale ha comunque subito una progressiva espansione
applicativa da parte della giurisprudenza, fino ad applicarlo in campi tradizionalmente
emblematici di responsabilità oleosa, come gli indicenti stradali e gli infortuni sul lavoro. La
scelta del dolo in questi casi stigmatizza più fortemente l’alto grado di disvalore delle condotte
assai sconsiderate di un automobilista e degli atteggiamenti gravemente irresponsabili del
datore di lavoro, ma veicola inoltre messaggi di prevenzione generale. Nonostante ciò, questa
operazione della giurisprudenza finisce per riproporre i due grossi nodi relativi alla
plausibilità e consistenza dei criteri che distinguono tra dolo eventuale e colpa con previsione,
e delle tecniche probatorie utilizzabili nel processo. Ci sono dunque ragioni sufficienti per fare
della categoria del dolo eventuale un’applicazione restrittiva, piuttosto che espansiva.
Dolo alternativo: si ha dolo alternativo quando l’agente con certezza (cd. dolo diretto) o come
possibilità (cd. dolo eventuale) il verificarsi di due eventi come conseguenza della sua azione,
ma non sa quale in concreto si realizzerà (es. un uomo che pugnala un individuo volendone
indifferentemente il ferimento grave o la morte). Questo più che un dolo autonomo è la
riflessione di situazioni in cui il soggetto si rappresenta molteplici eventi tra loro incompatibili.
Dolo generico e dolo specifico: il dolo generico è il dolo tipico, ossia la coscienza e volontà di
realizzare gli elementi costitutivi di un reato, ed è necessaria la corrispondenza tra volontà e
realizzazione. Il dolo specifico, invece, è uno scopo particolare e ulteriore che l’agente deve
prendere di mira, ma che non è necessario che si realizzi perché si configuri il reato (es. nel
delitto di furto è necessario che l’agente voglia impossessarsi della cosa altrui e persegua
l’ulteriore fine di trarre profitto, ma il delitto si configura anche se il profitto non viene
effettivamente ottenuto). Per stabilire se per un illecito si richieda un dolo specifico, serve una
corretta interpretazione del rapporto tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo della
fattispecie.
La legge può prevedere un dolo specifico per:
1. restringere l’ambito della punibilità
2. determinare la punibilità di un fatto che, altrimenti, sarebbe lecito (associarsi è lecito, ma
84
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
non lo è se il fine è quello di commettere delitti)
3. produrre un mutamento del titolo del reato
Dolo di danno e dolo di pericolo: il dolo di danno è la volontà di realizzare un fatto che
provoca la lesione completa dell’interesse protetto, e il dolo di pericolo è invece la volontà di
provocare la semplice esposizione al pericolo del bene.
Il dolo deve naturalmente essere provato, ma questo è reso complicato dal suo essere un processo
psicologico interno che va dedotto da fatti esterni conformi a fattispecie di reato. Proprio per la sua
complessità non vi sono criteri prefissati, né limiti predeterminabili a priori, e il giudice deve dunque
tenere conto di tutte le circostanze che possono assumere valore sintomatico ai fini dell’esistenza del
dolo, quali le modalità della condotta, lo scopo perseguito dall’agente, il comportamento tenuto dal reo
in seguito al fatto, ecc. Si può, ed è anzi molto utile, ricorrere a regole di esperienza, che possono essere
sufficienti per ritenere dimostrato il dolo, in mancanza di dati che possano spingere ad una
conclusione contraria.
Ciò che non è invece consentito è lo schema presuntivo, proprio perché lo stesso concetto di
presunzione non si adatta al dolo inteso come coscienza e volontà reali di un fatto criminoso. Il fatto
che il dolo vada sempre provato è dato anche dalla constatazione che persino nelle fattispecie legali
soggettivamente pregnanti viene richiesta la prova del dolo, e dunque va disatteso l’orientamento
giurisprudenziale che presume il dolo nella commissione del fatto salva prova contraria.
ERRORE
La volontà colpevole presuppone la conoscenza degli elementi costitutivi dell’illecito, e da ciò deriva
dunque che l’ignoranza o l’errata rappresentazione di uno o più requisiti dell’illecito penale esclude
la punibilità per il venir meno dell’elemento soggettivo del reato.
Si distingue solitamente tra:
Errore di fatto (o error facti): la mancata o errata percezione della realtà esterna
Errore di diritto (o error juris): l’ignoranza o erronea interpretazione di una norma giuridica
penale o extrapenale
Lo stato di dubbio è invece distinto dall’errore o ignoranza, infatti fino a che l’agente è incerto sulla
presenza di determinati requisiti della fattispecie, mancano i presupposti sia di una conoscenza esatta,
sia di un errore.
Il legislatore contemporaneo, nel disciplinare l’errore sul precetto, si deve preoccupare di bilanciare
la piena affermazione del principio di colpevolezza e l’esigenza di prevenzione generale di non
indebolire la tenuta dell’ordinamento penale. Dunque, si dispone che
l’errore sul precetto penale è irrilevante sulla base dell’art, 5 c.p., a meno che non si tratti di
errore inevitabile, e dunque scusabile
l’errore sul precetto extrapenale è invece disciplinato dall’art. 47 comma 3, che dispone che,
perché questo errore possa essere considerato scusante, è necessario che esso si risolve o
converta in un errore sul fatto di reato, ossia che l’agente ne risulti talmente fuorviato da non
rendersi conto di compiere un fatto previsto dalla legge come reato. Se invece l’errore su
norma extrapenale si limita a suscitare indirettamente nell’agente l’erronea convinzione che il
fatto realizzato sia penalmente lecito perché non rientra nella norma incriminatrice, allora si
ha un’ipotesi assimilabile a quella dell’errore su norma penale, e dunque va disciplinata sulla
base dell’art. 5 e l’errore va per questo ritenuto di regola irrilevante.
ERRORE DI FATTO SUL FATTO
Se l’agente non conosce uno o più elementi del fatto concreto rilevanti per la fattispecie
incriminatrice, egli non agisce dolosamente, ed il reato viene meno. L’errore di fatto può derivare
dall’ignoranza o dalla falsa rappresentazione della situazione di fatto in cui il soggetto agisce.
Questa forma di errore si chiama anche errore-motivo, poiché influisce sul processo formativo della
volontà (l’errore-inabilità si verifica invece durante l’esecuzione materiale del fatto criminoso, ed è
85
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
rilevante nei reato aberranti).
L’art. 47 comma 1 stabilisce che l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità
dell’agente, e se si tratta di errore colposo la punibilità non è esclusa quando il fatto è prevista dalla
legge come delitto colposo.
Errore e ignoranza devono vertere su elementi essenziali del fatto, ossia elementi la cui mancata
conoscenza impedisce che il soggetto si possa rappresentare un fatto corrispondente al modello legale.
Sono invece irrilevanti, di regola, gli errori conseguenti allo scambio tra soggetti (cd. error in persona)
o tra oggetti (cd. error in obiecto) che rivestono una posizione equivalente sul piano della fattispecie
incriminatrice (se ad esempio un cacciatore spara ad un uomo credendo di avere visto un cinghiale
non si può avere un omicidio doloso, ma se egli spara ad un uomo scambiandolo per un altro uomo che
voleva uccidere, l’errore è irrilevante). Se lo scambio riguarda invece persone od oggetti che occupano
un rango diverso di fronte al diritto, allora l’errore può in alcuni casi far venire meno il reato (es. un
uomo prende la bicicletta di un altro perché l’ha scambiata per la propria) o rendere applicabile
un’altra diversa figura criminosa o ancora incidere sul regime delle circostanze aggravanti o
attenuanti.
Irrilevante è invece l’errore sul nesso causale, a meno che la divergenza tra decorso causale
prefigurato ed effettivo non sia tale da fare escludere che l’evento costituisca realizzazione dello
specifico rischio insito nell’iniziale azione dell’agente.
L’errore di fatto esclude dunque il dolo, ma questo non significa che venga esclusa anche la
responsabilità penale, che può permanere a titolo di colpa se ne sussistono i presupposti ex art. 47, i
quali sono che:
1. l’errore deve essere rimproverabile, ossia dovuto ad un’inosservanza di norme precauzionali
di condotta imputabile all’agente
2. il fatto deve essere espressamente previsto dalla legge come delitto colposo (ad esempio furto
e danneggiamento non sono punibili a titolo di colpa).
Suscita problemi il trattamento dell’errore del soggetto inimputabile, che può essere errore
condizionato o non condizionato dall’infermità mentale. Si può ritenere, in mancanza di disposizioni a
riguardo, che l’errore condizionato non abbia rilevanza scusante, poiché altrimenti si renderebbe
inapplicabile la misura di sicurezza proprio nei casi in cui il soggetto si è dimostrato e può diventare
socialmente pericoloso, e ritenere invece che l’errore incondizionato abbia efficacia scusante se
determinato da circostanze di fatto che avrebbero presumibilmente tratto in inganno anche una
persona capace.
In materia di reati sessuali vi è una disciplina peculiare dell’errore, in particolare riguardo
all’ignoranza o errore del colpevole sull’età della persona offesa. Fino alla riforma dei reati sessuali del
’96, si riteneva che l’error aetatis fosse non fosse scusante nel caso in cui il fatto fosse commesso ai
danni di una persona minore di quattordici anni. Nel 2007, con la sentenza n. 322, la Corte
costituzionale ha riconosciuto uno spazio alla rilevanza scusante dell’errore sull’età della persona
offesa, estendendo a questa ipotesi i principi elaborati in materia di ignoranza della legge con la sent.
364/1988; in questo modo si ritiene dunque che l’error aetatis scusi solo se incolpevole, e questo
precetto è stato recepito a livello normativo con la legge n. 172 del 10 ottobre 2012, che ha modificato
l’art. 609 sexies c.p. ammettendo la rilevanza scusante dell’errore sull’età inevitabile.
L’art. 47 comma 2 dispone però che l’errore sul fatto che costituisce un certo reato non escluda la
punibilità per un reato differente, e dunque si sarà comunque ritenuti responsabili del reato di cui
siano stati effettivamente posti in esse gli estremi materiali e psicologici (se una persona si impossessa
di una cosa altrui perché la considera smarrita non risponderà di furto, ma risponderà comunque di
appropriazione di cose smarrite).
Se però l’errore ricade su elementi degradanti il titolo di reato la questione si fa più controversa.
Infatti, ad esempio, se una persona cagiona la morte di un’altra, supponendo erroneamente che
quest’ultima avesse prestato consenso all’uccisione, non è chiaro se ella debba rispondere di omicidio
semplice o di omicidio del consenziente. Alcuni sostengono che dovrebbe considerarsi rilevante non la
86
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
mera rappresentazione dell’agente, ma la sussistenza degli estremi materiali e psicologici
corrispondenti all’illecito concreto; altri escludono invece che il dolo del reato meno grave inglobi il
dolo relativo all’illecito-base più grave, e propendono dunque per l’applicazione della fattispecie meno
grave. Si può pensare allora, dal momento che il legislatore non ha preso una posizione a proposito, di
applicare per analogia la disciplina dell’errore sulle cause di giustificazione ex art. 59 comma 4.
L’analogia è, comunque, discutibile, ma va notato che la fattispecie meno grave è in questi casi quella
che meglio riflette l’effettivo atteggiamento psicologico dell’agente.
ERRORE SUL FATTO DETERMINATO DA ERRORE SU LEGGE EXTRAPENALE
L’art. 47 comma 3 stabilisce che l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità
quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (se ad esempio una persona si
impossessa di un oggetto altrui perché commette un errore nell’interpretazione della legge civile che
disciplina il rapporto di proprietà, egli commetto un errore di valutazione).
A questo proposito vi sono orientamenti interpretativi differenti, e questo a causa del problema del
rapporto tra l’art. 47 comma 3, che permette che l’errore su legge extrapenale, ossia errore di diritto,
funga da scusante, e l’art. 5, che stabilisce il principio dell’ignorantia legis non excusat.
Secondo un primo orientamento consolidato occorrerebbe distinguere tra norme extrapenali
che integrano la norma penale incriminatrice perché ne costituiscono un presupposto
necessario, e per questo l’errore che le coinvolge non scusa allo stesso modo di un errore sulla
norma penale, e norme extrapenali che non integrano la norma incriminatrice e ne rimangono
distinte, e per questo l’errore che le coinvolge scusa come un qualsiasi altro errore sul fatto. La
Corte di cassazione ha però applicato questo criterio distintivo quasi sempre per sostenere la
tesi dell’integrazione tra norma penale ed extrapenale, con la conseguenza di negare efficacia
scusante all’errore. La cassazione ha fatto ciò con lo scopo di fare prevalere il principio
dell’obbligatorietà incondizionata della legge penale, ma in questo modo ha sostanzialmente
abrogato l’art. 47 comma 3. Questo orientamento è stato però temperato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 364 del 1988, con la quale si è stabilita la rilevanza scusante
dell’ignoranza o errore inevitabile sulla legge penale, infatti in questo modo un eventuale
errore sulla legge penale potrebbe comunque portare ad un’esenzione di responsabilità se lo
considerasse inevitabile e scusabile.
Secondo un auterevole orientamento dottrinale, invece, le norme extrapenali richiamate dalla
norma penale integrano sempre la fattispecie dell’illecito, e dunque un errore su quelle
extrapenali si traduce in un errore su quella penale. Questo errore avrebbe però efficacia
scusante poiché l’art. 47 comma 3 introdurrebbe una deroga espressa al principio
dell’inescusabilità dell’errore sul precetto penale ex art. 5. Questo orientamento è apprezzabile
poiché argina la sostanziale disapplicazione dell’art. 47 comma 3, ma presenta comunque il
difetto di trascurare le ipotesi in cui l’art. 47 opera anche in assenza di un fenomeno di
integrazione tra norma penale richiamante e norma extrapenale richiamata.
Per spigare l’ipotesi di errore richiamata dall’art. 47 comma 3, non è in realtà necessario
ricorrere all’idea che questa disposizione introduca una deroga espressa al principio
dell’inescusabilità dell’errore di diritto, infatti non si può dire con certezza che in mancanza di
una disposizione come questa sarebbe stato sempre operante l’art. 5: ad esempio con il vecchio
codice del 1889 l’errore su legge extrapenale era riconosciuto come scusante, nonostante una
disposizione come quella dell’art. 47.3 mancasse nel predetto codice e fosse già riconosciuto il
principio dell’ignorantia legis non excusat; si giungeva infatti a riconoscere efficacia scusante
all’errore su legge extrapenale facendo coerente applicazione dei principi generali che
presiedono alla responsabilità dolosa. Questo modello è tutt’oggi applicabile, infatti il dolo
presuppone la conoscenza di tutti gli elementi del fatto corrispondenti alla fattispecie astratta,
e se quest’ultima contiene elementi giuridicamente qualificati da norme extrapenali (ossia
elementi normativi), allora bisogna concludere che questi elementi si devano riflettere nella
mente dell’autore dell’illecito nel loro esatto significato giuridico, e per questo l’errore di
interpretazione di una legge extrapenale qualificative di un elemento del fatto di reato, nelle
87
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
conseguenze è psicologicamente uguale all’errore di fatto, e se è così, allora l’art. 47 comma 3 si
colloca nello stesso alveo dell’art. 47 comma 1, e si tratta in entrambi i casi di errore sul fatto
che costituisce reato.
In analogia all’art. 47 comma 1, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che anche
nel caso di errore su legge extrapenale possa esservi comunque responsabilità per colpa,
sempre che l’errore sia dovuto a colpa e che la legge preveda il fatto come delitto colposo.
La legge extrapenale dell’art. 47 comma 3, secondo l’opinione prevalente, non consiste soltanto nelle
norme di natura non penale, ma anche nelle norme penali diverse da quella incriminatrice del caso
concreto. Vi sono quattro tipologie di errore su legge extrapenale:
1. l’errore su legge extrapenale sarà sempre scusante se è un errore sugli elementi normativi
della fattispecie penale, ossia elementi per la cui definizione serve il rinvio ad una norma
diversa da quella incriminatrice considerata
2. l’errore su legge extrapenale è sempre scusante anche nel caso in cui esso verta sugli elementi
normativi di natura non giuridica, ma etico-sociale (se una persona tiene un comportamento
che considera idoneo al comune sentimento del pudore non risponderò del delitto di atti
osceni, perché manca la coscienza di un requisito fondamentale di fattispecie)
3. l’errore può escludere la responsabilità anche quando ricade su una norma extrapenale
integratrice di una norma penale in bianco: una parte della dottrina adotta a proposito un
orientamento restrittivo, distinguendo l’ipotesi in cui la norma penale in bianco contenga un
precetto generico ma sufficientemente determinato (l’errore in questo caso è rilevante) e
l’ipotesi in cui essa sia così indeterminata da rinviare, per l’individuazione del suo contenuto,
interamente alla norma extrapenale (in questo caso l’errore è irrilevante perché cadrebbe su
una norma che conferisce al precetto penale tutto il suo contenuto, e l’errore va dunque
convertito sulla legge penale, e, secondo l’art. 5, deve considerarsi irrilevante)
4. l’errore può ricadere su una norma extrapenale che in concreto rileva ai fini della valutazione
del significato di un elemento costitutivo del fatto, pur non instaurandosi però sul piano della
fattispecie astratta un esplicito rapporto di richiamo.
ERRORE DETERMINATO DALL’ALTRUI INGANNO
L’agente può anche commettere un errore a causa dell’inganno di un terzo, e l’art. 48 stabilisce a
questo proposito che le disposizioni dell’art. 47 si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce
reato è determinato dall’altrui inganno, e del fatto commesso dall’ingannato risponde chi l’ha tratto in
inganno. L’errore deve vertere su un elemento costitutivo del reato, poiché altrimenti esso non
escluderebbe il dolo, e permarrebbe perciò la responsabilità; non sono inoltre scusanti gli errori su
motivi, circostanze, ecc.
Per quanto riguarda l’inganno, esso può consistere in qualsiasi artificio o espediente che possa
sorprendere la buona fede altrui, infatti ciò che importa è che esso riesca a provocare una falsa
rappresentazione della realtà all’altro.
Secondo una parte della giurisprudenza, l’inganno dovrebbe rilevare soltanto se vi fosse una
particolare idoneità causale a provocare l’errore, e non dovrebbe rilevare quando l’errore si potrebbe
evitare con l’uso della normale diligenza. Questa tesi viene criticata perché introduce un’arbitraria
limitazione dell’applicazione dell’art. 48 c.p., che richiama l’intero art. 47 e che deve dunque
ricomprendere anche l’errore in cui concorra la colpa del deceptus, che dovrà eventualmente
rispondere per colpa.
REATO PUTATIVO
L’art. 49 comma 1 stabilisce che non è punibile chi commette un fatto non costituente reato
nell’erronea supposizione che esso costituisca reato, ossia commette un reato putativo commesso per
errore di fatto (es. un uomo si impossessa di una cosa propria, credendo di commettere furto di una
88
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
cosa altrui) o di diritto (es. un uomo commette adulterio pensando che esso costituisca reato).
Il reato putativo può essere anche commesso a causa dell’ignoranza di commettere il fatto in presenza
di una causa di giustificazione come la legittima difesa, o in presenza di discolpa.
Il reato putativo non comporta responsabilità per l’agente, infatti la sua convinzione di commettere un
illecito non ha rilevanza.
REATO ABERRANTE
La divergenza tra ciò che voleva l’agente e ciò che effettivamente realizza, può dipendere non soltanto
da un errore che incide sul momento formativo della volontà, ma anche da un errore nell’uso dei mezzi
di esecuzione del reato o da un errore dovuto ad altra causa.
L’art. 82 comma 1 stabilisce allora che quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o
per altra causa viene cagionata offesa ad una persona diversa da quella cui l’offesa era diretta, il
colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere
(salve le disposizioni dell’art. 60 su aggravanti e attenuanti). Questa è l’ipotesi della aberrato ictus
monolesiva, ossia il caso in cui un errore esecutivo fa mutare l’oggetto materiale dell’azione e il
soggetto passivo, ma l’offesa rimane normativamente identica, e non muta dunque il titolo del reato
(ad esempio un uomo invece che uccidere x sparandogli, uccide y).
La figura dell’aberratio ictus solleva però problemi sui criteri di attribuzione della responsabilità,
poiché ci si chiede se l’art. 82 comma 1 introduca o no una deroga ai normali principi dell’imputazione
dolosa. L’indirizzo dominante sostiene che questa disposizione sarebbe superflua, poiché si conforma
ai principi generali sull’elemento psicologico del reato (il dolo permane perché per configurarsi basta
che l’agente si rappresenti correttamente gli elementi rilevanti del fatto, e dunque per l’omicidio
doloso sarebbe ad esempio sufficiente che si verifichi un’uccisione, e sarebbe irrilevante quale tra x e y
venisse concretamente ucciso). Questa tesi viene però contestata da chi privilegia una ricostruzione
del dolo che ne esalti la concreta dimensione psicologica (non è in questo senso irrilevante il fatto che
ad essere ucciso sia y invece che x), e secondo chi sostiene questa visione non si tratta di dimostrare
un dolo astratto, ma di qualificare come dolosa la cassazione dell’evento concreto. Presupposto di
questa qualificazione è la reale congruenza tra ciò che è voluto dall’agente e ciò che viene da egli
realizzato, ed è infatti questa congruenza che sembra mancare nell’aberratio ictus. Se, dunque, si
considera che il dolo vada ricostruito in base all’esatta congruenza tra “voluto” e “realizzato”, allora
l’art. 82 comma 1 finisce per mascherare un’ipotesi di responsabilità oggettiva, e dovrebbe dunque
auspicarsi un intervento riformatore a proposito.
In attesa di questo intervento, una parte della dottrina prospetta una reinterpretazione di questo
istituto che lo renda più compatibile con il principio della colpevolezza, e infatti si sostiene che
l’evento cagionato ad una persona diversa da quella voluta debba essere attribuito lo stesso all’agente
in modo da non farne risultare una responsabilità oggettiva, e per fare ciò il giudice dovrebbe
verificare che l’errore esecutivo sia dovuto a colpa dell’agente, ossia all’inosservanza di una norma
cautelare (altri sostengono invece che il giudice avrebbe da accertare soltanto la mera prevedibilità in
concreto dell’evento cagionato a persona diversa).
Sono comunque fatte salve le circostanze aggravanti e attenuanti dell’art. 60, e in questo modo si
applica una disciplina delle circostanze orientata al principio della prevalenza del “putativo” sul reale.
L’art. 82 comma 2 dispone che qualora, oltre alla persona diversa, venga offesa anche quella verso cui
era diretta l’offesa, allora il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino
alla metà. Questo è il caso dell’aberratio ictus plurilesiva, e si pone anche qui il problema dei criteri
di attribuzione della responsabilità. La soluzione più conforme alla volontà legislativa è quella di
ritenere che si risponda a titolo di dolo per l’offesa alla vittima designata, e si risponde per
responsabilità oggettiva per l’offesa alla persona erroneamente colpita (poiché la norma per
l’attribuzione della responsabilità non richiede che venga accertata l’esistenza di un agire colposo).
Anche in questo caso parte della dottrina prospetta una reinterpretazione correttiva che renda
l’aberratio ictus plurilesiva compatibile con il principio di colpevolezza.
89
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
La sanzione per l’aberratio plurilesiva appare particolarmente rigorosa in ragione del suo carattere di
azione “particolarmente pericolosa”, infatti la sua sanzione sarà molto superiore, di regola, a quella
che si applicherebbe in caso di concorso formale di un delitto colposo con uno doloso.
Sorge tuttavia il problema di stabilire, nel silenzio del legislatore, quale debba essere il trattamento da
applicare quando oltre alla vittima designata si ledano più persone diverse, o quando ancora si
ledano più persone diverse ma non la vittima designata. Per alcuni andrebbero applicati tanti aumenti
di pena sino alla metà quante sono le persone non designate lese, mentre per altri le disposizioni
sull’aberratio ictus si dovrebbero applicare all’offesa non voluta più simile a quella voluta, mentre per
le altre si potrà, se vi sono i requisiti, avere una responsabilità a titolo di colpa. Visto che la
disposizione dell’art. 82 comma 2 ha natura anomala e derogatrice, sarebbe però in realtà preferibile
limitarne l’applicazione alle ipotesi espressamente previste, e dunque in caso di lesione di più persone
non designate con o senza offesa della vittima designata, si dovrebbe applicare il più benevolo regime
del concorso formale del reato doloso con eventuali delitti colposi, sempre che le offese non volute
siano dovute a colpa dell’agente.
ABERRATIO DELICTI
L’art. 83 comma 1 stabilisce che fuori dai casi previsti dall’art. 82, se per errore nell’uso dei mezzi di
esecuzione del reato o per altra causa si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole
risponde a titolo di colpa dell’evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto
colposo. Questa è l’aberratio delicti, ossia il caso in cui l’agente finisce con realizzare un reato che lede
beni o interessi diversi da quelli che voleva ledere. L’agente non può dunque rispondere per dolo
poiché non voleva provocare il danno che ha provocato, ma risponderà comunque per colpa se il fatto
viene previsto come delitto colposo. Si può ritenere che l’imputazione dell’evento non voluto venga
imputato al reo non come realmente colposo, ma piuttosto imputato come se fosse colposo ma sulla
base di un criterio di responsabilità oggettiva, e dunque l’art. 83 comma 1 ricomprende anche gli
eventi non voluti che sono conseguenza meramente accidentale dell’erronea condotta del reo.
L’art. 83 prevede anche che nel caso in cui il colpevole abbia cagionato anche l’evento voluto, allora si
applicano le regole sul concorso dei reati, e dunque egli risponde di un reato doloso e di uno colposo.
Anche nel caso dell’aberratio delicti una parte della dottrina suggerisce una lettura correttiva
dell’articolo che scongiuri la responsabilità oggettiva e che lo renda compatibile con il principio di
colpevolezza.
3. COSCIENZA DELL’ILLICEITÀ
La coscienza dell’illiceità è un elemento costitutivo autonomo della colpevolezza, ossia un requisito
distintivo che si aggiunge all’imputabilità, al dolo o alla colpa, e all’assenza di cause di discolpa.
Se la colpevolezza esprime un rimprovero per l’illecito commesso, allora il rimprovero sarà tanto più
giustificato quanto più l’agente sia consapevole di avere commesso un fatto che contrasti con
l’ordinamento giuridico.
L’art. 5 c.p. accoglie il tradizionale principio dell’ignorantia legis non excusat, e infatti si deve escludere
che la volontà colpevole richieda la piena conoscenza dell’illiceità penale. Questo principio trovava la
sua ratio nell’incondizionata prevalenza della legge e degli interessi pubblici da essa rappresentati nel
quadro di uno statualismo accentratore e autoritario, e la Corte costituzionale ha in un primo tempo
ritenuto che questo principio, anche se dotato di inclinazione autoritaria, potesse essere giustificato
anche nel nostro ordinamento democratico grazie alla possibilità di conoscere le norme penali,
possibilità garantita dalla pubblicazione della legge e dall’irretroattività delle norme penali. Tuttavia,
la prassi ha fatto sembrare astratta e iniqua la pretesa assolutezza del principio di inescusabilità
dell’errore su legge penale, tanto più che i delitti di pura creazione legislativa sono sempre crescenti
(ed essi non presentano una pre-esistente diffusa disapprovazione sociale) e le disposizioni penali
sono sempre più numerose, nonché spesso complesse e poco chiare.
Per questi motivi, talvolta la giurisprudenza riconosce rilevanza all’errore di diritto, ritenendo
90
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
scusante la “buona fede” nelle contravvenzioni, a condizione che la mancata conoscenza dell’illiceità
del fatto derivasse non dalla mera ignoranza della legge, ma da una circostanza che inducesse alla
convinzione della liceità del comportamento tenuto.
Per un’interpretazione correttiva dell’art. 5 c.p. è necessario l’art. 27 comma 1 Cost., che, sancendo il
carattere personale della responsabilità penale, impedisce di ritenere irrilevante la mancata
percezione del disvalore penale del fatto commesso. Inoltre, perché la funzione rieducativa dell’art. 27
comma 3 risulti attuabile e credibile la risposta punitiva deve operare nei confronti di un soggetto che
si trovi in condizione di avvertire il disvalore penale del fatto realizzato.
Per soddisfare l’esigenza costituzionale di una maggiore compenetrazione tra fatto autore, mediata
dalla coscienza del disvalore penale, non è tuttavia necessario richiedere l’effettiva conoscenza da
parte dell’agente del carattere criminoso del fatto, poiché altrimenti si porrebbe in primo piano
soltanto il principio di colpevolezza, mettendo in secondo piano le esigenze di prevenzione generale e
di tenuta complessiva dell’ordinamento penale. Per effettuare dunque un compromesso tra
colpevolezza e prevenzione generale ci si può accontentare di richiedere la possibilità di conoscenza
dell’illiceità, ossia la capacità di riuscire a percepire l’antigiuridicità del fatto commesso. La
conoscibilità dell’illiceità rende evitabile e dunque inescusabile l’ignoranza o l’errore in cui il soggetto
potrebbe eventualmente cadere (perciò se l’ignoranza è evitabile e inescusabile, permangono
colpevolezza e responsabilità penale, viceversa se essa è inevitabile e scusabile, allora non vi sono né
colpevolezza né responsabilità penale).
La Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988, seguendo la tesi appena illustrata, ha dichiarato
parzialmente illegittimo l’art. 5 c.p., nella parte in cui non escludeva dal principio dell’inescusabilità
dell’ignoranza della legge penale i casi di ignoranza inevitabile e dunque scusabile.
Rimane tuttavia da chiarire quando l’ignoranza della legge risulti inevitabile, e dunque quali siano i
criteri per in base ai quali emettere giudizio sull’inevitabilità-scusabilità dell’ignoranza o dell’errore.
Questi ultimi, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, possono essere considerati i
seguenti:
Criteri soggettivi puri: fanno prevalentemente leva sulle caratteristiche personali del
soggettoagente (livello di intelligenza, livello di maturazione della personalità, grado di
scolarizzazione, ecc.). Questi criteri rischiano tuttavia di portare a giudizi troppo indulgenti o
troppo rigorosi, e per questo la stessa Corte costituzionale suggerisce di ricorrere ad essi in
casi marginali in cui i deficit di personalità dell’agente emergono in maniera corposa e
incontrovertibile
Criteri oggettivi puri: tengono conto di cause che rendono impossibile la conoscenza della
legge penale da parte di ogni consociato, qualsiasi caratteristiche personali egli presenti. Questi
criteri vengono utilizzati ad esempio in caso di assoluta oscurità del testo legislativo (anche se
in questo caso a commettere una violazione è stato il legislatore, che ha violato il principio di
legalità e sufficiente determinatezza della fattispecie, ed il cittadino non può dunque essere
punito per avere disatteso un precetto privo di contenuto riconoscibile), o di un repentino
duramente giurisprudenziale sulla liceità di un comportamento (anche in questo caso a
commettere una violazione è in realtà il nuovo orientamento giurisprudenziale, che viola il
principio di non retroattività delle incriminazioni, ed è questa la ragione, prima ancora della
mancanza di colpevolezza, che giustifica in questi casi l’impunito di chi agisce convinto che un
certo comportamento non sia un reato, facendo leva sull’orientamento giurisprudenziale
preesistente)
Criteri “misti”: tengono contemporaneamente conto delle circostanze oggettive che inducono
ad ignorare la legge penale (come ad esempio più sentenze in contrasto tra loro, indicazioni
fuorvianti delle autorità competenti, ecc.) e delle caratteristiche personali del soggetto agente
(come ad esempio il livello di socializzazione e differenziazione culturale, il ruolo sociale
dell’agente, ecc.). Con questi criteri misti oggettivo-soggettivi si persegue l’obiettivo da un lato
di scongiurare l’abuso repressivo che deriva dalla mancata considerazione degli elementi
91
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
personali dell’agente, e dall’altro di evitare l’eccesso di clemenza che può derivare dalla
considerazione della sola personalità dell’agente. In questo modo si vuole infatti valutare
l’incidenza delle circostanze oggettive alla stregua delle caratteristiche soggettive dell’agente,
in modo da darne una valutazione nel complesso più accurata.
Questo modello di accertamento dell’inevitabilità-scusabilità si presta però ad essere influenzato
nell’applicazione dalla concezione della colpevolezza dalla quale si prendono le mosse (colpevolezza
come categoria che riflette coefficienti psicologici reali o colpevolezza come categoria normativa che a
volte viene funzionalizzata ad obiettivi repressivo-preventivi). Ci si chiede allora se e in che misura il
giudizio relativo alla rimproverabilità dell’ignoranza debba tenere conto dei processi psicologici reali
dell’agente, infatti può accadere:
1. che l’autore del fatto si rappresenti effettivamente, prima di agire, la possibilità che il suo
comportamento sia antigiuridico, e che nonostante questo egli lo realizzi senza adempiere
preventivamente l’obbligo di una maggiore informazione. In questo caso la rimproverabilità
dell’ignoranza trova fondamento nel processo psicologico che ha avuto luogo nella mente
dell’autore, e ciò significato che il suo comportamento merita di essere censurato perché il reo
ha di fatto pensato che il suo comportamento poteva essere illecito, ma ha comunque agito
2. che l’autore del fatto non si rappresenti la possibilità che il suo comportamento sia illecito
perché non affiora alla sua mente nessun dubbio né pensiero sulla giuridicità o meno della sua
azione. In questo caso il giudizio di colpevolezza non che può che avere un fondamento
normativo, nel senso che, supposta l’assenza di cause di inconoscibilità oggettiva della legge
penale, si rimprovera al soggetto di avere vibrato gli obblighi di informazione giuridica alla
base delle convivenza civile. Questo giudizio di colpevolezza risulta tuttavia più funzionale alla
funzione repressivo-preventiva del diritto penale.
Questo modello di soluzione della problematica dell’ignoranza della legge è il frutto di un
compromesso politico-criminale tra il riconoscimento del principio di colpevolezza e il
soddisfacimento di esigenze generalpreventive, e questo carattere di compromesso si può notare nella
complessità della struttura dei presupposti dogmatici sui quali la soluzione si basa. Il giudizio di
colpevolezza finisce col presentare un carattere ibrido, misto di dolo (riferito al fatto tipico) e di colpa
(riferita alla mancata conoscenza del divieto penale).
CORTE COST. 364/1988
Questa sentenza affronta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 c.p., nella parte in cui
non prevede la rilevanza dell’ignoranza inevitabile della legge penale.
Chiarito in limine che l’assoluta irrilevanza o rilevanza della legge penale non trovano entrambi valido
fondamento, dato che entrambi sacrificherebbero incondizionatamente, rispettivamente, la libertà e la
dignità della persona numana e la tutela dei beni dell’ordinamento.
A livello comparatistico si riscontra infatti che l’assoluta irrilevanza dell’ignoranza del diritto non è
mai stata affermata in alcun ordinamento.
Inoltre, affermare una presunzione di conoscenza, con conseguente finzione di conoscenza della
stessa, andrebbe a contrastare con le teorie del reato che includono la coscienza dell’illiceità come
elemento essenziale del reato.
La colpevolezza, intesa a livello costituzionale, è il principio garantista in base al quale si pone un
limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione di fatti, nel senso che devono
essere indicati i necessari requisiti subiettivi/soggettivi minimi d’imputazione.
Il principio di colpevolezza è indispensabile al soggetto per rendergli conoscibili direttive di
comportamento certe; con la necessaria presenza di elementi soggettivi, il soggetto potrà essere
chiamato a rispondere penalmente solo per azione da lui controllabili, mai per comportamenti
realizzati nella non colpevole ed inevitabile ignoranza del precetto.
Dagli stessi lavori preparatori della costituzione risulta che tutti i costituenti ebbero chiaro che la
responsabilità penale personale ex art. 27 comma 1 Cost. implicava necessariamente, oltre
all’elemento materiale, un requisito subiettivo.
92
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
In questo senso, non servirebbe a nulla da un lato garantire la riserva di legge, la tassatività del diritto
penale, quando, dall’altro, il soggetto possa essere chiamato a rispondere di fatti che non può in ogni
caso impedire o ravvisare il dovere, nascente dal precetto incolpevolmente ignorato, di evitarli.
Il principio di colpevolezza costituisce quindi un importante aspetto del principio di legalità.
Il combinato disposto del primo e terzo comma dell’art. 27 Cost. la funzione rieducativa della pena
richiede almeno la colpa del reo in relazione agli elementi più significativi della fattispecie. Solo nel
caso in cui alla pena si assegnasse una funzione deterrente, di prevenzione generale, si potrebbe
configurare una responsabilità penale per fatto non colpevole (non concepibile nel nostro
ordinamento).
La concezione di colpevolezza da adottare non è prefigurabile nella costituzione; l’unico risultato
ottenibile è che si deve poter muovere all’autore un rimprovero per la commissione di un illecito.
Questo significa che, perché sia legittimamente punibile, il fatto imputato deve necessariamente
includere almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica.
Ciò impone che vengano sottoposti a pena solo quegli episodi che esprimano contrasto o indifferenza
nei confronti dell’ordinamento, legittimando quindi anche l’intervento rieducatore e ammonitore della
pena.
La violazione del dovere di osservare le leggi penali, violazione che è implicita nella commissione
stessa di un fatto di reato, non fa eccezione. L’impossibilità di conoscenza del precetto non ascrivibile
alla volontà dell’interessato deve necessariamente escluderne la punibilità. L’ordinamento
costituzionale non permette che l’obbligo di non ledere i valori penalmente tutelati sorga in maniera
spontanea, ma deve essere legato all’effettiva o quantomeno alla possibile conoscenza di detto obbligo.
La possibilità di conoscenza della norma penale è infatti presupposto della rimproverabilità del fatto,
inteso come comprensivo sia degli elementi oggettivi, che di quelli soggettivi.
L’oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto non può gravare sul cittadino e costituisce quindi
un limite alla responsabilità penale personale.
Il passaggio dalla possibilità di conoscenza all’effettiva conoscenza delle leggi penali avviene
attraverso la mediazione dell’opera conoscitiva dei singoli. Incombono quindi sul privato specifici
doveri di informazione e conoscenza, che sono espressione dei doveri di solidarietà sociale ex art. 2
Cost., ai fini del rispetto degli interessi altrui; è proprio a causa dell’inadempimento di tali doversi che
è costituzionalmente consentito chiamare a rispondere anche chi ignora la legge penale.
Chi, nonostante abbia adempiuto a tutti i doveri di informazione e conoscenza, venga comunque a
trovarsi in uno stato d’ignoranza della legge penale, non può essere trattato allo stesso modo di chi
violi, per trascuratezza o deliberatamente, tali doveri.
La colpevolezza, non come principio, ma come elemento del reato, deve quindi investire anche
l’atteggiamento psicologico del reo di fronte ai doveri d’informazione e attenzione sulle norme penali.
L’inevitabilità dell’errore va valutata in base a criteri oggettivi, facendo quindi riferimento
all’impossibilità di conoscenza da parte di ogni consociato (oscurità del teso legislativo,
interpretazione caotica della giurisprudenza). Tuttavia, l’esame così operato alla stregua di criteri
oggettivi andrà compensato dall’esame di particolari conoscenze ed abilità posseduta dal singolo
agente.
4. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA
Secondo la concezione normativa, il rimprovero di colpevolezza presuppone anche l’assenza di
circostanze anormali concomitanti all’azione che rendano psicologicamente necessitato il fatto illecito.
Una parte della dottrina, per tenere conto dell’influenza esercitata dalle circostanze anormali sul
processo motivazionale dell’agente, ha fatto assurgere a causa generale di elusione della colpevolezza
l’inesigibilità, ossia l’impossibilità di pretendere, in concomitanza di queste circostanze, un
comportamento diverso da quello tenuto dall’agente. Una parte della dottrina configura dunque, come
cause di esclusione della colpevolezza (secondo alcuni riconosciute espressamente dal legislatore), lo
stato di necessità e la coazione morale, ma va comunque notato che il principio di inesigibilità
93
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
presenta un carattere aperto e analogico, e dunque idoneo ad operare anche come canone extra-
legislativo di giudizio (ad esempio un medico, già stanco e provato dalla giornata, cui viene chiesto di
percorrere quattro ore di camino nella neve per visitare un malato grave, si potrà rifiutare ed essere
giustificato non sulla base dello stato di necessità, che non ricorre poiché manca l’attualità del pericolo
, ma perché il comportamento è comunque inesigibile).
Un’ulteriore applicazione analogica del principio di inesigibilità è quella delle situazioni con un
insolubile conflitto di doveri, come ad esempio nel caso del soggetto che debba scegliere quale dei due
obblighi giuridici di pari rango adempiere, posto che essi non possono essere adempiuti
contemporaneamente (come per il medico che deve scegliere a quale malato applicare l’unico
apparecchio cuore-polmone disponibile). Alla problematica del conflitto di doveri in senso lato
possono ricondursi anche le situazioni in cui vi è un conflitto tra norme di condotta di sfere normative
diverse e autonome (come ad esempio quella giuridica e quella religiosa) e si parla in questi casi di
illecito per convinzione per alludere a reati che hanno come motivazione psicologica un convincimento
morale, religioso, o simili.
È tuttavia da escludere che l’inesigibilità possa avere quel carattere ampiamente scusante che una
parte della dottrina ipotizza, infatti l’inesigibilità rischia di essere piuttosto una clausola “vuota”, in
quanto incapace di indicare i criteri che dovrebbero presiedere alla risoluzione dei casi concreti (si
dice che un comportamento non è colpevole perché un comportamento diverso era inesigibile, ma non
si dice perché era inesigibile). Inoltre, anche potendosi effettuare una verifica dell’inesigibilità,
bisognerebbe sapere se parametrarla all’agente concreto o piuttosto all’uomo medio, ma entrambe le
possibilità presentano obiezioni e svantaggi. Si comprende dunque perché la categoria dell’inesigibilità
abbia finito negli ultimi tempi con l’essere messa in forse anche nell’ambito della stessa dottrina
tedesca che le aveva un tempo attribuito largo riconoscimento, infatti l’opinione dottrinale prevalente
in Germania oggi sostiene che alla inesigibilità non competa più il ruolo di causa generale di discolpa
applicabile anche a prescindere da precisi riscontri di diritto positivo. Questo orientamento restrittivo
prevale sicuramente per i reati commissivi dolosi, mentre viene riconosciuto più ampio spazio
all’inesigibilità nei reati colposi e in quelli omissivi. D’altra parte, infatti, il ricorso all’inesigibilità non
sembra indispensabile neanche nei casi che sono stati in precedenza citati, come ad esempio quello del
medico che deve scegliere a chi dei due pazienti applicare l’apparecchio (in questo caso infatti si può
considerare che a mancare sia la stessa antigiuridicità del comportamento tenuto).
Questo non significa comunque che il giudice penale debba ignorare il potente conflitto
motivazionale che può in alcuni casi tormentare l’agente, infatti nei reati dolosi la considerazione
delle circostanze anormali concomitanti, se non esclude la colpevolezza, servirà comunque ad
attenuare la misura della colpevolezza, e, conseguentemente, della pena.
SCUSANTI LEGALMENTE RICONOSCIUTE
L’inesigibilità non può dunque essere una causa generale ed extra-legale di esclusione della
colpevolezza, ma si potrebbe comunque prospettare un riconoscimento più cauto e circoscritto del
principio di inesigibilità alle sole ipotesi in cui esso è fondamento plausibile di cause di esclusione della
colpevolezza o scusanti (diverse dalle scriminanti o cause di giustificazione perché lasciano integra
l’antigiuridicità del fatto e fanno venir meno solo la possibilità di rimprovero) espressamente previste
dal legislatore.
In questi limiti ristretti sono riconducibili alla categoria delle scusanti:
1. lo stato di necessità scusante (o cogente): nello stato di necessità si considerare un’azione
differente fosse inesigibile solo per il caso di pericolo di danno grave alla persona dell’agente o
di un prossimo congiunto, mentre il “soccorso di necessità” è solo una causa di giustificazione
2. la coazione morale: la coazione morale fa riferimento alla situazione di chi compie l’azione
criminosa sotto la minaccia psicologica esercitata da un’altra persona
3. l’ordine criminoso insindacabile della pubblica Autorità: l’ordine legittimo elide
l’antigiuridicità del fatto e diventa così causa di giustificazione, mentre l’ordine criminoso
insindacabile non esclude l’illiceità del fatto commesso, e per escludere da responsabilità
94
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
l’agente bisogna dunque fare leva sulla situazione di forte pressione psicologica in cui si trova
di agire, la quale annulla i presupposti di un processo di normale motivazione
4. l’ignoranza o errore inevitabile-scusabile della legge penale: a seguito della sentenza n.
364/1988, poiché in questo caso non si può pretendere psicologicamente un comportamento
diverso conforme al diritto (poiché l’ignoranza era inevitabile, l’agente non aveva la possibilità
di comportarsi differentemente).
COLPEVOLEZZA NELLE CONTRAVVENZIONI
Il codice penale prevede una disciplina specifica per l’elemento soggettivo nelle contravvenzioni,
infatti l’art. 42 comma 4 dispone che nelle contravvenzioni ciascuno risponda della propria azione od
omissione cosciente e volontaria, dolosa o colposa, e l’art. 43 all’ultimo comma dispone invece che la
distinzione tra reato doloso e colposo stabilita per i delitti si applica anche alle contravvenzioni,
quando per queste la legge penale fa dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Per quanto riguarda l’art. 42 comma 4, vi sono state delle divergenze d’interpretazione, infatti la
formula “sia essa dolosa o colposa” era stata inizialmente interpretata come “indipendentemente dal
dolo o dalla colpa”. Questo orientamento risulta oggi superato, e si ritiene dunque che la norma
consideri indifferente non che colpa o dolo siano presenti, ma indifferente quali dei due tra dolo e
colpa sia presente.
Resta però oggi controversa la tecnica di accertamento dell’elemento soggettivo nelle
contravvenzioni. Una parte della dottrina sostiene che la legge avrebbe dispensato il giudice
dall’indagine sull’accertamento psichico del contravventore, sancendo una presunzione di
colpevolezza per dolo o colpa, e dando invece all’agente l’onere di prova contraria. Secondo un’altra
parte della dottrina, invece, in sede di accertamento sarebbe sufficiente ricorrere alle comuni regole di
esperienza, sulla base delle quali sarà consentito condannare se non vi sono circostanze che
evidenzino una situazione eccezionale in cui il soggetto abbia realizzato il fatto senza dolo o senza
colpa.
Queste impostazioni rispondono alle esigenze di economia procedurale e di velocità del processo, ma
non trovano in realtà appiglio normativo, poiché non vi è un esplicita disposizione che consenta per le
contravvenzioni di derogare ai principi generali in tema di accertamento.
Inoltre l’art. 43 comma 2, attribuendo rilevanza alla distinzione tra dolo e colpa anche nelle
contravvenzioni tutte le volte in cui da queste distinzioni derivino conseguenze giuridiche, ammette
che il giudice tenga conto dell’intensità del dolo e del grado della colpa ai fini della commisurazione
della pena (e per farlo il giudice deve dunque accertarsi se la contravvenzione sia stata commessa con
dolo o colpa). Va inoltre precisato che alcune contravvenzioni, per la loro natura o per la loro tecnica
legislativa, possono essere commesse solo con dolo, come l’abuso di credulità popolare, o solo con
colpa, come la rovina di edificio. Oltre alla commisurazione della pena, la distinzione tra dolo e colpa
rileva anche per gli effetti dell’abitualità, per l’amnistia limitata ai reati colposi, ecc.
95
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO QUATTRO
CIRCOSTANZE DEL REATO
Non è certo nata in epoca moderna l’idea di permettere a situazioni o fattori esterni agli elementi
costitutivi del reato di incidere sulla pena per aggravarla o diminuirla. Nasce però con l’illuminismo il
problema di prevedere legislativamente ed espressamente queste situazioni, dette circostanze del
reato, ovvero elementi che stanno intorno o accedono ad un reato già perfezionato nella sua struttura,
e la cui presenza determina soltanto una modificazione della pena in termini quantitativi o qualitativi.
Si parla anche di accidentalia delicti per sottolineare che solo elementi contingenti che possono
mancare senza che il reato venga meno.
Il codice Rocco ha introdotto una disciplina ampia e dettagliata di queste circostanze, le quali sono
state differenziate in:
Circostanze attenuanti comuni: riferibili a tutti i reati
Aggravanti speciali
Aggravanti comuni: novità rispetto alla legislazione precedente ed applicabili a tutti i reati
In tal modo, per un verso il legislatore fa si che si tenga conto di eventuali circostanze particolari che si
siano verificate per meglio adeguare la pena al caso concreto, per l’altro limita il potere discrezionale
del giudice, fissandolo entro limiti legislativamente precostituiti.
Ci si chiesto per tempo se la circostanza integri una fattispecie autonoma, o se crei una nuova
fattispecie penale complessa una volta combinatasi con gli elementi costitutivi del reato-base. Se si
considera che ogni elemento che incide sulla sanzione deve rientrare tra i presupposti della
conseguenza giuridica, allora è coerente contestare la tradizionale distinzione tra elementi accidentali
ed elementi essenziali del reato. Assumono rilevanza pratica due ulteriori problemi, ossia quello della
determinazione dei criteri idonei a distinguere tra elementi essenziali e circostanze del reato, e quello
che riguarda il rapporto tra circostanze in senso stretto e criteri di commisurazione della pena dati
dall’art. 133 c.p.
La disciplina delle circostanze del reato è stata profondamente innovata da:
legge n. 354 del 26 luglio 1975: in materia di attenuanti generiche, recidiva, giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi ed altro. Con questa riforma si è voluta
imitare la “tolleranza zero” statunitense, ma ci si è ispirati ad un poco nobile intento
discriminatorio, ossia quello di differenziare il rigore del trattamento penale creando un
“doppio binario”, uno più mite per coloro che commettono un reato per la prima volta, ed uno
molto più severo per i recidivi.
legge n. 251 del 5 dicembre 2005: ha modificato il codice penale, facendo sostanzialmente
un passo indietro nella storia, rinnegando la riforma del 1974 con il ripristino della prevalente
obbligatorietà degli aumenti di pena connessi alla recidiva, e con l’inasprimento del regime
sanzionatorio
CLASSIFICAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE
CLASSIFICAZIONE
Sono possibili diverse classificazioni delle circostanze:
CIRCOSTANZE ATTENUANTI
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Comportano un aumento della pena rispetto al Comportano una diminuzione della pena
reato base (variazione c.d. quantitativa). rispetto al reato base (variazione c.d.
Esistono tuttavia dei casi in cui l’effetto è di quantitativa). Esistono tuttavia dei casi in cui
modificare qualitativamente la sanzione l’effetto è di modificare qualitativamente la
sanzione, a vantaggio del reo
CIRCOSTANZE COMUNI
Previste dalla parte generale del codice, sono
potenzialmente applicabili ad un insieme non
96
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
predeterminabile di reati (artt.61,62,112,114) CIRCOSTANZE SPECIALI
Previste dal legislatore soltanto in relazione a
specifiche figure di reato (artt. 625,626)
CIRCOSTANZE OGGETTIVE
Ex art. 70 c.p., sono circostanze oggettive quelle
che concernono la natura, la specie, i mezzi,
l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità
dell'azione, la gravità del danno o del pericolo,
ovvero le condizioni o le qualità personali
dell'offeso
97
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CIRCOSTANZE SOGGETTIVE
Ex art. 70 c.p., sono circostanze soggettive
quelle che concernono la intensità del dolo o il
grado della colpa, o le condizioni e le qualità
personali del colpevole, o i rapporti fra il
colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti
alla persona del colpevole (es. imputabilità)
CIRCOSTANZE GENERICHE
CIRCOSTANZE TIPICHE
Se sono sufficientemente determinate in sede Spetta al giudice concretizzare elementi
di tipizzazione legislativa indicati dal legislatore in forma generica.
Additate anche come “indefinite”, per un
deficiti di tassatività, risultano compatibili con
l’art. 25 comma 2 Cost., dato che il principio di
effettività opera solo in casi sfavorevoli al reo, e
non se la norma è posta a suo beneficio.
CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE
Nella maggior parte dei casi la natura circostanziale di certi elementi della fattispecie risulta
univocamente dalla formulazione legislativa, ma vi sono anche casi in cui non è chiaro se l’elemento sia
una circostanza o un elemento essenziale di una diversa e autonoma figura di reato. Sorge dunque il
problema di determinare dei criteri per una distinzione certa tra questi due tipi di elementi, e, dal
momento che il legislatore non ha fornito degli indici sicuri, la dottrina si è sforzata di ricavarne alcuni
di natura ora sostanziale ora formale. Prescindendo da quelli più obsoleti e discutibili, oggi tende a
prevalere un criterio discretivo che fa leva sull’esistenza di un rapporto di specialità tra l’ipotesi
circostanziata e l’ipotesi semplice di reato, nel senso che la prima deve porsi in un rapporto di specie a
genere rispetto alla seconda, poiché deve includerne tutti gli elementi, con l’aggiunta di uno o più
requisiti tipizzanti.
In realtà la specialità è una condizione necessaria ma non sufficiente per la qualificazione di un
elemento come sostanziali, e dunque nei casi più dubbi possono essere utili criteri ausiliari come
nomen juris, precedenti storici, rubrica legislativa, ecc.
Tuttavia, non vi sono ancora criteri di distinzione veramente sicuri, e dunque l’individuazione degli
elementi circostanziali finisce per essere necessariamente risolta caso per caso, ed è per questo
auspicabile un futuro rimedio da parte del legislatore.
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE
La disciplina normativa del criterio di imputazione delle circostanze ha di recente subito una profonda
modifica da parte della legge n. 19 del 7 febbraio 1990.
Fino al 1990 l’impostazione originaria del codice prevedeva che le circostanze venissero attribuite in
base ad un criterio puramente obiettivo (ossia solo per la loro presenza, mentre era completamente
irrilevante che il soggetto se le rappresentasse o meno).
Con la legge sopra citata si sono sottoposte anche le circostanze, e più in particolare quelle aggravanti,
ad un regime di imputazione soggettiva, infatti il nuovo testo dell’art. 59 comma 2 (ex comma 1)
stabilisce oggi che “le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se
da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”. Il
principio nulla poena sine culpa è stato così esteso anche alle circostanze che aggravano la pena,
mentre è rimasta inalterata l’imputazione obiettiva delle attenuanti, in quanto incide favorevolmente
sul trattamento punitivo.
Secondo una parte della dottrina, l’effettiva conoscenza dell’elemento circostanziale sarebbe richiesta
soltanto per il reato doloso, secondo una regola di imputazione soggettiva differenziata, mentre per
l’attribuzione dell’aggravante nel reato colposo basterebbe, pur potendola conoscere, che il reo non ne
abbia conosciuto l’esistenza per colpa. Tuttavia, l’interpretazione dell’art. 59 che si è imposta come
dominante finora è quella secondo la quale, ai fini dell’imputazione della circostanza aggravante, basta
98
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
che il reo ne abbia ignorato per colpa l’esistenza, e non importa se la circostanza acceda ad un reato-
base doloso o colposo. Se la si intende in questo modo, allora la specifica colpevolezza relativa alle
circostanze aggravanti esige in tutti i casi come coefficiente minimo di imputazione la colpa.
La portata innovativa del nuovo art. 59 è però più esigua rispetto a quella che può apparire, infatti
anche quando vigeva la precedente formulazione la regola dell’imputazione obiettiva subiva deroga:
per espressa volontà del legislatore
implicitamente nei casi in cui la struttura stessa dell’aggravante fosse tale da rivelarsi
incompatibile con un criterio di attribuzione che prescindesse del tutto da coefficienti
soggettivi (es. le aggravanti riguardanti i motivi dell’azione criminosa, che richiedono
necessariamente una corrispondente rappresentazione mentale dell’agente).
Inoltre, anche in presenza di circostanze strutturalmente compatibili con un’imputazione di tipo
oggettivo, dell’effettivo atteggiamento psicologico dell’agente la giurisprudenza ha finito col tener
conto ai fini della concreta determinazione dell’aumento di pena.
Un’adesione ancora più piena al principio di colpevolezza si è registrata in due casi:
1. per l’ipotesi di errore sulla persona offesa da un reato: l’art. 60 c.p. dispone che “nel caso di
errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell’agente le circostanze
aggravanti, che riguardano condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e
colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte,
che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti”. Se dunque, ad esempio, una
persona, credendo di uccidere un suo nemico, uccidesse invece suo padre, non verrebbe
condannato per parricidio (il quale comporta un’aggravante), ma soltanto per omicidio
semplice, in deroga alla regola generale imposta dall’art. 59 comma 2.
2. per l’errore sulle attenuanti: se dunque, ad esempio, una persona a causa di un errore
percettivo uccidesse una persona diversa dal proprio “provocatore”, egli beneficerebbe
dell’attenuante della provocazione, come se egli avesse realmente ucciso il provocatore.
L’ultimo comma dell’art. 60 ripristina i criteri generali di imputazione dell’art. 59 comma 2 per le
circostanze che riguardano età, altre condizioni, o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.
CRITERI DI APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI E DIMINUIZIONI DI PENA
L’effetto giuridico tipico delle circostanze è quello di modificare il regime sanzionatorio previsto
per la figura semplice di un reato, ma non sempre sono uguali i criteri che presiedono a questa
variazione di regime.
Vi sono:
Circostanze ad efficacia comune: per le quali l’aumento o la diminuzione di pena è
dipendente dalla pena ordinaria, nel senso che si effettua una variazione frazionaria fino ad un
terzo della pena
Circostanze ad efficacia speciale: le quali, secondo l’art. 63 comma 3, comportano un
aumento o diminuzione della pena superiore ad un terzo
Prima della riforma del 1984, si riteneva che le circostanze ad efficacia o effetto speciale
fossero quelle che comportavano una pena di specie differente da quella prevista per il reato
base (cd. circostanza autonoma) e quelle che comportavano una determinazione della misura
della pena indipendentemente dalla pena ordinaria (cd. circostanza indipendente).
L’art. 63 comma 3, nella precedente formulazione, stabiliva che quando per una circostanza la
legge stabiliva una pena di specie diversa o ne determinava la misura indipendentemente dalla
pena ordinaria, allora l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze doveva operarsi non
sulla pena ordinaria, ma su quella stabilita per la circostanza. Non era però chiaro se nelle
circostanze ad efficacia speciale dovessero rientrare anche alcuni ipotesi marginali come ad
esempio le circostanze che importano una variazione frazionaria superiore al limite ordinario.
Con la riforma l. 400/1984, l’art. 63 comma 3 è stato riformulato non solo introducendo
l’etichetta di origine dottrinale di “circostanze ad effetto speciale”, ma fornendone anche una
99
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
definizione legislativa, disponendo che “quando per una circostanza la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o si tratta di circostanza ad effetto
speciale, l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del
reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale
quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”.
Nella nuova formulazione viene anche eliminata la menzione alle circostanze indipendenti,
mantenendo quella alle circostanze autonome, ma ci si chiede allora se esse non debbano più
essere sottoposte alla speciale disciplina dell’art. 63 comma 3:
A. Parte della dottrina considera che esse continuino ad esservi implicitamente
ricomprese, a condizione che anch’esse determinino, in base ad un ideale calcolo
frazionario, un aumento o diminuzione superiore ad un terzo.
B. Un’altra parte della dottrina propende invece per considerare che tutte le circostanze
indipendenti continuino implicitamente ad essere soggette alla disciplina di questa
disposizione. Se si propende per questa seconda tesi, la vera novità della riforma del
1984 consiste nell’aver risolto in senso positivo il dubbio relativo alla possibilità di far
rientrare nelle circostanze ad effetto speciale anche quelle che comportano una
variazione frazionaria della pena superiore ad un terzo.
CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI
Talvolta allo stesso fatto di reato possono accedere più circostanze, e si parla di concorso omogeneo
per designare le ipotesi in cui sono compresenti più circostanze della stessa specie, ossia tutte
aggravanti o tutte attenuanti.
La disciplina del concorso omogeneo si differenzia a seconda che si tratti di:
Concorso omogeneo di circostanze ad efficacia comune: nel cui caso l’art. 63 comma 2
dispone che l’aumento o la diminuzione si operi sulla quantità di pena risultante dall’aumento
o diminuzione precedente, sempre salvi i limiti espressamente previsti:
1. l’art. 66 dispone che se concorrono più circostanze aggravanti, la pena risultanti dagli
aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge, e in ogni caso non può
eccedere i trent’anni di reclusione o i cinque di arresto
2. nel caso di concorso di circostanze attenuanti, l’art. 67 dispone che la pena non può essere
inferiore a dieci anni se la pena prevista per il delitto è l’ergastolo, e negli altri casi non può
essere inferiore a quattro anni
Concorso omogeneo di circostanze ad efficacia speciale, nel cui caso l’art. 63 comma 4
stabilisce che, se concorrono più circostanze aggravanti, si applica la pena stabilita per la
circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla.
Al comma 5 stabilisce, invece, che se concorrono più attenuanti si applica solo la pena meno
grave stabilita per le circostanze predette, ma il giudice può diminuirla.
Concorso omogeneo tra circostanze a efficacia comune e ad efficacia speciale: nel cui caso
l’art. 63 comma 3 stabilisce che “quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale,
l’aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato,
ma sulla pena stabilita per la circostanza”
quando infine, ex art. 68, “fuori dai casi di specialità” (art. 15), una circostanza aggravante
comprende in sé un’altra aggravante, o quando ciò accade con due attenuanti, allora è valutata
a carico o favore del colpevole solo la circostanza aggravante o l’attenuante che importa il
maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Si ha invece concorso eterogeneo quando ad uno stesso fato accedono circostanze aggravanti e
attenuanti. A differenza del codice Zanardelli, che prevedeva l’applicazione congiunta dei singoli
aumenti e diminuzioni, il codice Rocco ha introdotto il principio del bilanciamento, e dunque in base
100
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
all’art. 69 c.p. il giudice deve procedere ad un giudizio di prevalenza o equivalenza tra le circostanze
eterogenee, nel cui caso deve applicare solo le circostanze prevalenti, o equivalenza, nel cui caso dovrà
comminare la pena che si sarebbe avuta se non vi fossero state circostanze. Tale innovazione fu
ritenuta necessaria per garantire una visione organica e completa del giudice su colpevole e reato, in
modo tale che la pena da applicare in concreto fosse per quanto possibile il risultato di un giudizio
complessivo e sintetico sulla personalità del reo e sulla gravità del reato, anziché l’arido risultato di
successive operazioni aritmetiche.
In origine il giudizio di bilanciamento era limitato alle circostanze ad efficacia comune, poiché si voleva
sottrarre al sindacato valutativo del giudice la gravità delle circostanze speciali, che già erano stato
autonomamente valutate dal legislatore. Tuttavia, a seguito della riforma del 1974, il giudizio di
comparazione non incontra oggi alcun limite, e questo per attenuare l’eccessivo rigore sanzionatorio di
diverse fattispecie del codice Rocco e dei furti aggravati da circostanze speciali. Questa decisione
incontra però alcune obiezioni, in quanto si è così delegato al giudice in sede di commisurazione della
pena, il compito di adeguare il trattamento sanzionatorio alla mutata sensibilità sociale, dilatando così
eccessivamente il potere discrezionale del giudice.
Con il silenzio del legislatore sul tema, sorge il problema dell’individuazione dei criteri del giudizio
di bilanciamento: secondo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza i criteri
andrebbero ricavati dai parametri dell’art. 133 che disciplina il potere discrezionale del giudice nella
commisurazione della pena. L’obiezione a questa tesi è il fatto che l’articolo citato non disciplina
l’eventuale contrasto tra uno degli elementi che dispone per la valutazione. Un’opinione minoritaria,
ma forse preferibile, ritiene invece che il giudizio di comparazione vada effettuato mettendo a
confronto le circostanze eterogenee considerate nella loro specifica intensità accertata in concreto, e
non in astratto; questo criterio non può tuttavia essere applicato in maniera generale, né certo.
Da questo si trae che il giudizio di bilanciamento disciplinato dall’art. 69 c.p. dà spazio ad un potere
discrezionale libero da criteri-guida di fonte normativa.
Nel 2005, per cercare ad ovviare il problema dell’eccessivo spazio discrezionale del giudice, si è
inserito un ultimo comma nell’art. 69, che introduce un divieto di prevalenza delle circostanze
attenuanti sulle aggravanti in due ipotesi:
1. nei casi di recidiva reiterata (art. 99 comma 4)
2. nei casi previsti dagli artt. 111 e 112 comma 1 numero 4, relativi alla determinazione del reato
di persone non imputabili o non punibili
Questa riforma ha però suscitato riserve di ordine costituzionale, in quanto alcuni hanno ritenuto e
ritengono che la preclusione di un giudizio di prevalenza a favore dei recidivi reiterati leda il principio
di eguaglianza e i principi di individualizzazione del trattamento punitivo e di rieducazione ex art. 27
Cost.
APPLICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE E COMMISURAZIONE DELLA PENA
Le circostanze ad efficacia comune comportano un aumento o diminuzione sino ad un terzo della
pena che si sarebbe altrimenti inflitta per il reato-base, ma ciò significa che è il giudice a dovere
discrezionalmente decidere la misura della pena entro il minimo di un giorno e il massimo - un terzo -
della variazione di pena prodotta dalle circostanze. Va notato che questa discrezionalità di aggiunge a
quella data al giudice dall’art. 133 c.p. nella commisurazione della sanzione tra minimo e massimo
edittali. Sorge però il rischio, in questo modo, che circostanze di identico contenuto vengano prima
valutate per scegliere le pena entro minimo e massimo edittali del reato-base, e una seconda volta
valutate per stabilire l’entità della variazione connessa alla circostanza. Questa doppia valutazione di
elementi identici o analoghi va però contro il principio del ne bis in idem, e dunque lo stesso elemento
di fatto in sede di determinazione della pena va computato una sola volta
LE SINGOLE CIRCOSTANZE
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI
101
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
L’art. 61 c.p. contiene il catalogo delle circostanze aggravanti comuni, le quali sono:
1. “L’avere agito per motivi obietti o futili”
Il motivo è l’impulso-istinto che spinge psicologicamente l’agente ad agire, e la giurisprudenza
lo considera abietto quando è turpe e ignobile, e rivela nell’agente un tale grado di perversità
da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità; viene invece
considerato futile quando sussiste un’enorme sproporzione tra il movente e l’illecito.
Questa aggravante non viene ritenuta compatibile con l’attenuante della provocazione, e si
considera inoltre che essa abbia natura soggettiva.
2. “L’avere commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o
assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato”
Questa aggravante viene giustificata in base alla maggiore pericolosità di chi è disposto a
commettere un reato-mezzo pur di attuare il suo intento criminoso.
Ci si chiede però se questa aggravante debba sopravvivere anche a seguito della riforma
novellistica del 1974 riguardante il reato continuato. Il reato continuato si configura infatti
anche in presenza della violazione di leggi che configurano reati diversi, purché vi sia un
medesimo disegno criminoso: questo tipo di reato sembra coincidere con l’aggravante in
esame, e sembrerebbe dunque contraddittorio ritenere che la commissione di più reati uniti da
un unico vincolo possa contemporaneamente dare luogo ad un trattamento aggravato (sulla
base dell’aggravante teleologica) e ad un trattamento di favore (sulla base del reato
continuato). Nonostante sembri la soluzione più logica, la giurisprudenza prevalente respinge
la tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 61 comma 2 c.p.
3. “L’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento”
Questa ipotesi è quella della colpa cosciente o con previsione, che è opportuno trattare
nell’ambito del delitto colposo.
4. “L’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone”
Le sevizie, secondo la giurisprudenza, sono l’inflizione di sofferenze fisiche non necessarie alla
realizzazione del reato, mentre la crudeltà è l’inflizione di sofferenze morali che oltrepassano i
limiti della normale umanità e comunque non necessaria alla realizzazione del reato.
È controverso se questa aggravante abbia natura oggettiva, e attenga dunque alle modalità
dell’azione, o natura soggettiva, e denoti quindi una maggiore criminosità dell’agente. Si ritiene
comunque che essa sia compatibile con l’attenuante della provocazione.
5. “L’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età
avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”
Questa aggravante è la “minorata difesa”, ed è da considerarsi di natura oggettiva poiché
attiene alle modalità dell’azione.
6. “L’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente
alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito
per un precedente reato”.
Questa aggravante si riferisce alla situazione di latitanza, ma gli effetti giuridici conseguono
non alla qualificazione formale di latitanza ex art. 296 c.p.p., ma alla situazione di fatto sottesa
alla qualifica giuridica. Dunque, se ne deve dedurre, nonostante l’ultimo comma dell’art. 296
c.p.p. paragoni l’evito al latitante, che la circostanze aggravante in esame non si possa applicare
ai reati commessi dall’evaso. Questa circostanza ha natura soggettiva, perché si riferisce alle
condizioni e qualità personali del colpevole.
7. “L’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio [dunque
anche quelli che, pur non essendo definiti “delitti contro il patrimonio”, hanno conseguenze
pregiudizievoli nei confronti del patrimonio altrui], ovvero nei delitti determinati da motivi di
lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevane gravità”.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la rilevanza del danno vada valutata sul piano
oggettivo, prescindendo dalla capacità economica del danneggiato, mentre bisogna riferirsi alla
102
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
sua capacità economica solo come elemento sussidiario di valutazione cui ricorrere se la
valutazione intrinseca del danno non consente da sola di stabilire con certezza se esso sia di
rilevante gravità. Si ritiene inoltre che il danno vada accertato tenendo conto del momento in
cui il reato viene commesso. Inoltre, ai fini della configurabilità dell’aggravante, è un elemento
di danno valutabile anche il lucro cessante.
Questa aggravante ha natura oggettiva.
8. “L’avere aggravato tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso”
Questa ipotesi viene raramente applicata, ed è inoltre controversa la sua natiura, che appare
soggettiva se di pone l’accento sul profilo relativo alla persistente del proposito criminoso, e
oggettiva se si pone l’accento sul profilo della gravità del danno o del pericolo.
9. “L’avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto”
Questa aggravante non si può applicare nei casi in cui l’abuso costituisce elemento integrante
del reato- base, inoltre essa si può applicare non soltanto se si è in presenza di una delle qualità
elencate, ma se il loro possesso ha in qualche modo agevolato l’esecuzione del
reato. L’aggravante non può però essere applicata se l’abuso non è doloso, e si applica dunque
solo se effettivamente conosciuta e voluta.
Dominante è l’opinione che ritiene questa aggravante di natura soggettiva perché riguarda
qualità personali del reo.
10. “L’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico
servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello
Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa
dell’adempimento delle funzioni o del servizio”
Questa aggravante è dunque posta a tutela di persone che svolgono determinate funzioni, in
ragione dello speciale ruolo da essi rivestito.
In giurisprudenza è stato recentemente affermato che capo e funzionari di uno Stato estero
non sono assimilabili agli agenti diplomatici e consolari accreditati presso il governo italiano, e
si ritiene dunque che l’aggravante non sia ad essi applicabile.
Questa circostanza aggravante ha natura oggettiva perché riguarda la persona dell’offeso.
11. “L’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazione di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità”
La ratio di questa circostanza aggravante è l’abuso di fiducia di chi compie un reato a danno di
persone legate da particolari relazioni con il soggetto attivo, ma la relazione fiduciaria non va
di volta in volta provata, in quanto può ritenersi presunta.
Si ha:
Abuso di autorità: quando si approfitta di una condizione di supremazia nei confronti
del soggetto passivo
Abuso di relazioni domestiche: quando i coinvolti appartengono allo stesso nucleo
familiare
Abuso di relazione di ufficio: quando si abusa di una relazione che può essere anche di
mero fatto, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridic
Abuso di prestazione d’opera: qualsiasi rapporto in virtù del quale l’agente presti a
qualunque titolo la propria opera in favore di altr
Abuso di coabitazione: non rientra, secondo la giurisprudenza, solo la convivenza, ma
anche la permanenza momentanea di più persone nello stesso luogo idoneo alla vita
domestica
Abuso di ospitalità: si ritiene sufficiente che il soggetto attivo venga accolto
consensualmente dall’ospitante, anche occasionalmente.
Questa circostanza aggravante ha natura soggettiva perché riguarda i rapporti tra
colpevole e offeso.
11 bis. “L’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio
103
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
nazionale”
Questa circostanza è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 249 del 5 luglio 2010.
11 ter. “L’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore
all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione”
Questa aggravante cerca di rispondere all’esigenza di fronteggiare il fenomeno del bullismo,
ma questo inasprimento del regime sanzionatori non pare lo strumento più congruo ed efficace
per contrastare un fenomeno che ha profonde e complesse radici socio-psicologiche, e che
dovrebbe per questo essere fronteggiato piuttosto con interventi di politica sociale e culturale.
La circostanza ha natura oggettiva.
11 quater. “L’avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era
ammesso ad una misura alternativa alla detenzione”
Questa circostanza aggravante ha l’obiettivo di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure
alternative alla detenzione, sanzionando in maniera più grave chi ha commesso un reato
doloso durante il tempo in cui godeva di una misura alternativa
11 quinquies. “L’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la
libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572 [maltrattamenti contro familiari o
conviventi], commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in
danno di persona in stato di gravidanza”
Questa aggravante ha l’obiettivo di proteggere le persone considerate più vulnerabili.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI
L’art. 62 contiene invece il catalogo delle circostanze attenuanti “comuni”, le quali sono:
1. “L’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale”
Orientamento giurisprudenziale dominante sostiene che sia necessario che il movente sia
apprezzabile alla stregua degli atteggiamenti etico-sociali prevalenti. Nella maggior parte dei
casi, però, i giudici incorrono in aporie logiche che portano alla ritenuta inapplicabilità di
questa attenuante, poiché commettono l’errore di subordinare il giudizio sulla meritevolezza
del motivo a quello sulla meritevolezza della condotta in sé considerata. In questo modo si
perde di vista che l’azione non potrebbe mai essere considerata comportamento meritevole,
perché è pur sempre una condotta criminosa.
Bisogna dunque tenere separata l’azione dai motivi, in modo da poter applicare l’attenuante a
tutti i reati, persino i più gravi. Quello che è necessario è che tra l’azione illecita e il motivo
apprezzabile suscita un rapporto di congruenza esteriormente accettabile (come avviene ad
esempio per l’obiezione di coscienza, le manifestazioni pacifiste, ecc.)
Questa circostanza attenuante ha natura soggettiva, e può concorrere con la premeditazione.
2. “L’avere reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui”
Questa è l’attenuante della provocazione, che ha un momento soggettivo (lo stato d’ira) e uno
oggettivo (il fatto ingiusto, che deve essere verificato, e non vale infatti il convincimento
putativo della sussistenza della provocazione).
La giurisprudenza considera che manchi il nesso causale tra fatto ingiusto del soggetto passivo
e reazione dell’agente quando non vi è proporzione e adeguatezza tra provocazione e reazione.
Questa attenuante può concorrere con quella dei motivi di particolare valore morale e sociale,
e con il vizio parziale di mente, mentre non è compatibile con la premeditazione. Essa ha
inoltre natura soggettiva.
3. “L’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o
assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o
contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza”
La ratio viene ravvisata, forse in modo esagerato, nel fatto che le folle posso talvolta esercitare
un’efficacia suggestiva che allenta i freni inibitori e facilita la commissione di reati.
Questa attenuante ha natura soggettiva.
104
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
4. “L’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti
determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un
lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”
Con la legge n. 19 del 1990 si è integrato questo articolo introducendo la novità della presa in
considerazione del lucro e della sua entità, mentre prima si faceva riferimento al solo danno.
Il danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere valutato in relazione al valore della cosa,
mentre costituisce criterio solo sussidiario il riferimento alle condizioni economiche del
soggetto passivo; inoltre, l’accertamento deve avere riguardo al momento della consumazione,
e deve escludersi qualsiasi giudizio successivo al verificarsi del reato.
Il legislatore richiede, oltre alla speciale tenuità del lucro, anche la speciale tenuità dell’evento
dannoso o pericoloso, e ciò significa che l’offesa deve, per qualità e grado, apparire priva di
serio disvalore penale (nell’ipotesi di reato continuato la valutazione deve compiersi riguardo
ai singoli episodi delittuosi).
La circostanza attenuante ha natura oggettiva.
5. “L’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il
fatto doloso della persona offesa”
Per applicarsi, è dunque necessario un elemento materiale l’inserimento dell’azione dell’offeso
nella serie delle cause determinanti dell’evento) ed un elemento psichico (la volontà di
concorrere alla produzione dell’evento medesimo). Il concorso del fatto doloso dell’offeso deve
soltanto essere una concausa, e non essere causa sopravvenuta da solo sufficiente a produrre
l’evento, poiché altrimenti, in base all’art. 41 ult. comma, si interromperebbe il nesso causale
tra l’evento e l’azione del colpevole. Questa circostanza ha natura oggettiva.
6. “L’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso
preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”
L’art. 62 prevede due distinte circostanze attenuanti fondate sul ravvedimento del colpevole:
una prima circostanza è il risarcimento o riparazione del danno, che deve essere
effettivo ed integrale, in modo da compensare il danno patrimoniale e quello
extrapatrimoniale, e deve inoltre provenire dallo stesso colpevole (perché altrimenti
non si avrebbe ravvedimento). La dottrina a lungo dominante l’aveva considerata
un’attenuante di natura soggettiva, mentre con la sent. 138/1998 la Corte
costituzionale l’ha considerata oggettiva, poiché il fatto che il risarcimento deve essere
integrale è indice non solo dell’irrilevanza dell’atteggiamento interiore del reo, ma del
preminente risvolto che si intende dare all’esigenza che il pregiudizio subito dalla
persona offesa sia interamente riparato
una seconda circostanza è l’adoperarsi in modo spontaneo ed efficace per elidere o
attenuare le conseguenze del reato: la giurisprudenza ritiene che ci si riferisca qui alle
conseguenze diverse da quelle patrimoniali, e si esclude dunque l’applicabilità di
questa attenuante ai reati contro il patrimonio. Prevale qui l’opinione che si tratti di
una circostanza di natura soggettiva
CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE
Con il [Link]. n. 288/1944 art. 2 si è introdotto nel codice penale l’art. 62 bis, che ha a sua volta
introdotto le attenuanti generiche (che non erano state inserite nel 1930 per l’ispirazione
accentuatamente rigoristica del codice). L’art. 62 bis dispone che il giudice, indipendentemente dalle
circostanze previste dall’art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse se le ritiene
tali da giustificare una diminuzione della pena (e sono comunque considerate come una sola causa, che
può concorrere con le attenuanti dell’art. 62).
Sono controverse la natura e le funzioni delle attenuanti generiche, ma secondo l’orientamento più
tradizionale l’art. 62 bis costituirebbe una sorta di appendice dell’art. 133 in grado di consentire una
105
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
riduzione del minimo edittale se questo è sproporzionato rispetto alla gravità del fatto e la personalità
del colpevole (funzione identica a quella degli indici generali della commisurazione della pena). Questa
impostazione ha però il difetto di annullare la funzione autonoma dell’art. 62 bis, e andrebbe dunque
preferita l’interpretazione dell’articolo che gli assegna la funzione autonoma di permettere al giudice
di cogliere un valore positivo del fatto, nuovo o diverso, perché relativo al caso concreto, e dunque
particolare, rispetto ai valori dell’art. 62.
Anche per le attenuanti generiche vale il principio del divieto di doppia valutazione, infatti esso va
comunque valutato una sola volta, in virtù del principio ne bis in idem.
Le circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere sempre considerate come una sola circostanza,
sono soggette al principio del bilanciamento ex art. 69 commi 2 e 3.
Alcuni esempi di attenuanti generiche possono essere l’attenuante del danno di speciale tenuità che è
modesto ma non lievissimo, o quella che si può applicare ad un reato commesso in condizioni di
bisogno economico, ecc.
La legge di riforma del 2005 ha innovato anche in materia di circostanze attenuanti generiche, con
l’aggiunta di un secondo comma dell’art. 62 bis che limita l’applicabilità della diminuzione di pena ai
recidivi reiterati che siano autori di alcune tipologie delittuose previste dall’art. 407 del codice di rito.
L’art. 62 bis comma 2 stabilisce che “ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei
criteri di cui all’art. 133 primo comma numero 3) e secondo comma, nei casi previsti dall’art. 99 quarto
comma, in relazione ai delitti previsti dall’art. 407 comma 2 lettera a) del codice di procedura penale,
nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni”.
Obiezioni possono essere mosse sia riguardo alla formulazione legislativa, sia riguardo al merito.
L’obiettivo della norma è infatti quello di ridurre la discrezionalità valutativa del giudice ai fini della
concedibilità delle circostanze generiche nelle ipotesi di recidiva reiterata, impedendo al giudicante di
tenere conto dei criteri di commisurazione della pena che si riferiscono all’intensità del dolo e alla
capacità a delinquere del reo. Secondo il legislatore del 2005, risulta dunque giustificata una
presunzione normativa a carattere assoluto sull’elevata intensità del dolo e sull’elevata capacità a
delinquere dei recidivi reiterati che commettono uno dei delitti che vengono nominati dal comma. La
scelta di comprimere la discrezionalità del giudice trova però l’obiezione che la vede irragionevole alla
stregua dei principi generali della responsabilità penale.
Per questo motivo non è sorprendente che la Corte costituzionale abbia dichiarato la norma
parzialmente illegittima per contrasto con il principio di rieducazione e quello di ragionevolezza, in
quanto impedisce di utilizzare il criterio del comportamento tenuto dopo la comunione del fatto di
reato per la concessione al recidivo reiterato delle circostanze generiche.
Con il “decreto di sicurezza” n. 92 del 2008 si è resa ancora più restrittiva la disciplina delle
circostanze attenuanti generiche, aggiungendo un comma 3 all’art. 62 bis che dispone che “in ogni
caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò
solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma”. Questo nuovo
comma ha l’obiettivo di guidare e limitare la discrezionalità del giudice in chiave anti-clemenzistica,
ma la prassi e la storia ci insegnano che una semplice aggiunta nel testo, se non vi si accompagna un
reale cambiamento della cultura giudiziale, non basta a promuovere un effettivo riorientamento della
prassi applicativa.
RECIDIVA
Il codice, tra le circostanze inerenti la persona del colpevole, annovera la recidiva, per la quale secondo
il testo originario chi dopo essere stato condannato per un reato, ne commetta un altro, poteva
infliggere un aumento di pena. Con la riforma del 2005 la recidiva è stata ampiamente trasformata da
facoltativa in obbligatoria, e sono stati previsti più consistenti aumenti di pena e ulteriori effetti
giuridici (tutto questo per una paura di svalutazione della recidiva a causa dell’atteggiamento
clemenzialista da parte dei giudici, i quali possedevano ampio potere discrezionale).
La recidiva presenta le seguenti caratteristiche:
106
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
I reati-presupposto sono stati modificati, includendo, dopo la riforma, solo i delitti non
colposi, escludendo sia l’illecito colposo sia quello contravvenzionale, e facendo così diventare
recidivo solo chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commette un altro
delitto non colposo. Tuttavia, la ragionevolezza politico-criminale di tale scelta innovativa-
delimi
Non è facile dare una risposta univoca all’interrogativo che riguarda il fondamento dell’istituto
e il connesso aumento di pena. Si può comunque dire che l’aumento di pena per la recidiva
trova giustificazione nel fatto che la misura di pena inflittiva che si essa comminata nella
precedente condanna si è rivelata insufficiente a distogliere il reo da commettere nuovamente
reati.
Nel nostro codice penale la recidiva si pone in relazione con il concetto di capacità a
delinquere ex art. 133 comma 2, infatti la recidiva, da questo punto di vista, è indice della
maggiore capacità a delinquere del soggetto, il quale mostra sia una maggiore insensibilità ai
precetti dell’ordinamento, sia una maggiore propensione a delinquere in futuro.
La recidiva, oltre all’aumento della pena, comporta anche ulteriori conseguenze giuridiche
minori in rapporto all’amnistia, all’indulto, alla sospensione condizionale, all’estinzione della
pena ecc.
L’art. 99 prevede tre forme di recidiva:
1. Recidiva semplice: consiste nella commissione di un delitto non colposo a seguito della
condanna irrevocabile per un altro delitto non colposo, indifferentemente dal tempo trascorso
tra le due condanne. A seguito della riforma, si applica in questo caso un aumento di un terzo
della pena (prima era fino ad un sesto, e dunque a discrezionalità del giudice e in misura
minore). Presupposto dell’applicabilità dell’aggravamento della pena è che il precedente
delitto sia stato accertato con una sentenza definitiva di condanna, ma non è necessario che la
pena sia stata effettivamente scontata.
Per la sussistenza della recidiva si tiene anche conto delle precedenti condanne per cui sia
intervenuta una causa di estinzione del reato (es. amnistia) o della pena (es. prescrizione della
pena), in quanto cd. effetto penale della condanna, ma non delle precedenti condanne per cui
siano intervenute cause estintive di ogni effetto penale (es. riabilitazione).
2. Recidiva aggravata: ex art. 101, consiste nella commissione di un altro delitto non colposo
della stessa indole del precedente (cd. recidiva specifica) o nella commissione di un delitto non
colposo entro cinque anni dalla condanna precedente (cd. recidiva infraquinquennale), o nella
sua commissione durante o dopo l’esecuzione della pena, o ancora durante il tempo in cui il
condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena stessa.
In questo caso si può applicare un aumento della pena fino alla metà (prima era fino ad un
terzo), ma se concorrono più circostanze tra quelle che fanno da presupposto alla recidiva
aggravata, l’aumento di pena è della metà.
Riguardo alla recidiva specifica, all’art. 101 si precisa che “agli effetti della legge penale, sono
considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di
legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse del codice o da leggi
diversi, nondimeno, per natura dei fatti che li costituiscono [ad esempio ingiuria, diffamazione
e vilipendio; truffa, frode in commercio e bancarotta fraudolenta] o dei motivi che li
determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni [ad esempio
danneggiamento e omicidio determinati dall’intento di realizzare una vendetta mafiosa]”. Di
conseguenza, tra i reati stessi, considerati nella loro concretezza, dovranno intercorrere
caratteri fondamentali comuni.
3. Recidiva reiterata: consiste nella commissione di un nuovo delitto non colposo da parte di chi
è già recidivo. Per questa circostanza la riforma del 2005 ha irrigidito gli aumenti di pena, che
adesso sono:
107
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
A. metà (e non fino alla metà): nel caso di recidiva semplice
B. due terzi (e non fino a due terzi): se la precedente recidiva è aggravata specifica o
infraquinquennale o si riferisce ad un delitto non colposo commesso durante o dopo
l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae
volontariamente all’esecuzione della pena stessa.
4. Una nuova forma di recidiva prevista dal novellato art. 99 comma 5 è la recidiva (reiterata)
obbligatoria del soggetto recidivo che commette uno dei delitti indicati all’art. 407 comma 1
lettera a) c.p.p.
Per la prima volta questo catalogo di reati viene assunto come fondamento per la disciplina di
un istituto di diritto sostanziale come la recidiva, senza una ragionevole motivazione politico-
criminale. Quel catalogo di reati, prima della riforma, serviva infatti ad alimentare una sorta di
doppio binario con riferimento ad esigenze tipicamente processuali. Non è tuttavia
scientificamente sostenibile l’idea di una recidiva obbligatoria basata sulla restaurazione di
una presunzione legale di pericolosità.
L’ipotesi di recidiva obbligatoria non è limitata ai casi di reiterazione, ma include anche quelli
di recidiva aggravata di cui al comma 2, rispetto ai quali la pena non può essere inferiore ad un
terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
Va chiarito inoltre che, a parte l’ipotesi della recidiva reiterata obbligatoria, l’applicazione della
recidiva resta facoltativa.
5. L’art. 99 ultimo comma dispone infine che in nessun caso l’aumento di pena per effetto della
recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla
commissione del nuovo delitto non colposo.
La riforma del 1974 ha però finito con il riproporre il problema relativo alla natura giuridica
dell’istituto, infatti la dottrina aveva già in passato criticato la sua introduzione all’interno della
circostanze, poiché è concettualmente difficile concepire come circostanza del fatto di reato uno status
personale del reo derivante da una precedente condanna, ed inoltre la generalizzata facoltatività
dell’istituto della recidiva fa apparire quest’ultima non tanto come una circostanza, quanto come una
sorta di indice di commisurazione della pena.
Il problema che deriva da questa questione è il fatto che, se si considerasse la recidiva come una
circostanza, allora la si potrebbe assumere ad oggetto del giudizio di comparazione tra circostanze ex
art. 69. Sembra orientata in questo senso la giurisprudenza, che da un lato ritene obbligatoria la
contestazione alla recidiva in quanto circostanza e ammette il giudizio di comparazione, e dall’altro
limita la facoltatività soltanto all’aumento di pena (ma non agli altri effetti giuridici minori connessi).
Questo orientamento giurisprudenziale incontra però le obiezioni di una parte della dottrina, che
sottolinea la poca ragionevolezza dell’ammettere che il giudice possa escludere l’effetto principale
della recidiva, e tenerne nello stesso tempo conto per gli effetti minori.
108
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO CINQUE
DELITTO TENTATO
CONSUMAZIONE DEL REATO
Il concetto di consumazione esprime la compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una
fattispecie criminosa, e si ha dunque un reato consumato quando il fatto concreto corrisponde
interamente al modello legale delineato dalla norma incriminatrice in questa. Il giudizio sulla
consumazione del reato va effettuato però, naturalmente, caso per caso.
Per i reati di mera condotta a consumazione coincide con la compiuta realizzazione della condotta
vitata, mentre nei reati di evento la consumazione presuppone anche la produzione dell’evento (ad
esempio si avrà omicidio solo una volta avvenuta la morte di una persona).
La determinazione del momento della consumazione del reato assume rilevanza:
1. in ordine all’individuazione della norma da applicare nel caso di successione di leggi penali nel
tempo
2. rispetto all’inizio della decorrenza del termine di prescrizione
3. per l’amnistia e l’indulto, che vengono di solito concessi solo per i fatti commessi fino al giorno
precedente la data della legge
4. per la competenza territoriale
5. per l’applicazione della legge penale italiana rispetto alla legge penale straniera.
Il concetto di consumazione del reato è anche un termine di riferimento imprescindibile rispetto
all’autonoma figura del tentativo di reato.
DELITTO TENTATO IN GENERALE
La figura del delitto tentato o tentativo ricorre quando l’agente non riesce a portare a termine il delitto
programmato, ma gli atti parzialmente realizzati sono tali da esteriorizzare l’intenzione criminosa
(altrimenti si avrebbe solo un irrilevante proposito delittuoso).
Il fondamento politico-criminale della punibilità del tentativo è costituito, secondo la teoria oggettiva,
dall’esigenza di prevenire l’esposizione a pericolo dei beni giuridicamente protetti. Nell’ambito del
nostro diritto penale, ispirato alla protezione dei beni giuridici, risultano invece prive di legittimazione
teorica e politico-criminale:
le teorie soggettive: che vedono il fondamento della punibilità del tentativo nel suo essere
sintomo di pericolosità criminale. In quanto, ma se si accogliesse questa considerazione allora
si dovrebbero punire tentativo e reato compiuto allo stesso modo, poiché la volontà ribelle è la
medesima
le teorie miste: che mettono insieme motivazione soggettiva e oggettiva, ossia muovono dal
presupposto che il tentativo esprime una volontà ribelle ma ritengono meritevoli di punizione
solo la manifestazione di ribellione che possano scuotere la fiducia dei cittadini
nell’ordinamento penale
La teoria oggettiva del fondamento della punibilità è preferibile perché si collega più coerentemente
con i presupposti irrinunciabili di un diritto penale del fatto, ossia l’esigenza che il proposito illecito si
traduca in un comportamento effettivo che produca una lesione effettiva o la messa in pericolo (e
dunque la lesione non effettiva ma potenziale) di un bene protetto. Poiché il livello di offensività del
delitto tentato è minore rispetto a quello del delitto consumato, ma è comunque un delitto perfetto,
perché presenta tuti gli elementi necessari per l’esistenza di un reato, ossia fatto tipico, antigiuridicità
e colpevolezza, ed esso costituisce dunque un titolo autonomo di reato. In questo senso la
configurazione del tentativo come illecito autonomo nasce dalla combinazione di due norme:
1. la norma che configura un determinato reato
2. l’art. 56 c.p., che svolge una funzione estensiva della punibilità, poiché consente di reprimere
penalmente fatti che non pervengono alla soglia della consumazione
109
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ PUNIBILE
Il problema più grosso consiste nel determinare quando si abbia l’inizio dell’attività punibile, e per
determinarlo bisogna capire a che punto cominci la messa in pericolo del bene tutelato.
Nell’Ottocento liberale si prospettava un criterio che discriminava tra atti meramente preparatori e
atti esecutivi, e il codice Zanardelli del 1889 identificava dunque il tentativo con il “cominciamento
dell’esecuzione” del delitto programmato, ritenendo invece irrilevanti gli atti preparatori. Nella pratica
si è però rivelata incerta la distinzione tra atti preparatori non punibili e atti esecutivi punibili come
tentativo, e sono dunque stati proposti numerosi criteri, nessuno dei quali è riuscito però a dare
risultati sempre soddisfacenti.
I criteri che meritano menzione sono tre:
1. il criterio dell’univocità, che definisce preparatori tutti gli atti contrassegnati da una
perdurante equivocità, ed esecutivi invece gli atti univoci
2. il criterio dell’aggressione della sfera del soggetto passivo, che considera preparatori gli
atti che rimangono nella sfera del soggetto attivo ed esecutivi invece quelli che invadono la
sfera personale del soggetto passivo
3. il criterio dell’azione tipica, che considera esecutivi soltanto gli atti che danno inizio
all’esecuzione della condotta descritta dalla fattispecie di parte speciale (in questo modo però
in alcuni casi si restringe troppo l’ambito di punibilità del tentativo, e in altri non si riesce a
determinare esattamente quando il fatto sia esecutivo perché non è agevole individuare
quando inizi l’azione tipica, ad esempio nel caso dell’omicidio. Per ovviare agli inconvenienti di
questa teoria, la teoria materiale oggettiva ha allora sostenuto che siano considerati tentativo
anche gli atti prossimi o contigui a quelli tipici, ma rimane tuttavia difficile o quasi impossibile
per alcuni reati distinguere tra atti preparatori e atti prossimi all’azione tipica).
Con il codice Rocco si è abbandonato il tradizionale criterio dell’inizio di esecuzione, e si è disposto
all’art. 56 che “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde
di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. Parte della dottrina ha obiettato
che questo “nuovo” articolo non porti in realtà una vera sostituzione della distinzione tra preparazione
ed esecuzione, poiché di fatto la ripropone, con l’unica novità di integrare nel codice i due criteri,
elaborati da Carrara, della idoneità e della univocità degli atti. Tuttavia, il punto nevralgico
dell’incriminazione del tentativo da parte dell’art. 56 non sta nello stabilire se la nuova formulazione
superi o meno il problema della distinzione tra atti preparatori ed esecutivi, ma si trova piuttosto nella
preoccupazione di evitare che l’istituto nella sua applicazione concreta si presti ad essere manipolato
in senso illiberale. Si deve ritenere decisivo per questa preoccupazione l’impegno diretto a
concretizzare i requisiti dell’idoneità e della univocità alla luce del criterio sostanziale che fonda la
punibilità.
IDONEITÀ DEGLI ATTI
Secondo l’art. 56 comma 1 si ha tentativo se l’azione non viene compiuta (cd. tentativo incompiuto) o
se l’evento non si verifica (cd. tentativo compiuto).
Per quanto riguarda l’idoneità, essa, a differenza di quanto avveniva nel codice Zanardelli, non si
riferisce al mezzo, ossia lo strumento usato per compiere il delitto, ma all’atto, ossia l’impiego del
mezzo. In passato spesso si identificava l’idoneità con l’efficienza causale, e gli atti per essere idonei
dovrebbero in questo senso essere capaci di cagionare l’evento del reato preso di mira, tuttavia, va
obiettato che l’idoneità a produrre l’evento non può essere intesa in senso strettamente causale,
poiché, mancando nel tentativo l’evento del corrispondente delitto consumato, viene a mancare anche
uno dei termini necessari per l’esistenza di un rapporto eziologico.
Il concetto di idoneità deve quindi richiamare l’idea di capacità potenziale, attitudine, congruità
dell’atto compiuto rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira. Il parametro di accertamento
dell’idoneità consiste in un giudizio ex ante e in concreto, e questo criterio è detto criterio della
prognosi postuma (postuma perché viene effettuato dopo la commissione degli atti, ma prognosi
perché ci si pone mentalmente all’inizio dell’attività criminosa del reo), in base al quale il giudice deve
mettersi nella posizione dell’agente all’inizio dell’attività criminosa e valutare, sulla base delle
110
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
conoscenze dell’uomo medio più le eventuali conoscenze maggiori e specifiche del reo, se gli atti erano
o meno in grado di sfociare nella commissione del reato.
L’orientamento dominante ritiene che il criterio della prognosi postuma vada applicato effettuando il
giudizio di idoneità su una base parziale, ossia tenendo conto soltanto delle circostanze conosciute o
conoscibili al momento dell’azione da un uomo avveduto, pensato al posto dell’agente concreto (se ad
esempio il ladro avrà provato a rubare dalla borsa di una signora, non importerà il fatto che la borsa
fosse vuota sin dall’inizio ma lui non ne fosse a conoscenza), mentre un orientamento minoritario oggi
è quello che ritiene che il criterio predetto vada applicato effettuando il giudizio di idoneità su una
base totale, esaminando cioè tutte le circostanze già presenti al momento del fatto, anche se conosciute
in un momento successivo (nel caso prima citato il borseggiatore non dovrebbe dunque rispondere di
furto tentato, poiché la mancanza di denaro rende inidoneo il tentativo di sottrazione).
Il grado o livello di idoneità necessario ai fini della configurazione del tentativo punibile è invece
particolarmente dibattuto: alcuni ritengono che sia sufficiente che gli atti posti in essere rendano
possibile il verificarsi dell’evento, altri che vi debba essere una ragionevole possibilità di raggiungere il
risultato, altri che sia idonea l’azione adeguata rispetto all’evento voluto, altri che serva una verosimile
capacità dell’atto rispetto al fine illecito, e altri ancora che vi sia probabilità di verificazione del reato.
Quella che manca è però un’esplicita e approfondita elaborazione riguardo ai criteri che dovrebbero
presiedere alla graduazione del giudizio prognostico, con il conseguente rischio che tutte le posizioni
appena illustrate siano in realtà differenti solo per il nome, ma non nella sostanza.
Tutte queste ipotesi sono comunque legittimate perché possono tutte corrispondere ad “idoneità”, e
quest’ultima non è inoltre stata ulteriormente specificata dal legislatore. Per trovare una soluzione più
corretta è dunque necessario rifarsi a considerazioni teleologiche, e dunque a richiamare ancora una
volta il fondamento sostanziale della punibilità del tentativo. La dottrina prevalente, infatti, sostiene
che questo fondamento vada ravvisato nell’esigenza di impedire la messa in pericolo del bene
giuridico, e dunque, coerentemente a questo, bisogna escludere che il grado di sufficienza dell’idoneità
coincida con la semplice non impossibilità di consumazione del fatto delittuoso, e dunque l’idoneità
degli atti di tentativo deve essere più vicina alla probabilità che alla semplice non impossibilità.
UNIVOCITÀ DEGLI ATTI
Francesco Carrara disse che “finché l’atto esterno sarà tale da poter condurre tanto al delitto quanto
all’azione innocente, non avremo che un atto preparatorio, il quale non può imputarsi come conato”.
L’art. 56 prevede anche la necessità del requisito dell’univocità con l’obiettivo di impedire
un’eccessiva dilatazione dell’istituto del tentativo, ma per farlo bisogna stabilire quando un atto possa
considerarsi diretto in modo non equivoco a commettere un reato:
Secondo la concezione soggettiva il requisito dell’univocità fa riferimento ad un criterio di
prova, ossia l’univocità degli atti indicherebbe l’esigenza che in sede processuale venga
raggiunta la prova del proposito criminoso, la quale può essere ricavata dall’atto stesso ma
anche aliunde, ossia dai precedenti, dalla personalità del reo, dalla confessione, ecc. Si può però
obiettare che questo modo di intendere l’univocità si riduce ad una sorta di interpretatio
abrogans.
Secondo invece la concezione oggettiva, l’univocità degli atti rappresenta un criterio di
essenza, e dunque essa va considerata coma una caratteristica oggettiva della condotta, nel
senso che gli atti posti in essere devono avere l’attitudine a denotare il proposito criminoso
perseguito. In questo modo ciò che si rischia è però che l’ambito di operatività del tentativo si
restringa eccessivamente, poiché soltanto una minoranza degli atti potrebbero essere in sé
stessi segni del delitto programmato.
L’esigenza si configurare l’univocità come caratteristica dell’azione non esclude che la prova
del fino delittuoso possa essere desunta in qualsiasi modo, applicando i soliti canoni probatori
dell’elemento soggettivo del reato; tuttavia, una volta ottenuta la prova del fine dell’agente, è
necessario provare anche che gli atti, considerati nella loro oggettività, riflettano in maniera
sufficientemente congrua la direzione verso il fine criminoso che è stato accertato.
111
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Per provare ed accertare l’univocità degli atti si può seguire anche la teoria materiale
oggettiva individuale, che nel ricostruire l’univocità attorno al concetto di tipicità degli atti si
riferisce contemporaneamente al concreto piano criminoso dell’agente, e vengono così
considerati univoci gli atti che, secondo il programma criminoso dell’agente, si collocano come
prossimi o contigui all’azione esecutiva del reato. L’obiezione che si fa a questa teoria è il fatto
che in questo modo si necessità sempre una verifica processuale del piano delittuoso concreto,
e che questa non è sempre agevole.
ELEMENTO SOGGETTIVO
Se le particolarità strutturali del tentativo concernano anche il piano dell’elemento soggettivo è
controverso sia in dottrina sia in giurisprudenza, tuttavia non vi è dubbio sul fatto che nel nostro
ordinamento penale il tentativo sia punibile soltanto se commesso con dolo (sarebbe difficile, infatti,
pensare ad un tentativo involontario). Se però si considera che il dolo del tentativo sia identico al dolo
della consumazione, allora si deve dedurre che il tentativo si possa realizzare con tutte le forme di dolo
configurabili nell’ambito della consumazione, compreso il dolo eventuale, ma questo ultimo punto
solleva delle controversie (si potrebbe ad esempio pensare al caso di un uomo che, fuggendo, spari alle
gambe di un poliziotto pur rappresentandosi la possibilità di colpirlo mortalmente: dovrà essere
accusato di tentato omicidio o di lesione volontaria?). La dottrina minoritaria e la giurisprudenza anni
fa dominante muovono dal presupposto che il nostro ordinamento positivo non contiene norme che
distinguano i due tipi di dolo, e poiché la differenza tra tentativo e consumazione viene circoscritta
dalla legge al piano della sola struttura oggettiva, se ne deduce che il dolo del tentativo e quello della
consumazione non possono che essere uguali. La tesi contraria, che ritiene incompatibili tentativo e
dolo eventuale, viene sostenuta dalla dottrina maggioritaria e si sta sempre più affermando anche in
giurisprudenza. Per sostenerla si potrebbe continuare a prospettare una concezione soggettiva o
probatorio dell’univocità come requisito del tentativo punibile, infatti riducendo l’univocità
all’esigenza di provare in giudizio l’intenzione criminosa dell’agente, la non equivocità del
comportamento finisce con il coincidere con la prova di una volontà intenzionalmente diretta a
commettere il reato, ma appunto perché la volontà che si richiede è intenzionale, il dolo eventuale per
il tentativo va escluso. Anche al di fuori di una concezione soggettiva dell’univocità, la tesi
dell’incompatibilità può poggiare da un lato sul fatto che l’autonomia strutturale della fattispecie del
tentativo rispetto alla corrispondente consumazione, giustifica che anche il dolo del tentativo non
corrisponda completamente a quello della consumazione; inoltre permane l’incompatibilità strutturale
tra il dolo eventuale e il requisito dell’univocità della condotta, anche se se ne accoglie una concezione
oggettiva. La direzione finalistica dell’atto deve essere certa sia sul piano materiale che su quello
psicologico, e tra questi due aspetti vi deve essere piena congruenza, dunque non può dirsi univoco un
comportamento che l’agente realizza senza tendere a realizzarlo, ma soltanto accettando il rischio
della sua verificazione.
CONFIGURABILITÀ DEL TENTATIVO NELL’AMBITO DELLE VARIE TIPOLOGIE DELITTUOSE
Si può configurare il tentativo solo quanto i requisiti richiesti dall’art. 56 c.p. sono compatibili con le
caratteristiche oggettive dei vari tipi delittuosi del nostro ordinamento:
1. Il tentativo non è ammissibile per le contravvenzioni, dal momento che l’art. 56 c.p. si riferisce
soltanto ai delitti, e questo perché le contravvenzioni sono di una tale gravità che il legislatore
ha considerato inopportuno perseguirle per il solo tentativo.
2. Il tentativo non è ammissibile per i delitti colposi, poiché sarebbe contraddittorio asserire che
il tentativo sia compatibile con la mancanza dell’intenzione di commettere un delitto.
3. Si parlerà in seguito della controversa configurabilità del tentativo nei reati omissivi.
4. Il tentativo non è ammissibile nei delitti preterintenzionali (infatti nel caso in cui il soggetto
sopravviva l’agente è responsabile di delitto di lesione o percosse).
112
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
5. Il tentativo non è ammissibile per i reati insussistenti, poiché non consentono di frazionare il
processo esecutivo in più atti, e dunque una volta compiuto l’unico atto che costituisce il reato,
l’azione si considera consumata (ad esempio questo vale per l’ingiuria verbale).
6. Il tentativo non è ammissibile per i delitti di attentato e i delitti a consumazione anticipata, sia
perché in questi casi il tentativo equivale a consumazione, e dall’altro perché sarebbe
insensato ipotizzare atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere “atti diretti a”.
7. La configurabilità del tentativo è controversa per i reati di pericolo: parte della dottrina ritiene
che ciò possa avvenire in alcuni casi, ma in realtà la tesi preferibile e maggioritaria ritiene che il
tentativo non sia in questi casi configurabile poiché altrimenti si finirebbe per punire “il
pericolo di un pericolo”, anticipando eccessivamente la soglia della punibilità.
8. Nei reati aggravati dall’evento il tentativo è ipotizzabile quando l’evento ulteriore può
realizzarsi indipendentemente dal compimento della condotta vietata (ad esempio la morta di
una donna in seguito al tentativo di aborto).
9. Nei reati condizionati la configurazione del tentativo dipende dalla possibilità che si verifichi la
condizione obiettiva di punibilità indipendentemente dal perfezionarsi della condotta tipica.
10. Il tentativo non è ammissibile per i reati abituali, poiché e singole azioni non assumono
rilevanza penale autonoma.
11. Si può invece configurare il tentativo per i reati permanenti, sempre che la condotta sia
frazionabile.
TENTATIVO E CIRCOSTANZE
Per quanto riguarda il rapporto tra tentativo e circostanze, alcuni distinguono
tra:
Tentativo circostanziato di delitto: ossia quando le circostanze si realizzano nel contesto
dell’azione tentata. Vi sono casi in cui la sussistenza delle circostanze e la loro compatibilità
con il tentativo è pacifica (ad esempio il rapporto di parentela tra padre e figlio è una
circostanza già compiuta prima che si verifichi un tentativo di omicidio, aggravato dal
rapporto), mentre in altri casi il tentativo circostanziato di delitto è caratterizzato da una
realizzazione soltanto parziale delle circostanze (ad esempio il tentativo di omicidio
accompagnato da atti diretti a seviziare), e in questi casi la figura suscita più riserve.
Tentativo di delitto circostanziato: ossia quando un delitto se fosse giunto a consumazione,
sarebbe stato qualificato dalla presenza di una o più circostanze.
Suscita riserve anche alla figura riconosciuta dalla giurisprudenza del tentativo di delitto
circostanziato, soprattutto a proposito delle circostanze del danno patrimoniale di rilevante
gravità o di speciale tenuità. Queste riserve di fondano da un lato sul fatto che non si riesce a
trovare la ragione per ritenere che in questo settore le esigenze connesse al principio di
legalità possano essere derogate, e dall’altro dal fatto che esistono limiti ontologici invalicabili.
Per questi motivi, si deve concludere che le uniche circostanze compatibili con il tentativo sono quelle
che si realizzano compiutamente nello stesso contesto dell’azione tentata.
DESISTENZA E RECESSO ATTIVO
Può capitare che a interrompere la consumazione del reato non sia un ostacolo esterno, ma sia
l’iniziativa dello stesso agente, e a questo proposito i commi 3 e 4 dell’art. 56 stabiliscono che “se il
colpevole volontariamente desiste dall’azione (desistenza volontaria), soggiace soltanto alla pena
per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé un reato diverso”, e che “se volontariamente
impedisce l’evento (recesso attivo o pentimento operoso), soggiace alla pena stabilita per il tentativo,
113
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
diminuita da un terzo alla metà”.
Le due figure di desistenza e recesso vengono tradizionalmente distinte in base ad un criterio ex post,
che fa leva sull’esaurimento o meno dell’esecuzione, e ciò significa che si ha desistenza volontaria
finché l’agente recede da un’azione che non ha ancora completato l’iter esecutivo, mentre si ha recesso
quando l’azione criminosa si è realizzata, ma l’agente riesce ad impedire il verificarsi dell’evento
lesivo.
Queste due figure trovano tradizionalmente legittimazione nella teoria del “ponte d’oro”, e ciò
significa che l’ordinamento, per prevenire l’offesa ai beni giuridici, farebbe affidamento sulla promessa
di impunità o di una riduzione della pena come controspinta psicologica alla spinta criminosa (le
obiezioni mosse sono il fatto che questa teoria presuppone che tutti i rei conoscano questa norma, e
che inoltre essi siano sempre in grado di valutare pro e contro delle proprie azioni, anche se, se si
accettassero queste obiezioni, si dovrebbe concludere che, se davvero i rei non sono spesso in grado di
ragionare razionalmente, allora anche la funzione deterrente della minaccia penale è inutile).
Un’ulteriore fondamento della desistenza si può individuare nell’ottica degli scopi della pena, e
precisamente sul duplice piano di prevenzione generale e speciale, poiché chi si pente e desiste dal
reato non presenta un’elevata pericolosità per gli altri, né mostra di possedere una volontà criminosa
così intensa da giustificare il ricorso ad una pena rieducativa.
Va comunque ricordato che desistenza e recesso, per essere efficaci, devono sempre essere
volontari, ma l’opinione dominante di dottrina e giurisprudenza considera che volontarietà non
debba corrispondere necessariamente ad un autentico ravvedimento, e dunque l’azione deve
semplicemente non essere stata imposta da circostanze esterne. Tuttavia, bisogna capire quali siano i
criteri per stabilire quando la scelta dell’agente sia libera o imposta dall’esterno. A questo proposito
non vi sono elaborazioni teoriche approfondite, e dunque bisogna guardare alla prassi, la quale oscilla
tra criteri diversi: talvolta si afferma che la libertà è esclusa da fattori esterni che rendono
irrealizzabile l’impresa criminosa, talvolta che la libertà di scelta è già compromessa dalla perfezione
soggettiva di elementi di rischio, talvolta che la scelta è coartata quando la situazione sembra così
rischiosa che nessuna persona ragionevole sarebbe disposta a compierla.
Vi sono alcuni casi-limite in cui non è facilmente applicabile il criterio dell’esaurimento o no
dell’azione esecutiva per determinare se si tratti di desistenza o di recesso. In questi casi limite, la
scelta tra l’una o l’altra appare arbitraria, con la conseguenza però che si finirà per avere in casi
analoghi decisioni che portano all’impunità e decisioni che portano alla riduzione della pena. La stessa
giurisprudenza si è accorta che sembra iniquo discriminare nel trattamento sanzionatorio situazioni
che paiono analoghe, ed ha dunque tentato di rimediare a ciò ricorrendo ad artifici argomentativi, ma
sarebbe necessario un intervento legislativo.
TENTATIVO E ATTENTATO
I delitti di attentato si caratterizzano per il fatto che il legislatore ha considerato reato perfetto il
compimento di atti diretti ad offendere un bene ritenuto meritevole di protezione anticipata, perché di
rango elevato. Sotto la vigenza del codice Zanardelli, solo gli atti esecutivi potevano configurare sia il
tentativo, sia l’attentato, ma il codice Rocco ha fatto retrocedere la soglia della punibilità ad uno stadio
precedente, equiparando la punibilità del tentativo e dell’attentato a livello di attività preparatoria.
Tuttavia, mentre per il tentativo si è imposta un’interpretazione restrittiva che richiede per la sua
punibilità un’attività sostanzialmente esecutiva, per l’attentato è invece inizialmente prevalso
l’orientamento che gli conferiva un’autonomia strutturale rispetto al tentativo, e questo per colpire
anche gli atti più remoti, purché siano espressione di una volontà intesa a ledere il bene.
Verso la fine degli anni ’60 giurisprudenza e dottrina hanno interpretato la formula “fatto diretto a"
come “fatto idoneo diretto a”, e la formula “chiunque attenta a” come “chiunque compier atti idonei
diretti a”, valorizzando il criterio dell’idoneità del tentativo ed ritenendo che essi riguardi l’intera
materia penale.
114
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Oggi la dottrina ritiene dunque per lo più che vi sia omogeneità strutturale tra tentativo e attentato, e
che per la punibilità dell’attentato occorra dunque che l’attività posta in essere sia idonea a ledere il
bene.
REATO IMPOSSIBILE
L’art. 49 comma 2 stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione o
l’inesistenza del suo oggetto, l’evento dannoso o pericoloso risulta impossibile, e stabilisce all’ultimo
comma che il giudice può però ordinare che l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.
L’interpretazione tradizionale sostiene che questo comma sia superfluo in quanto il reato impossibile
non è altro che un tentativo impossibile, infatti anche se non vi fosse stata questa norma il
comportamento che essa disciplina non sarebbe stato punibile a causa della mancanza dei requisiti,
del delitto tentato, dell’idoneità dell’azione e dell’esistenza dell’oggetto.
Alcuni autori, sostenitore della concezione realistica, ritengono però di poter desumere dall’art. 49 un
principio estendibile all’intero sistema penale, ossia il “principio generale che funge da criterio
ispiratore della concezione per la quale non può esservi reato senza una lesione o una messa in
pericolo effettiva del bene protetto”. Secondo questa dottrina la rilevanza del principio di necessaria
lesività emergerebbe nei casi di pretesa mancata corrispondenza tra tipicità e offesa al bene protetto,
infatti di fronte a condotte formalmente conformi alla fattispecie incriminatrice ma di fatto incapaci di
lede il bene protetto, il ricorso all’art. 49 comma 2 permetterebbe di non punire la condotta sulla base
della valutazione pratica. La tesi che sostiene che l’art. 49 comma 2 non sia il semplice “rovescio” del
56, lo fa adducendo che l’art. 49 riferisce l’idoneità non agli “atti” (come l’art. 56), ma alle “azioni”, e il
fatto, inoltre, che non si spiega perché gli atti diretti in modo univoco a commettere una
contravvenzione rimangono impuniti se idonei a produrre l’evento (dal momento che il tentativo non
è configurabile nelle contravvenzioni), mentre possono portare all’applicazione di una misura di
sicurezza dal momento che l’art. 49 si applica anche alle contravvenzioni.
Le obiezioni a questa tesi sono però il fatto che l’art. 49 non può essere d’aiuto nel stabilire quando
sussiste la lesione o la mossa in pericolo del bene protetto, perché non fa in alcun modo riferimento
alla natura degli interessi tutelati, e di conseguenza l’interesse tutelato va desunto dalle singole
fattispecie incrimiantrici. Tuttavia, se esso va desunto dalla fattispecie, allora è impossibile ipotizzare
un fatto conforme a quest’ultima ma non lesivo dell’interesso protetto, ed è proprio questa la
contraddizione logica sulla quale coloro che criticano la tesi concentrano le proprie obiezioni.
Inoltre, si sostiene anche che l’accoglimento di questa tesi potrebbe rappresentare una fonte di grave
pericolo per lo Stato di diritto, infatti se il giudice dovesse far seguire alla già accertata corrispondenza
tra fatto e modello legale un secondo giudizio sull’effettiva lesività, allora risulterebbe minacciata la
certezza del diritto, e sorgerebbe anche il rischio di confondere la funzione giudiziaria con quella
legislativa.
Anche se si propende per il rifiuto del recupero dell’art. 49 in chiave di concezione realistica
dell’illecito, questo non significa che vada accettata la conclusione che questa disposizione si limiti a
riflettere il mero aspetto negativo del delitto tentato, infatti la ragione di questa disposizione si può
cercare risalendo alle ragioni storiche che ne hanno determinato l’introduzione.
Il legislatore, introducendo nel codice Rocco un’apposita disposizione per il reato impossibile, ha
inteso fugare ogni dubbio riguardante l’irrilevanza penale del tentativo assolutamente inidoneo in
concreto a mettere in pericolo il bene protetto. Per accertare se il bene protetto fosse veramente in
pericolo, non ci si può accontentare del giudizio prognostico su base parziale effettuato ex art 56 nella
sola ottica dell’agente, infatti bisogna effettuare l’ulteriore verifica compiuta su base notale
nell’ottica della vittima come titolare del bene posto in pericolo. Per questa verifica, dunque, bisogna
applicare il criterio della prognosi postuma tenendo conto non solo delle circostanze conosciute o
conoscibili dall’agente al momento dell’azione, ma di tutte le circostanze presenti nella situazione.
Tuttavia, i casi di tentativo inidoneo, se non mettono in pericolo il bene protetto, possono comunque
assurgere a indici di uno stato di pericolosità sociale dell’agente, e possono dunque giustificare la
misura di sicurezza della libertà vigilata.
115
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO DUE
CONCORSO DI PERSONE
L’istituto del concorso di persone nel reato disciplina i casi in cui più persone concorrono alla
realizzazione di un medesimo reato, ed è un istituto che va diventando sempre più importante a causa
del costante incremento delle forme di criminalità organizzata.
Secondo un orientamento tradizionalmente consolidato i diversi tipi di associazione a delinquere
presuppongono un vincolo stabile tra più soggetti ed un programma criminoso riferito ad un insieme
indeterminato di reati, mentre il concorso di persone nel reato (o partecipazione criminosa) determina
un vincolo occasionale tra più persone per la realizzazione di un reato o di più reati determinati che,
in astratto, potrebbero essere realizzati anche da un solo soggetto. Il concorso di persone viene
dunque solitamente qualificato eventuale per distinguerlo dal concorso necessario, che ricorre
quando è il reato stesso a richiedere la presenza di più soggetti per la sua integrazione (es. rissa,
associazione a delinquere, corruzione, ecc.).
MODELLI DI DISCIPLINA DEL CONCORSO CRIMINOSO
Nei codici moderni le fattispecie incriminatrici sono modellate sulla figura dell’autore individuale, e si
pone dunque il problema di rinvenire la norma che consenta esplicitamente di punire non soltanto chi
materialmente ha commesso il fatto, ma anche chi si è reso compartecipe dell’illecito pur non
ponendo in essere condotte contrarie alla legge. Le norme sul concorso di persone nel reato assolvono
dunque alla funzione di rendere punibili comportamenti (cd. atipici) che non lo sarebbero in base alla
signora norma incriminatrice, integrando le fattispecie di diritto speciale.
In astratto sono però prospettabili molteplici modelli di disciplina del concorso criminoso, e dal punto
di vista della configurazione normativa della fattispecie concorsuale il legislatore si trova
fondamentalmente di fronte all’alternativa tra modello differenziato e modello unitario di tipizzazione
del fatto:
Modello differenziato: il legislatore dovrà tipizzare in maniera autonoma le diverse forme di
partecipazione distinguendole in funzione dei ruoli rivestiti dai vari concorrenti, ossia autore,
determinatore, istigatore, ecc. questa tecnica differenzia la responsabilità di ciascun
concorrente sul piano della tipicità del fatto.
Modello unitario: il legislatore dovrà invece propendere per la tipizzazione causale, ossia
riconducendo alla fattispecie concorsuale tutte le condotte che hanno efficacia eziologica nei
confronti dell’evento lesivo, non assumendo importanza la precisa demarcazione tra forme
primarie e secondarie tipiche. Della reale entità del contributo si potrà tener presente al
momento della commisurazione della pena.
Con il codice Rocco si è modificata la disciplina precedente, optando per il modello della tipizzazione
unitaria basata sul criterio dell’efficienza causale della condotta di ciascun concorrente. L’art. 110 c.p.
stabilisce infatti che “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace
alla pena per questa stabilita”, il che significa che concorre a pari titolo chi apporta un contributo
qualsiasi, purchè dotato di rilevanza causale nell’ambito della realizzazione collettiva del fatto. Questa
inversione di tendenza trova alla sua origine varie motivazioni:
1. il retroterra culturale influenzato dal pensiero positivistico-naturalistico, incline a valorizzare
il dogma della causalità anche sul terreno dei presupposti della responsabilità penale
2. ragioni di coerenza sistematica imponevano di adottare anche i questo ambito il principio
dell’equivalenza causale che era stato adottato negli artt. 40 e ss.
3. nella prassi si lamentava la mancanza di sicuri criteri di demarcazione che consentissero di
distinguere in modo certo le diverse forme di partecipazione
Tuttavia, così come in altre occasioni, anche in questo caso il legislatore fascista non è riuscito a
slegarsi completamente dal passato, e infatti la distinzione tra compartecipazione primaria e
secondaria è ricomparsa a causa del varco aperto dall’art. 114, che dispone che “il giudice, qualora
ritenga che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt.
116
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può
diminuire la pena”.
Inoltre, la rinuncia alla distinzione tra le tipologie di compartecipazione, ha presentato l’inconveniente
di un’eccessiva dilatazione della responsabilità a titolo di concorso, favorita dalla tendenza della
giurisprudenza a sorvolare sui requisiti oggettivi minimi di una legittima responsabilità concorsuale.
Di conseguenza, parte della dottrina, ritiene che tale tendenza si esponga a giudizio di
incostituzionalità per mancanza di precisazione totale o parziale.
LE TEORIE SUL CONCORSO CRIMINOSO
La dottrina ha escogitato diverse teorie per spiegare il fondamento tecnico-giuridico della punibilità di
condotte consensuali atipiche rispetto alle fattispecie incriminatrici di parte speciale:
Teoria dell’accessorietà: secondo questa teoria la partecipazione criminosa ha natura
accessoria, ossia la condotta atipica del semplice partecipe non ha rilevanza penale autonoma,
ma l’acquista nella misura in cui accede alla condotta principale o tipica dell’autore. In questo
senso, la teoria dell’accessorietà, è permeata da preoccupazioni di tipo garantistico.
In particolare:
1. la teoria dell’accessorietà estrema sostiene che la punibilità della condotta di
partecipazione dipenda dalla realizzazione di una condotta principale punibile in concreto
2. la teoria dell’accessorietà limitata, versione dominante, è sufficiente che l’azione principale
sia obiettivamente antigiuridica
Le obiezioni mosse a questa teoria da parte della dottrina italiana, anche se in parte possono
essere ridimensionate, sono:
A. il fatto che essa non riuscirebbe a giustificare la punibilità dei concorrenti nei casi di
esecuzione frazionata, in cui nessuno realizza un’azione qualificabile come principale e
l’azione tipica risulti solo dall’incontro dei diversi contributi dei singoli compartecipi
B. il fatto che, dal momento che nelle ipotesi di concorso nel reato proprio (come ad
esempio il peculato) la condotta principale potrebbe essere realizzata soltanto dal
soggetto che riveste la qualifica soggettiva, allora si dovrebbe rinunciare
all’incriminazione a titolo di reato proprio se a porre in essere l’azione esecutiva fosse
un compartecipe privo di qualifica.
Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale: secondo questa teoria la fattispecie del
concorso di persone sarebbe una fattispecie nuova, autonoma e diversa da quella
incriminatrice di parte speciale modellata sull’autore singolo. In questo modo, le condotte
atipiche non sono rilevante penalmente perché accessorie alla condotta principale, ma
piuttosto perché l’intero fatto realizzato in concorso si rapporta ad un nuovo concetto di
tipicità, e dunque le singole condotte dovranno considerarsi tipiche o atipiche in rapporto alla
nuova fattispecie concorsuale risultante dall’incontro tra art. 110 c.p. e norma incriminatrice.
Teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate: secondo questa teoria l’incontro
dell’art. 110 c.p. con la singola norma incriminatrice non dà vita ad una sola fattispecie
plurisoggettiva eventuale, ma crea tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i
soggetti compartecipi, e tutte quante accomunate dal nucleo di accadimento materiale, ma
distinte per l’atteggiamento psichico e per alcuni espetti esteriori che ineriscono solo alla
condotta dell’uno o dell’altro concorrente.
La teoria dell’accessorietà e quella della fattispecie plurisoggettiva eventuale sembrano in grado di
contribuire a spiegare la punibilità delle condotte di mera partecipazione. Si potrebbe infatti
controbattere alle pretese insufficienze della teoria dell’accessorietà nelle ipotesi di esecuzione
frazionaria, infatti in queste ipotesi si potrebbe sostiene che l’accessorietà è reciproca perché ciascun
contributo, per avere rilievo giuridico, deve essere accostato ad un altro complementare, e dunque non
vi è una condotta principale e una secondaria, ma due condotte entrambe non tipiche che si accostano.
117
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Nei casi invece di concorso nel reato proprio bisogna invece dire che l’art. 117 non specifica che le
condizioni del mutamento del titolo di reato, e dunque la disposizione lascia insoluto l’interrogativo se
la condotta esecutiva del reato proprio possa essere o no realizzata anche dal concorrente privo della
qualifica soggettiva richiesta. Nel silenzio del legislatore si può dunque ritenere che acquisti in
proposito rilevanza decisiva il riferimento alla norma incriminatrice di parte speciale, e dunque l’art.
177 presupporrebbe che la persona non qualificata svolga nella fattispecie di concorso lo stesso ruolo
rivestito nella corrispondente fattispecie monosoggettiva (ad esempio se a rubare denaro pubblico
non è la persona qualificata ma un inserviente in accordo con egli, allora non si configurerà un
concorso in peculato ex art. 117, ma un concorso in furto o in appropriazione indebita).
Va in ogni caso ammesso che la teoria della fattispecie plurisoggettiva spiega meglio, sul piano logico-
formale, il fenomeno della punibilità delle condotte atipiche, ma, tuttavia, solo su questo piano, perché
rimane comunque insolito il problema dei criteri idonei a determinare la rilevanza delle semplici
condotte di partecipazione nei confronti della fattispecie concorsuale come fattispecie autonoma e
diversa rispetto alla fattispecie monosoggettiva. Rimane cioè da determinare quando una condotta di
partecipazione atipica riguardo alla fattispecie incriminatrice sia invece tipica rispetto alla fattispecie
concorsuale. La risposta a questo quesito non viene data dalla teoria, e, in mancanza di una
tipizzazione legale delle forme di concorso, il compito di stabilire i requisiti minimi di una
partecipazione penalmente rilevante rimane in mano alla dottrina e alla giurisprudenza.
STRUTTURA DEL CONCORSO CRIMINOSO
1. PLURALITÀ DI AGENTI
I requisiti strutturali del concorso di persone nel reato sono:
1. la pluralità di agenti
2. la realizzazione della fattispecie oggettiva di un reato
3. il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune
4. l’elemento soggettivo
Per quanto riguarda il primo requisito esso è scontato, infatti è naturale che per aversi il concorso di
persone si devono avere due o più soggetti, i quali non devono essere necessariamente tutti punibili,
come si può riscontrare negli artt. 112 e 119 c.p:
Art. 112 c.p.: stabilisce infatti che gli aggravamenti di pena previsti in questo articolo si
applichino anche se “taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile”, per cui si
prescinde dalla punibilità di qualcuno dei concorrenti
Art. 119 c.p.: stabilisce invece, al comma 10, che “le circostanze soggettive, le quali escludono
la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla
persona cui si riferiscono”, dunque, visto che tra esse vi sono anche ad esempio l’inimputabilità
e la mancanza di dolo, si deve dedurre che la pluralità di soggetti sussiste anche se qualcuno è
incapace di intendere e di volere o agisce senza dolo.
Si possono dunque ricondurre al concorso criminoso: il costringimento fisico a commettere un reato; il
reato commesso per un errore determinato dall’inganno altrui; il costringimento psichico a
commettere un reato (coazione morale); la determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo
di far commettere un reato; la determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile.
2. REALIZZAZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTIVA DI UN REATO
Non importa quale ruolo ciascun compartecipe rivesta nell’esecuzione del fatto, ma è importante che i
contributi dei singoli concorrenti devono confluire nella realizzazione comune della fattispecie
oggettiva di un reato (elemento oggettivo). Il problema è in questo caso quello di stabilire i coefficienti
minimi della rilevanza penale di ciascuna condotta di partecipazione.
In applicazione dei principi generali, va notato che non occorre che il fatto collettivo venga consumato,
ma è sufficiente che la realizzazione comune si traduca in atti idonei diretti in modo non equivoco a
118
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
commettere un delitto, e si avrà in questo caso un concorso di persone in un delitto tentato. L’esigenza
minima che vengano realizzati almeno gli estremi oggettivi di un delitto tentato è desumibile dall’art.
115, infatti esso stabilisce che, salvo che la legge disponga altrimenti, nessuno è punibile per essersi
semplicemente accordato con altri, se all’accordo non segue la messa in atto del fatto programmato, e
nessuno è punibile per il semplice avere istigato altri, se il reato non viene poi commesso. Lo stesso
articolo stabilisce che questi comportamenti possono comunque giustificare l’applicazione della
misura di sicurezza della libertà vigilata perché indici di pericolosità sociale.
Infine, la riserva “salvo che la legge disponga altrimenti” allude alle ipotesi nelle quali già il semplice
accordo o la mera istigazione sono elevati ad autonoe figure di reato (es. art. 304).
3A. CONTRIBUTO DI CIASCUN CONCORRENTE: CONCORSO MATERIALE
La responsabilità a titolo di concorso presuppone che ogni concorrente arrechi un contributo
personale alla realizzazione dell’illecito, il quale può essere un concorso materiale, se interviene
personalmente negli atti che danno vita all’elemento materiale del reato, o morale, se dà un impulso
psicologico alla realizzazione di un reato che viene posto in essere da altri.
Il concorso materiale può essere prestato assumendo ruoli di rango diverso, ossia:
Autore: colui che compie gli atti esecutivi del reato
Coautore: chi interviene insieme agli altri nella fase esecutiva
Ausiliatore o complice: colui che si limita ad apportare un qualsiasi aiuto materiale nella
preparazione o nell’esecuzione del reato. La prestazione di iuto ricade sempre al di fuori della
fattispecie incriminatrice di diritto speciale.
La figura del complice è la più problematica, poiché appare meno ovvia la sua punibilità, per la quale
si sbatte sui coefficienti minimi necessari:
Teoria condizionalistica: l’opinione tradizionale, ossia la teoria condizionalistica, esige che
l’azione del complice costituisca condicio sine qua non del fatto punibile. Tuttavia, si obietta a
questa teoria che il ricorso a questo criterio presenta l’inconveniente di restringere
eccessivamente l’area del concorso, poiché accettando questa teoria non si potrebbero punire i
casi di partecipazione non necessaria (come quella di un complice che fornisce la chiave di una
cassaforte al ladro, il quale avrebbe potuto, anche se in tempi diversi, aprire la cassaforte anche
senza di essa).
Teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo: è stata elaborata per superare le pretese
insufficienze della teoria precedente, in base alla quale si considera penalmente rilevante non
soltanto l’aiuto necessario, ma anche quello che semplicemente agevola o facilita il
conseguimento dell’illecito.
Vi è una sostanziale analogia tra questa teoria e la visione giurisprudenziale dell’efficienza
causale nell’ambito del concorso di persone, infatti nella prassi giudiziaria è consolidata la tesi
secondo cui il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando ha efficacia causale,
ma anche quando agevola il reato. Dunque per la punibilità dell’azione è sufficiente che la
condotta si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo
apprezzabile alla commissione dell’illecito.
Secondo alcuni autori, però, neanche questa teoria avrebbe validità generale, infatti vi
sarebbero ulteriori casi di partecipazione non necessaria sempre meritevoli di pena anche
senza un influsso causale, neppure agevolatore (ad esempio nel caso in cui una persona
fornisse al ladro uno strumento per forzare la porta ma quest’ultimo non lo utilizzasse,
preferendo un altro strumento).
Teoria della prognosi o dell’aumento di rischio: quella che subentra è allora la teoria della
prognosi o dell’aumento del rischio, secondo la quale è sufficiente che l’azione del partecipe
appaia ex ante idonea a facilitare la commissione del reato rendendone più probabile la
commissione. Secondo alcuni, questa teoria potrebbe trovare fondamento normativo nell’art.
56, che per la rilevanza giuridica degli atti, riguardo al tentativo, ne richiede l’idoneità, e
119
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
dunque questo articolo confermerebbe che per la tipicità i giudizi causali possono essere
formulati non soltanto nell’ottica di un legame effettivo tra una certa condotta ed un
determinato evento, ma anche sul piano di una semplice attitudine causale.
Quest’impostazione trascura però che le forme di tipicità cui ci si riferisce accedono ad un fatto
collettivo che giunge a consumazione anche a prescindere dell’ausilio rivelatosi poi inutile, e
dunque il giudizio prognostico sull’idoneità ex ante dell’ausilio a facilitare la commissione del
reato, di fronte ad un fine criminoso concretamente raggiunto, non pare avere senso. La
valutazione dell’idoneità della condotta ad influire sulla realizzazione del fatto sarebbe infatti
sufficiente solo in sede di tentativo, e dunque l’art. 56 non può essere invocato per un fatto che
non è stato tentato, ma è stato commesso.
Rimane confermato che non vi può essere partecipazione materiale penalmente rilevante a
prescindere da un influsso effettivo sull’azione tipica o sull’evento costitutivo del reato, e si tratta
perciò a questo punto di precisare la portata e i limiti del contributo materiale del complice.
La formula della causalità agevolatrice è quella che pare più giusta, ossia quella che considera che
assuma rilevanza penale non solo la condotta di partecipazione che rende possibile la perpetrazione
del fatto, ma anche quella che si limiti a facilitarne o agevolarne la realizzazione. La rilevanza penale
della condotta si basa non sull’evento in astratto (ad esempio “la cassaforte sarebbe stata aperta anche
senza chiave”), ma l’evento che si è realizzato in concreto (“la cassaforte è tuttavia stata aperta con la
chiave”). Anche in questo caso di cerca di arginarne l’espansione eccessiva.
3B. CONTRIBUTO DI CIASCUN CONCORRENTE: CONCORSO MORALE
Il contributo del partecipe può anche essere un impulso psicologico ad un reato materialmente
commesso da altri, ossia un concorso morale o partecipazione psichica, il cui “autore” può essere:
il determinatore: il compartecipe che fa sorgere nell’autore un proposito criminoso prima
inesistente, ed assume quindi un ruolo che, pur non essendo materiale, è comunque piuttosto
decisivo
l’istigatore: colui che si limita a rafforzare nell’autore un proposito criminoso già esistente
La rilevanza penale dell’istigazione, che comprende nel proprio significato entrambi i tipi di
concorso morale, è desumibile dall’art. 115 comma 30, che stabilisce la non punibilità
dell’istigazione rimasta sterile, e riconosce implicitamente che quando l’istigazione viene
accolta e il reato viene commesso, l’istigatore ne deve rispondere a titolo di concorso. Nel
nostro ordinamento, quindi, non assumono rilevanza solo le condotte istigatorie che pongono
un antecedente causale del reato commesso dall’esecutore, ma anche quelle che veramente
determinanti non sono, perché si limitano a rinsaldare l’altrui proposito criminoso.
Nell’ambito delle relazioni interpersonali la prova dei legami causali è molto più difficile che sul
terreno degli eventi fisici, tanto che si dibatte se la causalità psicologica sia una vera e propria forma di
causalità. Nulla autorizza comunque a ripiegare su giudizi di tipo meramente prognostico, come se la
condotta di partecipazione psichica potesse essere individuata in base alla sua generica attitudine o
idoneità a funzionare come favore di rafforzamento dell’altrui proposito criminoso.
Contro l’utilizzabilità di criteri di idoneità ex ante valgono gli stessi argomenti utilizzati nell’ambito
della partecipazione materiale, infatti come è da escludere la complicità fisica in mancanza di una
condotta che risulti avere almeno agevolato la commissione del delitto, non può analogamente esservi
complicità morale a prescindere da un’effettiva influenza sulla psiche dell’esecutore materiale del
reato.
Va inoltre precisato che l’istigazione non può essere mai una semplice informazione o un’indicazione
puramente teorica, poiché deve sottendere il consiglio o l’incitamento a comportarsi in un determinato
modo (potendo comunque verificarsi nelle forme più varie, es. mandato, consiglio, suggerimento ecc.).
Per questo motivo, è da escludersi che sia sufficiente ad integrare la complicità morale la connivenza o
l’adesione psichica, sia pure riconoscibilmente manifestata a chi esegue il reato, così come si esclude
che basti la mera presenza sul luogo del delitto, nonostante il contrario avviso della giurisprudenza.
120
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Può talvolta verificarsi una divergenza tra il fatto oggetto di istigazione e il fatto concretamente
realizzato, e la divergenza può riguardare:
A. il tipo astratto di reato. ipotesi disciplinata dall’art. 116 c.p.
B. l’oggetto materiale dell’azione: bisogna però stabilire se, per la punibilità dell’istigazione, la
volizione di essa debba trovare esatto riscontro nel fatto concreto realizzato, richiedendo
dunque un’identità tra i due fatti. Si potrebbe da un lato considerare che l’identità sia
necessaria, e che dunque in sua assenza l’istigazione non possa considerarsi penalmente
rilevante, ma in questo modo si lascerebbero scoperte delle esigenze repressive.
Una particolare forma di istigazione è quella realizzata dall’agente provocatore, ossia colui che
provoca un delitto per assicurare il colpevole alla giustizia. Ad esempio l’art. 97 del testo unico in
materia di sostanze stupefacenti stabilisce la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria delle
unità specializzate antidroga che acquistano sostanze solo per acquisire elementi di prova dello
spaccio di droga; l’art. 12 della legge n. 302/1990 stabilisce invece che non siano punibili gli ufficiali di
polizia giudiziaria della direzione investigativa antimafia che procedono a fatti illeciti per raccogliere
prove dei delitti di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, e ancora delitti in materia di
armi ed esplosivi.
Il problema a questo proposito, in via generale, è quello di stabilire se lo speciale scopo perseguito
dall’agente possa neutralizzare la rilevanza penale, a titolo di concorso, di una condotta che rimane pur
sempre istigatrice. Secondo un orientamento rigoristico, l’obiettivo di fare perseguire i colpevoli non
sarebbe comunque in grado di giustificare un comportamento che oggettivamente e soggettivamente,
ha contribuito a mettere in pericolo o ledere un bene giuridico.
Quella da preferire potrebbe essere la tesi della dottrina dominante, che sostiene che l’agente
provocatore non possa essere punito per mancanza di dolo, tutte le volte in cui egli abbia agito con lo
scopo di assicurare i colpevoli alla giustizia e non abbia accettato neanche il rischio dell’effettiva
consumazione del reato.
Le specifiche ipotesi sopra citate vanno, invece, inquadrate nella causa di giustificazione di
adempimento di un dovere.
4. ELEMENTO SOGGETTIVO DEL CONCORSO CRIMONOSO
Ogni condotta di partecipazione deve essere sorretta da un corrispondente requisito psicologico, e
l’elemento soggettivo del concorso criminoso è costituito da due componenti:
1. coscienza e volontà del fatto criminoso
2. volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato comune, ossia un quid pluris.
Questa volontà di concorrere non deve necessariamente presupporre un accordo precedente o
la reciproca consapevolezza dell’altrui concorso, infatti è sufficiente che la coscienza del
contributo dell’altro esista unilateralmente. Se più soggetti operano tutti all’insaputa l’uno
dell’altro, si configurano distinti ed autonomi reati monosoggettivi.
Nei casi in cui la fattispecie incriminatrice monosoggettiva richiede un dolo specifico, per la
configurabilità di un concorso punibile è sufficiente che la particolare finalità che la legge penale
richiede sia perseguita da almeno un soggetto di quelli che concorrono a commettere il reato.
L’ammissibilità di una partecipazione dolosa ad un delitto colposo ed una partecipazione colposa ad
un delitto doloso è controversa:
Concorso doloso a delitto colposo: se se ne negasse la configurabilità rimarrebbero,
ingiustificatamente, impuniti quelli che concorrono nell’altrui fatto colposo con una condotta
atipica. Poiché l’articolo 110 stabilisce che il fenomeno concorsuale si riferisce al medesimo
reato, sembrerebbe che esso legittimi una concezione unitaria della partecipazione criminosa,
e se è così, allora la possibilità di imputare lo stesso fatto a titolo soggettivi diversi sarebbe da
escludere (altrimenti si accogliere una concezione del concorso pluralistica, ossia come istituto
costituito da una pluralità di reati). Inoltre, se il legislatore avesse voluto riconoscere la
possibilità che più partecipi rispondessero a titoli diversi dello stesso illecito lo avrebbe
121
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
riconosciuto in maniera esplicita, così come ha fatto altri casi (ad esempio l’art. 116, almeno
secondo la disciplina originaria, considera concorrenti soggetti che rispondono di dolo e di
responsabilità oggettiva), e dunque sarebbe lecito ritenere che essa sia un’eccezione che deve
essere prevista per sussistere.
Tuttavia, sembra lecito anche dubitare che le ipotesi inquadrabili nella figura della
partecipazione dolosa a delitto colposo acquistino realmente una rilevanza penale tale da
rendere la rinuncia alla loro incriminazione un intollerabile vuoto di tutela.
Concorso colposo a delitto doloso: alle problematiche argomentazioni precedenti si
aggiungono quelle relative al carattere specifico di questa presunta forma di concorso. La
responsabilità colposa, secondo un principio generale del nostro ordinamento, presuppone
un’espressa previsione legislativa, e ciò lo conferma l’art. 113, che prevede solo la
cooperazione nel delitto colposo, e fa dunque dedurre un’esclusione della cooperazione nel
delitto doloso. Inoltre, la tendenza prevalente oggi è quella di circoscrivere l’ambito del dovere
obiettivo di diligenza incombente su ciascuno entro limiti che siano compatibili il più possibile
con il carattere personale della responsabilità penale. Dunque, se si presuppone in ognuno
l’attitudine ad un’autodeterminazione responsabile, allora ognuno deve evitare soltanto i
pericoli derivanti dalla propria condotta, mentre no nei ha l’obbligo di impedire
comportamenti pericoli di terzi, e non possono per questo essere definite colpose le azioni che
sono pericolose non in sé stesse ma semplicemente perché forniscono ad altri l’occasione di
delinquere.
IL CONCORSO NELLE CONTRAVVENZIONI
Le contravvenzioni, sulla base dell’art. 42 ultimo comma, sono indifferentemente punibili a titolo di
dolo o di colpa, e riguardo al primo caso non sorgono ostacoli nel ricondurre la disciplina del concorso
nella contravvenzione dolosa alla disposizione generale dell’art. 110 (che richiama i “reati”, e
comprende dunque anche le contravvenzioni).
Per le contravvenzioni colpose la questione è più complicata, perché l’art. 113 disciplina il concorso
soltanto relativamente ai delitti. Secondo l’orientamento prevalente, il concorso nella contravvenzione
colposa dovrebbe rientrare nella disciplina dell’art. 110, ma in questo modo ci si troverebbe di fronte
all’incongruenza di ritenere le circostanze aggravanti dei primi due numeri dell’art. 112 applicabili alle
contravvenzioni colpose, e inapplicabili ai delitti colposi, che sono invece più gravi. Inoltre,
accogliendo questa tesi si finisce per estendere la punibilità di un numero di comportamenti atipici
ben maggiore di quello che si ha nell’ambito del concorso nei delitti colposi, poiché le contravvenzioni
sono molte di più.
Infine, in questo modo si affiderebbe un’ampia portata incriminatrice ad una norma implicita, dedotta
in via interpretativa dall’art. 110, mentre sarebbe più legittima pretendere una disciplina espressa.
LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Anche se di principio la responsabilità dei concorrenti viene parificata, il legislatore ha espressamente
previsto circostanze aggravanti e attenuanti per determinare la pena in funzione dell’effettivo
contributo di ciascun soggetto alla realizzazione dell’illecito.
Le aggravanti, la cui applicazione è obbligatoria, sono le seguenti.
1. L’art. 112 stabilisce un aggravamento di pena nel caso in cui il numero di concorrenti sia di
cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti. Questa disposizione è stata prevista
perché il maggior numero di soggetti denota un maggiore allarme sociale e una maggiore
capacità a delinquere. Il calcolo del numero dei soggetti prescinde dalla colpevolezza,
imputabilità o punibilità dei singoli concorrenti.
2. La seconda aggravante prevista è invece quella per chi ha promosso (ossia ideato l’impresa
prendendone l’iniziativa), organizzato (ossia predisposto il progetto esecutivo, scegliendo i
mezzi e le persone che devono attuarlo) o diretto (ossia chi assume una funzione di guida ed
122
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
amministrazione) la partecipazione al reato, e questo perché chi assume la direzione
dell’impresa delittuosa merita, secondo il legislatore, un trattamento più severo (art. 112
comma 10 n.2)
3. Un’ulteriore aggravante è quella prevista per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o
vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette (art. 112 comma 10
n.3). secondo l’opinione dominante è necessario che la persona dotata del potere di
supremazia abbia realizzato una vera e propria coazione psicologica sul soggetto sottoposto,
non bastando una forma qualsiasi di soggezione psicologica.
4. Un’ultima circostanza aggravante di pena è quella prevista per chi ha determinato a
commettere il reato un minore di diciott’anni, o una persona in stato di infermità o di
deficienza psichica, o si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella
commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (art. 112 comma 10 n.4).
Tale circostanza integra a disciplina prevista dall’art. 111 (determinazione al reato di persona
non imputabile o non punibile), in quanto si applica fuori dal caso preveduto dalla predetta
disposizione normativa.
Con le leggi n. 203/1991 e 172/1992 sono stati aggiunti due nuovi commi all’art. 112, i quali
stabiliscono che “la pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalsa di persona non imputabile o
non punibile, a cagione di una condizione, o qualità personale, nella commissione di un delitto per il
quale è previsto l’arresto in flagranza. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di
altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4
del primo comma la pena è aumentata fino alla metà, e in quello previsto dal secondo comma la pena è
aumentata fino a due terzi”. Tale provvedimento si è reso necessario per contrastare il crescente
fenomeno dell’utilizzazione di soggetti non imputabili nell’ambito della criminalità organizzata.
LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E IL CONTRIBUTO DI “MINIMA IMPORTANZA”
L’applicazione delle circostanze attenuanti è invece facoltativa, e l’art. 114 ne prevede due:
Comma 1: il giudice può diminuire la pena se ritiene che l’opera prestata da taluno dei
concorrenti abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.
Non sempre però è facile stabilire quando il contributo sia di minima importanza, ma
l’opinione dominante presuppone che sia necessaria una valutazione giudiziale dell’efficienza
dell’apporto causale arrecato da ciascun singolo concorrente; la minima importanza si avrà
soltanto quando l’azione del concorrente può facilmente essere sostituita con l’azione di altre
persone, o con una diversa distribuzione dei compiti.
La giurisprudenza è però solita fornire, di questa attenuante, un’interpretatio abrogans, infatti
quasi in ogni caso concreto essa finisce con l’escludere l’applicazione di questa circostanza.
Comma 30: è detta della minorazione psichica, ed è stabilita a favore di chi è stato determinato
a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni della
coercizione esercitata da un soggetto rivestito di autorità oppure della minorità o infermità
mentale.
LA RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPE PER IL REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO
L’art. 116 disciplina espressamente un’ipotesi particolare di aberrato delicti in ragione del suo
verificarsi frequentemente nell’ambito del fenomeno concorsuale. Questo articolo stabilisce che,
qualora il reato commesso sia differente da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione, e viene anche aggiunto che se il
reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi voleva un reato meno
grave. In questo modo viene però configurata un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma questa
rinuncia al requisito della colpevolezza, in quanto nell’intenzione del legislatore del ’30, obbediva al
proposito di introdurre un trattamento punitivo così rigoroso da disincentivare la realizzazione in
123
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
concorso di attività criminose.
Tale fenomeno differisce dalla figura dell’aberratio delicti in senso stretto, ex art. 83 c.p., in quanto:
1. Nell’aberratio delicti, l’evento diverso che si realizza è il risultato di un errore nell’uso dei
mezzi di esecuzione del reato o effetto di altra causa, mentre per l’art. 116 l’evento divrso deve
essere voluto
2. Nell’aberratio delicti non si richiede che l’evento diverso sia prevedibile
Per mitigare il rigore della responsabilità fondata sul solo nesso causale, nel dopoguerra una
giurisprudenza minoritaria ha cominciato a subordinare la punibilità del partecipe per il reato diverso
da quello voluto all’ulteriore requisito della previsione dell’evento. Tuttavia, nonostante questo
tentativo di interpretazione correttiva, il contrasto tra art. 116 c.p. e art. 27 comma 10 Cost. venne
eccepito. La Corte costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha però respinto
l’eccezione sostenendo che la responsabilità ex art. 116 poggiasse sulla sussistenza non solo del
rapporto di causalità materiale, ma anche su un rapporto di causalità psichica (nel senso che il reato
più grave deve potersi rappresentare alla psiche dell’agente come un prevedibile sviluppo di quello
voluto, in modo da potersi così affermare anche la necessaria presenza di un coefficiente di
colpevolezza).
La giurisprudenza, su queste basi, propende oggi per la tesi che sostiene che i presupposti della
responsabilità ex art. 116 siano:
il rapporto di causalità tra l’azione di ogni partecipe e il reato diverso da quello programmato
la prevedibilità di questo reato diverso e non voluto (alcuni sostengono che essa debba essere
prevedibilità in astratto, ossia un rapporto tra fattispecie incriminatrici poste a confronto a
priori, mentre altri sostengono che essa debba essere prevedibilità in concreto, ossia un
rapporto che tiene conto di tutte le circostanze della singola vicenda in esame).
Con questa rilettura, si nota dunque che la responsabilità ex art. 116 tende oggi verso il modello
dell’imputazione colposa, poiché perde i suoi connotati rigidi oggettivo-causali, anche se non ne
integra tutti i requisiti poiché non è richiesta la prova della violazione del dovere obiettivo di diligenza.
L’opinione dominante sostiene inoltre che l’art. 116 si applichi anche nel caso in cui si compia anche il
reato diverso e non voluto, ossia si porti a termine il reato concordato, e un ulteriore non da tutti
voluto (sempre che il secondo sia uno sviluppo prevedibile del primo). Per reato diverso s’intende
quello caratterizzato da un diverso nomen iuris, e non solamente aggravato.
L’art. 116 comma 2 c.p. precisa inoltre che la disciplina del comma 1 si applica a prescindere dalla
maggiore o minore gravità del reato non voluto rispetto a quello voluto, ma nel caso di maggiore
gravità del reato diverso il giudice deve obbligatoriamente applicare una diminuzione della pena a chi
voleva il reato meno grave (è infatti una circostanza attenuante).
CONCORSO NEL REATO PROPRIO E MUTAMENTO DEL TITOLO DEL REATO PER TALUNO DEI
CONCORRENTI
Un soggetto privo della qualità personale, ossia un extraneus, può concorrere nella commissione di un
reato realizzabile monosoggettivamente soltanto da un soggetto qualificato, ossia un intraneus, e
questa è l’ipotesi del concorso nel reato proprio (es. cittadino comune che istighi il militare alla
diserzione).
Questa ipotesi di concorso rientra nella disciplina dell’art. 110, ma, secondo i principi generali
dell’imputazione dolosa, la responsabilità dell’extraneus richiede la consapevolezza di concorrere ad
un reato proprio, e ciò significa che egli deve essere a sua volta a conoscenza della qualifica
dell’intraneus. Tuttavia, può succedere che la qualifica non sia determinante per l’esistenza di un reato,
ma comporti solo la diversa qualificazione giuridica di un fatto che costituirebbe già reato ad altro
titolo. Se ad esempio x istigasse un pubblico ufficiale ad appropriarsi di denaro pubblico, questo fatto
sarebbe qualificabile come appropriazione indebita per l’extraneus e come peculato per l’intraneus, e
dunque, se l’estraneo è a conoscenza della qualifica del pubblico ufficiale vi è concorso nel reato
proprio di peculato sulla base dell’art. 110 c.p., ma i problemi sorgono se l’estraneo non ne è a
124
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
conoscenza.
L’interpretazione comune sostiene che si riferisca proprio a questa ipotesi l’art. 117, che dispone che
se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra colpevole e offeso, muta il
titolo di reato per uno dei concorrenti, anche gli altri rispondono dello stesso reato, e, se esso è più
grave, il giudice può diminuire la pena per quelli che non presentano le condizioni, qualità o rapporti
sopra citati. Questo articolo propone una scelta legislativa sostanzialmente analoga a quella dell’art.
116, infatti, analogamente a questo articolo, l’art. 117 finisce per introdurre una forma di
responsabilità oggettiva, e non è inoltre conforme con i principi dell’imputazione dolosa il fatto che
un partecipe debba rispondere di concorso in un reato proprio di cui non presenta la qualifica
necessaria. Si tratta, quindi, di una disciplina che persegue l’obiettivo di estendere l’incriminazione a
titolo di reato proprio anche a soggetti che non potrebbero risponderne in base ai principi generali, in
quanto ricomprende i casi in cui i reati siano diversi poiché i soggetti si trovano in posizioni soggettivi
diverse.
Per reagire però ad un trattamento penale così rigoroso, una parte della dottrina esclude che l’art. 117
deroghi ai nomali principi del concorso in reato dell’art. 110, e si esige dunque che in entrambi i casi
l’extraneus sia a conoscenza della qualifica dell’altro, e per questo motivo con il progetto di riforma del
1973 e con lo schema di delega legislativa del 1992 per la riforma del codice si era proposto di
esplicitare questa necessaria conoscenza della qualifica. Tuttavia, nel diritto vigente l’articolo non
presenta ancora questo requisito, e l’orientamento dominante sostiene che l’art. 117 deroghi
effettivamente ai principi generali dell’art. 110. Reinterpretando però l’art. 117 in maniera conforme al
principio costituzionale della colpevolezza, la sua applicabilità andrebbe circoscritta ai soli casi in cui
la qualifica soggettiva in questione, anche se non conosciuta dall’extraneus, fosse però conoscibile in
base a parametri di un uomo ragionevole che si trovasse al suo posto.
Si discute se l’art. 117 presupponga una certa distribuzione di ruoli tra intraneo ed estraneo, ossia ci
si chiede se per il mutamento del titolo di reato sia necessario che sia l’intraneus a porre in essere
l’attività esecutiva o se possa essere anche l’extraneus a farlo (ci si chiede ad esempio se il pubblico
ufficiale lasciasse aperta la cassaforte agevolando il furto di un extraneus, quale reato dovrebbe
configurarsi, se concorso in peculato o concorso in furto). L’art. 117 non esplicita le circostanze in cui
si ha mutamento del titolo del reato per le particolari qualità del colpevole o rapporti con l’offeso, e
dunque bisogna ogni volta fare riferimento all’interpretazione della fattispecie di parte speciale che
viene in questione (ad esempio il peculato può essere commesso solo da soggetto qualificato, e dunque
se quest’ultimo agevola il furto di un extraneus, il mutamento del titolo sarà escluso e si configurerà un
semplice concorso in furto). Tuttavia, non è di questo avviso la giurisprudenza e dottrina prevalente,
che ritiene che il ruolo dell’intraneus nell’esecuzione del fatto sia indifferente, e che il concorso nel
reato proprio si configuri anche nel caso in cui la persona dotata di qualifica si limitasse ad agevolare il
reato senza prendere parte all’esecuzione.
La stessa disposizione, infine, prevede una circostanza attenuante facoltativa a favore di chi volle il
reato meno grave, la quale è applicabile, secondo l’orientamento prevalente, soltanto al soggetto
ignaro della qualifica. He comporta la diversa qualificazione giuridica del fatto.
LA COMUNICABILITÀ DELLE CIRCOSTANZE
Con la legge n. 19 del 1990 si è verificato un mutamento di disciplina riguardo alla questione della
comunicabilità o estensibilità delle circostanze aggravanti e attenuanti ai soggetti in concorso.
Prima di questa riforma l’art. 118 c.p. prevedeva una disciplina differenziata in funzione del carattere
oggettivo o soggettivo delle circostanze determinato alla stregua dell’art. 70 c.p:
Art. 118 comma 1 stabiliva infatti che le circostanze oggettive attenuanti o aggravanti
venissero sempre valutate, rispettivamente, a favore o a carico di tutti i concorrenti, anche se
uno di essi non le avesse conosciute
Art. 118 comma 2 stabiliva, invece, che le circostanze soggettive attenuanti o aggravanti si
applicassero soltanto ai concorrenti cui si riferivano, tranne quelle che fossero servite ad
agevolare la commissione del reato, che si estendevano invece a tutti i concorrenti (mentre mai
125
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
si estendevano la recidiva e l’imputabilità, che era circostanze oggettive inerenti alla persona
del colpevole).
A seguito della riforma del 1990, l’art. 118 dispone che le circostanze che aggravino o diminuiscano le
pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti
alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Ci si chiede
allora se le circostanze non menzionate dall’articolo debbano invece estendersi automaticamente a
tutti i concorrenti, o se debbano invece soggiacere alla nuova regola di imputazione soggettiva
introdotta in via generale dall’art. 59 c.p., e si può dire che la soluzione più apprezzabile è quest’ultima
che si rifà al principio di colpevolezza. Applicando l’art. 59 vale dunque la regola della persistente
rilevanza oggettiva delle circostanze attenuanti, e dunque della loro estensibilità a tutti i concorrenti
(fatta eccezione per quelle inestensibili menzionate all’art. 118).
L’art. 59 c.p. dispone comunque che le aggravanti possono applicarsi solo se conosciute o conoscibili
dal reo, e dunque potranno estendersi soltanto ai concorrenti che ne fossero al corrente o potessero
esserlo.
In sostanza, oggi, secondo la disciplina del nuovo art. 118, sono estensibili tutte le circostanze
soggettive, diverse da quelle eccettuate dal medesimo articolo, purché conosciute o conoscibili,
ancorché non siano servite ad agevolare la esecuzione del reato. L’ambito di estensibilità risulta quindi
ampliato.
LA COMUNICABILITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PENA
Sulla base dell’art. 119 comma 20, si estendono a tutti i compartecipi le circostanze oggettive di
esclusione della pena, ossia le cause di giustificazione, o scriminanti, elencate agli artt. 50 e ss. del
codice, che annullano l’antigiuridicità o illiceità del fatto. Queste cause si estendono a tutti i
concorrenti perché se il fatto non viene considerato illecito, non si possono considerare tali le condotte
che hanno concorso alla sua realizzazione.
Le cause soggettive di esclusione della pena (es. vizio di mente, furto ai danni di un proprio genitore,
ecc.) si applicano invece soltanto al soggetto cui si riferiscono, e non si estendono agli altri concorrenti,
e questo perché la punibilità viene meno per ragioni che fanno riferimento ad un soggetto, ma non agli
altri.
DESISTENZA VOLONTARIA E PENTIMENTO OPEROSO
Ci si chiede, in mancanza di un’esplicita disciplina legislativa, se per essere esente da pena il
concorrente che desiste possa limitarsi ad annullare il contributo prestato da egli alla realizzazione del
fatto collettivo, o se debba invece impedire la consumazione del reato anche da parte degli altri
concorrenti. La questione è complicata dal fatto che la desistenza si può manifestare in forme diverse,
infatti, mentre per l’esecutore materiale essa consiste in un atteggiamento negativo, ossia nella
desistenza dal compiere il reato, che annulla perciò la consumazione dello stesso, più complesso è il
discorso per il complice.
Spesso i complici svolgono infatti il loro ruolo prima del tentativo di reato, e dunque la sua desistenza
dovrà consistere in un contributo attivo mirato a neutralizzare le conseguenze di una collaborazione
che egli ha già prestato, ma rimane il problema che si è posto all’inizio: se ad esempio x ha prestato lo
strumento necessario per un furto, per poter sfuggire alla pena dovrà semplicemente riprendersi lo
strumento, o dovrà anche impedire che l’altro/ gli altri commettano il furto? Attenendosi al principio
della personalità della responsabilità penale, è da ritenere che per la desistenza del partecipe possa
essere sufficiente il semplice neutralizzare la condotta in precedenza realizzata, poiché facendo questo
si emancipa dalla commissione di un fatto che non può così essergli più attribuito (ma per questo
bisogna comunque verificare che il reato consumato non contenga più nulla di riconducibile
all’originario contributo del soggetto che desiste).
Naturalmente la desistenza ha carattere personale, e dunque essa non può estendersi agli altri
concorrenti.
126
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
La configurabilità del pentimento operoso presuppone che l’azione collettiva sia giunta ad
esaurimento e che uno dei concorrenti riesca però ad impedire che si verifichi l’evento lesivo (ad
esempio un complice di omicidio che si pente e porta in ospedale la persona che ha tentato di
uccidere). Anch’essa è, naturalmente, una circostanza attenuante soggettiva.
ESTENSIBILITÀ DELLA DISCIPLINA DEL CONCORSO “EVENTUALE” AL CONCORSO “NECESSARIO”
Il concorso necessario o il reato necessariamente plurisoggettivo ricorre quando è la stessa
disposizione incriminatrice di parte speciale a richiedere la presenza di più soggetti per
l’integrazione dell’illecito.
I reati di questo tipo si distinguono in:
Reati plurisoggettivi propri: tutti i coagenti sono punibili, come nel caso dell’associazione a
delinquere o nella rissa
Reati plurisoggettivi impropri: sono punibili solo uno o alcuni dei partecipanti, come nella
corruzione di minorenni o nell’usura.
Per quanto riguarda quest’ultimi, ci si chiede se il concorrente necessario possa invece essere
ritenuto responsabile in base alle norme che disciplinano il concorso eventuale.
A. Una parte della dottrina ritiene che questo problema vada risolto alla stregua della
voluntas legis, ossia verificando se l’esenzione da responsabilità del concorrente
necessario risponda o meno all’obiettivo della norma incriminatrice violata e alle
direttive generali dell’ordinamento giuridico.
B. Sembra però preferibile l’opinione tradizionale che nega la punibilità del concorrente
non espressamente incriminato dalla norma incriminatrice, infatti il fatto che la sua
condotta, pur necessaria, non sia stata espressamente assoggettata a pena dal
legislatore, sottintende una scelta legislativa a favore dell’impunità, altrimenti si
violerebbe il principio del nullum crimen sine lege.
Un secondo problema è invece quello riguardante l’applicabilità ai concorrenti necessari, punibili sulla
base della norma incriminatrice, delle norme sul concorso eventuale relative alle aggravanti e
attenuanti (artt. 112 e 114), e riguardante anche la comunicabilità delle circostanze e delle cause di
esclusione della pena (artt. 118 e 119). La dottrina dominante (a differenza dell’atteggiamento
giurisprudenziale oscillante) sostiene che queste norme siano applicabili al concorso necessario,
poiché espressione di una disciplina generale relativa al carattere plurisoggettivo della fattispecie, a
meno che non siano espressamente derogate dalle disposizioni che configurano i diversi reati
necessariamente plurisoggettivi.
Concorso eventuale è poi ammissibile nella realizzazione di un reato necessariamente
plurisoggettivo, e la partecipazione eventuale si potrà configurare da parte di soggetti diversi dai
concorrenti necessari.
CONCORSO EVENTUALE E REATI ASSOCIATIVI
Negli ultimi anni si sono resi più acuti principalmente due problemi di interferenza tra il concorso di
persone e il reato associativo, dovuto essenzialmente al dilagare della criminalità politico-terroristica
e mafiosa, che corrisponde al modello dei reati a concorso necessario.
Un primo problema è quello di stabilire quali condizioni siano necessarie perché un’associazione
criminosa (o meglio i suoi “vertici”) risponda a titolo di concorso eventuale anche per i reati-scopo
materialmente eseguiti da altri associati. Non bisogna in questo caso incorrere nel rischio di attribuire
ai vertici delle associazioni una sorta di responsabilità di posizione che faccia di essi automaticamente
dei concorrenti morali. Per il concorso morale servono infatti presupposti minimi da accertare
concretamente caso per caso, e non basta dunque che i reati siano stati commessi da altri associati su
direttive programmatiche fissate dai capi, ma è piuttosto necessario che le direttrici generale del
programma criminoso dell’associazione predeterminino sufficientemente i tratti essenziali dei singoli
comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi.
127
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Il secondo problema è quello di verificare se e con che presupposti sia configurabile un concorso
“esterno" ex art. 110 e seguenti ad una associazione criminosa da parte di soggetti estranei ad essa,
ma con essa collaboranti. Se si adotta un concetto ampio di partecipe, allora l’ambito applicativo da
riservare alla figura del concorrente esterne si restringe inevitabilmente, ma se si considera che la
rilevanza penale di una condotta di partecipazione al reato associativo implichi necessariamente
l’acquisizione del ruolo di associato, allora vi è un vuoto di tutela nei casi di collaborazione da parte di
un soggetto esterno. Per colmare questo vuoto di tutela penale non si può che ipotizzare un concorso
eventuale esterno ex art. 110 e ss. del codice, nel reato associativo che viene in questione in concreto.
La Cassazione, con quattro pronunce a sezioni unite, ha cercato di precisare presupposti e limiti di un
concorso eventuale nel reato di associazione. Con la più recente presa di posizione, essa ha computo
un passo in avanti nel definire i contorni del concorso esterno precisando la nozione di partecipazione:
Partecipazione interna: si può definire partecipe interno quello che ha un rapporto di stabile
e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio criminale che ne implichi
un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale prende parte al fenomeno associativo,
rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni scopi criminosi.
Partecipazione esterna: si può definire concorrente esterno il soggetto che non è inserito
stabilmente nella struttura dell’organizzazione, ma fornisce ad essa un concreto, specifico,
consapevole e volontario contributo che esplichi una effettiva rilevanza causale, ossia che si
presenti come condizione necessaria alla conservazione o al rafforzamento
dell’organizzazione. Tale efficacia eziologica deve essere accertata ex post, e cioè proprio alla
stregua dei medesimi criteri rigorosi che più in generale soccorrono per dimostrare il nesso di
condizionamento secondo il modello di sussunzione di leggi scientifiche.
La difficoltà che permane è però quella di rinvenire leggi di copertura o generali massime di
esperienza per distinguere in modo rigoroso e univoco tra contributi che abbiano o meno efficacia
condizionalistica per la conservazione o il rafforzamento dell’organizzazione criminale. In questo
modo lo spazio di discrezionalità del giudice si presenta molto ampio, e per limitarlo sarebbe
auspicabile un intervento legislativo che precisi le forme di contiguità intollerabili e dunque meritevoli
di repressione penale.
128
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE TERZA
REATO COMMISSIVO COLPOSO
Poiché la criminalità colposa ha subito un aumento negli ultimi decenni, si è avvertita la necessità di un
maggiore approfondimento dogmatico della struttura del delitto colposo, la quale ha indotto la
dottrina più recente a costruire la fattispecie colposa in modo separato ed autonomo rispetto al
reato doloso. Inoltre, la colpa è negli anni stata approfondita e specificata in differenti tipologie di
colpa con peculiarità strutturali (colpa medica, colpa sportiva, colpa stradale, ecc.).
TIPICITÀ
IL FATTO COMMISSIVO COLPOSO TIPICO: AZIONE
Gli elementi costitutivi della fattispecie commissiva colposa sono più complessi di quelli del delitto
commissivo doloso, e questo anche perché la dogmatica penalistica ha affrontato con maggiore ritardo
lo studio dell’illecito colposo, non avendolo inizialmente considerato come categoria dotata di
sufficiente autonomia per meritare una trattazione separata.
Il significato pratico del concetto di azione consiste nella sua funzione selettiva dei comportamenti
penalmente rilevanti, nel senso che questo concetto serve per escludere le “non azioni” da ciò che è
penalmente sanzionabile. Tuttavia, nell’ambito del delitto colposo assumono rilevanza penale anche
comportamenti che non corrispondono a questo concetto di azione come atto volontario e cosciente
(vi è infatti, ad esempio, la colpa incosciente).
Ci si deve dunque chiedere cosa significhi “azione cosciente e volontaria” nell’ambito del delitto
colposo. Se si sostenesse che in questa definizione non rientrassero atti riflessivi, istintivi, automatici
ed incoscienti, allora si cadrebbe in una contraddizione, perché nella prassi giudiziaria molti di questi
atti sono puniti a titolo di colpa, e dunque si dovrebbe concludere che vengano incriminate come
delitti colposi delle “non azioni”.
Bisogna dunque dire che nel campo del delitto colposo vi è azione penalmente rilevante finché è
possibile muovere un rimprovero per colpa, e dunque il concetto di coscienza e volontà dell’azione
dato dall’art. 42 deve essere differenziato per i delitti dolosi, nei quali la coscienza e volontà consiste
in un coefficiente psicologico effettivo, e quelli colposi, nei quali essa si identifica con un dato
psicologico (colpa cosciente) o con un dato normativo (colpa incosciente). Inoltre, in quest’ultimo
senso l’azione si considera voluta anche quando risulta solo dominabile dal volere, ossia che può
essere impedita con l’attivazione dei normali poteri di arresto e di impulso della volontà. Dunque
all’agente si imputa il fatto di non avere attivato i poteri di controllo che doveva e poteva attivare per
evitare l’evento lesivo, ovvero non ha osservato lo standard di diligenza richiesto.
INOSSERVANZA DELLE REGOLE PRECAUZIONALI DI CONDOTTA
L’art. 43 stabilisce che si ha delitto colposo quando l’evento, anche se previsto, non è voluto
dall’agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline. In questo articolo si richiamano dunque requisiti di natura
psicologica e requisiti a carattere normativo.
La violazione delle norme a contenuto precauzionale caratterizza infatti il reato colposo sotto un
duplice punto di vista, nel senso che integra una specifica forma di colpevolezza, ma essa rileva anche
sul piano della tipicità, poiché ogni illecito colposo si conforma sulla base del rapporto che intercorre
tra la trasgressione del dovere oggettivo di diligenza e i restanti elementi della fattispecie
incriminatrice. Ne consegue che il contenuto del dovere di diligenza muta in funzione del tipo di
fattispecie che viene in questione.
Nel reato causalmente orientato con evento naturalistico, il contenuto della regola cautelare si
specifica in relazione all’evento da evitare, e dunque in questo caso sarà azione tipica quella che (tra le
azioni compiute dal soggetto e causalmente collegate con l’evento) dia per prima luogo ad una
129
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
situazione di contrarietà con la regola di condotta a contenuto preventivo.
L’inserimento dell’inosservanza del dovere di diligenza tra gli elementi della tipicità del fatto colposo
consente di raggiungere due importanti obiettivi, ossia riequilibrare la tendenza ad attribuire peso
decisivo alla “causazione materiale dell’evento”, e rafforzare la funzione della norma penale di tutela
dei beni giuridici.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA E IL LIMITE DEL CASO FORTUITO
Le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali rappresentano la cristallizzazione di giudizi di
prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo, e dunque sono proprio prevedibilità ed evitabilità a
dover fare da criteri atti ad individuare le misure precauzionali da adottare nelle situazioni concrete
per prevenire o ridurre l’insorgere di conseguenze dannose.
Tuttavia, per esimere da responsabilità, non è sufficiente la semplice osservazione di una regola
cautelare adottata dall’agente perché socialmente diffusa, infatti essa potrebbe in alcuni casi essere
inadeguata a conseguire l’obiettivo precauzionale, ed è per questo che l’agente non deve
semplicemente attenersi a già che è socialmente diffuso, ma giudicare di volta in volta la prevedibilità
ed evitabilità per verificare la persistente validità della regolare cautelare che dovrebbe essere
osservata.
Inoltre, non sempre è presente una regola socialmente diffusa, e, nel caso in cui l’uso sociale non si sia
ancora pronunciato, è assolutamente escluso il richiamo di regole consolidate nella prassi (questo
accade ad esempio in relazione agli inediti pericoli legati all’attività di sperimentazione svolta nei
laboratori scientifici). In questi ambiti il soggetto deve compiere ex novo un giudizio prognostico
relativo alla pericolosità dell’attività in questione.
Le società contemporanee sono inoltre dette “del rischio”, e all’interno di esse continuano ad
aumentare le situazioni la cui dannosità e pericolosità è scientificamente incerta. In queste situazioni
può venire in rilievo il principio di precauzione, che si deve ritenere inidoneo a produrre
automaticamente nuove regole cautelari, ma comunque in grado di fungere da criterio atto a
sollecitare un rafforzamento dei doveri di attenzione e informazione che tendano a verificare meglio la
fondatezza dei pericolo o dei rischi paventabili.
Va comunque notato che l’osservanza di regole precauzionali trova un limite nell’ambito delle attività
rischiose ma comunque consentite dall’ordinamento per la loro elevata utilità sociale.
Il criterio della prevedibilità ed evitabilità dell’evento opera anche nell’ambito della colpa specifica,
ossia quella dovuta all’inosservanza di regole scritte di condotta, solo che in questo caso il giudizio
prognatismo sul pericolo e sui mezzi per evitare l’evento dannoso è compiuto dall’autorità che pone la
norma scritta.
Una ulteriore riprova della funzione fondante che il criterio della prevedibilità esplica rispetto al
concetto di colpa penale, la si può ricavare dall’insegnamento tradizionale che considera limite
negativo della colpa il caso fortuito, finendo così per costruire i due concetti come complementari.
Dunque il caso fortuito esclude la colpa proprio perché consiste in un accadimento imprevedibile.
FONTI E SPECIE DELLE QUALIFICHE NORMATIVE RELATIVE ALLA FATTISPECIE COLPOSA
Le regole precauzionali richiamate dalle fattispecie colpose possono avere una fonte sociale o
giuridica:
Fonte sociale: sono qualifiche normative sociali la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia, e ciò
significa che le regole che le riguardano non hanno una fonte giuridica, ma sono ricavate
dall’esperienza della vita sociale. Questa è la cosiddetta colpa generica. In particolare si ha:
A. Negligenza: quando la regola di condotta volata prescrive un’attività positiva
B. Imprudenza: quando si trasgredisce una regola di condotta da cui discende l’obbligo di
non realizzare una determinata azione o di compierla con modalità diverse da quelle
tenute
130
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
C. Imperizia: quando si ha una forma di imprudenza o negligenza “qualificata”, ed essa si
riferisce infatti ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche
Talvolta la valutazione penalistica delle diverse forme di colpa generica risente di
condizionamenti legati alle caratteristiche dei settori di vita di volta in volta coinvolti,
come ad esempio nel caso della responsabilità medica, per la quale un orientamento
tradizionale distingueva tra negligenza o imprudenza, nei cui casi la colpa andava accertata
secondo le regole generali, e dunque poteva rilevare anche la colpa lieve, o errore diagnostico
dovuto ad imperizia, nel cui casi poteva rilevare solo la colpa grave, o dolo, facendo leva sul
disposto dell’art. 2236 c.c. In realtà l’orientamento giurisprudenziale, per evitare di inibire
eccessivamente l’operato del medico gravandolo di eccessive cautele, mostrava una maggiore
larghezza in sede di valutazione penale dell’imperizia, in considerazione delle difficoltà cui il
medico può andare incontro. Successivamente è seguito un orientamento sempre più rigoroso,
che applicava in linea di principio anche alla colpa medica per imperizia i comuni criteri di
valutazione della colpa penalmente rilevante ex art. 43 c.p., e questo per tutelare meglio i diritti
del paziente.
La nuova disciplina della responsabilità medica è quella introdotta dalla “riforma Balduzzi”
del 2012, che aveva la preoccupazione di ridurre il rischio penale gravante sul ceto medico per
prevenire la “medicina difensiva”. Si è dunque creata una disciplina normativa differenziata
della responsabilità colposa medica, per effetto della quale non risponde di colpa lieve il medico
che si attiene ad accreditate linee guida. Il senso di questa disciplina speciale è il fatto che la
colpa lieve rispecchia una mancanza condonabile se a commetterla è un tipo di medico nel
complesso affidabile perché fedele, in linea di massima, alle linee guida di un sapere scientifico
consolidato, mentre non può essergli condonabile la colpa grave, che si ha quanto maggiore è
la divergenza tra la condotta tenuta e quella che avrebbe dovuto tenere.
Il reato colposo deve la sua complessità al fatto che è compito del giudice diagnosticare l’azione
delittuosa alla stregua di criteri sociali di valutazione necessariamente “aperti” e spesso fluidi.
Fonte giuridica: a fonte delle regole cautelari può anche essere giuridica o scritta, ed è la colpa
specifica che l’art. 43 c.p. tratta riferendosi a “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Per quanto riguarda le leggi, si discute se possano esservi ricomprese anche le leggi penali
genericamente intese, ma a questa importanza viene contestato il fatto che nel nostro
ordinamento la colpa non consiste nella causazione di un evento unita alla violazione di una
qualsiasi norma, ma nella trasgressione di una norma che ha una specifica finalità cautelare,
e per questo per “leggi” vanno intese non tutte le norme penali, ma solo le leggi che hanno una
specifica finalità precauzionale nel senso di impedire eventi involontari connessi allo
svolgimento di attività lecite.
I regolamenti sono invece fonti che contengono norme a carattere generali predisposte
dall’Autorità pubblica per regolare lo svolgimento di certe attività, mentre gli ordini e le
discipline contengono norme destinate solo ad una specifica cerchia di soggetti, e possono
essere emanati/e da Autorità pubbliche e private.
La colpa specifica presenta dunque il vantaggio di basarsi su fonti certe, e non elastiche e
mutevoli come quelle sociali, ma lo svantaggio che consiste nel fatto che la semplice difformità
della condotta concreta dalle norme scritte basta a far presumere l’esistenza della colpa.
Occorre comunque verificare di volta in volta se le norme scritte esauriscano la misura di
diligenza richiesta all’agente nelle situazioni considerate, e solo in questo caso l’osservanza di
tali norme esclude la responsabilità penale. In caso contrario, il giudizio di colpa torna a
basarsi sull’inosservanza di una generica misura precauzionale.
Le norme giuridiche a contenuto prudenziale si distinguono inoltre in norme rigide e norme
elastiche:
A. Norme rigide: predeterminano in modo assoluto la regola di condotta da osservare
131
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
B. Norme elastiche: per essere applicate presuppongono che la regola di condotta sia
specificata in base al caso concreto (ad esempio la distanza di sicurezza dipende dallo
spazio di frenata).
Generalmente le regole cautelari con fonte giuridica presentano una maggiore certezza, ma vi
sono casi in cui le fonti giuridiche indicano le cautele da osservare in modo così vago e poco
preciso da riprodurre la stessa indeterminatezza della colpa generica (ad esempio l’art. 2087
c.c. dispone l’obbligo, piuttosto generico, per l’imprenditore di adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro). Si può per questo ritenere che si abbia colpa specifica non soltanto
quando sia stata violata una misura cautelare espressa normativamente, ma quando essa abbia
anche contenuto sufficientemente determinato.
CONTENUTO DELLA REGOLA DI CONDOTTA
In alcuni casi il dovere obiettivo di diligenza impone al soggetto di astenersi dal compiere una
determinata azione perché compiendola si avrebbe un rischio troppo elevato di realizzazione della
fattispecie colposa (ad esempio un uomo colto da un malore dovrebbe astenersi dal guidare). Grava un
obbligo analogo di astensione su coloro che non sono sufficientemente esperti per espletare
prestazioni che richiedono particolari cognizioni tecniche (ad esempio risponderà di colpa per
assunzione un medico inesperto che causi la morte di un paziente dopo avere accettato di operarlo,
nonostante sapesse che la vittima avrebbe potuto rivolgersi a chirurghi più esperti, cd. colpa per
assunzione).
Nella maggior parte dei casi l’osservanza del dovere di diligenza impone di realizzare l’azione
adottando determinate misure di cautelari (di sicurezza) (es. la velocità massima), e in questi casi si
dice che la norma cautelare si atteggia a regola modale, poiché il soggetto è diligente se adotta le
specifiche modalità comportamentali dettate dalla fonte normativa scritta o dagli usi sociali.
Parte della dottrina tende a distinguere le regole cautelari in
Proprie: quando la loro osservanza assicura che non si verificherà l’evento dannoso
Improprie: quando esse permettono solo di ridurre il rischio della verificazione dell’evento
dannoso
Il dovere di diligenza potrà avere a contenuto anche un obbligo di preventiva informazione (ad
esempio l’automobilista che va all’estero deve informarsi sulle norme vigenti all’estero in materia
stradale).
Infine, chi ha una posizione gerarchicamente sovraordinata, è titolare dell’obbligo di scegliere con
avvedutezza i propri collaboratori, di istruirli e di controllarne l’operato, mentre i dipendenti devono
attenersi scrupolosamente alle istruzioni che vengono ad essi impartite.
STANDARD OGGETTIVO DEL DOVERE DI DILIGENZA
Il giudizio di prevedibilità ed evitabilità va effettuato ex ante in base al parametro oggettivo dell’homo
eiusdem professionis et condicionis, e questo significa che la misura di diligenza, perizia e prudenza da
tenere sarà quella del modello di agente che svolge la medesima professione, lo stesso mestiere, ecc. di
quello reale. All’interno della stessa categoria sociale di appartenenza si possono spesso trovare
diversi tipi di agenti-modello, e dunque la misura di perizia oggettivamente richiesta può essere
graduabile (ad esempio nel campo sanitario quella richiesta per il medico cattedratico sarà diversa da
quella del medico specialista e del medico generico).
Il fatto che venga utilizzato un tipo oggettivo di agente-modello non impedisce comunque di
individualizzare ulteriormente in dati casi la misura della diligenza imposta, come avviene ad esempio
se una persona appartiene ad una certa categoria sociale ma possiede delle conoscenze ulteriori delle
quali è necessario tenere conto. Alcuni autori distinguono inoltre tra maggiori conoscenze causali
(ad esempio l’automobilista che conosce la pericolosità di un incrocio), nel cui caso si innalza lo
132
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
standard delle diligenza richiesta nella situazione concreta, e speciali capacità (ad esempio
l’automobilista che è un esperto pilota di corsa), nel cui caso non si innalza lo standard della diligenza.
L’individuazione del tipo di agente-modello del caso concreto è dunque il presupposto per specificare
le misure cautelari da adottare allo scopo di neutralizzare o ridurre il rischio che si verifichino eventi
lesivi.
Vi sono quindi due tipi di orientamenti differenti a questo proposito:
Orientamento sociologico: secondo il quale l’agente-modello deve adottare le stesse misure
preventive che la maggior parte degli altri appartenenti alla sua categoria adottano in
relazione allo stesso di tipo di attività. In questo modo si ha il vantaggio di evitare l’elevato
costo di misure preventive tecnologicamente più avanzate, e di predeterminare in misura più
certa e prevedibile il contenuto dei doveri dell’agente-modello. Tuttavia, si obietta a questa
teoria che essa depotenzia l’efficacia della funzione preventiva proprio quando in gioco vi è la
tutela di beni giuridici primari come vita, salute, e integrità fisica.
Orientamento deontologico (per il quale propende la maggior parte di dottrina e
giurisprudenza): secondo il quale l’agente-modello deve adottare le misure preventive
tecnologicamente più evolute ed efficaci disponibili al momento, anche se costose e poco
diffuse.
Parte della dottrina, specialmente tedesca, sostiene la tesi della doppia misura della colpa, ossia
considera che si debba accertare la colpa in due fasi, accertando in sede di tipicità la violazione del
dovere obiettivo di diligenza commisurato alla stregua dell’agente-modello, e verificando in sede di
colpevolezza se il soggetto concreto era in grado di impersonare i tipo ideale di agente collocato nella
situazione data.
LIMITI DEL DOVERE DI DILIGENZA: RISCHIO CONSENTITO
Nell’individuare le regole cautelari da adottare nelle diverse situazioni concrete si deve tenere conto
del fatto che un margine di rischio ineliminabile è comunque presente in quasi tutte le attività
umane (come ad esempio nelle attività intrinsecamente pericolose, come la circolazione
automobilistica, ferroviaria o aerea, o le attività tecnologicamente complesse, l’attività medico-
chirurgica ecc., che sono lecite perché utili socialmente o comunque indispensabili). Per questo, il
giudizio di colpa presuppone che sia oltrepassato il limite del rischio consentito (o dell’adeguatezza
sociale) nell’ambito delle diverse attività umane, e per verificare il superamento di questo limite è
necessario bilanciare il grado di pericolosità di certe azioni o attività e la libertà di realizzarle in base
agli usi sociali o in ragione dei vantaggi se ne possono ricavare, tenendo sempre conto del rapporto di
equilibrio tra i beni giuridici in gioco.
Il problema della determinazione degli spazi di rischio consentito assume un rilievo pratico tanto
maggiore quanto più si tratti di attività caratterizzate da un’intrinseca e accentuata pericolosità. Si
sostiene di norma che se si verifica un danno nonostante il diligente svolgimento di queste attività,
allora ciò che manca è il disvalore tipico dell’illecito colposo, ma questa conclusione non chiarisce i
criteri idonei ad individuare il punto di equilibrio tra l’esigenza di proteggere i beni giuridici
minacciati dalle attività rischiose, e l’esigenza della libertà d’azione.
La soluzione dei conflitti tra valori contrapposti, che tipicamente insorgono sul terreno del cosiddetto
rischio consentito, diventa particolarmente impegnativa e inquietante oggi in materia di
responsabilità per il tipo di produzione, qualora si tratti di attività pericolose e sia da un latto
assente la previsione legale di misure precauzionali, e dall’altro carente il sistema di controllo
preventivo da parte dell’autorità amministrativa. In questi casi la formula del rischio consentito non
permette di risolvere il conflitto tra libertà dell’imprenditore di produrre ciò che vuole e la
salvaguardia della vita e della salute dei soggetti minacciati dalla produzione di sostanze pericolose,
infatti è il giudice, a seguito di un attento e complesso bilanciamento, che deve decidere se l’osservanza
dell’obbligo della necessaria prudenza imponga di rinunciare all’attività produttiva pericolosa.
133
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Altri criteri della valutazione sulla circoscrizione dei limiti di osservanza delle misure precauzionali
sono criteri fattuali, nel senso che si ritiene consentito ciò che viene di fatto tollerato dalla comunità
sociale. Criterio giuridicamente più vincolante dell’individuazione preventiva dell’area del rischio
consentito può invece essere offerto dal riferimento alle autorizzazioni amministrative, che rendono
esplicitamente lecito lo svolgimento di certe attività, subordinandone l’esercizio al rispetto di precise
norme cautelari.
LIMITI DEL DOVERE DI DILIGENZA: PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO E COMPORTAMENTO DEL
TERZO
Ci si chiede se dall’esistenza a carico di ciascun consociato di un dovere obiettivo di diligenza nella vita
di relazione derivino anche obblighi a contenuto cautelare relativi alla condotta di terzi.
Se la regola che si assume violata è una norma scritta, allora bisognerà accertare in via interpretativa
se nello scopo perseguito dalla disposizione scritta rientri anche l’impedimento di eventi cagionati
dall’azione di terzi.
Se invece la regola che si assume violata è una norma desumibile dagli usi sociali il discorso è più
complesso, infatti riguardo alla violazione di regole generiche di diligenza bisogna distinguere a
seconda che la condotta dei terzo dia luogo ad una forma di responsabilità colposa o dolosa.
Mancato impedimento del fatto colposo del terzo: in questo caso la semplice circostanza di
prevedere o potere prevedere che una nostra condotta agevoli il comportamento doloso di un
terzo non è sufficiente a renderci responsabili, e questo a causa dell’aspettativa sociale detta
principio dell’affidamento. Questo principio generali ha delle eccezioni, ossia nei casi in cui
particolari circostanze facciano presumere che il terzo non sia in grado di soddisfare le
aspettative dei consociati, e nei casi in cui l’obbligo di diligenza si innesta su una posizione di
garanzia nei confronti di un terzo incapace di provvedere a sé stesso.
Il principio dell’affidamento ha però trovare nella giurisprudenza un riconoscimento
complessivamente abbastanza limitato, e il suo spazio di operatività risulta infatti condizionato
dalle preoccupazioni repressive connesse ai diversi settori che vengono in rilievo di volta in
volta. Ad esempio nel settore della circolazione stradale il principio dell’affidamento ha trovato
più che altro disconoscimento, infatti in questo ambito è consolidato l’orientamento rigoristico,
secondo cui il conducente è obbligato a tenere conto delle prevedibili scorrettezze altrui,
poiché le severe esigenze di prudenza e diligenza tipiche di questo settore servirebbero a fare
fronte a situazioni di pericolo determinate da condotte di altre persone. Questo orientamento
rigoristico ha però ricevuto temperamento nei pochi casi in cui è stato apposto il limite
dell’imprevedibilità.
La giurisprudenza di legittimità è invece, in linea di principio, più disposta a dare spazio al
criterio dell’affidamento in materia di responsabilità medica, in particolare nell’ambito
dell’attività svolta in équipe, ma sono comunque molti i limiti apposti alla concreta operatività
dell’affidamento come criterio di esclusione della responsabilità colposa. La premessa da cui i
giudici prendono di solito le mosse è costituita dal rilievo che la divisione del lavoro è un
fattore di sicurezza, poiché ogni sanitario è messo nelle condizioni di profondere tutte la sua
attenzione nell’attività di sua competenza senza dovere controllare continuamente i colleghi; la
divisione del lavoro è però contemporaneamente un fattore di rischio, perché è fonte di rischi
nuovi e diversi che derivano da possibili difetti di coordinamento o di informazione, errori di
comprensione, ecc., dunque quando si verificano circostanze che evidenziano la negligenza
altrui, ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro dovrebbe farsi carico di questi rischi
(questo orientamento è ispirato a preoccupazioni general-preventive che riducono il principio
dell’affidamento più ad una enunciazione teorica che ad un criterio operante nella prassi).
Mancato impedimento del fatto doloso del terzo: nella misura in cui l’azione dolosa è frutto
di una libera scelta del soggetto che ne è autore, vale a maggior ragione in questo caso il
principio dell’autoresponsabilità, in base al quale ciascuno risponde delle proprie azioni
deliberate in modo libero e responsabile. Anche il principio dell’autoresponsabilità ha delle
134
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
eccezioni:
1. un primo limite si ha nei casi in cui un soggetto riveste una posizione di garanzia
avente a contenuto la difesa di un bene rispetto anche alle aggressioni dolose di terzi
che intendono minacciarla (come ad esempio per una guardia del corpo)
2. un secondo limite si ha in rapporto al controllo di fonti di pericolo che un terzo
potrebbe usare per commettere un illecito doloso, quando però particolari conoscenze
dell’agente o circostanze concrete siano tali da rendere particolarmente elevata la
probabilità che il terzo ne approfitti
NESSO DI RISCHIO TRA COLPA ED EVENTO
Nel reato colposo di evento il risultato lesivo è la conseguenza della condotta illecita, ed anche in
questo tipo di reato il nesso di causalità si accerta secondo la teoria condizionalistica.
Sul terreno della responsabilità colposa l’evento deve essere una conseguenza necessaria non tanto
della semplice azione materiale, quanto piuttosto di un’azione con specifiche caratteristiche, ossia
dell’azione che contrasta con il dovere oggettivo di diligenza: l’evento deve dunque apparire come una
concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire.
L’esigenza che l’evento sia riconducibile alla condotta come colposa può essere indicata con la formula
“nesso di rischio”, che significa che nell’evento lesivo deve concretizzarsi il pericolo che l’agente
avrebbe dovuto neutralizzare o ridurre con le cautele che ha invece omesso. È comunque lo stesso
codice, all’art. 43, ad esplicitare la causalità della colpa, poiché richiede che l’evento si verifichi “a
causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline”.
Questo nesso di rischio ha due implicazioni:
1. l’evento lesivo provocato dalla condotta colposa deve rientrare nello scopo di tutela perseguito
dalla regola cautelare violata, e deve ossia appartenente a quel tipo di eventi che la regola era
finalizzata a prevenire
2. il nesso di rischio induce contrattualmente a chiedersi come sarebbe andata se l’agente avesse
adottato la misura cautelare che doveva adottare, e ci si chiede dunque chiedere se,
rappresentandosi mentalmente il c.d. comportamento alternativo lecito imposto ex ante dalla
norma cautelare, questo comportamento, tenendo conto di tutte le particolarità del caso
concreto, sarebbe davvero risultato idoneo ad evitare che l’evento si verificasse. In questo
modo si può controllare l’efficacia preventiva concreta della regola cautelare, e se all’efficacia
astratta non si accompagna quella concreta, allora si deve concludere che manchi la causalità
della colpa.
Se si ritenesse invece che la responsabilità penale debba sussistere indipendentemente
dall’evitabilità concreta dell’evento, si ridimensionerebbe la distinzione tra la responsabilità per colpa
e la responsabilità obiettiva basata sulla mera causazione materiale dell’evento. Proprio affinché la
responsabilità colposa non diventi una forma di responsabilità oggettiva “occulta”, la dottrina più
avveduta e la giurisprudenza più recente tendono a valorizzare il requisito del nesso di rischio
concepito come evitabilità in concreto dell’evento quale presupposto fondamentale.
Un problema che rimane dibattuto è però quello che si chiede se il nesso di rischio o causalità della
colpa concepito come evitabilità in concreto dell’evento in virtù del comportamento alternativo lecito,
abbia a che fare con la categoria della causalità, con quella della colpa, o con entrambe. Ci si chiede
dunque se il nesso di rischio tra colpa ed evento, e dunque la responsabilità colposa, vadano esclusi
solo quando è certo o anche quando è probabile o meramente possibile che il comportamento
conforme alla regola preventiva sarebbe risultato inidoneo ad impedire l’evento.
Una parte della dottrina sostiene che la causalità in senso giuridico presupponga
immancabilmente l’evitabilità dell’evento mediante la condotta alternativa che il soggetto
avrebbe doverosamente dovuto realizzare al posto di quella illecito. Da ciò si fa derivare
l’implicazione che, per l’affermazione della responsabilità penale nell’ambito dei reati sia
commissivi che omissivi, occorre dimostrare con particolare rigore l’efficacia impeditiva del
135
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
comportamento alternativo lecito, ossia, supponendo che il dovere cautelare sia stato
adempiuto, ci si deve chiedere se quest’azione sarebbe valsa ad evitare il verificarsi dell’evento
con una probabilità vicina alla certezza (se non è così, deve valere il principio del in dubio pro
reo). L’obiezione che viene fatta a questo orientamento consiste nel fatto che non è così
scontato che sia opportuno e giusto privilegiare a tal punto le ragioni dell’imputato da
escludere la responsabilità colposa se è ipotizzabile che l’osservanza del dovere avrebbe avuto
probabilità di evitare l’evento.
Una parte tendenzialmente maggioritaria della dottrina contemporanea, dunque, esclude che
la problematica del comportamento alternativo lecito abbia a che fare con la causalità e si opta
piuttosto per un inquadramento della questione nell’ambito della colpa, per lo più in
combinazione con l’impiego del criterio dell’aumento o della mancata diminuzione del rischio.
A. Reati commissivi colposi: una volta verificato il nesso di causalità materiale tra
l’azione illecita e l’evento lesivo, per il giudizio di colpa si considera sufficiente
supporre che la condotta alternativa conforme al dovere cautelare avrebbe, se
realizzata, diminuito significativamente il rischio di verificazione dell’evento offensivo.
B. Reati omissivi colposi: alla causazione materiale dell’evento da parte dell’agente si
sostituisce una forma di causalità normativo-ipotetica, in termini di mancato
impedimento dell’evento da parte del soggetto garante, con la conseguenza che
accertamento della causalità e della colpa finiscono per coincidere, e dunque la teoria
del rischio finirebbe col rimpiazzare completamente una causalità materiale mancante,
con l’effetto di estendere l’area della punibilità. Per questo si ritiene che nei reati
omissivi colposi l’affermazione di responsabilità supponga la quasi certa idoneità della
condotta doverosa ad evitare l’evento, ma vi sono comunque autori che sono favorevoli
all’impiego della teoria del rischio anche per questo tipo di reati.
Tuttavia, la scelta di inquadramento dogmatico costituisce un tentativo di razionalizzazione postuma,
volta a giustificare soluzioni pregiudizialmente auspicate sul piano valutativo e politico-giuridico. Il
problema, quindi, non è l’inquadramento stesso, ma se sia giusto ed opportuno procedere
all’imputazione penalistica dell’evento sulla base di criteri quali l’aumento o la mancata diminuizione
del rischio.
ANTIGIURIDICITÀ
Anche nel reato colposo la tipicità funge da indizio rispetto all’antigiuridicità (intesa come assenza di
cause di giustificazione), per cui se si accerta l’esistenza di un’esimente, il fatto commesso non
costituisce reato. La dottrina italiana non ha dedicato particolare attenzione al problema delle cause di
giustificazione nel reato colposo, lasciando così quasi supporre che l’antigiuridicità obiettiva del fatto
tipico si atteggi allo stesso modo che nel reato doloso. Si può però ritenere che la diversità strutturale
tra i due tipi di illecito condizioni l’operatività delle cause di giustificazione in modo da non rendere
operabili nel reato colposo tutte le esimenti esistenti (la giurisprudenza ha infatti nella prassi teso ad
applicare soprattutto il consenso dell’avente diritto, la legittima difesa e lo stato di necessità).
CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO
La giurisprudenza prevalente tende ad escludere l’efficacia scriminante del consenso nei reati colposi,
sia a causa della natura dei beni della vita e dell’integrità fisica, sia a causa dell’incompatibilità tra il
consenso concepito come volontà di lesione (eccedente i limiti dell’art. 5 c.c.) e il carattere volontario
del reato colposo.
L’argomento che si basa sul l’indisponibilità degli interessi oggetto di tutela, benché efficace, non
vale a dimostrare una sorta di inconciliabilità di principio tra esimente del consenso e reato colposo,
ma dimostra solo che la tesi della compatibilità ha una portata pratica limitata dato lo scarso numero
di reati colposi che tutelano interessi indisponibili.
L’argomento che si basa invece sul contrasto tra volontà di lesione sottesa al consenso e
136
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
l’involontarietà dell’offesa sottesa alla colpa, si contesta ad esso il fatto che si può acconsentire ad
un’attività pericolosa, senza volere però che si verifichi il possibile evento lesivo, e per questo la
volontaria assunzione del rischio da parte del titolare del bene varrà a scagionare l’agente quando la
lesione che di fatto si verifica rientra nell’area di disponibilità riconosciuta dall’art. 5 c.c ,ex art. 50 c.p.
Non è infatti però che non si possa mai consentire all’esposizione a pericolo del bene della vita, infatti
l’obbligo di non esporre a rischio la vita altrui trova un limite nel riconoscimento del principio
dell’autodeterminazione responsabile.
Tradizionalmente, infatti, la scriminante del consenso ha esercitato un ruolo per circoscrivere la
responsabilità colposa nei due importanti settori dell’attività medica e dell’attività sportiva, ma la
dottrina oggi prevalente tende a ridimensionare la funzione scriminante del consenso, rinvenendo il
fondamento della liceità nell’art. 51, quali attività giuridicamente autorizzate. Di conseguenza, al
consenso rimane uno spazio residuale.
LEGITTIMA DIFESA
L’applicabilità della legittima difesa al reato colposo è contestata da una parte della giurisprudenza,
sostenendo che la legittima difesa presuppone la volontà di ledere l’aggressore, mentre nel reato
colposo manca la volontà dell’offesa. Tuttavia, questa tesi non convince, perché presuppone una
considerazione troppo meccanica dei dati, infatti entro lo spazio occupato dall’azione difensiva sembra
legittimo provocare anche un evento lesivo che l’altro agente non voleva e che avrebbe potuto evitare
con l’uso della dovuta diligenza. Sembrerebbe infatti irragionevole che l’ordinamento consentisse di
ledere volontariamente l’aggressore ma punisse le conseguenze involontarie di un’azione difensiva che
non mirava alla lesione dell’aggressore.
STATO DI NECESSITÀ
La configurabilità dello stato di necessità nel delitto colposo è generalmente ammessa in dottrina e
giurisprudenza. Lo stato di necessità, in realtà, ricorre soltanto quando l’azione necessitata viola il
dovere obiettivo di diligenza, mentre vi sono ipotesi in cui l’azione necessitata viola soltanto
apparentemente il dovere di diligenza. Se ad esempio il conducente di un bus frena bruscamente per
evitare di scontrarsi con un mezzo e provoca così delle lesioni ai passeggeri, il comportamento del
conducente è diretto a tutelare anche il bene della persona che ne risulta offesa, e in concreto realizza
dunque il migliore adempimento possibile del dovere generale di prudenza messo a garanzia della
sicurezza della circolazione, e si potrebbe considerare dunque quasi imposto da un limite logico al
rispetto della regola che è stata violata soltanto formalmente.
Non potrà dunque riconoscersi il diritto all’indennità fissato dall’art. 2045 c.c. quando il fatto tipico
viene a mancare per la conformità del comportamento necessitato alla regola precauzionale.
COLPEVOLEZZA
STRUTTURA PSICOLOGICA DELLA COLPA
Anche nel reato colposo la colpevolezza ha la funzione di racchiudere i presupposti dell’imputazione
soggettiva del fatto al soggetto agente. Il concetto di imputabilità e il problema sella coscienza
dell’illiceità non presentano caratteristiche fondamentalmente diverse da quelle discusse nell’ambito
del delitto doloso, per cui è sufficiente esaminare la struttura psicologica.
La colpa, dal punto di vista psicologico, presuppone l’assenza della volontà diretta a commettere il
fatto. I manuali distinguono solitamente tra:
Colpa propria: ossia la colpa tipica, quella caratterizzata dalla mancanza di volontà dell’evento
Colpa impropria: ossia un’ipotesi eccezionale, che si configura nonostante la volontà
dell’evento, come nei casi di eccesso colposo nelle cause di giustificazione, di erronea
supposizione colposa di una scriminante, e di errore di fatto determinato da colpa. La colpa
impropria sembra dare l’impressione di caratterizzare fatti dolosi trattati come se fossero
colposi, ma va invece sottolineato che essi sono strutturalmente colposi, infatti il dolo non si
può configurare per mancano coscienza e volontà del fatto tipico, data l’erronea
137
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
rappresentazione della realtà, inoltre all’agente si rimprovera non di avere voluto l’evento, ma
di averlo provocato per negligenza o imperizia.
Quanto all’elemento conoscitivo,va notato che la colpa è compatibile con la previsione dell’evento (art.
43 comma 3), infatti si definisce colpa cosciente o colpa con previsione quella presente nelle ipotesi
in cui il soggetto non vuole commette l’illecito ma si è comunque rappresentato l’evento come
possibile conseguenza della sua condotta.
Nella maggior parte dei casi la colpa è però colpa incosciente, e questo significa che il soggetto non si
rende conto di potere ledere o mettere in pericolo beni giuridici altrui con la propria condotta, e per
questo all’agente si rimprovera di non avere prestato sufficiente attenzione alla situazione pericolosa.
In realtà la gran parte dei casi di colpa inconsapevole difetta di coscienza e volontà come coefficienti
psicologici reali, dal momento che molti sono i casi di azioni impulsive o automatiche, o omissioni
dovute a mera dimenticanza. La struttura della colpa incosciente finisce così col non essere costituita
da componenti psicologiche in senso stretto, e il giudizio di imputazione diventa in questo modo di
natura schiettamente normativa e l’accertamento della colpa tende a coincidere con la possibilità di
muovere al soggetto un rimprovero per non avere osservato le norme di comportamento necessarie a
prevenire la lesione dei beni giuridici.
Se le cose stanno così, la funzione specifica della categoria della colpevolezza, che consiste
nell’esprimere il legame personalistico tra fatto e autore, rischia di venire meno nel reato colposo, e
dunque di far tendere la responsabilità ad assumere una dimensione troppo oggettivistica. Questo
spiega perché la dottrina più sensibile proponga di limitare l’ambito di rilevanza penale della colpa
incosciente, tanto che alcuni ne suggeriscono addirittura la depenalizzazione.
LA MISURA “SOGGETTIVA” DEL DOVERE DI DILIGENZA
Da quello che si è detto si capisce quanto siano importanti gli sforzi di parte della dottrina, che cerca di
personalizzare il più possibile il giudizio di colpa con l’introduzione di una doppia misura del dovere
di diligenza: dopo avere verificato in sede di tipicità la violazione del dovere obiettivo di diligenza
sulla base del “homo eiusdem condicionis et professionis”, il rimprovero di colpevolezza viene fatto
dipendere dall’accertamento dell’attitudine del soggetto che ha in concreto agito ad uniformare il suo
comportamento alla regola di condotta violata, sulla base della misura soggettiva, ossia del livello
individuale di capacità, esperienza e conoscenza dell’agente.
Tale criterio oggettivo (homo eiusdem condicionis et professionis) è stato escogitato per rimediare agli
inconvenienti di una determinazione troppo generale ed astratta del dovere di diligenza,
specificandone il contenuto e la misura in rapporto alla cerchia sociale di appartenenza dell’agente
concreto. Bisogna tuttavia stabilire fino a che punto possa giungere l’esigenza di personalizzazione del
rimprovero di colpa, infatti se si pretendesse di tenere conto di tutte le caratteristiche personali
dell’agente concreto, si finirebbe col giustificare ogni azione colposa, perché saremmo portati a
concludere che un altro comportamento non fosse esigibile, ma in questo modo si rinuncerebbe alle
esigenze di prevenzione sul terreno della responsabilità colposa.
Si comprende allora come in sede di personalizzazione del giudizio di colpa si debbano comunque
astrarre alcune caratteristiche dell’agente concreto, e in questo modo si assume come punto di
riferimento un soggetto ideale. Dunque anche il giudizio più personalizzato non può rinunciare
rinunciare ad un certo, seppur minimo, grado di oggettivizzazione o generalizzazione.
L’oggetto della disputa che divide oggettivisti e soggettivisti riguarda lo stabilire se, per il giudizio di
colpa, rilevino non tratti caratteriali o disposizioni emotive come indifferenza, insensibilità, ecc., ma
piuttosto le caratteristiche fisiche e/o intellettuali come difetti, menomazioni o cattive condizioni di
salute, livello di scolarizzazione e socializzazione, conoscenze ed esperienze.
La scelta a favore o contro questa inclusione viene influenzata da opzioni o di fondo sul peso rispettivo
da assegnare al principio di colpevolezza o alle esigenze di prevenzione generale:
se infatti si privilegiano le esigenze general-preventive, è maggiormente coerente
l’oggettivizzazione del giudizio di colpa sino al punto di presumere dalla considerazione dei
138
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
limiti fisico-intellettuali dell’agente concreto. Se venissero invece bilanciate equilibratamente
la difesa sociale e il principio di colpevolezza, allora sarebbe giusto evitare che si risponda
penalmente al di là dei limiti fisico-intellettuali di ciascuno.
L’orientamento più diffuso è però quello che propende per una concezione normativo-
oggettivizzante della colpa penale, e per questo la nostra giurisprudenza non affronta quasi
mai esplicitamente il profilo della misura soggettiva della colpa, ma i giudici finiscono in questo
modo col circoscrivere la loro attenzione ai soli profili di tipicità e antigiuridicità della colpa,
trascurando il versante della colpevolezza colposa.
Si rischia però così di appiattire la responsabilità colposa su una sostanziale forma di
responsabilità obiettiva, ed è quindi apprezzabile la nuova sensibilità che qualche giudice sta
dimostrando nei confronti dell’esigenza di una maggiore valorizzazione giurisprudenziale, in
prospettiva futura, degli aspetti più soggettivi della colpa, ma in realtà la cosa più auspicabile
sarebbe un profondo mutamento culturale della giurisprudenza.
IL GRADO DELLA COLPA
L’art. 133, tra gli indici di commisurazione della pena, menziona il grado della colpa, e dunque è il
legislatore stesso ad ammettere una graduazione della colpa, senza esplicitare però criteri con cui
effettuarla. Inoltre, le tradizionali distinzioni civilistiche riguardanti i gradi della colpa non sono
automaticamente applicabili al penale, l’imputazione della colpa civile persegue obiettivi differenti dal
rimprovero penale.
Se, dunque, la colpa consiste nella violazione del dovere obiettivo di diligenza, eventualmente
commisurata alla stregua del personale potere di agire dell’agente concreto, allora per stabilire la
gravità della colpa sarà necessario accertare la misura di divergenza tra la condotta effettivamente
tenuta e il comportamento da tenere in base alla norma cautelare che bisognava seguire nel caso di
specie. Per questa valutazione si utilizzerà un criterio oggettivo, per accertare quando il
comportamento concreto si allontani dallo standard oggettivo di diligenza richiesta, e un criterio
soggettivo, per verificare le cause soggettive che hanno fatto sì che l’agente concreto non osservasse
la misura prescritta di diligenza.
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA
L’adesione alla concezione normativa della colpevolezza impone di tenere conto delle circostanze
anormali concomitanti all’agire anche in questo ambito, e, anzi, è a maggior ragione nei reati colposi
che questi circostanze possono arrivare a decidere della punibilità di un illecito, poiché l’adempimento
di un dovere oggettivo di diligenza presuppone che l’agente abbia certe attitudini psico-fisiche che
possono subire una menomazione in presenza di particolari circostanze con effetti sul processo
volitivo.
Una parte della dottrina è dell’opinione che il legislatore del ’30 sia venuto incontro all’esigenza di
un’espressa tipizzazione legislativa dell’efficacia scusante delle circostanze anormali, più di quanto
non sia avvenuto in altri ordinamenti. Alcuni autori leggono dunque in questa prospettiva gli articoli
sul caso fortuito, sulla forza maggiore (art. 45 c.p.) e sul costringimento fisico (art. 46 c.p.),
considerandole ipotesi legislativamente previste di circostanze anormali che impediscono all’agente di
conformare il suo comportamento alla regola obiettiva di diligenza da osservare nel caso concreto.
Poiché queste circostanze anormali sono previste dal codice, il giudice è comunque costretto a tenerne
conto, mentre più importante è esaminare la rilevanza pratica delle circostanze anormali non tipizzate
(es. stanchezza eccessiva, terrore, ecc.), che possono comunque inibire le capacità psicofisiche
dell’agente incidendo sulla normalità del processo volitivo.
Nel nostro ordinamento la rilevanza scusante delle situazioni non tipizzate si può desumere da
un’avveduta interpretazione dell’art. 42 comma 1 c.p., che dispone che “nessuno può essere punito
per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e
139
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
volontà”. Questa disposizione è idonea a fungere da clausola generale che ricomprende tutte le
circostanze anormali non tipizzate o innominate.
La possibilità di valorizzare l’efficacia scusante delle circostanze anomale implica anche una crescente
attenzione alla prassi, così da enucleare le situazioni e circostanze che, in ogni attività, sono solite
incidere più tipicamente o più ricorrentemente sul potere di agire dei soggetti con doveri cautelari.
LA COOPERAZIONE COLPOSA
LA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ART. 113 C.P.
L’art. 113 c.p. dispone che “nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione
di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso; la pena è aumentata
per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art.
111 e nei numeri 3 e 4 dell’art. 112”. Il legislatore si è in questo modo preoccupato di differenziare il
concorso di persone nel reato doloso da quello nel reato colposo, definendo quest’ultimo
cooperazione colposa.
Con questo articolo si è voluto porre fine alla disputa dottrinale coeva al codice che discuteva
sull’ammissibilità di una compartecipazione criminosa nel rato colposo, contro la quale si schierava chi
sosteneva che vi fosse incompatibilità tra il carattere involontario della colpa e il previo accordo, il
quale era allora considerato elemento necessario del concorso.
A seguito dell’introduzione di questo articolo la dottrina si è dunque concentrata sui criteri atti a
distinguere la cooperazione colposa dal concorso di cause colpose indipendenti. Nella dottrina
tradizionale l’orientamento dominante era quello che sosteneva che la cooperazione colposa si
distinguesse dal concorso di cause autonome per l’esistenza di un legame psicologico tra gli agenti.
Tuttavia, all’interno di questa posizione alcuni autori sostengono che sia sufficiente che il legame
psicologico consista nella consapevolezza di collaborare con la propria condotta all’azione materiale
altrui, sempre in assenza della volontà di cagionare l’evento lesivo, mentre altri sostengono invece che
sia necessaria l’ulteriore consapevolezza del carattere colposo della condotta altrui. In ogni caso,
proprio questa consapevolezza di collaborare varrebbe a fare incriminare una condotta di
cooperazione che in sé potrebbe non contrastare direttamente una regola cautelare, e che riceve
invece qualifica colposa soltanto per riflesso della negligenza, imprudenza o imperizia altrui, cui ci si
limita a volontariamente aderire.
L’art. 113 c.p. assolverebbe così, oltre ad una funzione di disciplina, anche ad una funzione
incriminatrice, poiché servirebbe ad attribuire rilevanza penale a comportamenti colposi atipici
rispetto alle fattispecie monosoggettive di parte speciale, che non sono punibili senza una norma ad
hoc estensiva della punibilità. Questa impostazione riceve diversi ordini di obiezioni, tra le quali il fatto
che non è chiaro perché la semplice consapevolezza di concorrere con altri sia sufficiente a
incriminare una condotta che in sé considerata si ritiene lecita. Inoltre, il privilegio dato all’elemento
psicologico come requisito delle condotte di cooperazione, implica una sfasatura tra l’elaborazione
dell’istituto in esame e la più recente evoluzione della teoria della colpa penale, poiché il concetto di
colpa è normativo, e la violazione del dovere soggettivo di diligenza rileva già sul piano della tipicità
del fato colposo. Ne consegue dunque che la colposità delle singole condotte di cooperazione deve
essere accertata già nell’ambito dell’elemento materiale, ossia un terreno che precede quello
dell’elemento psicologico. Inoltre, se si esigesse che il concorrente atipico fosse consapevole della
colposità della condotta dell’autore principale, allora si potrebbe obiettare che l’art. 113 finirebbe per
operare solo nell’ambito della colpa cosciente.
Valorizzando invece la struttura prettamente normativa della colpa ci si accorge che la supposta
funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p. può fortemente essere messa in dubbio in relazione alla
categoria degli illeciti causalmente orientati, in cui la condotta è penalmente rilevante innanzitutto
per il fatto di contribuire direttamente o indirettamente alla produzione dell’evento. Nel delitto
causalmente orientato colposo, la condotta sarà tipica se si porrà anche in contrasto con il dover
obiettivo di diligenza, e ne deriva dunque che in presenza di queste condizioni l’istituto della
cooperazione può apparire superfluo, poiché ciascun fatto causalmente orientato è punibile alla
140
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
stregua della norma incriminatrice di parte speciale incentrata sull’autore singolo.
Si può dunque dire che l’art. 113, rispetto alle fattispecie causalmente orientate o causali pure,
possiede solo la funzione di sottoporre le eventuali ipotesi di collaborazione ad un regime penale
differente rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione delle fattispecie monosoggettive di parte
speciale.
Recentemente sono però state addotte nuove argomentazioni per recuperare la funzione
incriminatrice dell’art. 113 c.p. anche nell’ambito di questi illeciti, ed è stato quindi asserito che
sarebbero ipotizzabili comportamenti che, seppure causalmente rilevante rispetto alla produzione
dell’evento e seppure in contrasto con obblighi di natura cautelare, non risulterebbero tipici rispetto
alle fattispecie monosoggettive colpose di parte speciale. Si sostiene che questi comportamenti atipici
di cooperazione contrastino con obblighi cautelari di natura secondaria, ossia obblighi che hanno ad
oggetto il comportamento altrui, “nel senso che impongono di verificare, controllare, impedire
eventuali attività colpose da parte di terzi” direttamente produttive dell’evento lesivo; sarebbe dunque
nell’ambito della violazione di obblighi cautelari secondari che l’art. 113 manterrebbe una funzione
incriminatrice di comportamenti non altrimenti punibili, anche nell’ambito dei reati causalmente
orientati.
Non risulta tuttavia convincente neppure questa impostazione, poiché finisce paradossalmente per
confermare la validità dell’assunto che invece pretenderebbe di confutare, in quanto il rimprovero
penale si riferisce ad un’omissione di controllo o sorveglianza che ha l’effetto di non impedire il reato
del terzo, che andava invece impedito, e ricorre per questo lo schema del reato omissivo improprio
colposo, il quale è un modello direttamente riconducibile alla fattispecie monosoggettiva di parte
speciale, senza che al riguardo muti qualcosa a seconda che l’obbligo di condotta disatteso abbia a
contenuto il diretto impedimento dell’evento lesivo o l’impedimento di una condotta altrui che causa
l’evento da evitare.
Se l’art. 113 c.p. ha una funzione incriminatrice, essa va dunque riferita alle sole fattispecie colpose a
forma vincolata, ossia quelle che reprimono un’offesa realizzata soltanto con specifiche modalità
comportamentali. In tutti i casi in cui la condotta colposa è puntualmente tipizzata dal legislatore, un
semplice comportamento di collaborazione non corrisponda a ciò che il legislatore ha puntualmente
previsto, risulterebbe penalmente irrilevante, ma diventa invece rilevante, se sussistono tutti i
requisiti richiesti, proprio in virtù dell’art. 113, che, in questi casi, svolge una funzione incriminatrice
oltre a quella di disciplina.
Da un punto di vista politico-criminale, questo meccanismo di estensione della tipicità si rivela però di
dubbia opportunità, infatti se il legislatore per la tutela di determinati beni ha preferito ricorrere alla
creazione di fattispecie a forma vincolata, questo significa che ha inteso tutelarsi non ad oltranza
contro ogni possibile offesa, ma in maniera frammentaria, ossia soltanto contro le specifiche modalità
di offesa specificate nelle norma, e l’effetto predetto dell’art. 113 finirebbe perciò col comportare una
“deviazione teleologica”.
Nella dottrina più recente sono comunque tornate ad emergere varie critiche nei confronti della
plausibilità politico-criminale di una disposizione come quella dell’art. 113, considerata sia nella sua
funzione di disciplina che nella sua limitata funzione incriminatrice.
141
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE QUARTA
REATO OMISSIVO
Il modello tipico di illecito penale è tradizionalmente il reato di azione. Per buona parte dell’Ottocento,
in coerenza con la predominante ideologia individualistico-liberale, la responsabilità per omissione
costituiva l’eccezione, e non poteva essere diversamente dal momento che presupponeva l’affermarsi
del diverso principio solidaristico. Questo ruolo secondario assegnato alla responsabilità omissiva
spiega anche perché la dottrina abbia sensibilmente tardato nel procedere all’elaborazione di
un’autonoma dogmatica degli illeciti omissivi, infatti solo nei primi decenni del ’900 per assistere ad
un’autentica nascita di interesse della dottrina italiana per il tema dell’illecito omissivo. Il primo che
comincia ad essere fatto oggetto di trattazione monografica è il reato omissivo improprio, il quale è la
figura più problematica di illecito di omissione, mentre dagli anni ’30 in poi l’interesse comincia a
vertere anche sul reato omissivo proprio.
Questo interesse per gli illeciti di omissione nasce anche dal progressivo incremento degli obblighi di
agire dotati di rilevanza penale avvenuto tra ’800 e ’900, e che tenderanno ad aumentare
ulteriormente dal secondo dopoguerra in poi (non a caso la dottrina italiana torna ad impegnarsi negli
anni ’50 del tema della responsabilità per omissione, anche se in una prospettiva più dogmatica,
trascurando i problemi politico-criminali).
La prospettiva dogmatica e quella politico-criminale si ricongiungeranno invece nella successiva fase
di elaborazione della materia avvenuta negli ultimi decenni, infatti i nuovi approcci mostrano da un
lato una maggiore consapevolezza della necessità di sviluppare un’autonoma dogmatica dei reati
omissivi, e dall’altro dedicano particolare attenzione al problema della responsabilità penale per
omesso impedimento dell’evento, non solo sotto il profilo delle condizioni che giustificano
l’equiparazione tra il cagionare e il non impedire un evento lesivo, ma anche dal punto di vista della
possibilità di utilizzare questa forma di responsabilità come moderno strumento di politica criminale.
DIRITTO PENALE DELL’OMISSIONE E BENE GIURIDICO
Il ricorso sempre più frequente ai reati omissivi propri per soddisfare finalità di natura collettivo-
solidaristica ha sollevato il problema politico-criminale della compatibilità tra la punibilità delle
omissioni e l’idea della protezione dei beni giuridici. Il diritto penale dell’omissione tenderebbe infatti
a promuovere il benessere collettivo, e dunque da questo punto di vista le fattispecie omissive proprie
costituirebbero lo strumento tecnico-legislativo privilegiato per realizzare la funzione “propulsiva” del
diritto penale (verso la quale si possono manifestare ampie riserve critiche).
Si comprende dunque perché una parte della dottrina propenda per degradare il reato omissivo puro
ad illecito di pura disobbedienza, tanto che alcuni sostengono, quasi analogamente, che l’illecito
omissivo proprio non leda un bene giuridico, ma piuttosto non produca un bene o un’utilità futura (e
debba quindi trasformarsi da illecito di pura omissione ad illecito amministrativo).
Va tuttavia notato che questo orientamento opera un’errata generalizzazione, poiché esaminando
approfonditamente l’attuale realtà normativa si possono distinguere ipotesi di pura disobbedienza, e
ipotesi in cui la fattispecie omissiva è posta a tutela di qualcosa di assimilabile al concetto di bene
giuridico (es. beni di prestazione in cui il bene protetto è l’interesse al conseguimento di utilità future).
LA BIPARTIZIONE DEI REATI OMISSIVI IN “PROPRI” E “IMPROPRI”
Per distinguere i reati omissivi propri (o puri) e i reati omissivi impropri (o impuri), o commissivi
mediante omissione, si possono adottare criteri diversi, tra i quali il più tradizionale si basa sulla
necessità della presenza o meno di un evento come requisito strutturale del fatto di reato.
Secondo questo criterio:
sono propri i delitti omissivi che consistono nel mancato adempimento di un’azione che la
legge penale ordina di realizzare, e dunque quello che viene rimproverato non è l’avere
impedito che si verificasse un eventuale evento dannoso, ma il non avere compiuto l’azione
doverosa (es. omissione di soccorso)
142
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
sono impropri gli illeciti omissivi che consistono nella violazione dell’obbligo di impedire il
verificarsi di un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva-base, ed in questi casi,
dunque, l’omittente assume il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto
Per rimanere fedeli all’origine storica della categoria dogmatica del reato omissivo improprio
andrebbe attribuita rilevanza decisiva non sono alla presenza di un evento nella sua struttura,
quando invece al fatto che questo tipo delittuoso non ha una previsione legislativa espressa
(infatti questa fattispecie risulta dalla combinazione della clausola generale dell’art. 40 cpv. e
delle norme di parte speciale direttamente incentrate su un reato di azione e trasformate in
fattispecie omissive mediante l’interpretazione giudiziale). Emerge da qui la problematica
estranea alle poche ipotesi di omesso impedimento di un evento espressamente disciplinate
dal legislatore penale, come ad esempio la fattispecie del mancato impedimento di strepiti di
animali dell’art. 659 c.p.
Pare comunque preferibile operare la distinzione tra reati omissivi propri e impropri in funzione della
diversa tecnica di tipizzazione, ritenendo cioè reati omissivi proprio quelli direttamente configurati
come tali dal legislatore, e impropri quelli che non sono previsti espressamente e sono invece ricavati
dalla conversione di fattispecie che erano state create per incriminare comportamenti positivi.
LA FATTISPECIE OBIETTIVA DEL REATO OMISSIVO PROPRIO
SITUAZIONE TIPICA
Gli elementi costitutivi della fattispecie omissiva propria sono fissati dal legislatore, e il primo di essi è
la situazione tipica, ossia l’insieme dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di attivarsi (ad
esempio nell’omissione di soccorso la situazione tipica è la condizione di pericolo del soggetto da
soccorrere). La norma incriminatrice, nel descrivere la situazione tipica, indica anche il fine cui deve
tendere il compimento dell’azione comandata, fine espresso in forma specifica (art. 365 “fare referto”)
o in forma generica (art. 593 “prestare l’assistenza occorrente”).
Nella descrizione legislativa della situazione tipica, così come nei reati di azione, possono esservi
elementi descrittivi (rinviano alla realtà naturalistica) o elementi normativi giuridici, ma è andata
sempre aumentando la tendenza ad impiegare questa seconda tecnica normativa, e i reati omissivi
propri hanno sempre più perso un’immediata connessione con la comune realtà naturale e sociale.
Nasce di qui una certa artificiosità dell’illecito omissivo proprio, e si è posto in questo modo ancora
più acutamente il problema se il dolo sia configurabile a prescindere dalla previa conoscenza della
norma che fa obbligo di agire in un determinato modo.
Le fattispecie omissive proprie, proprio con riferimento alla problematica sull’oggetto della volontà
colpevole, possono essere distinte a seconda che la situazione tipica sia:
Pregnante: nel cui caso l’obbligo di attivarsi ha per presupposto una realtà naturalistica o
sociale immediatamente percepibile dal soggetto a prescindere dalla conoscenza dell’obbligo
giuridico di agire
Neutra: nel cui caso è difficile che il soggetto possa capire di trovarsi nella situazione che lo
obbliga ad attivarsi in un certo modo se egli non conosce o non sospetta dell’esistenza dello
specifico obbligo giuridico di agire
CONDOTTA OMISSIVA TIPICA E POSSIBILITÀ DI AGIRE
Un’altra componente fondamentale del reato omissivo proprio è la condotta omissiva.
L’orientamento dottrinale dominante è quello che propende per l’accoglimento della teoria
normativa, secondo la quale l’omissione di può definire come non compimento di una determinata
azione che era invece da attendersi in base ad una norma.
Nell’illecito omissivo proprio è condotta omissiva tipica quella che consiste nel mancato compimento
dell’azione richiesta in presenza della situazione conforme alla fattispecie incriminatrice. Per potere
143
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
compiere l’azione comandata si deve però presupporre che il soggetto abbia la “possibilità di agire”,
che in questo ambito va intesa nel senso minimo di possibilità materiale di adempiere al comando, la
quale potrebbe escludersi per mancanza delle necessarie attitudini psico-fisiche o delle condizioni
esterne indispensabili per compiere l’azione doverosa. Dovrà invece tenersi conto in sede di
colpevolezza degli altri elementi che entrano a fare parte della possibilità di agire intesa in un senso
più ampio, che ricomprenda anche le capacità intellettive.
Va comunque precisato che se il soggetto si è seriamente impegnato nell’adempiere l’obbligo di agire
ma non è riuscito a soddisfarlo a causa di circostanze esterne, allora il reato viene meno.
Se, inoltre, i doveri di agire incombono su più soggetti e non presuppongono necessariamente un
adempimento personale, allora l’attivarsi di uno dei soggetti può fare venire meno i presupposti della
situazione tipica, rendendo penalmente irrilevante l’omissione degli altri.
LA FATTISPECIE OBIETTIVA DEL REATO OMISSIVO IMPROPRIO
AUTONOMIA DELLA FATTISPECIE OMISSIVA IMPROPRIA E PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Il reato omissivo improprio contravviene all’obbligo di impedire il verificarsi di un evento lesivo, il
quale è un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva, ossia creata originariamente per
incriminare un fatto incentrato su un comportamento positivo. Questo tipo di reati vengono anche
detti reati commissivi mediante omissione perché si considera che i casi di mancato impedimento
di un evento tipico non integrino un vero e proprio illecito di omissione, ma costituiscano piuttosto
una manifestazione dei reati commissivi espressamente tipizzati dal legislatore (ad esempio il codice
incrimina “chiunque cagiona la morte di un uomo”, ma in alcuni casi si ritiene che anche lasciare che
qualcun altro cagioni la morte di un uomo sia incriminabile perché comporta un eguale disvalore).
Secondo l’impostazione più tradizionale, quindi, i reati omissivi impropri violerebbero il divieto di
cagionare l’evento che dà vita alla fattispecie commissiva.
La maggior parte delle legislazioni non hanno sinora disciplinato espressamente nella parte speciale
del codice la materia delle omissioni improprie, spesso per il convincimento che il legislatore non sia
in grado di prevedere una volta per tutte i molteplici e mutevoli casi di equivalenza tra azione causale
ed omissione non impeditiva. Per questo motivo anche il codice penale italiano si limita a
regolamentare l’illecito omissivo improprio solo nella parte generale con la previsione di una clausola
generale di equivalenza all’art. 40 cpv., che dispone che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. L’interprete deve perciò ricostruire il reato omissivo
improprio in base all’innesto della disposizione dell’art. 40 cpv. sulle norme di parte speciale che
prevedono le ipotesi di reato commissivo, e sorge così una nuova fattispecie incentrata sul mancato
impedimento dell’evento.
Questa nuova fattispecie non è però una manifestazione della fattispecie commissiva espressamente
prevista (come sostiene l’impostazione tradizionale), ma è una fattispecie autonoma, dal momento
che essa, poiché incrimina l’inosservanza dell’obbligo di impedire l’evento, non può che imperniarsi su
una norma di comando, e non di divieto. Riconoscendo l’autonomia del reato omissivo improprio si
sollevano però dei dubbi sulla compatibilità di questo modello di illecito con i principi di legalità e
sufficiente determinatezza della fattispecie. È infatti il giudice che deve ricostruire la maggior parte
degli elementi di cui si compone la nuova e autonoma fattispecie omissiva impropria. La tensione
conflittuale tra la punibilità delle omissioni improprie e il rispetto del principio di legalità, inevitabile a
causa del carattere di clausola generale della forma dell’art. 40 cpv., è inoltre maggiormente aggravata
dall’inidoneità di questa formula a fornire una direttiva-guida sicura ed efficace all’interprete.
Se si vuole evitare che l’individuazione del confine tra punibile e non punibile in questo ambito
rimanga affidata alla giurisprudenza, allora non rimane che smettere di pensare che il legislatore non
sia in grado di prevedere nella parte speciale tutte le ipotesi di omesso impedimento dell’evento
meritevoli di sanzione penale. Infatti è comunque possibile che vi siano lacune, ma questo è accettabile
anche per il fatto che il diritto penale è per sua natura frammentario, e la sua frammentarietà è spesso
un costo imposto proprio dall’esigenza di rendere il più possibile compatibili controllo penale e
144
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
principio di legalità.
LA SFERA DI OPERATIVITÀ DELL’ART. 40 CPV. C.P.
L’art. 40 cpv. stabilendo una regola di equivalenza tra il non impedire un evento che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, e il cagionarlo, estende la punibilità, ma bisogna verificare se la regola è
davvero generale o va limitata ad alcuni tipi di reato.
Nonostante questo significhi estendere indiscriminatamente e ipertroficamente la punibilità, alcuni
vedono questa regola come regola generale, ma in realtà un primo confine si può tracciare se si tiene
conto del fatto che l’art. 40 cpv. serve a giustificare l’incriminazione di alcuni comportamenti
omissivi non espressamente tipizzati nelle fattispecie speciali. Di conseguenza, da ciò deriva infatti
che l’impiego di questa disposizione viene escluso quando la stessa norma incriminatrice menziona la
condotta omissiva o in via esclusiva o accanto all’azione in senso stretto. Occorre tuttavia selezionare i
tipi legali la cui struttura ostacola una loro integrazione mediante inattività, come ad esempio:
Delitti di mano propria: che presuppongono un atto positivo di carattere necessariamente
personale
Reati abituali: che presuppongono una determinata condotta di vita risultante da una
reiterazione di comportamenti positivi
Reati che presuppongono una condotta caratterizzata da note descrittive necessariamente
inerenti ad un comportamento positivo
La norma incriminatrice, talvolta, impernia tutta la formulazione del fatto su concetti normativi, e in
questi casi per stabilire se assuma rilevanza la condotta omissiva non sarà necessario richiamare l’art.
40 cpv., ma si dovrà avere riguardo al contenuto degli obblighi comportamentali desumibili dalle
norme di condotta richiamate dagli elementi normativi contenuti nella norma incriminatrice. Si scopre
dunque che vi sono fattispecie indifferentemente realizzabili con azione od omissione, e questo si
spiega considerando che a fondamento dell’incriminazione in questi casi vi è la violazione di obblighi
comportamentali che si riconnettono al ruolo sociale disimpegnato da un determinato soggetto.
Bisogna dunque delimitare positivamente l’area di operatività della fattispecie omissiva impropria, e a
questo scopo è utile l’indicazione desumibile dalla circostanza che la norma dell’art. 40 cpv. si trova
inserita nella rubrica del “rapporto di causalità”. La connessione operata dal legislatore tra regola
dell’equivalente e problema causale si presta infatti a valere come indice a favore di una determinata
delimitazione dell’ambito operativo della fattispecie omissiva impropria, nel senso che il campo
d’azione della fattispecie considerata va limitato ai casi in cui affiora un problema del nesso causale tra
condotta ed evento lesivo, e si tratta cioè del riconoscimento a livello positivo che la regola di cui
all’art. 40 cpv. è applicabile soltanto ai reati di evento. Per delimitare in maniera ancora più puntuale la
sfera di operatività del principio di conversione della fattispecie commissiva-base in fattispecie
omissiva impropria, occorre però anche scartare dai reati di evento quelli caratterizzati da elementi
strutturali che possono accedere soltanto ad una condotta positiva, evidenziandone le caratteristiche
fenomeniche o atteggiandosi a modalità ulteriori che accompagnano l’azione.
Dunque, come specifico campo d’azione della regola dell’equivalenza ex art. 40 cpv. residua in realtà
quello dei reati causali puri, ossia quei reati di evento il cui disvalore si concentra nella produzione
della lesione, mentre sembrano indifferenti le specifiche modalità comportamentali che innescano il
processo causale. L’ambito dei reati di evento caratterizzati dalla semplice attitudine causale della
condotta tende prevalentemente a circoscriversi attorno alle due ipotesi tipiche dei classici delitti
contro la vita e incolumità individuale, e di determinati reati contro l’incolumità pubblica. Si tratta cioè
di fattispecie penali finalizzate alla protezione della persona umana contro le aggressioni ai beni della
vita e dell’integrità fisica.
Non è però da escludere che nel codice siano rinvenibili altri esempi di reati causali puri a tutela di
beni diversi dalla protezione della persona umana contro le aggressioni ai beni della vita e
dell’integrità fisica. Si può ad esempio dubitare che rientri in questa categoria il delitto di
danneggiamento ex art. 635 c.p., infatti azione ed omissione in questo delitto possono equivalersi o no
145
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
a seconda che la dispersione, il deterioramento e l’insolvibilità si considerino come modalità di
realizzazione del fatto legate ad una specifica forma di condotta o indifferentemente riconducibili ad
una condotta tanto attiva che omissiva.
La mancanza di un’espressa disciplina legislativa che circoscriva l’ambito dei beni o interessi suscettivi
di essere tutelati con il ricorso ad una forma di responsabilità in esame suscita perplessità anche
riguardo dal concorso mediante omissione ad un reato materialmente commesso ad altri. Dottrina e
giurisprudenza sono prevalente d’accordo sull’intendere per “evento” ex 40 cpv. nell’ambito della
partecipazione delittuosa il reato oggetto di volontà comune materialmente posto in essere da uno dei
compartecipi e non impedito da chi tra essi aveva l’obbligo di impedirlo. Si ritiene però per lo più che
per questa equivalenza evento-reato non impedito non operi il limite dell’applicabilità dell’art. 40 cpv.
ai soli reati causali puri.
Tuttavia vi è anche chi pensa che in questo modo si assegni alla regola dell’equivalenza contenuta
nell’art. 40 cpv. un ambito di operatività talvolta più ristretto e talvolta più lato a seconda che si tratti
di responsabilità omissiva monosoggettiva o in concorso. È però soprattutto da sottolineare come a
questo diverso ambito di operatività finisca col corrispondere una diversa estensione dei beni
assumibili ad oggetto di una più rafforzata tutela. Non possono comunque non sorgere delle
perplessità in proposito, poiché si muove dalla premessa che possano esistere esigenze di tutela che
giustificano la più ampia applicazione dell’art. 40 cpv.; in mancanza però di un’espressa presa di
posizione legislativa a riguardo sembra altrettanto legittima la tesi secondo cui la limitazione del
giudizio di equivalenza alle sole fattispecie casuali pure dovrebbe trovare applicazione anche nei casi
di concorso mediante omissione.
Si potrebbero superare queste incertezze se il legislatore indicasse i settori di operatività della
responsabilità per omesso impedimento dell’evento.
SITUAZIONE TIPICA
La fattispecie obiettiva del reato omissivo improprio ricomprende innanzitutto la situazione tipica
intesa come il complesso dei presupposti di fatto che danno vita ad una situazione di pericolo per il
bene da proteggere, e che rendono dunque attuale l’obbligo di attivarsi del garante.
Manca però una previsione legale espressa di tutte le componenti costitutive del reato omissivo
improprio, e per questo il contenuto e lo scopo del dovere di agire del garante possono specificarsi
solo in rapporto alle circostanze del caso concreto.
OMESSO IMPEDIMENTO DELL’EVENTO ED EQUIVALENTE NORMATIVO DELLA CAUSALITÀ
Ulteriori elementi costitutivi del delitto omissivo improprio sono la condotta omissiva di mancato
impedimento e l’evento non impedito. Per ritenere responsabile l’omittente per l’evento verificatosi
bisogna dimostrare che esiste una connessione tra l’evento e la condotta omissiva, ma ci si chiede
allora quale sia la natura del rapporto tra mancato compimento dell’azione impeditiva ed evento
lesivo.
Una parte della dottrina ha a questo proposito insistito nel vecchio sforzo di dimostrare che anche il
“non impedire" sia una categoria realistica della causalità. Questo sforzo è più di recente sfociato
nell’assunto che la vera causa dell’evento non è il non fare, ma l’aliud factum, nel senso che il
comportamento effettivamente tenuto risulterebbe doppiamente impeditivo, poiché impedirebbe
l’azione cui il soggetto obbligato era tenuto, che, se compiuta, avrebbe a sua volta impedito l’evento.
Neanche questo tentativo risulta però convincente, infatti se si sostiene ad esempio che la mancata
manovra degli scambi è causa del deragliamento in quanto l’azione contraria lo avrebbe impedito, il
ragionamento torna a fare leva su dati ipotetici e non più reali.
La realtà è che l’art. 40 comma 1 va letto in rapporto al comma 2, che stabilisce che “non impedire un
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. La dottrina dominante nega per
questo che nei reati omissivi sia dato riscontrare un rapporto di causalità eguale a quello esistente nei
reati di evento commessi mediante azione. Nei reati omissivi per determinare il nesso omissione-
146
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
evento quello che si emette è infatti un giudizio ipotetico o prognostico, per il quale il giudice non
potrà basarsi solo sulle sue personali conoscenze, ma dovrà adottare i criteri di giudizio del modello
della sussunzione sotto leggi. Solo dopo avere individuato la legge di copertura che permette di
affermare che al verificarsi di certi antecedenti vengono generalmente meno determinate
conseguenze, si potrà utilizzare la formula della condicio sine qua non per effettuare un ulteriore
controllo (l’omissione è causa dell’evento quando non la si può mentalmente sostituire con l’azione
doverosa senza che l’evento venga meno). Si può a questo proposito parlare di causalità ipotetica o
causalità in senso normativo, ma va chiarito che non si tratta di un rapporto causale vero e proprio, ma
di un suo equivalente ai fini dell’imputazione giuridica al soggetto garante dell’evento non impedito.
Riguardo al problema del grado di certezza raggiungibile nell’accertamento della causalità omissiva,
parte della dottrina si preoccupa di sottolineare che trattandosi di un giudizio effettuato in termini
ipotetici non si può pretendere lo stesso rigore che si esige nell’accertamento di un vero e proprio
nesso causale. L’opinione maggioritaria è dunque quella che ritiene che ci si possa accontentare del
fatto che applicando la formula della condicio l’azione doverosa, se compiuta, valga ad impedire
l’evento con una probabilità vicina alla certezza. Questa tesi è da apprezzare perché mostra di
comprendere che nei giudizi prognostici non vi può essere una certezza assoluta, ma diventa
comunque poco accettabile se la si intende nel senso che l’accertamento della causalità omissiva
dispensi il giudice dal fare ricorso a criteri veramente attendibili.
Possono, infatti, anche prospettarsi casi di responsabilità omissiva in cui lo stesso giudizio prognostico
non ha bisogno di accontentarsi di una probabilità quasi certa, poiché vi è la certezza che se l’azione
doverosa fosse stata compiuta l’evento lesivo non si sarebbe verificato (se ad esempio una baby-sitter
lascia che il neonato a lei affidati giochi vicino ad uno stagno da solo ed egli vi cade e annega, non vi è
dubbio che la dovuta sorveglianza sarebbe certamente bastata a scongiurare l’evento).
Inoltre, se si accoglie la tesi che la stessa spiegazione del nesso causale nei reati commissivi ha
struttura probabilistica, allora ci si accorge che le differenze nel livello di certezza del rispettivo
accertamento della causalità reale e della causalità omissiva finiscono forse con il ridimensionarsi.
La concezione tradizionale della causalità omissiva nel corso degli anni ha subito revisioni critiche e
aggiustamenti teorici sotto l’impulso di sollecitazioni provenienti dalla prassi applicativa (in
particolare nella responsabilità medica e in quella del datore di lavoro nella responsabilità d’impresa).
L’accresciuta attenzione della dottrina nei confronti della causalità omissiva ha finito con l’investire tre
tipi di questioni, relative a:
1. i criteri di distinzione tra azione ed omissione e tra causalità commissiva e causalità omissiva
2. i complessi rapporti e i connessi confini tra causalità commissiva, causalità omissiva e colpa,
che spesso creano problemi di sovrapposizione o confusione nella concreta prassi giudiziaria
ma sui quali tutt’oggi esistono orientamenti dottrinali forse troppo differenziati
3. il modo di concepire la causalità omissiva in sé considerata, in una prospettiva di interazione
tra teoria e prassi
L’approfondimento di quest’ultimo punto si è reso necessario soprattutto nel settore della
responsabilità medica, infatti l’universo medico è quello tipicamente connotato dalla logica della
probabilità, e in assenza di certezze non si è quasi mai in condizione di potere asserire che l’intervento
medico corretto, omesso, avrebbe salvato il paziente con certezza o quasi certezza. Questo rende
complicato l’accertamento processuale del nesso di condizionamento tra la condotta omissiva del
medico e il decesso del paziente, e si deve quindi scegliere se continuare a pretendere una probabilità
quasi certa (rinunciando però ad esercitare la repressione penale nei casi in cui non si può ottenere
questa quasi certezza) o flessibilizzare la causalità omissiva ricostruendola in una prospettiva
probabilistica ancorata alla teoria del rischio.
L’orientamento giurisprudenziale favorevole ad un affievolimento della causalità omissiva mostra di
accontentarsi, per l’imputazione dell’evento, della prognosi che l’intervento appropriato del medico
avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di salvezza del paziente. Questo spesso viene
giustificato considerando che ai fini della punibilità per mancato impedimento dell’evento
basterebbero anche poche possibilità di salvataggio del paziente quando è in gioco la vita umana (bene
147
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
di rango molto elevato), ma a questo argomento ideologico viene opposto il fatto che la concezione
della causalità penalmente rilevante deve essere basata su criteri generali che prescindono dalla
qualità e dal peso dei beni giuridici di volta in volta in gioco.
Questo orientamento è stato progressivamente contrastato da un orientamento reattivo che punta a
recuperare la causalità in senso rigorosamente condizionalistico, tanto che vi sono state sentenze in
cui si è richiesta una probabilità, non solo statistica, ma anche logica, vicina al 100%, toccando così
picchi di rigore in senso estremistico.
La terza fase dell’evoluzione giurisprudenziale è invece segnata dal tentativo di superare gli opposti
estremismi appena citati con l’elaborazione di un modello causale rigoroso ma non tanto da
frustrare troppo le esigenze punitive della prassi. Si trova esemplificazione di questo orientamento
nella sentenza a sezioni unite Franzese del 2002, che rappresenta ad oggi il più rilevante punto di
riferimento giurisprudenziale in tema di causalità, anche omissiva. In questa sentenza si sostiene che
ai fini della verifica del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento concreto non è decisivo il
coefficiente di probabilità frequentista (vicino a 100, 95, ecc.) relativo alla legge di copertura utilizzata,
ma conta il poter confidare con un elevato grado di credibilità razionale nel fatto che la legge
statistica di copertura trovi applicazione anche nel singolo caso oggetto di giudizio, vista l’alta
probabilità logica che nella situazione concreta siano da escludere attori causali alternativi. Quello che
nella sentenza non si chiarisce è cosa significhi escludibilità di fatto causali alternativi nel caso
specifico della causalità omissiva, e quello che si chiede è dunque se essi vadano intesi come alternativi
rispetto alla condotta omissiva o rispetto alle cause naturalistiche assumibili ad antecedenti positivi
dell’evento, o ancora se richiamino scenari causali suscettibili in linea ipotetica di essere attivati dal
compimento mentalmente supposto dell’azione doverosa.
Riceve in ogni caso conferma la risalente consapevolezza che è proprio il carattere ipotetico della
causalità omissiva a rendere la maggior parte delle volte complicato l’accertamento. A differenza
della causalità commissiva, dove serve spiegare cosa sia realmente accaduto per effetto del
comportamento dell’agente, nella responsabilità per omissione bisogna immaginare cosa sarebbe
accaduto se il garante avesse compiuto l’azione omessa, e poiché bisogna “immaginare”, vi è
necessariamente incertezza, cosa che fa sembrare illusorio l’orientamento dottrinale dominante
favorevole ad ammettere la causalità omissiva solo nei casi di imponibilità dell’evento con una
probabilità vicina alla certezza.
Questo rischio è poi ancora più evidente nell’ambito della responsabilità medica, che è proprio il
settore in cui la sentenza Franzese ha cercato di restaurare un modello di causalità in senso
condizionalistico, sostenendo che il precedente modello basato sulla teoria del rischio fosse
incompatibile con il diritto vigente. Nonostante questo, nella prassi giudiziaria si continua ad essere
ancorati al paradigma dell’aumento o della mancata diminuzione del rischio.
Questo persistente affievolimento della causalità omissiva è dovuto al fatto che il modello di causalità
condizionalistica elaborato con la sentenza Franzese risulta troppo pretenzioso per potersi applicare
fedelmente, in particolare quando il caso riguardo un ambito particolarmente delicato come quello
della responsabilità medica o la responsabilità del datore di lavoro, i quali sono connotati da alti livelli
di problematicità e incertezza. Insistere in questi ambiti nel richiedere una causalità omissiva in chiave
condizionalistica può sì equivalere ad una nobile forma di fedeltà ad un garantismo penale, garantismo
che viene però smentito dalla natura delle cose, e infatti è più realisticamente giunto il momento di
prendere atto che a maggior ragione la causalità omissiva ha una natura probabilistica suscettibile di
essere approfondita soprattutto grazie ad approcci che si possono inquadrare in una sempre più
affinata teoria del rischio.
Un caso esemplificativo è il caso di due genitori di una bambina affetta da thalassemia omozigote, i
quali, essendo testimoni di Geova e non volendo violare il divieto religioso del loro culto, hanno
interrotto la terapia emotrasfusionale della figlia, la quale è successivamente morta. In questo caso
bisogna dunque analizzare se la prosecuzione della pratica delle trasfusioni avrebbe, e con che
probabilità, potuto impedire la morte della bambina. La sentenza della Corte d’Assise di Cagliari ha
affermato che non è possibile stabilire quale sarebbe stata la vita della figlia e il decorso della sua
malattia per effetto della terapia, e dunque è giusto fare riferimento ai dati che si hanno sugli effetti
148
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
che ha di norma la terapia, ma è giusto anche tenere conto del fatto che in particolare nell’ambito
medico non si possono fare previsioni certe (la malattia avrebbe potuto aggravarsi, si sarebbero potuti
instaurare processi morbosi, ecc.).
Tuttavia, ai fini della responsabilità penale dei genitori non serve supporre che la terapia
emotrasfusionale avrebbe certamente garantito la sopravvivenza della bambina, ma è sufficiente
ritenere che l’omissione della terapia abbia favorito la mera accelerazione del decesso (anche se non si
può escludere che la morte si sarebbe verificata in un momento diverso, infatti quella su cui bisogna
basarsi è questa morte, così come avvenuta nel caso particolare, e non la morte intesa come evento
astratto), e dunque, a fronte di queste considerazioni, i genitori possono essere e sono stati ritenuti
responsabili per omissione.
LA POSIZIONE DI GARANZIA
Perché la causazione e il mancato impedimento di un evento risultino penalmente equivalenti, non è
sufficiente accertare il nesso di causalità ipotetica tra l’evento stesso e la condotta omissiva, poiché
serve infatti (come richiede l’art. 40 cpv.) la violazione di un obbligo giuridico di impedire l’evento.
Poiché l’art. 40 cpv. non specifica né quali siano gli obblighi giuridicamente rilevanti né quali siano i
criteri per individuarli, spetta a dottrina e giurisprudenza determinare di volta in volta quali siano
questi obblighi, e ciò comporta il vantaggio di avere un numero aperto di obblighi che può essere
ampliato e modificato per far fronte alle nuove esigenze di tutela che emergono dalla prassi, ma anche
lo svantaggio di rendere particolarmente oscillante il settore dei reati omissivi impropri.
I giudici italiani si sono comunque in genere preoccupati di rispettare il principio della giuridicità
formale dell’obbligo di impedire l’evento, evitando così la pericolosa confusione tra sfera giuridica e
sfera etica (ad esempio in una pronuncia si è negata la natura giuridica dell’obbligo del figlio di
impedire la morte del padre, sostenendo che essa non fosse desumibile dalle norme sui rapporti di
famiglia del codice civile).
La dottrina italiana non ha svolto grossi approfondimenti, e si è per lo più limitata a riecheggiare la
teoria formale dell’obbligo di impedire l’evento, ossia una concezione che inclina ad individuare le
situazioni tipiche di obbligo penalmente rilevanti sulla base della fonte formale della loro rilevanza
giuridica. nell’originaria formulazione di questa teoria ci si limitava ad enumerare il “trifoglio”, ossia
una triplice fonte giuridica dell’obbligo di attivarsi:
legge penale ed extrapenale
contratto
precedente azione pericolosa
Ma una parte della dottrina ha poi esteso le possibili fonti includendo anche la negotiorum gestio e la
consuetudine.
La tradizionale concezione formale è soggetto ad obiezioni difficilmente superabili, infatti la dottrina
italiana ha dimostrato che questa concezione non è in grado di spiegare in modo appagante perché il
diritto penale assimili l’omissione non impeditiva all’azione causale. Infatti, ad esempio, non tutti gli
obblighi extrapenali di attivarsi sono automaticamente suscettibili di convertirsi in un obbligo di
impedire l’evento, o meglio obbligo di garanzia, rilevante ai sensi di una fattispecie omissiva propria.
Se non fosse così si finirebbe col subordinare il giudizio di rilevanza penalistica ex art. 40 cpv. al
richiamo di criteri di valutazione facenti capo ad altre branche dell’ordinamento. Inoltre, anche
quando l’obbligo di garanzia ha la sua fonte in una norma penale che configura direttamente una
fattispecie omissiva impropria, la sua rilevanza ai sensi di una fattispecie omissiva impropria va
comunque vagliata alla luce della specifica funzione espletata nell’ordinamento dall’art. 40 cpv.
La teoria formale entra inoltre in contraddizione con sé stessa nell’includere tra le fonti dell’obbligo di
impedire l’evento l’agire pericoloso precedente, infatti non esiste alcuna norma giuridica esplicita in
base alla quale si possa affermare che il compimento di un’azione pericolosa precedente faccia
insorgere obblighi a contenuto impeditivo.
La dottrina più recente, preso atto delle insufficienze della teoria formale, si è sforzata di approfondire
il problema del fondamento penalistico della regola dell’equivalenza sancita dall’art. 40 cpv.
Nascono di qui approcci tendenti a sostituire o ad integrare i tradizionali criteri giuridico-formali di
149
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
individuazione degli obblighi di garanzia con criteri materiali o contenutistici desunti dalla specifica
funzione attribuibile alla responsabilità per omesso impedimento dell’evento nel nostro sistema
penale.
Tuttavia, neanche questa impostazione è in grado di circoscrivere la materia in esame entro confini
sempre certi e ben definiti, infatti l’adozione di questa teoria ha dato luogo a numerosi contributi
sfocianti nella progettazione di criteri di individuazione e delimitazione degli obblighi di garanzia
di volta in volta diversi. Sembra dunque che la notevole diversità delle costruzioni escogitate sia
conseguenza dei tentativi di razionalizzazione postuma di scelte aprioristiche relative alle funzioni di
tutela che si intendono assegnare alla responsabilità per omesso impedimento dell’evento.
Comunque, anche a pretendere che sia sempre una norma giuridica ad attribuire esplicita rilevanza
delle situazioni di fatto da cui scaturiscono gli obblighi di garanzia, rimangono due dati:
1. nella maggior parte dei casi la norma invocabile ha natura extrapenale (ed è noto come nelle
altre branche dell’ordinamento il principio di legalità non venga osservato con lo stesso rigore
richiesto in ambito penale)
2. il fatto che risulta in modo ancora più decisivo in termini di legalità e certezza il modo di
ricostruire la funzione della responsabilità per omesso impedimento dell’evento, solo che,
essendo insufficienti gli appigli forniti dall’art. 40 cpv. l’interprete finisce con l’usufruire di
ampi margini di discrezionalità nel determinare la sfera di operatività e i limiti delle fattispecie
omissive proprie.
Per rendere dunque davvero compatibili responsabilità per omesso impedimento dell’evento e
principi costituzionali in materia penale, non resta che auspicare un intervento legislativo che tipizzi le
posizioni di garanzia come perno centrale attorno al quale ruota la fattispecie omissiva impropria.
Ai fini di un’individuazione degli obblighi di impedire l’evento rilevanti sul terreno del diritto vigente,
è opportuno dare conto soprattutto delle acquisizioni che godono oggi di un più ampio consenso.
La funzione dell’art. 40 cpv. è quella di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, dovuta
all’incapacità dei loro titolari di proteggerli adeguatamente, motivo per cui si attribuisce ad altri
soggetti la speciale posizione di garanti dell’integrità dei beni che si ha interesse a salvaguardare.
Il principio di equivalenza tra l’omissione non impeditiva e l’azione causale presuppone dunque non
un semplice obbligo giuridico di attivarsi, ma una posizione di garanzia nei confronti del bene
protetto, che è generalmente definibile come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed
un bene giuridico, determinato dall’incapacità del titolare a proteggerlo autonomamente (un caso
esemplificativo può essere quello della madre che lascia morire di inedia il suo bambino, caso nel
quale la relazione di dipendenza a contenuto protettivo nasce dall’incapacità naturale del bambino a
svolgere da solo alcune funzioni vitali).
La natura speciale del vincolo di tutela relativo alle situazioni di garanzia si riflette anche sulla natura
degli obblighi di attivarsi che discendono da queste situazioni, infatti gli obblighi di garanzia hanno
carattere speciale perché incombono solo su alcuni soggetti, ossia i garanti, e non su tutti i cittadini. È
questo dunque il motivo per cui da una fattispecie omissiva propria, realizzabile da chiunque come
l’omissione di soccorso, non può mai scaturire un obbligo di attivarsi o meglio un obbligo di garanzia
rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv., mentre possono derivare obblighi di garanzia rilevanti ai sensi di
quest’articolo da una fattispecie omissiva propria come quella dell’art. 677 comma 3, infatti secondo
questo articolo l’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina è imputabile non a
chiunque, ma solo al proprietari dell’edificio o costruzione, e dunque se dall’omissione nasce una
lesione della vita o incolumità, il proprietario potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 677
ma anche anche di omicidio o di lesioni realizzate mediante omissione colposa.
In base ad una classificazione funzionale incentrata sul contenuto materiale e sullo scopo della
posizione di garante, le posizioni di garanzia possono distinguersi in:
Posizioni di protezione (es. quella dei genitori sui figli minori): che hanno lo scopo di
preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità,
indipendentemente dalla fonte da cui scaturiscono
Posizioni di controllo (es. il proprietario dell’edificio pericolante deve impedire che si
verifichino eventi dannosi a carico di tutti i soggetti che possono trovasi nelle vicinanze): che
150
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
hanno invece lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo in modo da garantire
l’integrità di tutti i beni giuridici che ne possono risultare minacciati.
Le posizioni di garanzia possono inoltre distinguersi in:
Posizioni di garanzia originarie (es. quella dei genitori e dei proprietari di edifici
pericolanti): che nascono in capo a determinati soggetti, in considerazione dello specifico ruolo
o della speciale posizione di volta in volta rivestita
Posizioni di garanzia derivate (es. quella della baby-sitter che si impegna a sorvegliare i
bambini): che si trasferiscono dal titolare originario ad un altro, principalmente con un atto di
trasferimento negoziale. Questo atto si trasferimento negoziale è spesso un contratto, ma
perché gli obblighi di attivarsi di fonte contrattuale possano assumere rilevanza ai sensi
dell’art. 40 cpv. sono necessarie le seguenti condizioni:
1. l’altro contraente deve essere il titolare del bene protetto, o un garante a titolo
originario
2. il nuovo garante deve assumere in concreto la funzione di tutela al cui assolvimento si è
impegnato. Da questo punto di vista, presupposto della responsabilità penale per
omesso impedimento dell’evento è che la violazione del contratto coincida con la
mancata sostituzione del garante originario non più in grado di intervenire al momento
del possibile verificarsi dell’evento lesivo (un esempio è il caso in cui i genitori abbiano
assunto una baby-sitter e decidano di allontanarsi da casa nonostante quest’ultima non
sia ancora arrivata: la baby-sitter ha soltanto violato l’impegno contrattuale, mentre
sarebbe stato diverso se lei se ne fosse andata dopo avere preso in custodia il bambino)
3. sulla responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento non incidono molto le
successive vicende relative all’eventuale invalidità del contratto per le norme civili,
infatti per la valutazione penalistica conta che in base all’iniziale accordo tra le parti si
sia creato un effettivo affidamento al garante del bene da proteggere.
Gli obblighi di garanzia penalmente rilevanti possono derivare anche da un’assunzione volontaria
della posizione di garante (una parte della dottrina giustifica in questo modo anche la rilevanza
dell’assunzione di compiti di garanzia in virtù di un contratto nullo). Per la rilevanza penalistica delle
posizioni di garanzia spontaneamente assunte ciò che veramente conta è che l’intervento del garante
determini o accentui un’esposizione a pericolo del bene da proteggere (perché l’intervento induce ad
affrontare un pericolo che non si sarebbe altrimenti corso o perché impedisce l’attivarsi di istanze di
protezione alternative).
Tra le principali posizioni di protezione penalmente rilevanti vanno innanzitutto citate quelle che
trovano la loro fonte direttamente nella legge, e in particolare nel diritto di famiglia. Il rapporto
genitori-figli minori, sancito dall’art. 30 Cost. e dall’art. 147 c.c., non è reciproco, ma in casi eccezionali
il figlio può assumere il ruolo di garante in senso penalistico della vita dei genitori (ad esempio un
figlio che spontaneamente si faccia carico dell’assistenza di un genitore malato incapace di provvedere
a sé stesso). Inoltre va detto che i genitori hanno l’obbligo di impedire che i figli subiscano lesioni dei
beni della vita e dell’integrità fisica, ma non hanno l’obbligo di impedire danni a carico dei loro beni
patrimoniali.
Si ritiene comunemente che questo vincolo obblighi il genitore ad impedire eventi lesivi cagionati sia
da terzi sia da fatti naturali (come ad esempio nel caso della thalassemia citato in precedenza), ma è
invece controversa la configurabilità a carico del genitore di una responsabilità in concorso mediante
omissione nel reato di violenza sessuale o di maltrattamenti se il genitore non denuncia o non chiede
l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo caso non vi è un’adeguata tipizzazione normativa, ma si
può dire che sia preferibile il punto di vista più liberale, dal momento che è impossibile accertare se il
genitore abbia tenuto un comportamento intenzionale o sia rimasto inerte per altre ragioni quali
paura, compiacimento, rassegnazione, ecc.
Per i coniugi la legge prevede un obbligo di reciproca assistenza all’art. 143 c.c., obbligo che può
diventare un obbligo di garanzia penalmente rilevante avente a contenuto la salvaguardia della vita e
dell’incolumità del partner, a condizione che tra i coniugi vi sia un concreto rapporto di affidamento
151
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
sulla reciproca protezione dei beni di rispettiva appartenenza in caso di bisogno.
L’ordinamento penitenziario prevede altre posizioni di protezioni di fonte legale agli articoli 1 e 11
della legge n. 354 del 26 luglio 1975, in cui si può desumere un obbligo, per i dipendenti
dell’Amministrazione penitenziaria, di tutela della vita e dell’incolumità personale dei detenuti e
internati negli istituti di pena.
Un’altra posizione di protezione di fonte legale è quella del medico nei confronti del paziente (poiché
egli è incapace di proteggersi da solo dai pericoli per la propria salute ed integrità) che deriva dall’art.
32 Cost. e dalle disposizioni normative che disciplinano il servizio sanitario nazionale.
Va comunque ricordato che le posizioni di protezione possono però trovare la loro fonte anche in un
atto di autonomia privata come il contratto (es. babysitter), ma anche da un’assunzione volontaria
dei compiti di garante che determini o accentui una situazione di rischio per il bene protetto.
Le posizioni di controllo su fonti di pericolo si configurano in presenza di due condizioni:
1. il titolare del bene si trovi nell’impossibilità di proteggere il bene
2. il garante tenga nella sua sfera di signoria la sorgente (l’oggetto materiale o l’attività) da cui si
origina la situazione di pericolo a carico di terzi
Si considerano dunque le ipotesi di responsabilità per eventi lesivi connessi a fonti di pericolo che
rientrano in una propria sfera di appartenenza, come ad esempio l’obbligo di apprestare le misure di
sicurezza idonee ad evitare eventi dannosi, il quale sorge in capo al soggetto proprietario, possessore o
custode di cose immobili o mobili potenzialmente lesive di beni altrui. Esempi di questi obblighi, con
fonte legale, sono l’obbligo già citato disposto dall’art. 677 c.p., o quelli dati da codice penale e
legislazione speciale riguardanti il datore di lavoro a tutela dell’incolumità del lavoratori e talvolta
dell’incolumità pubblica.
Sono posizioni di controllo su fonti di pericolo anche i casi in cui il garante è obbligato ad impedire
l’agire illecito di un terzo, anche se questa posizione di garanzia è subordinata a presupposti che
possono mutare in rapporto ai settori che vengono in questione. In alcuni casi le due condizioni sono:
1. il terzo non abbia i requisiti necessari a governare responsabilmente il proprio
comportamento
2. per questa incapacità egli debba sottostare al potere di controllo e vigilanza di un garante (ad
esempio nel caso dei figli minori, degli infermi mentali, ecc.)
In altri casi invece la posizione di garanzia si basa sull’esistenza di un potere giuridico che pone certi
soggetti in condizione di impedire la commissione di reati da parte di altri soggetti (ad esempio nel
caso dell’obbligo di impedimento di reati societari gravante su amministratori e sindaci di società).
Per quanto riguarda la responsabilità penale degli appartenenti alle forze dell’ordine, la
giurisprudenza, sulla base di un’applicazione rigoristica della teoria formale dell’obbligo di impedire
l’evento, ha incondizionatamente affermato il principio secondo cui l’ufficiale o agente di polizia
giudiziaria concorre nel delitto se assistendo alla commissione di un reato non impedisce che questo
sia compiuto. Tuttavia, va notato che il dovere di impedimento dei reati gravante sulla forza pubblica o
sugli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria sia troppo generico per potere soddisfare veramente le
caratteristiche di determinatezza e specialità del rapporto di protezione posto a fondamento della
posizione di garanzia. Dunque, al di fuori delle ipotesi in cui l’omissione agevoli seriamente la
commissione di un reato, l’agente risponderà al massimo di mancato adempimento di un dovere
funzionale.
Le posizioni di controllo su fonti di pericolo possono anche derivare da un contratto (se l’altro
contraente è il titolare originario della posizione medesima), o dall’assunzione volontaria delle relative
funzioni.
LA DISTINZIONE TRA “AGIRE” ED “OMETTERE” NEI CASI PROBLEMATICI
Vi sono casi in cui la condotta ha una forma ambivalente, ossia il giudice penale potrebbe vederla
come condotta attiva o come condotta omissiva. Esempi sono gli illeciti colposi imperniati su
152
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
un’azione, infatti se si considera il caso di un soggetto che guidi di sera a fari spenti e provochi un
incidente mortale, si può anche considerare che l’incidente sia dovuto all’inosservanza della regola di
prudenza che impone di accendere i fari di sera, ossia all’omissione di un preciso dovere di condotta.
Dal momento che nella colpa è sempre insito un momento omissivo che consiste nella mancata
osservanza di una regola cautelare, se si estremizzasse quella considerazione si potrebbero
teoricamente cancellare i fatti commissivi colposi, incentrando il significato della condotta sempre sul
difetto di diligenza.
Questa estremizzazione non è in realtà stata mai proposta, ed essa presenta comunque il difetto di
ignorare la circostanza che il soggetto chiamato a rispondere del fatto colposo non sempre è garante
della salvaguardia del bene protetto (nel caso del dovere di prudenza dell’automobilista, ad esempio,
esso non ha come presupposto una pregressa posizione di garanzia in senso tecnico, ma il fatto di
compiere un’azione positiva pericolosa).
In settori complicati come quello della responsabilità medica o di quella del datore di lavoro per eventi
lesivi collegati all’attività d’impresa, la distinzione tra agire e omettere ha finito con l’assumere un
certo rilievo pratico in sede di verifica processuale del nesso di causalità. Per entrambi i casi la
giurisprudenza ha teso a ricostruire la condotta oggetto di imputazione per lo più in chiave omissiva,
spiegabile sulla base di due motivazioni di fondo:
1. il significato del comportamento ad esempio del medico viene valutato secondo un’ottica
orientata secondo lo specifico ruolo professionale, e questo significa che il medico viene
penalisticamente percepito come garante di un trattamento corretto del malato, per cui non
bisogna considerare, in senso naturalistico, un’azione la prescrizione sbagliata e un’omissione
l’astensione della cura, ma bisogna piuttosto notare che ai fini del disvalore penale entrambe le
situazioni sono un mancato adempimento dell’obbligo di garantire prestazioni appropriate
2. la preferenza accordata all’omissione si spiega anche con la possibilità di assecondare istanze
repressive avvertite come prevalenti nel presupposto che la causalità dell’omissione consenta
un rigore probatorio più attenuato rispetto a quello che viene richiesto per la causalità
commissiva.
La dottrina ha obiettato contro questa tendenza giurisprudenziale che la distinzione tra
causalità commissiva e causalità omissiva andrebbe invece mantenuta sia per esigenze
garantistiche connesse al principio di tipicità penale, sia perché le modalità di accertamento
delle due forme di causalità non sono uguali. Senza sottovalutare queste preoccupazioni
garantistiche di matrice dottrinale, si deve però concordare che soprattutto in campo medico
sono tendenzialmente più frequenti situazioni ambivalenti in cui non è chiaro se l’imputazione
abbia ad oggetto un’azione inappropriata o un’omissione. La ricostruzione giudiziale dei casi
concreti, e dunque la qualificazione del fatto in chiave di causalità omissiva o commissiva,
risente di giudizi di valore rapportati a quello che viene di volta in volta percepito come il
prevalente significato sostanziale dell’addebito rivolto al medico.
Per questi motivi è stato recentemente proposto dalla dottrina un criterio distintivo che
identifica come commissivo il comportamento del medico che introduce nel quadro clinico del
paziente un nuovo fattore di rischio che poi si concretizza nell’evento lesivo, e come omissivo
il comportamento che semplicemente non contrasta un fattore di rischio già presente nel
quadro clinico.
Vi sono condotte ambivalenti, però, anche nei reati dolosi, e ne sono esempi l’impedimento di azioni
di soccorso altrui e di interruzione di un personale intervento soccorritore. Un esempio di
impedimento di soccorso altrui si ha se un soggetto ne costringe un altro, ad esempio impugnando una
pistola, a non portare in ospedale un ferito grave che aveva già caricato sulla macchina, nel cui caso
l’agente risponderà non di omissione di soccorso, ma di omicidio mediante azione, perché non si è
limitato a non prestare aiuto, ma ha agito per neutralizzare strumenti di salvataggio già messi in opera
per attenuare o rimuovere la situazione di pericolo. Per l’interruzione di un personale intervento
soccorritore si può invece fare l’esempio di un soggetto che lancia una fune ad un altro soggetto che è
caduto in un pozzo ma decide poi di ritirarla: in questo caso si avrà omissione di soccorso se la ritira
153
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
prima che abbia raggiunto il soggetto caduto, mentre si avrà omicidio doloso mediante azione se la
ritira quando ha già raggiunto il soggetto, che sta per servirsene.
ANTIGIURIDICITÀ
L’antigiuridicità nell’illecito omissivo (e in quello commissivo) ha la funzione di convalidare l’illiceità
indiziata dalla conformità al tipo, per cui se sussiste una causa di giustificazione l’omissione tipica
non risulta antigiuridica e la punibilità viene meno. Tuttavia, le cause di giustificazione più applicate ai
reati di azione non sempre si riescono ad applicare ai reati omissivi altrettanto facilmente, e lo
possono fare solo in presenza di particolari circostanze che non si verificano spesso nella realtà. Non è
infatti semplice trovare esempi di legittima difesa con condotta omissiva (si può avere nel caso in cui
una persona non presti soccorso ad un ferito che lo minaccia), mentre sono più ipotizzabili omissioni
giustificate dallo stato di necessità, come nel caso in cui un soggetto ometta di prestare soccorso
perché l’azione di salvataggio metterebbe sé stesso in pericolo.
COLPEVOLEZZA
La struttura della colpevolezza nei reati omissivi è fondamentalmente analoga a quella dei reati
commissivi, ma presenta in alcuni aspetti a discostarsi da essa.
Nei reati omissivi impropri si prospetta un problema politico-criminale che assume rilevanza ai fini
della graduazione della colpevolezza, ossia il problema dell’equiparabilità del cagionare al non
impedire sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, risolto, seppur in maniera implicita,
affermativamente dall’art. 40 cpv. Una parte della dottrina ha infatti obiettato che la minore quantità
di energia fisica esplicanti nel reato omissivo e il minore sforzo necessario per decidere di lasciare le
cose nello stato in cui si trovano, non possono non implicare una carica minore di pericolosità del
soggetto e dunque un trattamento punitivo meno severo.
DOLO OMISSIVO
Nei reati omissivi la ricostruzione degli aspetti strutturali e contenutistici del dolo è complessa e
delicata, in particolare per i reati omissivi propri, poiché caratterizzati dall’assenza di una condotta
positiva e di un evento naturalisticamente percepibile, e ci si chiede dunque fino a che punto sia
possibile avere coscienza e volontà di omettere senza conoscere previamente la legge penale che
impone il dovere di attivarsi in un certo modo:
per quanto riguarda i reati omissivi propri con situazione tipica pregnante, l’obbligo di
attivarsi ha come presupposto una realtà naturalistica o sociale immediatamente percepibile
dal soggetto a prescindere dalla sua conoscenza dell’obbligo giuridico di agire (come ad
esempio per l’omissione di soccorso). In questi casi la coscienza e volontà di omettere può fare
a meno della conoscenza dell’obbligo giuridico di attivarsi penalmente sanzionato
per quanto riguarda i reati omissivi propri con situazione tipica neutra, essi riflettono
fattispecie di pura creazione legislativa cui non preesiste un disvalore socialmente percepibile
o diffuso. In questi casi il presupposto dell’obbligo di agire non dice nulla al soggetto se egli
non conosce o non ha ragione di sospettare dell’esistenza di una norma giuridica che lo rende
penalmente rilevante. Per questi reati una parte della dottrina ritiene che il dolo inglobi la
conoscenza attuale del comando penale in deroga al principio posto dall’art. 5 c.p.
Perché l’omittente risponda a titolo di dolo in generale non è sufficiente la conoscenza dei presupposti
(ossia la situazione tipica) del dovere di attivarsi, ma serve anche la consapevolezza della possibilità
di agire nella direzione voluta dalla norma. Senza quest’ultimo elemento, l’omissione non può mai
esprimere il significato di una risoluzione, di una scelta tra due o più possibilità di condotta.
Alcuni autorevoli seguaci della teoria dell’azione finalistica hanno criticato questo assunto, sostenendo
che il dolo omissivo non sia un dolo vero e proprio, ma a questa opinione si può facilmente obiettare
che sostenere che al dolo di omissione manchi il momento volitivo significa in realtà rimanere ancorati
a preconcetti astratti e a postazioni dogmatiche aprioristiche. Inoltre, in relazione alla preoccupazione
154
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
politico-criminale secondo cui l’inclusione della possibilità di agire nel contenuto rappresentativo del
dolo omissivo premierebbe i soggetti più insensibili che in quanto tali non rifletterebbero
minimamente sulla possibilità di attivarsi per difendere i beni protetti, si può replicare che la
necessaria consapevolezza della possibilità di agire per integrare il dolo omissivo, non si deve
identificare con la consapevolezza delle specifiche modalità di realizzazione dell’azione doverosa, ma
con una consapevolezza implicita o generica della possibilità di adempiere al dovere di condotta.
Il dolo, nei reati omissivi impropri, comprende i presupposti di fatto della posizione di garanzia, la
quale rappresenta un fondamentale elemento costitutivo del fatto tipico (ad esempio non risponderà
di omicidio doloso la baby-sitter che omette di sorvegliare il bambino che le è stato affidato se non
riconosce che il bambino che sta per annegare è quello che le hanno affidato). Entra a fare parte del
dolo la conoscenza dell’obbligo extrapenale di agire derivante da un contratto o un altro atto
negoziale, e questa conoscenza può essere presupposto indispensabile perché il soggetto si renda
conto di rivestire una posizione di garanzia, cosicché un errore in proposito, convertendosi in un
errore sulla situazione tipica, può avere efficacia scusante ex art. 47 ultimo comma.
Per la configurabilità del dolo non è invece necessario che l’omittente sappia che la violazione
dell’obbligo di garanzia è penalmente sanzionata in virtù della regola generale, secondo cui non è
richiesta la conoscenza attuale della norma penale trasgredita.
COLPA
Il difetto di diligenza può riferirsi al mancato riconoscimento della situazione tipica da parte
dell’omittente. L’adempimento del dovere di diligenza presuppone ovviamente che il soggetto
obbligato abbia la possibilità di agire nel senso richiesto, e cioè che sia possibile per lui agire sì in
senso fisico, ma sia anche in grado di dominare i fattori necessari al raggiungimento dello scopo. In
sintesi, i requisiti della possibilità di agire sono:
1. conoscenza o riconoscibilità della situazione tipica
2. possibilità obiettiva di agire
3. conoscenza o riconoscibilità del fine dell’azione doverosa
4. conoscenza o riconoscibilità dei mezzi necessari al raggiungimento del fine medesimo
Per stabilire se la condotta omissiva sia in contrasto con il dovere oggettivo di diligenza, si deve
verificare la possibilità di agire valutando se un modello di agente avveduto sarebbe stato in grado
nella situazione data di riconoscere la situazione tipica e agire nel senso voluto dall’ordinamento.
Successivamente, in sede di colpevolezza, si dovranno verificare le capacità psico-fisiche
dell’omittente concreto, accertando l’assenza di circostanze anormali capaci di rendere
eccezionalmente impossibile anche all’agente modello di comportarsi come richiesto
dall’ordinamento. Il punto di riferimento spazio-temporale che questa verifica necessità è il
comportamento effettivamente tenuto dall’omittente, e questo criterio risulta utile soprattutto nei casi
di colpa incosciente, come le omissioni dovute a mera dimenticanza. Anche se solitamente si considera
la colpa incosciente coma una delle due tipici forme dell’elemento psicologico del reato colposo, si è già
detto che la maggior parte dei casi di colpa inconsapevole difetta di coscienza e volontà come
coefficienti psicologici reali. Allora, il giudizio di imputazione diventa di natura schiettamente
normativa, e l’accertamento della colpa tende a coincidere con la possibilità di muovere all’omittente
un rimprovero per non avere agito come richiesto anche se nella situazione data non sussistessero
circostanze che lo impedivano.
Nei delitti omissivi impropri va rilevato he il contenuto del dovere di diligenza e quello dell’obbligo
di impedire l’evento finiscono per intersecarsi e coincidere, nel senso che il garante, per impedire che
si verifichino determinati eventi è tenuto a fare ciò che gli viene imposto dall’osservanza delle regole di
diligenza dettate dalla situazione particolare.
Tutto questo però non toglie che concettualmente le due entità devono essere tenute distinte per
meglio valutare la loro portata. Se si mantiene questa distinzione concettuale si riesce infatti a
sostenere che l’obbligo di diligenza deve basarsi sulla posizione di garanzia dell’omittente, che la
misura della diligenza imposta non può superare quella cui è obbligato in quanto garante.
155
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
COSCIENZA DELL’ILLICEITÀ
Nei reati omissivi la coscienza dell’illiceità equivale alla conoscenza del comando di realizzare una
determinata azione, ma questa conoscenza non si può richiedere ai fini della punibilità (così come nei
reati commissivi non si richiede la conoscenza del divieto di porre in essere un’azione conferme ad un
modello delittuoso). Per la sussistenza della colpevolezza nei reati omissivi è invece sufficiente la
possibilità di conoscere il precetto penale che consiste nel comando di agire penalmente
sanzionato, ma nei delitti di omissione la possibilità di conoscere il comando va accertata con criteri
particolari.
L’obbligo di agire viene di agire viene normalmente percepito con meno immediatezza rispetto a
quello di non agire, e per questo nei reati commissivi la possibilità di non conoscere il precetto va
tenuta in conto solo in presenza di circostanze oggettive, mentre nei reati omissivi va sempre tenuta
presente. I reati omissivi esulano spesso, inoltre, dall’ambito della coscienza morale media.
TENTATIVO
Nei delitti omissivi è complessa la configurabilità del tentativo, e infatti la dottrina tradizionale non ha
dato una soluzione unitaria, ammettendo generalmente la possibilità di ipotizzare il tentativo nei reati
commissivi mediante omissione, e non ammettendola, invece, per i reati omissivi puri.
La dottrina si è dimostrata generalmente concorde nel riconoscere la configurabilità del tentativo nei
delitti omissivi impropri poiché questi delitti hanno la struttura di reati di evento, ed è dunque
possibile ipotizzare il tentativo in tutti i casi in cui l’omissione non è seguita dalla verificazione
dell’evento. Gli unici dubbi a questo proposito riguardano la determinazione del momento iniziale
dell’omissione punibile, ma la soluzione probabilmente più corretta è quella che ritiene che
l’omissione tentata assuma rilevanza penale nel momento in cui il ritardo nell’azione di salvataggio
provoca un pericolo diretto per il bene tutelato o aggrava una situazione di pericolo persistente.
Per i reati omissivi puri non si pensa che si possa configurare il tentativo perché se il termine utile
per compiere l’azione prescritta non è ancora scaduto, allora non averla compiuta non implica ancora
la violazione dell’obbligo, mentre se il termine è già scaduto non vi è tentativo, ma reato perfetto.
Inoltre l’omissione, non essendo immediatamente percepibile con i sensi, in molti casi può rimanere
inaccessibile alla coscienza dell’osservatore, e dunque sarà impossibile riconoscere l’obiettivazione di
una volontà diretta a non compiere l’azione prescritta.
Tuttavia, una parte della dottrina non è di questo avviso, e ritiene che, nonostante i casi non siano
facilmente verificabili nella pratica, si possa configurare tentativo quando il soggetto non si limiti a non
agire, ma compia atti positivi diretti univocamente a non compiere l’azione prescritta (es. un pubblico
ufficiale che si rechi all’estero per non essere presente nel luogo e al momento in cui avrebbe dovuto
compiere un atto di ufficio). La tesi che sembra meglio accoglibile è però quella che considera che “ove
il termine per adempiere non sia decorso, ci si troverà di fronte ad un’ipotesi di tentativo tutte le volte
che un soggetto obbligato precostituisca una situazione tale da rendere possibile l’ottemperanza alla
pretesa normativa”.
La riconoscibilità di una volontà di non adempiere appare, invece, meno agevole di fronte alla
realizzazione di comportamenti che siano volti a produrre l’impossibilità dell’adempimento. In questi
casi, in mancanza di altri criteri di riferimento, per la configurazione del tentativo sarà di ausilio il
ricorso ai principi generali.
PARTECIPAZIONE CRIMINOSA
PARTECIPAZIONE NEL REATO OMISSIVO
La dottrina italiana non ha approfondito questo argomento, probabilmente aderendo implicitamente
all’idea che i consolidati principi del concorso di persone nel reato siano indifferentemente applicabile
all’azione e all’omissione.
Per il concorso mediante omissione in un reato omissivo ci si è limitati ad osservare che esso è
ammissibile se più soggetti obbligati decidono insieme che ciascuno non adempierà al suo obbligo di
156
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
condotta, ma comunque notato che questa figura non è di grossa importanza pratica, infatti per la
responsabilità è sufficiente tenere conto della singola condotta omissiva idonea di per sé ad integrare
tutta la fattispecie di reato.
Si può inoltre configurare anche un concorso mediante azione in un reato omissivo (come ad
esempio nel caso in cui un soggetto ne istighi un altro a non soccorrere una persona in pericolo).
Tuttavia, il ricorso all’istituto della partecipazione criminosa in questi casi si rivela superfluo se
l’istigatore è personalmente in grado di soccorrere la persona in pericolo, nel senso che in questo caso
egli può direttamente assumere il ruolo di autore del delitto di omissione di soccorso.
PRESUPPOSTI E LIMITI DELLA PARTECIPAZIONE MEDIANTE OMISSIONE NEL REATO
COMMISSIVO
Si può concorrere mediante omissione alla realizzazione di un reato commissivo solo se l’omittente è
garante dell’impedimento dell’evento ossia del reato commesso da terzi. La dottrina e la
giurisprudenza tendono a prescindere dalla presenza o meno nella struttura del reato di un evento in
senso naturalistico. In realtà, posto che nel caso di realizzazione monosoggettiva dell’illecito omissivo
improprio il giudizio di equivalenza ex art. 40 cpv. va limitato alle fattispecie con evento naturalistico,
ci si deve chiedere se si debba dare per scontato che questa regola possa invece legittimamente
disattendersi se il garante viene chiamato a rispondere a titolo di concorso. Questa questione non
riguarda solo il piano dogmatico, infatti più si estende l’ambito tipologico dei fatti di reato suscettivi di
costituire oggetto di un obbligo di impedimento, più si dilata la gamma degli interessi tutelabili, e
diventa ancora più complesso il processo di selezione degli obblighi di garanzia e dei rispettivi soggetti
titolari.
Già riguardo al primo tipo di posizione di garanzia, ossia la posizione di protezione, si pone un
problema di limiti alla responsabilità, infatti si ritiene che il soggetto titolare della posizione di
protezione sia vincolato all’impedimento di eventi lesivi del bene oggetto di protezione cagionati sia da
fatti naturali sia dall’aggressione di un terzo, e sussistono comunque oscillazioni di orientamento nella
prassi applicativa. Non mancano comunque posizioni dottrinali tendenti a denunciare eccessi
rigoristici della giurisprudenza in questo ambito. Ad esempio la Corte di cassazione nel 1935 ha
condannato un padre a titolo di concorso in omicidio doloso per avere assistito (senza fare nulla,
benché fosse contrario al proposito criminoso) ad una specie di consiglio di famiglia in cui si era deciso
di uccidere il figlio più giovane, convinti che il suo sangue avrebbe fatto scoprire un tesoro. Una parte
della dottrina, per evitare queste condanne aberranti, ha proposto di introdurre correttivi sul piano
dell’elemento psicologico, ritenendo, cioè, che un limite all’equiparazione tra il non impedire l’evento e
il cagionarlo siano i reati commessi con dolo indiretto o eventuale. Già la dottrina meno recente ha
però segnalato l’inefficacia dei rimedi circoscritti all’elemento soggettivo, vista anche la grande
difficoltà di accertare la vera intenzione dell’omittente.
Il diritto penale societario è un altro dei settori in cui il concorso mediante omissione ha fatto
scontrare le opinioni di dottrina e giurisprudenza, soprattutto a riguardo dell’individuazione della
portata e dei limiti della posizione di garanzia di amministratori e sindaci, come presupposto di
obblighi di impedimento di reati commessi da altri membri della società. La giurisprudenza, a questo
proposito, tende tradizionalmente a interpretare gli obblighi di impedimento in chiave espansiva,
mentre la dottrina sostiene che la configurabilità di posizioni di garanzia a scopo impeditivo
presupponga un’equilibrata corrispondenza tra doveri e poteri di impedimento. Inoltre, se si
condividesse la tesi secondo la quale la responsabilità per omesso impedimento dell’evento andrebbe
circoscritta al novero dei reati casuali puri, anche nell’ambito del diritto penale societario, la questione
degli obblighi di impedimento di reati gravanti su organi societari finirebbe per diventare di scarsa
importanza.
157
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE QUINTA
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
I normali criteri di imputazione soggettiva di un fatto al suo autore sono il dolo e la colpa (art. 42
comma 2), ma all’art. 42 comma 3 viene disposto anche che “la legge determina i casi nei quali
l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione”, e
per “altrimenti” si intende la responsabilità oggettiva, la quale è la responsabilità in virtù della quale
un determinato evento viene posto a carico dell’autore in base al solo rapporto di causalità
materiale. La responsabilità oggettiva dunque (come ad esempio vi è nell’aberractio delicti, nella
responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, ecc.) introduce eccezioni vistose al
principio di colpevolezza, ma ci si deve chiedere se esse siano giustificabili.
Le ragioni politico-criminali sottese alla responsabilità oggettiva possono mutare nel tempo, e questo
spiega perché molte delle attuali ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le quali quella del delitto
preterintenzionale e dei reati aggravati dall’evento) vengano fatte tradizionalmente risalire al vecchio
principio canonistico-medievale “qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu”, in base al quale di
riteneva che il delinquente-peccatore (delitto e peccato venivano quasi a coincidere) dovesse
rispondere di tutte le conseguenze oggettivamente cagionate dalla sua precedente azione criminosa,
fossero esse volute, non volute, prevedibili o fortuite. In epoca illuministica il principio predetto è stato
reinterpretato in chiave di prevenzione generale, sostenendo così che l’addossare al potenziale autore
tutte le conseguenze materialmente connesse alla sua azione illecita dovrebbe fungere da deterrente
particolarmente forte. Secondo una parte della dottrina contemporanea proprio questa maggiore
efficacia incriminatrice dovrebbe continuare a giustificare il mantenimento di almeno alcuni forme di
responsabilità obiettiva.
In realtà questa maggior efficacia preventiva è più presunta che reale, infatti il convincimento non si
può dimostrare su piano empirico, ed è poi poco realistico pensare che la maggior parte dei potenziali
rei siano così esperti in diritto penale da potere cogliere la sottile differenza tra responsabilità
colpevole e oggettiva. Il ricorso alla responsabilità oggettiva può anche servire, nell’ambito
processuale, ad eliminare difficoltà probatorie riguardo ai casi in cui risulta complesso l’accertamento
giudiziale del dolo o della colpa (e questo è avvenuto soprattutto nell’ambito delle contravvenzioni).
Infatti, le ragioni che indussero il legislatore del ’30 a rinunciare ad esplicite deroghe alla colpevolezza
motivate da esigenze meramente probatorie sono valide tutt’oggi, e appaiono anzi rinforzate dal
crescente riconoscimento del carattere costituzionalmente inderogabile del principio di colpevolezza.
Nella nostra prassi giurisprudenziale accade talvolta che la presunzione di dolo o di colpa si manifesti
in misura eccessiva, creando così forme di responsabilità oggettiva “occulta”; in questi casi il mancato
accertamento in concreto della colpevolezza è tanto più ingiustificabile alla stregua dei principi
generali, poiché la configurazione legislativa dell’illecito di per sé richiede il dolo o la colpa come
presupposti dell’imputazione soggettiva, e dunque degradando la responsabilità a responsabilità
oggettiva si va contro il volere del legislatore.
Si può dunque concludere che per giustificare deroghe al principio di colpevolezza non bastano né
ragioni di prevenzione generale, né ragioni di semplificazione probatoria.
Infine, la responsabilità oggettiva non configura un modello delittuoso autonomo, ma si innesta
strutturalmente nelle diverse tipologie delittuose.
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E PRINCIPI COSTITUZIONALI
L’art. 27 comma 1 Cost. sancisce il principio del carattere personale della responsabilità penale, e
dunque la compatibilità della responsabilità oggettiva con le norme costituzionali varia in base alla
portata che si assegna a questo principio:
una prima interpretazione, cd. interpretazione “minima” del principio della personalità,
sostiene che la responsabilità oggettiva sia compatibile con la Costituzione perché pur sempre
ancorata, attraverso il rapporto della causalità materiale, alla condotta dello stesso soggetto
destinatario dell’azione, e sostiene che l’unico limite sia invece la responsabilità per fatto altrui
158
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
(ad esempio rappresaglie nei confronti di innocenti per punire indirettamente nemici). Questa
tesi però non convince perché mortifica il significato innovativo dell’importante affermazione
di principio fatta dal legislatore costituzionale, infatti in realtà il divieto di responsabilità per
fatto altrui appartiene già alle origini della civiltà giuridica, e sarebbe per questo stato
osservato anche se non espresso in Costituzione.
Vi è anche chi sostiene che per affermare l’appartenenza “personale” del fatto all’autore
sarebbe sufficiente esigere la possibilità del controllo finalistica sul divenire causale, per cui la
responsabilità oggettiva presupporrebbe la prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo.
Tuttavia, va detto che la prevedibilità e l’evitabilità, al di fuori dell’ambito delle conseguenze
dannose prevedibili delle attività intrinsecamente pericolose ma socialmente utili (il cui rischio
consentito, se superato, fonda la responsabilità colposa), bastano già a fondare la
responsabilità colposa, e verrebbe perciò meno la presunta differenza tra colpa e
responsabilità oggettiva.
Si deve invece considerare incostituzionale la responsabilità oggettiva se si legge il principio
della personalità nella sua interpretazione “massima”, ossia come sinonimo di
responsabilità personale colpevole. Se infatti la colpevolezza necessita almeno della presenza
di una condotta contraria al dovere di diligenza (colpa), allora non si può parlare di
colpevolezza nella responsabilità oggettiva.
Si può giungere a concludere per l’incompatibilità tra responsabilità oggettiva e Costituzione anche
considerando che l’art. 27 comma 3 Cost. dispone la funzione rieducativa della pena, la quale impone
che il fatto addebitato sia psichicamente riportabile al soggetto da rieducare, altrimenti non si
potrebbe muovergli rimprovero e non avrebbe dunque senso cercare di rieducarlo.
Si è già visto che la tesi della costituzionalizzazione del principio di colpevolezza argomentando in base
al collegamento sistematico dei commi 1 e 3 dell’art. 27 Cost. è stata accolta dalla Corte costituzione
nelle sentenze n. 364/1988 e n. 1058/1988. Se dunque l’inderogabile rispetto del principio di
colpevolezza fa, come ammette la Corte, da presidio garantistico a salvaguardia della libertà di
programmazione delle azioni future di ciascuno, la responsabilità oggettiva è costituzionalmente
inammissibile perché confligge con questa libertà: egli infatti non potrebbe programmare la sua vita in
modo da sfuggire al rischio di condanne se queste ultime possono dipendere anche da fattori che egli
non può controllare, ed è per questo che nelle sentenze citate la Corte stabilisce la necessità “che
ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano
soggettivamente collegati all’agente”. Per questi motivi appaiono incostituzionali quasi tute le
principali ipotesi codicistiche di responsabilità oggettiva.
La presa d’atto che sussiste un contrasto tra la responsabilità oggettiva e il principio costituzionale
della personalità della responsabilità penale può però indurre a cercare un’interpretazione più
costituzionalmente conforme delle norme penali coinvolte, ed è stato così ad esempio sostenuto che
l’art. 27 comma 1 Cost. imponga una diversa lettura della preterintenzione, considerandola non come
un misto di dolo e responsabilità oggettiva, ma piuttosto un dolo misto a colpa. Si dovrebbe però così
tentare una rilettura adeguatrice di tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva, e in ognuna di esse
un’interpretazione costituzionalmente conforme induce a richiedere in relazione agli elementi di
fattispecie che in base all’impostazione originaria del codice andrebbero attribuiti all’agente per la loro
sola esistenza oggettiva, qualcosa in più in termini di prevedibilità o conoscibilità in concreto,
assimilabile il più possibile alla colpa.
Questo è l’orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, in particolare con
l’importante sentenza a sezioni unite del 22 gennaio 2009. L’ipotesi del fatto era riconducibile alla
morte o lesione come conseguenza di un altro delitto ex art. 586 c.p. (nello specifico si trattava di uno
spacciatore imputato della morte di un tossicodipendente), ma la Cassazione ha affermato i seguenti
principi generali: la responsabilità per l’evento non voluto presuppone il nesso di causalità con
l’agente, ma anche che in capo ad egli sia accertata la presenza di un elemento soggettivo costituito da
una colpa in concreto, a sua volta ancorata ad un coefficiente di prevedibilità e di evitabilità dell’evento
159
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
valutate dal punto di vista di un agente modello razionale al posto di quello concreto (con anche tutte
le circostanze del caso).
Tuttavia, questo nuovo orientamento non è risolutivo quanto potrebbe a primo acchito sembrare,
infatti, dal momento che la disciplina ordinaria è tuttora immutata, non è detto che la strada
dell’interpretazione adeguatrice venga percorsa dalla prassi applicativa, e inoltre in dottrina non tutti
sono d’accordo sul fatto che una generalizzata conversione delle ipotesi di responsabilità oggettiva in
responsabilità colposa sia la scelta più razionale e opportuna in ambito politico-criminale.
Più in particolare in dottrina si concorda sull’esigenza di rivedere l’attuale disciplina dei casi di
responsabilità obiettiva, ma vi è anche chi sottolinea l’opportunità di mantenere forme di trattamento
penale più severo per alcune ipotesi di delitto aggravato dall’evento che presentino una tipica e
accentuata pericolosità del fatto criminoso-base. È in realtà discutibile che queste ipotesi presentino
una maggiore pericolosità, e la tesi del maggiore disvalore risente ancora della vischiosità del vecchio
e screditato principio del versari in re illicita.
CASI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA “PURA”
Nel codice Rocco vi sono casi di responsabilità oggettiva pura e casi di responsabilità oggettiva mista a
dolo o a colpa. I casi di responsabilità oggettiva pura sono i seguenti:
1. Aberratio delicti: l’art. 83 c.p. dispone che “se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del
reato o per un’altra causa si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a
titolo di colpa dell’evento non voluto quando il fatto è previsto dalla legge come delitto
colposo”. Fatta dunque salva la possibilità di un’interpretazione correttiva, “a titolo di colpa” si
riferisce al piano delle conseguenze sanzionatorie, nel senso che verranno applicate le pene
previste per il reato colposo, mentre rimane di natura oggettiva il criterio di attribuzione della
responsabilità
2. Responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto: l’art. 116 c.p. stabilisce
che qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da qualcuno dei concorrenti, ne
risponde anche egli se l’evento è conseguenza della sua azione.
REATI DI STAMPA
Nella sua originaria formulazione, l’art. 57 c.p. chiamava a rispondere di omesso impedimento dei
reati commessi a mezzo stampa il direttore o vice-direttore del giornale, per il solo fatto oggettivo
della loro posizione di supremazia. Con la sentenza n. 3/1957 la Corte costituzionale ha respinto
l’eccezione di incostituzionalità di questo articolo, ma ha comunque sollecitato una riforma legislativa,
che è stata realizzata con la legge n. 127 del 4 marzo 1958. Il nuovo articolo dispone ora che “slava la
responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o vicedirettore
responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo
necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di
colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente
un terzo”. Una parte della dottrina continua a sostenere che l’articolo configuri sempre un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, sostenendo che “ titolo di colpa” significhi soltanto che il fatto deve essere
disciplinato come se fosse colposo.
La dottrina e giurisprudenza prevalente, tuttavia, considerano oggi la figura di reato prevista dall’art.
57 c.p. come colposa a tutti gli effetti, e questa è probabilmente l’interpretazione più corretta, anche
perché corrisponde meglio all’effettivo intento del legislatore della riforma. Per evitare però che la
responsabilità del direttore si trasformi in una responsabilità di posizione si devono precisare il più
possibile limiti e portata dell’obbligo di controllo, e va detto che, anche se il giudice deve
necessariamente specificare il contenuto dell’obbligo di controllo nei casi concreti, va respinta la tesi
che dà al giudice una “delega in bianco” per l’individuazione della diligenza richiesta.
Per circoscrivere l’ambito dei doveri di controllo di direttore e vice di dovrà dunque tenere conto sia
delle modalità di funzionamento, della struttura e dell’articolazione dei ruoli all’interno delle moderne
aziende giornalistiche, sia della natura “informativa” o “valutativa” dello scritto da controllare (per la
parte informativa il direttore dovrà effettuare un controllo più scrupoloso della veridicità delle fonti, e
160
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
meno penetrante per le valutazioni personali del giornalista).
CASI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA “MISTA”
LA PRETERINTENZIONE
La maggior parte delle nostre ipotesi di responsabilità oggettiva si innestano su una precedente
fattispecie-base, spesso basata su un’azione dolosa, ma vi sono comunque ipotesi di responsabilità
oggettiva connesse ad una fattispecie-base colposa.
Si è già detto che il codice fa riferimento alla preterintenzione all’art. 42 comma 2, mentre alla
resposnabilità oggettiva si fa riferimento nel comma 3 quando si dispone che “la legge determina i casi
nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente”. Le ipotesi pacifiche di preterintenzione nel
nostro ordinamento sono soltanto due:
Omicidio preterintenzionale ex art. 584: che avviene quando un soggetto cagiona
involontariamente la morte di un uomo con atti che erano diretti a percuotere o ledere
Aborto preterintenzionale ex art. 18 comma 2 della legge n. 194 del 22 maggio 1978: che si
ha quando si cagiona involontariamente un aborto con azioni che erano dirette a provocare
lesioni
Il delitto preterintenzionale non delinea in realtà un nuovo modello di responsabilità, ma costituisce
piuttosto un’ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva, infatti l’art. 43 comma 2 dispone che il
delitto è “preterintenzionale o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento
dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”: si ha dunque un’azione dolosa
relativamente all’evento meno grave voluto, ed un evento-conseguenza non voluto, ma per il quale la
legge non richiede espressamente la colpa, e per il quale basta dunque la semplice responsabilità
oggettiva.
L’opposta tesi, che sostiene che la preterintenzione sia un misto di dolo e colpa, fa talvolta leva
sull’argomento che si sia in presenza di un caso di colpa per inosservanza di leggi, nel senso che
l’evento più grave non voluto conseguirebbe alla violazione della norma penale che vieta l’azione
dolosa diretta a commettere il reato meno grave. Tuttavia, si può a questa tesi obiettare che la colpa
per inosservanza di leggi consegue alla violazione non di una qualsiasi legge, ma solo di quelle a
finalità precauzionale che abbiano specificamente per scopo l’impedimento di eventi come quello
verificatosi.
Tuttavia, la categoria dei delitti preterintenzionali non è comunque priva di riserve, infatti essa
rappresenta una filiazione del dolo indiretto, concezione del dolo già da tempo abbandonata, e per
questo la preterintenzione si espone a tutte le obiezioni avanzatili contro la responsabilità oggettiva
(per questo una riforma del codice potrebbe abrogare questo istituto).
I REATI AGGRAVANTI DALL’EVENTO
Sono reati aggravati o qualificati dall’evento quelli che subiscono un’aumento di pena per il
verificarsi di un evento ulteriore rispetto ad un fatto-base che già costituisce reato.
Il fenomeno dei delitti aggravati dall’evento è riscontrabile soprattutto nell’ambito dei reati
commissivi dolosi, ma non mancano comunque ipotesi di reati omissivi, di delitti colposi o di
contravvenzioni aggravanti da un evento più grave.
I reati aggravati dell’evento sono forse l’espressione più tipica dell’antico principio “qui in re illicita
versatur tenetur etiam pro casu”, infatti l’evento aggravatore viene per questo principio accollato
all’agente in base al mero nesso causale, a prescindere da requisiti di colpevolezza.
Tradizionalmente i reati di questo tipo si distinguono in due categorie a seconda che:
l’evento aggravante sia voluto o meno (ad esempio il reato di calunnia, che rimane tale a
prescindere dalla circostanza che l’evento aggravante sia voluto o meno)
la volontà dell’evento più grave comporti l’applicabilità di una diversa fattispecie penale (ad
esempio i delitti di abuso di mezzi di correzione o disciplina, o di aborto non consentito, che si
trasformano in omicidi o lesioni personali se gli eventi aggravatori sono voluti).
161
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Il vero problema dei reati aggravati dall’evento è in realtà la loro natura giuridica, infatti ai tempi
dell’emanazione del codice si riteneva che l’evento aggravatole fosse da attribuire all’agente in base al
semplice nesso di causalità materiale (responsabilità oggettiva), ma il dibattito teorico nel tempo è
andato incentrandosi sul problema dell’inquadramento formale dei reati in esame tra le figure di reato
circostanziato o tra le fattispecie autonome di reato.
Privilegiando però il terreno di maggiore rilevanza sostanziale dei criteri di attribuzione della
responsabilità, non mancano oggi ragioni per scegliere la soluzione che tende a rendere i reati in
esame il più possibile compatibili con il principio di colpevolezza. Questa soluzione consiste nel
ricondurre i reati aggravati dall’evento al modello dei reati circostanziati. Abbiamo infatti detto che a
seguito della riforma del 1990 il regime di imputazione delle circostanze aggravanti non risponde più
alla logica della responsabilità obiettiva, ma presuppone qualcosa di simile alla colpa come coefficiente
minimo di responsabilità, sotto forma di conoscenza o conoscibilità del fatto che integra la circostanza,
e a questo nuovo regime di imputazione appartengono anche le circostanze che consistono in eventi
futuri successivi alla realizzazione della condotta, come accade tipicamente nei delitti aggravati
dall’evento.
Questo inquadramento può comunque suscitare perplessità, in particolare riguardo alla conseguente
applicabilità anche ai reati aggravati dall’evento della regola di bilanciamento contenuta nell’art. 69
c.p., che, se applicata troppo indiscriminatamente o troppo indulgentemente, potrebbe far sorgere
l’incongruenza di equiparare circostanze qualitativamente differenti tra loro (annullando ad esempio
con l’attenuante dello stato d’ira l’aggravante molto grave della morta o delle lesioni gravi). Questi
inconvenienti non sembrano comunque un’obiezione insormontabile, poiché il giudice dovrebbe
operare il bilanciamento con molta cautela.
CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ
L’art. 44 c.p. dispone che, quando per la punibilità del reato la legge richiede che si verifichi una
condizione, il colpevole risponde del reato anche se l’evento da cui dipende il verificarsi della
condizione, non è da lui voluto. Si può porre un problema di attribuzione dell’evento condizione a
titolo di responsabilità oggettiva in presenza di due condizioni:
1. che si tratti di condizioni di punibilità causalmente ricollegabili all’azione tipica
2. che si tratti di condizioni di punibilità “intrinseche”, che incidano dunque sulla lesione del bene
protetto. Si deve comunque ritenere che anche l’attribuzione oggettiva delle condizioni
intrinseche di punibilità contrasti con la responsabilità personale colpevole dell’art. 27 Cost., in
quanto esse dovrebbero essere imputabili almeno a titolo di colpa sulla base dei principi fissati
dalle sentenze n. 364/88 e 1085/88.
162
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE SESTA
CONCORSO DI REATI E CONCORSO DI NORME
CAPITOLO UNO
CONCORSO DI REATI
Accade di norma che ad una condotta umana corrisponde un reato e a più condotte umane più reati,
ma nei confronti della stessa condotta possono anche influire più norme incriminatrici, e questo può
dare luogo ad un concorso di reati o ad un concorso apparente di norme.
Il concorso di reati si distingue in:
Concorso materiale: si ha quando uno stesso soggetto realizza più reati con più azioni od
omissioni (e in questo caso si applicheranno tante pene quanti sono i reati)
Concorso formale: si ha quando uno stesso soggetto commette più reati con una sola azione
od omissione (e in questo caso si applicherà la pena prevista per la violazione più grave,
aumentata fino al triplo)
Si ha invece concorso apparente di norme quando una stessa condotta risulta solo apparentemente
riconducibile a più fattispecie incriminatrici, ma integra in realtà un solo reato. Concorso di reati e
concorso apparente di norme rappresentano dunque fenomeni simmetrici e contrari.
UNITÀ E PLURALITÀ DI AZIONE
Il punto di partenza della teoria del concorso di reati è la distinzione tra unità e pluralità di azione.
Si ha una azione quando si realizzano i presupposti minimi che integrano la fattispecie incriminatrice,
anche se la condotta tipica risulta dal compimento di più atti (es. omicidio effettuato con un numero x
di pugnalate). Si ha unità di azione anche quando la stessa fattispecie astratta richiede la
realizzazione di più atti per la sussistenza del reato (es. rapina). Si ha unità di azione anche nei delitti
di durata (es. sequestro di persona). Un punto più complicato è quello che riguarda i casi di
reiterazione della stessa azione tipica entro un breve lasso di tempo, come ad esempio nel caso di un
ladro che si impossessi di tanti oggetti con molteplici e successivi atti di sottrazione.
Da tempo, per individuare un criterio per la distinzione di unità e pluralità di azione, si fa ricorso ad
un approccio di tipo normativo-sociale basato sul senso comune, richiedendo cioè, come requisiti per
l’unitarietà dell’azione, la contestualità degli atti e l’unicità del fine (ad esempio la citata azione del
ladro sarebbe in quest’ottica un’azione unitaria). Questo criterio non riesce però a risolvere sempre la
questione, infatti la considerazione dell’unicità sia di scopo che di contesto non va separata dalla
contemporanea ricognizione del significato normativo delle fattispecie che di volta in volta vengono in
questione. La distinzione, quindi, talora coincide con quela tra unità e pluralità di reati, in altri lascia
del tutto impregiudicata del carattere unico o plurimo del reato.
UNITÀ DI AZIONE NEI REATI COLPOSI E NEI REATI OMISSIVI
Nei reati colposi vi è unità di azione se, nonostante la violazione di più obblighi di diligenza, l’evento
tipico si è verificato una sola volta, mentre, se si sono verificati più eventi tipici o più volte lo stesso
evento tipico, allora bisogna stabilire se tra un evento e l’altro l’agente fosse in grado o meno di
adempiere all’obbligo di diligenza (se lo era, si avrà pluralità di azione, altrimenti unità).
Nei reati omissivi impropri vi è una sola omissione se il garante poteva impedire i diversi eventi solo
attivandosi contemporaneamente, mentre vi solo più omissioni se, dopo il primo evento, egli poteva
impedire gli altri. Nei reati omissivi propri, invece, si hanno più omissioni se l’omittente viola
contemporaneamente più obblighi di condotta, ma i diversi obblighi potevano adempiersi uno dopo
l’altro.
163
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CONCORSO MATERIALE
Il concorso materiale può essere di due tipologie:
Concorso materiale omogeneo: quando, con più azioni od omissioni, un soggetto realizza più
violazioni di una stessa norma incriminatrice (ad esempio se un soggetto uccide prima un
uomo e poi un altro)
Concorso materiale eterogeneo: violazione di più norme incriminatrici (ad esempio se un
soggetto prima ruba un’arma e poi commette un omicidio)
L’art. 71 c.p. tratta dell’ipotesi in cui con una sola sentenza o un solo decreto si deve pronunciare
condanna per più reati contro la stessa persona, mentre l’art. 80 c.p. si riferisce all’ipotesi in cui, dopo
una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato
commesso anteriormente o posteriormente alla stessa condanna, o quando si devono eseguire più
sentenze o decreti nei confronti della stessa persona.
Mentre il codice Zanardelli del 1889 prevedeva il cumulo giuridico delle pene, il codice Rocco ha
introdotto il cumulo materiale delle pene, sulla base del principio tot crimina, tot poenae (le pene
previste per ciascuno dei delitti commessi si cumulano). Vi sono però dei temperamenti, che
riguardano:
concorso di reati che comportano l’ergastolo e di reati che comportano pene detentive
temporanee (art. 72)
concorso di reati che comportano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa
specie (art. 73)
concorso di reati che comportano pene detentive di specie diversa (art. 74)
concorso di reati che comportano pene pecuniarie di specie diversa (art. 75)
ulteriori limiti previsti agli articoli da 76 a 79 c.p.
L’ambito di applicabilità del cumulo materiale delle pene è stato poi ridotto dalla riforma del 1974,
che ha esteso la figura del reato continuato alle ipotesi di violazione di norme incriminatrici
eterogenee ma con uno stesso disegno criminoso, cui, secondo l’art. 81 c.p., si deve applicare il più mite
regime del cumulo giuridico delle pene.
Va comunque condiviso l’orientamento prevalente, che tende a negare al concorso materiale di reati
una specifica rilevanza come autonomo istituto di diritto sostanziale, ma piuttosto come
un’unificazione in via esecutiva delle sanzioni applicabili al soggetto.
CONCORSO FORMALE
REQUISITI
Si ha concorso formale di reati quando uno stesso soggetto commette una pluralità di violazioni della
legge penale con una sola azione od omissione, e si fa anche in questo caso la distinzione tra:
Concorso formale omogeneo: in cui viene più volte violata la stessa disposizione
incriminatrice (es. omicidio plurimo)
Concorso formale eterogeneo: in cui la pluralità di violazioni riguarda invece diverse
disposizioni incriminatrici
Il presupposto del concorso formale è quindi un’unicità di azione od omissione, ma non è sempre facile
stabilire quando ad una stessa azione/omissione corrispondano più reati.
1. Unicità di azione e pluralità di reati nel concorso formale eterogeneo: questo avviene
solitamente quando un nucleo del fatto corrisponde a due o più fattispecie incriminatrici,
mentre le parti residue corrispondono per alcuni elementi ad una fattispecie e per altri ad
un’altra (se ad esempio un borseggiatore si divincolasse dalla persona da lui derubata e da un
pubblico ufficiale nel frattempo intervenuto, compirebbe insieme resistenza a pubblico
ufficiale e rapina impropria, ma nello specifico vi sarebbero elementi come il prendere il
portafoglio appartenenti alla sola rapina).Perché la confluenza di più fattispecie verso la stessa
condotta fa configurare un concorso formale eterogeneo se questa confluenza è effettiva,
altrimenti vi sarebbe un conflitto apparente di norme.
164
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
2. Unicità di azione e pluralità di reati nel concorso formale omogeneo: per stabilire invece
se si configuri un concorso formale omogeneo bisogna verificare quante volte la stessa azione
violi una stessa disposizione incriminatrice.
Rispetto alle fattispecie incriminatrici che tutelano beni altamente personali (vita, integrità
fisica, ecc.) si configura una pluralità di reati se con la stessa azione si ledono soggetti passivi
diversi, mentre rispetto alle fattispecie incriminatrici che tutelano beni non personali, in
presenza di una sola azione, pur lesiva di soggetti passivi differenti, non si configura sempre
una pluralità di reati (ad esempio è il caso di un furto di un unico oggetto appartenenti a più
proprietari).
DISCIPLINA GIURIDICA
L’art. 81 comma 1 c.p., così come riformato dalla riforma novellistica del 1974, stabilisce che chi, con
una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della stessa
disposizione, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino
al triplo. Con l’introduzione del cumulo giuridico al posto del cumulo materiale delle pene, si è
eliminato uno degli aspetti più repressivi del codice Rocco, riportando la disciplina a quella che vigeva
con il codice Zanardelli del 1889.
Le ragioni per cui comunemente si critica il cumulo materiale e si preferisce il cumulo giuridico sono
due:
1. il peso umano della sofferenza, almeno nel caso della pena detentiva, si accresce
progressivamente con la durata delle pene (dunque con un cumulo materiale si avrebbe
sproporzione tra numero di reati ed entità delle pene
2. chi compie più reati con una sola azione attua una sola risoluzione criminosa, e dimostra
dunque una minore pericolosità sociale. Questa seconda motivazione non è però esente da
dubbi, e va comunque notato che il legislatore reintroducendo il cumulo giuridico non ha però
esplicitato se questo regime sia applicabile anche nei casi in cui le pene previste per i reati in
concorso siano di specie diversa.
All’art. 81 è stato aggiunto un nuovo comma con la riforma del 2005, il quale ha portato ad un nuovo
ed ingiustificato furore repressivo nei confronti del soggetto recidivo reiterato obbligatorio. Il nuovo
comma dispone infatti che “fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso
formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata
la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può comunque
essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave”.
REATO CONTINUATO
L’istituto del reato continuato è una particolare figura di concorso materiale, disciplinato in
maniera autonoma perché la pluralità di reati commessi dalla stessa persona fa parte dello stesso
disegno criminoso, e ciò giustificherebbe un trattamento più mite perché dimostrerebbe una minore
riprovevolezza. Tuttavia, vi è anche chi sostiene che il “medesimo disegno criminoso" debba piuttosto
costruire un’aggravante.
Nel codice del 1930 si annoveravano tra i requisiti del reato continuato la molteplice violazione di una
stessa disposizione di legge, ma l’art. 81 cpv. a seguito della riforma del 1974 ammette la
continuazione dei reati anche in presenza della violazione di norme incriminatrici eterogenee. Questo
perché prima della riforma la giurisprudenza si era spesso trovata di fronte ad episodi delittuosi
portatori di un disvalore penalmente unitario, ma insuscettivi di venire considerati reati contanti
perché integravano diversi schemi di reato corrispondenti a diverse violazioni di disposizioni
incriminatrici.
Va comunque notato che una particolarità consiste nel fatto che, a seguito della riforma del processo
penale, l’istituto della continuazione può essere applicato anche dal giudice di esecuzione, infatti l’art.
165
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
671 c.p.p. stabilisce che in caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il p.m. possono chiedere al giudice
l’esecuzione dell’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato (se non era
stata esclusa dal giudice della cognizione).
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO CONTINUATO
1. Pluralità di azioni ed omissioni: l’art. 81 c.p. per pluralità di azioni od omissioni intende una
pluralità di condotte autonome che danno luogo ad altrettanti episodi criminosi. Le diverse
azioni, pur non dovendosi intendere in senso naturalistico (non valgono le tante pugnalate, o le
tante azioni con cui si è rubata la refurtiva, ecc.), possono essere compiute in tempi diversi, con
un notevole lasso di tempo l’una dall’altra, ma quanto maggiore sarà la distanza tanto più
gravosa risulterà la prova dello stesso disegno criminoso.
2. Pluralità delle disposizioni di legge violate: secondo requisito è la pluralità delle
disposizioni di legge violate, introdotto con la riforma novellistica del 1974, e differente da
molti altri ordinamenti, nei quali per il reato continuato si continua ad esigere l’omogeneità dei
reati continuati.
3. Unicità del disegno criminoso: portata e limiti del reato continuato si definiscono soprattutto
in sede di interpretazione del requisito del medesimo disegno criminoso, e vi sono in
particolare due orientamenti:
secondo un primo orientamento, questo requisito sarebbe stato assunto dal legislatore
in un’accezione puramente intellettiva, ed equivarrebbe dunque ad una mera
rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi delittuosi, e dunque un
programma iniziale di tutte le attività (non basterebbe una generica programmazione
di attività delinquenziale);
un secondo indirizzo vede invece l’unicità del disegno criminoso come una
rappresentazione anticipata che deve però presentare l’ulteriore requisito dell’unicità
dello scopo, e dunque i reati devono porsi in un rapporto di interdipendenza funzionale
al conseguimento di un unico fine.
È probabilmente da preferire questo orientamento, dal momento che non si richiedesse
l’unicità dello scopo, allora non sapremmo più riconoscere quale sia l’elemento
significativo in grado di accomunare reati anche del tutto eterogenei tra loro, inoltre,
l’unicità dello scopo è data dalla stessa ratio della diminuzione della pena prevista
dall’art. 81 cpv. (la pena viene diminuita perché si considera che il reo non abbia tante
e differenti “determinazioni criminose”, ma una soltanto).
Posto dunque che un requisito del reato continuato è anche l’unicità dello scopo, questa figura di
reato può comprendere solo illeciti sorretti dalla volontà di commetterli, e non può quindi applicarli ai
reati colposi; è invece ammessa la continuazione per le contravvenzioni, purché siano in forma dolosa.
REGIME SANZIONATORIO
L’art. 81 cpv. stabilisce che al reato continuato si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato
più grave aumentata fino al triplo, sulla base dunque del cumulo giuridico (stesso regime cui viene
sottoposto il concorso formale di reati al comma 1). All’ultimo comma viene però precisato che la pena
non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile sommando le singole pene dei reati in
concorso.
Sorge allora il primo problema, ossia quello di determinare il concetto della violazione più grave, e
secondo un primo orientamento per individuare quale sia la violazione più grave occorre riferirsi
all’astratta previsione legislativa, e dunque alla qualità e all’entità delle sanzioni applicabili per i
singoli reati in continuazione, tenendo conto anche di aggravanti, attenuanti, recidiva, e stadio di
166
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
consumazione o di tentativo. Un altro orientamento ritiene che il riferimento vada invece fatto non
soltanto alla previsione legislativa astratta, ma anche a tutti gli altri elementi (anche compresi gli indici
di commisurazione della pena dell’art. 133 c.p.) che possono incidere sulla valutazione dei singoli
episodi in continuazione, e la violazione più grave sarà così quella che ad un esame complessivo dei
fatti coinvolti nella vicenda concreta risulta più gravemente, non punibile, ma punita. La tesi
preferibile è però quella tradizionale, poiché ad accettare questa seconda si rischierebbe si stravolgere
la valutazione fatta dal legislatore sull’obiettiva gravità dei reati, operata attraverso la scelta dei
minimi e massimi edittali.
Un secondo problema è poi l’applicabilità del cumulo giuridico nei casi in cui i reati commessi
sono punibili con pene eterogenee (problema analogo a quello che si pone in sede di concorso
formale di reati). La dottrina propende per un’applicazione la più ampia possibile del cumulo giuridico,
mentre la giurisprudenza mostra orientamenti oscillanti e contraddittori: inizialmente si è teso ad
escludere la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee (ritenendo che sarebbe altrimenti
stato violato il principio della legalità delle pene poiché si sarebbe applicata una pena diversa da quella
prevista da ciascun reato), ma successivamente sono emersi orientamenti favorevoli ad ammettere la
continuazione, entro limiti non sempre coincidenti. Nel caso, infatti, di reati puniti con pene di specie
diversa (es. reclusione e arresto), dopo interventi di segno contrario delle Sezioni Unite, la Corte
costituzionale con la sentenza interpretativa n. 312 del 1988 ha preso posizione, avallando
l’orientamento estensivo ed affermando che non è ragione per non dare massima espansione al reato
continuato e ai relativi benefici, e sostenendo inoltre che non vi sia una violazione del principio di
legalità poiché anche la pena risultante dal cumulo giuridico è pur sempre pena legale prevista
dall’ordinamento all’art. 81 c.p.
L’ammissibilità del reato continuato in casi di reati puniti con pene di genere diverso (es. arresto e
multa) è invece ancora controversa, e la sua soluzione dipende dall’individuazione dei criteri alla cui
stregua operare l’aumento della pena prevista per il reato ritenuto più grave.
Sono dunque prospettabili più soluzioni:
1. operare un aumento della pena base prevista per il reato più grave, per cui la pena pecuniaria
si trasformerebbe nella parte aggiuntiva di pena detentiva in base ai criteri di ragguaglio
dell’art. 135, ma questa soluzione confligge con il principio del favor rei sotteso al reato
continuato
2. fissare la pena base per il reato più grave, aumentarla rispetto agli altri reati in termini di pena
detentiva, e convertirla subito dopo in pena pecuniaria con i criteri di ragguaglio dell’art. 135
c.p
3. oppure (e questa soluzione si sta consolidando in giurisprudenza soprattutto per i casi di reati
meno gravi puniti con pena detentiva e pena pecuniaria congiunta) applicare una pena
complessiva, costituita da due pene di genere diverso - ossia detentiva e pecuniaria - in modo
che una parte di sanzione sia riferibile ad entrambe le violazioni in concorso e la pena
pecuniaria attenga solo a quella meno grave.
È comunque auspicabile un intervento legislativo volto a chiarire la questione.
Un’ultima questione controversa è quella che riguarda la possibilità di ammettere la continuazione
tra reati già giudicati con sentenza irrevocabile e reati ancora sub judice. La continuazione tra
reati è stata ammessa nell’ipotesi in cui il giudicato copre la violazione più grave, cosicché l’aumento
può avvenire attraverso l’inasprimento della sanzione inflitta per il reato già giudicato. Vi sono invece
indirizzi contrastanti nell’ipotesi opposta, poiché in questo secondo caso bisogna rideterminare la
pena per la violazione più grave con la conseguenza di annullare la precedente determinazione della
pena base. La Corte costituzionale, allora, con la sentenza interpretativa n. 115 del 1987, ha avallato la
tesi favorevole alla configurabilità della continuazione, sulla base della considerazione che a seguito
della riforma del 1974 ciò che conta davvero ai fini dell’unificazione è soltanto l’unicità del disegno
criminoso, e anche sulla base del fatto che il principio dell’intangibilità del giudicato è suscettivo di
deroga quando dalla sua intangibilità derivi un ingiusto sacrificio dei diritti del condannato.
Va in ultimo precisato che anche al reato continuato si applica la nuova disciplina del trattamento del
soggetto recidivo reiterato che ha commesso reati in continuazione.
167
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
NATURA GIURIDICA
L’art. 81 comma 3 a seguito della riforma non contiene più la frase che esplicitava che le diverse
violazioni legate dal vincolo della continuazione “si considerano come un solo reato”, e questo ha
suffragato la tesi di chi considera che nel reato continuato vi siano una vera e propria pluralità di
illeciti, ma in realtà l’argomento non sembra decisivo, poiché l’eliminazione di questa frase è più un
“ritocco linguistico” che una scelta precisa del legislatore. Si può dunque dire che sia ancora oggi
meglio sostenibile la tesi secondo cui la stessa ratio dell’istituto impone di considerare il reato
continuato come uno o più reati in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che
dall’accoglimento dell’uno o dell’altro punto di vista discendono nei confronti del reo. Il reato
continuato va ritenuto reato unico ai fini dell’applicazione della pena, della dichiarazione di abitualità
e professionalità, e va invece ritenuto plurimo per l’amnistia propria, il computo della durata del
tempo necessario a prescrivere, ecc.
168
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO DUE
CONCORSO APPARENTE DI NORME
In alcuni casi il confluire di più norme incriminatrici nei confronti di uno stesso fatto è soltanto
apparente, e si ha dunque unicità di reato poiché quella applicabile è in realtà una sola norma
incriminatrice (es. Tizio si impossessa di un oggetto altrui di tenue valore per provvedere ad un grave
ed urgente bisogno: può essere sia furto comune ex art. 624 o furto in stato di bisogno ex art. 626.1
n.2). Questo fenomeno si definisce concorso o conflitto apparente di norme, i cui presupposti sono
l’esistenza di una medesima situazione di fatto, e la convergenza di una pluralità di norme che
sembrano prestarsi a regolarla. Per individuare i casi di concorso apparente di norme, e distinguerlo
quindi dal reale concorso di norme, sono stati prospettati i tre criteri:
1. Specialità
2. Sussidiarietà
3. Consunzione o assorbimento
Tra questi, solo il criterio di specialità trova esplicito riconoscimento nel codice penale, all’art. 15,
mentre gli altri sono frutto di elaborazione dottrinale, e proprio perché non riconosciuti dal codice
parte della dottrina ne contesta l’utilizzabilità.
Tuttavia, l’art. 15 c.p. si può interpretare come norma che intende disciplinare non il generale
fenomeno del concorso di norme, ma una specifica ipotesi di concorso, ossia quella in cui le norme
concorrenti si trovano in rapporto di genere a specie, e non dicendo nulla sulle ipotesi diverse dalla
specialità questo articolo non esclude e non può escludere che nel nostro ordinamento possano
operare altri criteri non previsti dalla legge. Rimane oggi una delle materie più controverse del diritto
penale.
1. SPECIALITÀ
L’art. 15 c.p. dispone che “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale
regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o la
disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”, e viene così stabilito il principio della
prevalenza della legge speciale rispetto alla legge generale. Tuttavia, il rapporto tra le due norme
è tale per cui, ove la seconda mancasse, i casi che vi rientrano sarebbero riconducibili alla prima, ed è
questo caso di furto comune (generale) e furto in stato di bisogno (speciale, e contenente quindi
elementi specializzanti, ovvero lo stato di bisogno).
Bisogna precisare che il rapporto di specialità può intercorrere non soltanto tra norma incriminatrici,
ma anche tra norme incriminatrici e norme “di liceità”, infatti ad esempio la norma che dichiara lecito
l’arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.) è speciale rispetto a quella che incrimina il sequestro di persona
(art. 605 c.p.).
Un orientamento diffuso più in giurisprudenza che in dottrina sostiene che il concetto di “stessa
materia” dell’art. 15 c.p. alluda all’esistenza sì di un medesimo fatto apparentemente riconducibile a
più norme, ma presupponga anche identità od omogeneità del bene protetto, con la conseguenza che il
rapporto di specialità intercorrerebbe soltanto tra norme poste a tutela di uno stesso bene giuridico.
Tuttavia, questa interpretazione inserisce tra i presupposti di operatività dell’art. 15 un elemento che
ne stravolge la funzione, infatti il rapporto di specialità ha natura logico-formale e, dunque, gli sono
estranei apprezzamenti di valore del tipo di quelli che è invece necessario emettere in sede di
individuazione dell’oggettività giuridica. Essa darebbe inoltre luogo a conseguenze applicative
assurde, poiché porterebbe ad esempio ad affermare il concorso di reati tra l’ingiuria, in cui il bene
tutelato è l’onore, e l’oltraggio ad un magistrato in udienza, in cui il bene tutelato è il prestigio
dell’amministrazione della giustizia, mentre si ritiene che sia più corretto affermare che in questo caso,
come in altri simili, vi sia concorso apparente.
Secondo un altro indirizzo interpretativo, il concetto di “stessa materia” farebbe riferimento non solo
alle ipotesi in cui uno stesso fatto rientra in più norme incriminatrici, ma anche in quelle in cui uno
stesso fatto concreto è riconducibile a due o più figure criminose, anche se in astratto tra esse non vi è
169
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
un rapporto di genere a specie, e si parla dunque dunque di specialità in concreto. Il rapporto di
specialità in concreto andrebbe risolto applicando dunque la norma che meglio si adatta al caso di
specie, che normalmente viene ravvisata in quella che prevede il trattamento più severo.
Dal punto di visto logico il concetto di specialità in concreto si risolve in realtà in un non-senso, poiché
non si comprende perché un rapporto di genere a specie tra due norme possa dipendere dalle
particolarità di un fatto concreto, infatti come rapporto tipicamente sussistente tra norme astratte, la
specialità o esiste o non esiste, ma non vi è una terza possibilità. In realtà l’escogitazione dell’idea della
specialità incontrato deriva dalla constatazione che il rapporto di specialità non è da solo in grado di
risolvere tutte le ipotesi di concorso apparente di norme, e lo riconferma anche il fatto che i sostenitori
stessi della specialità in concreto, nell’individuare la norma prevalente da applicare, fanno ricorso al
criterio dell’assorbimento della fattispecie meno grave in quella più grave, criterio di valore che non ha
nulla a che vedere con il principio di specialità. Si può dunque dire che parte della dottrina ha propeso
per dilatare il principio della specialità sino a snaturarne la logica perché, pretendendosi di risolvere il
problema del conflitto apparente di norme in base al solo criterio della specialità, si è poi costretti a far
dire al principio della specialità ciò che non può dire.
Un’altra parte della dottrina, invece estende il rapporto di specialità ai casi di specialità reciproca o
bilaterale, ossia ai casi in cui nessuna norma è speciale o generale, ma ciascuna è sia generale sia
speciale, poiché entrambe hanno un nucleo di elementi comuni, ma hanno anche elementi specifici e
generici rispetto ai corrispondenti dell’altra (es. l’aggiotaggio comune e l’aggiotaggio societario, che
hanno in comune gli atti di aggiotaggio, ma quello comune richiede il fine di turbare il mercato interno
- ossia un dolo specifico, mentre per quello societario basta il dolo generico, e mentre l’aggiotaggio
comune può essere commesso da chiunque, quello societario può essere commesso solo da soggetti
con determinate qualifiche). Anche in questo caso la ragione che induce ad introdurre il correttivo
della specialità reciproca o bilaterale è la constatata insufficienza del principio di specialità in senso
stretto inteso a risolvere i casi di apparente concorso di reati.
Tuttavia, la validità logica del concetto di specialità reciproca soggiace ad obiezioni non meno decisive
di quelle opponibili al concetto di specialità in concreto, infatti il rapporto di genere a specie in quanto
ha senso sul piano logico-formale in quanto un gruppo di casi rappresenta un sottoinsieme rispetto
all’insieme costituito da un altro gruppo più generico di casi, mentre non ha senso ipotizzare la stessa
relazione logica in senso inverso.
Si potrebbe dunque sostenere, ed è forse più logico, che l’ambito di applicazione del principio di
specialità vada circoscritto entro i limiti connaturati alla sua accezione originaria, e quindi il rapporto
di specialità in questo senso sussiste soltanto tra fattispecie astratte e in senso univoco. La “stessa
materia” dell’art. 15 indice dunque il presupposto dell’instaurarsi di un rapporto di specialità tra
fattispecie, ossia che ricorre una medesima situazione di fatto apparentemente sussumibile sotto più
norme.
Per risolvere il conflitto apparente di norme soccorrono però anche gli ulteriori e più idonei criteri
della sussidiarietà e della consunzione o assorbimento.
2. SUSSIDIARIETÀ
Il principio di sussidiarietà intercorrerebbe tra norme che prevedono stadi o gradi diversi di offesa
di uno stesso bene, in modo tale che l’offesa maggiore assorbe la minore, e di conseguenza
l’applicabilità dell’una norma è subordinata alla non applicazione dell’altra, secondo il principio lex
primaria derogat legi subsidiariae.
Talvolta è il legislatore stesso ad indicare esplicitamente un rapporto di sussidiarietà con l’utilizzo di
una clausola di riserva, come accade ad esempio per il reato di abuso di ufficio, che è applicabile solo
se non risultano applicabili altre fattispecie più gravi sempre a tutela della pubblica amministrazione.
Talvolta invece vi sono casi di sussidiarietà tacita, come il rapporto che intercorre tra la
contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza e il delitti di atti osceni, che sono figure che
tutelano lo stesso bene e che differiscono soltanto per la diversa intensità dell’aggressione.
Al criterio di sussidiarietà si può obiettare che non risulta sempre facilmente distinguibile dal criterio
dell’assorbimento.
170
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
L’obiezione, invece, che sostiene che il criterio della sussidiarietà si risolva in un doppione di quello di
specialità, trascura che il rapporto di specialità presuppone un rapporto logico di genere a specie tra i
rispettivi elementi delle fattispecie astratte, e dunque non si identifica con il criterio della
sussidiarietà, che implica invece l’assorbimento di un fatto meno grave in uno più grave lesivo dello
stesso bene, anche se le fattispecie astratte contengono elementi del tutto differenti.
3. ASSORBIMENTO: “NE BIS IN IDEM” SOSTANZIALE
Il principale criterio di valore utilizzato per risolvere i casi di conflitto apparente tra norme non
risolubili alla stregua del rapporto di specialità è il criterio dell’assorbimento o consunzione, che si può
invocare per escludere il concorso di reati in tutte le ipotesi in cui la realizzazione di un reato
comporta la commissione di un secondo reato che finisce col sembrare assorbito dal primo.
Questo criterio ha fondamento del principio ne bis in idem processuale, il quale non ha esplicito rilievo
costituzionale espresso nel nostro ordinamento, ma è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria
dall’art. 649 c.p.p., inoltre viene riconosciuto anche come diritto fondamentale dell’individuo nell’art.
4 Prot. 7 CEDU e nell’art. 50 della Corta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Le caratteristiche essenziali del principio dell’assorbimento sono:
esso non poggia su un rapporto logico tra norme ma su un rapporto di valore, in base al quale
l’apprezzamento negativo del fatto concreto sembra tutto già compreso nella norma che
prevede il reato più grave, con la conseguenza che la contemporanea applicazione della norma
del reato meno grave porterebbe ad un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni
esso richiede non l’identità naturalistica del fatto, ma la sua unitarietà normativo-sociale.
Per l’assorbimento, dunque, il fatto appare identico anche in presenza di azioni diverse dal
punto di vista naturalistica, purché siano tutte espressive di un disvalore penale omogeneo
avvertito come tale dalla coscienza sociale (e va per questo attribuito una sola volta allo stesso
autore l’accadimento unitariamente valutabile dal punto di vista normativo, sulla base del
principio del ne bis in idem sostanziale).
Normalmente in questi casi la norma prevalente da applicare è da individuare attraverso il criterio
del trattamento penale più severo, e, se non si ritiene decisivo il criterio del “superiore minimo
edittale”, ci si baserà su una comparazione del rango e della qualità dei beni tutelati.
L’esigenza di fare ricorso al principio dell’assorbimento ai casi non risolvibili attraverso il criterio di
specialità, appare tanto più giustificata, quanto l’interprete opera all’interno di ordinamenti
caratterizzata dalla cd. artificiosa proliferazione dei tipi di reato (es. legislazione anti-terrorismo), la
quale finisce con l’aggravare rischio che uno stesso fatto delittuoso subisca più di una qualificazione
penale.
PROGRESSIONE CRIMINOSA, ANTEFATTO E POST-FATTO NON PUNIBILI
La progressione criminosa è il fenomeno del contestuale susseguirsi di aggressioni di crescente
gravità nei confronti di uno stesso bene (es. percuotere una persona prima di ucciderla).
L’antefatto non punibile è invece un reato meno grave che, secondo l’id quod plerumque accidit,
costituisce il mezzo ordinario di realizzazione di un reato più grave (es. commettere la
contravvenzione di detenzione di chiavi false per commettere un furto).
Il post-fatto non punibile è invece una condotta criminosa susseguente il cui disvalore si ritiene già
incluso in una condotta precedente che integra un reato più grave (es. svendita di monete false a
seguito della contraffazione delle monete).
In tutti e tre questi casi si assiste ad un fenomeno caratterizzato da un’analogia sostanziale, ossia più
azioni naturalistiche in base ad un giudizio normativo-sociale sembrano riconducibili ad nazione
giuridicamente unitaria.
Va comunque detto che quelle tre ipotesi non costituiscono figure autonome, ma sono semplici
esemplificazioni del superiore principio dell’assorbimento.
171
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
REATO COMPLESSO
L’art. 84 c.p. stabilisce che le disposizioni sul concorso di reati non si applicano quando la legge
considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che
costituirebbero reato di per sé stessi. Viene così disciplinato il reato complesso, ossia un’unificazione
legislativa sotto forma di identico reato di due o più illeciti, i cui rispettivi elementi costitutivi sono
tutti compresi nella figura risultante dall’unificazione. Questo articolo ha lo scopo di evitare che
l’interprete applichi il regime di concorso di reati in casi in cui il legislatore ha unificato
normativamente fatti che integrerebbero autonome fattispecie incriminatrici.
Se però è questa la funzione pratica dell’art. 84, non si comprende perché una parte della dottrina
dilati la figura del reato complesso fino a ricomprendervi i reati complessi in senso lato, ossia i casi in
cui un reato abbraccia in un reato meno grave più elementi ulteriori che non costituiscono di per sé
reato (es. la violenza carnale che nasce dall’unificazione di violenza privata più congiunzione carnale,
che non costituisce da sola reato), infatti in questi casi l’esclusione della norma più generica in favore
dell’applicazione di quella speciale è effetto del principio di specialità.
Ulteriori disposizioni riguardanti il reato complesso sono:
Art. 84 comma 2: stabilisce che “qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato
complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono
essere superati i limiti massimi indicati negli artt. 78 e 79”,
Art. 131: stabilisce che “nei casi preveduti dall’art. 84, per il reato complesso si procede
sempre d’ufficio, se per taluno dei reati che ne sono elementi costitutivi o circostanze
aggravanti si deve procedere d’ufficio”
Art. 170 comma 2: stabilisce che “la causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o
circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.”
172
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE SETTIMA
SANZIONI
CAPITOLO UNO
I PRESUPPOSTI TEORICI E POLITICO-CRIMINALI
La pena è uno strumento di afflizione inflitto all’autore del fatto illecito, ma il momento afflittivo
implicito nella pena può in realtà essere strumentalizzato per il raggiungimento di fini diversi, che
mutano in funzione delle più generali concezioni della società e dello Stato che via via emergono nel
corso dell’evoluzione storica. L’evoluzione storico-sociale influisce, in realtà, anche sulle tecniche usate
per punire il reo, e grazie a questo processo evolutivo il concetto di sanzione penale non si limita oggi
alla sola pena, ma include anche il concetto di misura di sicurezza, ossia una misura ulteriore che
consegue alla commissione del reato ma la cui funzione si differenzia da quella delle pene stricto sensu,
in quanto il fine delle misure di sicurezza è quello di risocializzare il reo in quanto soggetto
socialmente pericoloso.
Anche le vicende del nostro sistema sanzionatorio ruotano attorno alle tre fondamentali linee-guida:
1. Retribuzione: per compensare la colpa del male commesso (che implica a sua volta il concetto
di proporzione)
2. Prevenzione generale: fondata sulla presunzione che la minaccia della pena serva a distogliere
la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi
3. Prevenzione speciale: fa leva sull’idea che l’inflizione di una pena ad un determinato soggetto
serva ad evitare che il medesimo compia in futuro altri reati
LE ORIGINARIE SCELTE SANZIONATORI DEL CODICE ROCCO
Per ragioni contingenti legate anche all’ideologia fascista, il codice Rocco enfatizza particolarmente
l’obiettivo della lotta alla criminalità come uno dei punti più qualificanti di uno Stato forte. È anche
vero, però, che a partire dalla fine dell’ottocento si assisteva in Europa ad un forte aumento della
criminalità, e dunque il legislatore del ’30 ha cercato di arginare questo fenomeno e, in più, di cogliere
l’occasione per sanare il contrasto tra la Scuola classica e la Scuola positiva, che divideva gli studiosi
italiani dell’epoca:
Scuola classica: difendevano la concezione retributiva della pena, sul presupposto
dell’esistenza del libero arbitrio, all’interno di una concezione del diritto penale di ascendenza
illuministico-liberale
Scuola positiva: respingevano l’idea retributiva della pena in quanto negavano il libero
arbitrio, e prospettavano invece un sistema di misure adattate al tipo di delinquente e aventi
finalità terapeutiche per i delinquenti recuperabili e scopi neutralizzanti per quelli
irrecuperabili
Il tentativo di conciliazione delle due scuole sfociò in un risultato che fece apparire la nostra
legislazione come avanguardista, in quanto venne introdotto il sistema del doppio binario, per il
quale si prevede, accanto e in aggiunta alla pena tradizionale inflitta sul presupposto della
colpevolezza, una misura di sicurezza, ossia una misura fondata sulla pericolosità sociale del reo e
finalizzata alla sua risocializzazione. In particolare, la funzione di prevenzione generale viene tutta
affidata alla pena, mentre alle misure di sicurezza viene affidata la funzione di prevenzione speciale.
In ogni caso, va precisato che “sistema del doppio binario” indica non soltanto la presenza di sanzioni
penali di natura diversa, ma la possibilità di applicare allo stesso soggetto, che sia al tempo stesso
imputabile e socialmente pericoloso, tanto la pena quanto la misura di sicurezza.
CONTRADDIZIONI E INSUFFICIENZE DEL SISTEMA DEL DOPPIO BINARIO
Il meccanismo del doppio binario introdotto con il codice Rocco non è in realtà riuscito a tradursi in un
sistema di sanzioni organico e coerente, infatti la sua natura eccessivamente compromissoria si
173
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
evidenzia in alcune palesi contraddizioni teoriche e in alcune incongruenze pratiche.
L’applicabilità allo stesso soggetto di una pena e una misura di sicurezza sembra supporre una
concezione dell’uomo come essere diviso in due parti, ossia da un lato libero e responsabile e dunque
assoggettabile a pena, e dall’altro determinato e pericoloso e dunque assoggettabile a misura di
sicurezza.
Inoltre, nella disciplina positiva vi sono interferenze che finiscono col rendere molto problematica e
incerta la linea di demarcazione tra i criteri che presiedono all’applicazione della pena e della misura
di sicurezza. L’art. 133 c.p. stabilisce che si deve tenere conto, per la commisurazione della pena, anche
della capacità del colpevole, desunta da indici relativi alla sua personalità e ambiente di provenienza.
L’art. 203 c.p. dispone poi che la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle stesse
circostanze indicate dall’art. 133, e dunque ciò vuole dire che per il giudizio di pericolosità rilevano gli
stessi elementi che servono per commisurare la pena, ma in questo modo sfumano le differenze di
presupposti applicativi tra pene e misure, e di conseguenza diventa artificioso lo stesso principio del
doppio binario.
Inoltre, si rivela nella pratica una mistificazione la pretesa distinzione tra modalità di esecuzione
differenti delle pene e delle misure di sicurezza, infatti tra esse, sul piano del trattamento, vi è una
sostanziale identità di contenuto afflittivo, dovuta anche al fatto che alla strategia legislativa
differenziata non è mai seguito l’apprestamento di corrispondenti strutture che consentissero
un’effettiva e concreta diversificazione nell’esecuzione di pene e misure di sicurezza.
Queste contraddizioni spiegano perché in dottrina la distinzione tra le due forme di sanzioni sia stata
definita “frode delle etichette”.
LA PENA SECONDO LA COSTITUZIONE
Il problema relativo al fondamento e alla funzione della pena si colloca in una nuova prospettiva in
seguito all’entrata in vigore della Costituzione, al cui art. 27 comma 3 si è disposto che “le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”. La dottrina coeva per “tendere” ha inteso che la rieducazione non debba essere una
finalità essenziale, ma solo uno scopo eventuale della pena, mentre scopo necessario rimarrebbe il
primo enunciato dall’art. 27, ossia la retribuzione. Questa interpretazione finisce in realtà con il
mortificare e sminuire la carica innovatrice che ha ispirato la disposizione, la quale voleva con ogni
probabilità innovare l’ordinamento introducendo la funzione di risocializzazione della pena.
Si potrebbe obiettare che la rieducazione intesa come risocializzazione finirebbe con l’annullare la
differenza di scopi di pene e misure di sicurezza, ma con questa obiezione si opera in realtà
un’inversione metodologica, in quanto essa, in contrasto con il principio della gerarchia delle fonti,
implicherebbe un’interpretazione della norma costituzionale alla luce delle scelte politico-criminali
recepite nella legislazione ordinaria. Inoltre, va comunque sottolineato che anche se entrambe le
forme hanno finalità rieducativa, la rieducazione si connota in maniera diversa in funzione delle
caratteristiche soggettive dei destinati (imputabili o inimputabili) della sanzione penale.
Va inoltre rilevato che il legislatore deve avere scelto l’espressione “tendere” perché la rieducazione
del reo non è uno scopo che viene raggiunto sempre e in tutti i casi, infatti esso è soltanto un obiettivo
tendenziale, perseguibili finché il reo sia disposto a collaborare.
I limiti della presa di posizione costituzionale sulle finalità della pena sono diversi:
la prevenzione speciale sub specie di rieducazione non è da sola sufficiente ad esaurire tutte le
funzioni cui oggi la sanzione penale assolve (nella fase ad esempio della minaccia, l’obiettivo
perseguito è quello della prevenzione generale)
la genericità del concetto di rieducazione, che addossa all’interprete il dovere di precisare
limiti e portata della rieducazione alla stregua dell’insieme dei principi che caratterizzano il
nostro sistema costituzionale
SIGNIFICATO E LIMITI DELL’IDEA RIEDUCATIVA
174
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
L’idea di prevenzione speciale mediante rieducazione va precisata nel suo significato e nei suoi limiti
anche per sciogliere dubbi su di essa e controbattere ad obiezioni contro essa.
Una delle principali obiezioni è quella che sostiene che l’idea rieducativa non consenta alcuna
predeterminazione temporale della durata delle sanzioni, ma dovrebbe tendere ad un trattamento
finalizzato alla correzione definitiva, anche se la durata sia imprevedibile. Inoltre, persino
l’assunzione di un reato come presupposto indefettibile della sanzione sarebbe poco comprensibile dal
punto di vista di un diritto penale del trattamento, infatti si potrebbe essere rieducati per qualsiasi
comportamento molesto per la collettività.
Non a caso, infatti all’interno di una prospettiva teorica pur favorevole al principio di rieducazione, si è
sostenuto che l’idea retributiva è un momento logico ineliminabile della pena, poiché garantisce
che il diritto penale mantenga sempre un nesso con il fatto di reato, e non venga dunque permesso un
illimitato intervento statale nei confronti della libertà del singolo. In realtà, però, pretendendo di
rinvenire nell’idea retributiva una garanzia contro gli eccessi di un’illimitata rieducazione, si rischia di
finire con il fare assegnamento su parametri irrazionali e incontrollabili, ossia l’opposto di ciò che si
pensava di potere conseguire. Inoltre questa impostazione sembra dare per scontato che tra il
concetto di retribuzione e il principio del diritto penale del fatto sussista un rapporto di necessaria
implicazione, ma in realtà non è così, perché l’idea retributiva si presta in astratto anche ad esprimere
l’esigenza di compensare una colpevolezza legata più all’atteggiamento interiore dell’agente che non
all’obiettiva gravità del fatto commesso.
In realtà, l’inserimento della rieducazione nella prospettiva del diritto penale del fatto è un dato che si
può desumere dalla Costituzione se si pone in relazione l’art. 27 comma 3 con l’art. 25 comma 2, che
sancisce il principio di legalità e configura inequivocabilmente la pena come effetto giuridico di un
fatto criminoso. Questo non vale comunque a sottovalutare l’esigenza di una proporzionalità tra fatto e
sanzione, infatti il principio della proporzione, oltre a caratterizzare l’idea generale di giustizia,
costituisce uno dei criteri-guida che presiedono al funzionamento dello Stato di diritto.
Per quanto riguarda il problema dei contenuti che la rieducazione deve assumere, si può dire che l’art.
27 comma 3 sembri recepire un’idea rieducativa eticizzante, sottesa al concetto di emenda morale.
Occorre inoltre evitare l’errore di identificare il concetto costituzionale di rieducazione con quello di
ascendenza positivistico-criminologica, infatti l’idea rieducativa dell’art. 27 postula un modello di
risocializzazione come processo inteso a favorire la riacquisizione dei valori basilari della convivenza.
Per determinare quale sia il contenuto del comma 3 dell’art. 27 bisogna porlo in connessione con il
complesso dei principi ispiratori del nostro sistema costituzionale. Alcuni autori hanno dunque
proposto un collegamento tra questo comma e il principio di eguaglianza materiale dell’art. 3,
sostenendo dunque che la pena avrebbe funzione rieducativa nella misura in cui sarebbe suo compito
di recuperare socialmente i soggetti che sono indotti a delinquere perché in condizioni di inferiorità ed
emarginazione sociale. Questa teoria ha però il difetto di creare una frattura dello scopo rieducativo
della pena nei casi in cui il reo sia un soggetto già bene inserito socialmente, e dunque non bisognoso
di essere socialmente reinserito. Per sanare questa frattura bisogna operare una distinzione tra la
rieducazione come generale obiettivo da perseguire e le tecniche che si rendono di volta in volta
necessarie per ottenere il risultato: la rieducazione come obiettivo allude al processo di
riappropriazione dei valori fondamentali della convivenza da parte del reo, ed essa può riferirsi a
qualsiasi delinquente, mentre la rieducazione come tecnica/strumento sarà diversa a seconda che il
reo sia un emarginato (nel cui caso servirà anche un processo di reinserimento sociale) o un c.d.
“colletto bianco”.
Affinché il processo rieducativo possa avere corso senza tradursi in un’imposizione coercitiva nei
confronti del destinatario, occorre che vi sia la disponibilità psicologica del reo, ed è in questo senso
- come già chiarito - che bisogna leggere il verbo “tendere” dell’art. 27 comma 3. Si può dunque
cogliere che il principio rieducativo entra veramente in crisi solo nei casi-limite in cui il delitto è frutto
di una scelta politico- ideologica che si pone e vuole porsi in contrasto con i principi ispiratori
dell’ordinamento, poiché in questi casi l’esigenza rieducativa e l’indisponibilità psicologica del reo si
scontrano con una tensione conflittuale particolarmente grave. Questo accade soprattutto perché è
175
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
necessario rispettare anche un altro valore costituzionale, ossia l’autonomia morale dell’individuo.
Rieducazione e prassi legislativa
L’idea rieducativa non è rimasta una vuota enunciazione costituzionale, ma è assurta a criterio-guida
di diverse riforme che hanno cercato di rendere l’ordinamento vigente più compatibile con il principio
dell’art. 27.3 Cost. Le più importanti concretizzazioni legislative del principio di rieducazione sono le
seguenti:
1. Ergastolo: per attenuare il contrasto tra la pena dell’ergastolo e la finalità rieducativa, la legge
n. 1634 del 25 novembre 1962 ha modificato l’art. 176 stabilendo che “il condannato
all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno
26 anni” (abbassati in seguito a 20 nel 1986), e la miniriforma penitenziaria del 1986 ha poi
esteso anche agli ergastolani la possibilità di beneficiare della semilibertà e della liberazione
anticipata.
2. Sospensione condizionale: inizialmente, per ridurre gli effetti desacralizzanti della pena
detentiva, con la riforma del 1974 era stato esteso l’ambito di operatività della sospensione
condizionale elevando il tetto delle condanne sospendibili a quelle fino ai 2 anni, e stabilendo
la possibilità di concedere un secondo provvedimento di sospensione entro lo stesso tetto dei 2
anni. Successivamente, nel 1981, è stata subordinata la concedibilità della seconda
condizionale all’adempimento di alcuni obblighi specifici da parte del beneficiario, con l’idea
che l’adempimento agli obblighi di condotta dovrebbe stimolare la rieducazione.
3. Ordinamento penitenziario: con la legge n. 354 del 26 luglio 1975 è stata introdotto la
riforma dell’ordinamento penitenziario, i cui punti più qualificanti sono la ricezione
dell’ideologia del trattamento rieducativo e l’introduzione di misure alternative alla detenzione
ispirate all’idea del probation.
Quanto all’ideologia del trattamento, se ne colgono i segni nelle norme del nuovo
ordinamento penitenziario che prevedono l’indagine scientifica sulla personalità e interventi
di psicologi ed esperti per modificare gli atteggiamenti che ostacolano una costruttiva
partecipazione sociale (un esempio ne sono le norme che prevedono che il trattamento del
condannato vada realizzato con lavoro, istruzione, religione, attività culturale e soprattutto
instaurazione di rapporti con il mondo esterno)
Sono inoltre state introdotte misure alternative alla detenzione, ossia affidamento in prova,
semilibertà e liberazione anticipata, che mirano alla rieducazione attraverso il reinserimento
del condannato nell’ambiente esterno, favorito dal sostegno di organi tecnici di assistenza.
Una soddisfacente attuazione dei principi della riforma penitenziaria è tuttavia impedita dalla
drammatica riemersione di esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale già a partire
dalla seconda metà degli anni ’70, creando così un pendolo politico-criminale. La necessità di
contrastare la forte criminalità induce presto a restringere l’applicabilità dei predetti nuovi
statuti attraverso preclusioni oggetti che riguardano gli autori dei reati più gravi. Nel 1986 con
la miniriforma della legge Gozzini si è teso ad un timido rilancio dell’ideologia rieducativa, ma
si è assistito subito dopo ad un inasprimento del trattamento penitenziario dovuto, nei primi
anni ’90, alla necessità di fronteggiare l’escalation della criminalità organizzata mafiosa: si sono
infatti inasprite le sanzioni per i condannati per delitti di questo stampo, ma si è invece
incentivato il “pentitismo”, ma bisognerebbe stabilire se e in quale misura la collaborazione
giudiziaria possa essere sintomo credibile di rieducazione.
Successivamente, con la riforma Simeone (legge n. 165 del 27 maggio 1998) e la legge n. 231
del 12 luglio 1999 si sono ulteriormente ampliate le condizioni di accesso per le misure
alternative, ma il risultato è stato quello di svilire le potenzialità risocializzanti degli istituti di
affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare, stravolgendone
funzioni e significati.
176
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
4. Sanzioni sostitutive: con la legge n. 689 del 24 novembre 1981 sono poi state introdotte delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, sulla base della convinzione che le pene
detentive brevi siano più desocializzanti che rieducative, dal momento che il soggetto subisce il
contagio criminale della realtà carceraria
5. Pena pecuniaria: con la legge n. 689 del 1981 è stata modificata la disciplina della pena
pecuniaria, stabilendo che la pena vada commisurata in base alle condizioni economiche del
reo (art. 133 bis), in modo che egli subisca una pena più giusta e sia così più stimolato a
riacquisire il rispetto dei valori offesi.
L’EVOLUZIONE PIÙ RECENTE DEL DIBATTITO SULLE FUNZIONI DELLA PENA
LA PREVENZIONE GENERALE
Dalla seconda metà degli anni ’60 l’idea di prevenzione generale ha ricominciato ad essere oggetto di
dibattito teorico, da un lato perché l’aumento della criminalità ha prospettato l’esigenza di
riconsiderare le condizioni che garantiscono una reale efficacia deterrente della sanzione penale, e
dall’altro perché la prassi attuativa della risocializzazione ha dato alcuni esiti poco confortanti, che
hanno indotto alcuni studiosi a considerare che l’idea rieducativa fosse caduta in crisi.
L’idea che lo scopo della pena sia di impedire che vengano commessi in futuro reati si deve a Protagora
e Seneca, ma è stata elaborata in chiave psicologica nel XIX sec. da Bentham in Inghilterra e Feuerbach
in Germania. Si presume, secondo questo modello, che l’uomo sia un essere razionale che prima di
agire valuta pro e contro della scelta criminale. In tempi recenti si è però obiettato che il delinquente
non è un individuo che valuta razionalmente i motivi delle proprie azioni, ma è piuttosto soggetto a
stimoli inconsci e difficilmente controllabili. Tuttavia, anche questo modello ha un difetto, ossia quello
del peccare per eccesso, in quanto non è nemmeno vero che tutti i delinquenti siano irrazionali, dal
momento che alcuni reati vengono commessi esattamente da persone che calcolano rischi e benefici
(come accade ad esempio spesso nei reati a materia economica).
Qualunque sia il nucleo di verità dell’idea della prevenzione generale negativa in forma di coazione
psicologica, la rivalutazione della concezione general-preventiva si poggia comunque su altre basi. Si
tende infatti sempre di più a sottolineare che la minaccia della pena ha una funzione morale-
pedagogica o di orientamento culturale dei consociati, ossia prevenzione generale positiva. Secondo
questa impostazione, la forte disapprovazione sociale favorisce l’identificazione della maggioranza dei
cittadini con il sistema di valori protetto dall’ordinamento giuridico. Infatti, il timore si potere subire
una sanzione punitiva agirebbe inconsapevolmente come fattore che facilita in ognuno la formazione
di una coscienza morale (un Super-io) che osservi i comandi della legge, dunque il diritto penale
assolve una funzione di socializzazione così come scuola, gruppo, comunità, famiglia, ecc.
Naturalmente l’effetto di moralizzazione della minaccia della pena viene meno se ad essa non si collega
la sua concreta applicazione nei casi di trasgressione della legge penale.
Si produce però un effetto general-preventivo anche a livello di esecuzione della pena, se il
trattamento penitenziario viene percepito come “spiacevole” dai consociati.
Questa teoria della prevenzione generale allargata manca però di fondamenti scientifici sicuri, ma è
comunque fuori di dubbio che la funzione di orientamento culturale affidata alla pena non possa
essere acriticamente generalizzata e data per scontata, ma è subordinata alla presenza di alcune
condizioni:
Esistenza di tendenziale convergenza tra disapprovazione sociale e disapprovazione legale
Buon livello di credibilità del sistema penale complessivo
La prospettiva della prevenzione generale positiva o allargata suscita però due obiezioni, ossia il fatto
che essa si presta a rilegittimare la concezione retributiva della pena, e soprattutto che finisce con il
privilegiare la soddisfazione dei bisogni collettivi di stabilità e sicurezza, mettendo in secondo piano la
funzione rieducative che la pena dovrebbe esercitare.
La prevenzione generale assume una differente rilevanza in ognuno dei momenti in cui opera, ossia
momento della minaccia, dell’inflizione e dell’esecuzione.
177
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Le funzioni di deterrenza e orientamento culturale si trovano soprattutto nella fase della minaccia,
poiché se si vuole impedire la commissione di illeciti bisogna ovviamente far sì che il sistema penale
eserciti la sua influenza prima che vengano commessi. Questa funzione di prevenzione generale ha
invece uno spazio più ristretto nella fase dell’inflizione, poiché se così non fosse la tendenza sarebbe
quella di infliggere pene esemplari per distogliere i cittadini da commettere reati, strumentalizzando
così il condannato.
La funzione di prevenzione generale svolge un ruolo secondario anche durante la fase di esecuzione
della pena, in cui domina invece la preoccupazione per il trattamento rieducativo.
RETRIBUZIONE
L’idea di retribuzione, accanto a quella di prevenzione, è uno degli oggetti di costante dibattito sul
concetto e sulle funzioni della pena. La tesi che la pena serva a compensare o retribuire il male
arrecato alla società con il reato trova la sua fonte nella concezione venero-cattolica e nella filosofia
idealistica, ma il significato dato oggi alla “retribuzione” non è quello originario. Infatti si ritiene ormai
che realizzare la giustizia assoluta non sia compito di uno Stato di diritto, laico e pluralistico, e quando
si parla di retribuzione ci si riferisce oggi non alla prospettiva degli scopi della pena, ma a qualcosa di
differente che presuppone che il problema del perché punire sia già risolto. L’idea della retribuzione
implica, in questo senso, anche l’idea di proporzione tra gravità dell’offesa ed entità della
sanzione, proporzione che permette anche che lo stesso colpevole avverta la pena come giusta e sia
quindi più disponibile alla rieducazione.
Una maggiore accentuazione dell’idea retributiva si registra nell’ambito di alcune tendenze dottrinali
“neoretribuzionistiche”, che considerano che l’idea retributiva trovi una base empirica nei bisogni
emotivi di punizione esistenti nella società e in ciascun individuo di fronte alla perpetrazione dei reati.
Si considera dunque che la visione del delinquente che commette un reato sia contagiosa, poiché
nell’inconscio di ciascuno è vivo il desiderio di trasgredire le proibizioni, e dunque la punizione da
parte dello Stato di chi ha trasgredito da un lato canalizza l’aggressività suscitata nei cittadini dalla
commissione dell’illecito, e dall’altro rafforza la loro fedeltà ai valori tutelati.
La moderna teoria retributiva, da questo punto di vista, si risolve però in una versione della teoria
generalpreventiva intesa come tecnica di socializzazione, poiché essa pretende di spiegare il reale
meccanismo con cui minaccia e inflizione della pena rafforzano la coscienza morale dei consociati e
contribuiscono così a preservare l’integrità dei beni protetti.
Questo recente recupero di una funzione satisfatorio-stabilizzatrice della pena intesa in senso
retributivo desta però un grave e giustificato allarme, poiché i bisogni emotivi di punizione sono
irrazionali e contingenti, e lasciano quindi la punizione in mano a spinte incontrollabili, facendo così
riemergere il rischio di punizioni non proporzionate all’offesa. La principale obiezione è inoltre quella
che sostiene che questa impostazione, privilegiando la funzione positiva che la pena assolve per la
società, si disinteressa del destino del singolo delinquente, dimenticando così la corresponsabilità
della società nella genesi del delitto. È invece proprio la presa d’atto di questa corresponsabilità che
impedisce di rinunciare a vedere nella pena uno strumento razionale in grado di incidere
positivamente anche sul singolo individuo delinquente, ed è proprio questa persistente tensione verso
la rieducazione che rende lo Stato moralmente superiore e gli permette di punire chi ha commesso un
illecito.
PREVENZIONE SPECIALE
La funzione di prevenzione speciale tende ad impedire che chi si è già reso responsabile di un reato
delinqua nuovamente. La tecnica sanzionatoria più elementare per perseguire questo obiettivo è la
neutralizzazione del soggetto potenzialmente pericoloso attraverso la coercizione fisica o forme di
interdizione giuridica che impediscano al reo di continuare a svolgere attività che hanno occasionato la
commissione di delitti. Un altro mezzo è il condizionamento della personalità del reo ossia la sua
emenda morale.
In tempi moderni, però, la prevenzione speciale assume a criterio-guida la rieducazione concepita
come risocializzazione, che presiede alla fase esecutiva della pena, ma che svolge anche un ruolo
178
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
decisivo nella fase dell’inflizione o commisurazione giudiziale della pena.
L’ideologia della risocializzazione è recentemente entrata in crisi, tanto che oggi alcuni parlano di
“mito” della risocializzazione. Questa crisi deriva dal presunto fallimento degli sforzi compiuti finora
sul pino della concreta realizzazione del finalismo rieducativo, nel senso che alcune statistiche
americane e svizzere dicono che le possibilità di recidiva rimangono invariate, indipendentemente
dalla comminazione e dal tipo di trattamento. Non è tuttavia dimostrato che questi dati sperimentali
siano univoci e probanti, e va infatti comunque sottolineato che questo presunto fallimento
riguarderebbe però il trattamento inteso soprattutto nell’accezione specifica di terapia della
personalità, condotta da esperti in psicologia secondo criteri scientifici. Ma va sottolineato che
l’ideologia della rieducazione può esprimersi con tecniche articolate che non corrispondo
necessariamente al modello medico, e che inoltre i dati disponibili non sono così decisivi da
dimostrare nemmeno il fallimento del trattamento concepito come terapia della personalità, che è
stata applicata solo a piccoli gruppi di detenuti ben selezionati e all’interno di istituti-modello.
IL PROBLEMA DEL SUPERAMENTO DEL DOPPIO BINARIO
La progressiva estensione del finalismo rieducativo al campo delle pene in senso stretto, imposta
dall’art. 27 comma 3 Cost. e realizzatasi con la riforma penitenziaria e con riforme più recenti, ha finito
col mettere immediatamente in crisi l’impianto dell’originario sistema sanzionatorio del codice Rocco,
che aveva inteso dare la funzione si prevenzione speciale solo alle misure di sicurezza.
La dottrina ha in realtà messo in luce da subito le contraddizioni del sistema del doppio binario, e
sono di qui emersi due orientamenti:
1. Uno, proiettato soprattutto ad una riforma, sollecitava l’unificazione della pena e della misura
di sicurezza in un’unica sanzione, contemporaneamente in grado di assolvere le finalità
dell’una e dell’altra misura
2. Un secondo orientamento che tendeva a detrarre il periodo di privazione di libertà personale
sofferta senza causa dall’ammontare della misura di sicurezza da applicarsi dopo la pena.
Questi orientamenti sono segno dell’esigenza di superare l’attuale sistema del doppio binario
con scelte sanzionatorie più coerenti con la Costituzione.
La Costituzione ha implicitamente prefigurato un sistema monistico di sanzioni, per il quale ad un
reato deve corrispondere una sola sanzione orientata in senso educativo, la quale può essere pena o
misura di sicurezza, da scegliere in base alle caratteristiche soggettive del reo (pena per i soggetti
psicologicamente normali, e misura di sicurezza per quelli affetti da turbe psicologiche e bisognosi
dunque di terapia).
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DELLA PENA NELLA REALTÀ DELL’ORDINAMENTO
Pur con i limiti dati dal fatto che nel nostro Paese continuano a mancare indagini empiriche sul
funzionamento reale del sistema penale, bisogna rilevare che le linee di tendenza attualmente
riscontrabili nella fenomenologia punitiva non sono per niente univoche, ma vi sono anzi modelli
eterogenei di punizione dai quali risulta un quadro complessivo contraddittorio.
Si è detto che a partire dalla metà degli anni ’70 si era andata affermando una tendenza incline a
rimpiazzare la pena carceraria con misure alternative alla detenzione, tendenza potenziata dalla legge
Gozzini del 1986, la quale ha sì ridotto l’area del carcere, ma ha prodotto anche l’effetto negativo del
fenomeno della “fuga” dalla pena detentiva, determinata da orientamenti eccessivamente
indulgenzistici nella concezione in particolare della misura dell’affidamento in prova al servizio
sociale. Un ulteriore inconveniente è poi stato quello della perdita di certezza della pena inflitta in sede
di condanna, con la conseguenza di indebolire fortemente la funzione preventivo-orientativa della
pena.
Gli altri nuovi modelli di sanzione, ossia lavoro sostitutivo, pena pecuniaria orientata alla capacità
economica del reo, semidetenzione e libertà controllata, non sono riusciti invece ad attecchire.
Negli ultimi anni si è dunque assistito ad una reazione contraria, ossia ad una rinnovata tendenza al
massiccio ricorso al carcere.
179
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Ulteriori effetti destabilizzanti sul sistema sanzionatorio sono poi derivati dall’introduzione nel nuovo
sistema processuale dei cosiddetti riti alternativi, ossia il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e il
patteggiamento sulla pena (art. 444 c.p.p.), i quali sono procedimenti speciali affidati all’iniziativa e
all’accordo delle parti (imputato e pubblico ministero) che comportano una sensibile riduzione della
pena che sarebbe altrimenti applicabile all’etto del giudizio normale. Questi meccanismi processuali
cercano di rendere più efficiente il funzionamento della macchina giudiziaria, ma hanno una portata
dirompente che è sfuggita ai compilatori del codice di rito, infatti non è chiaro sino a che punto essi
siano compatibili con gli scopi di prevenzione generale e speciale, dal momento che rimane difficile
orientare in senso preventivo-rieducativo una pena la cui scelta rimane in larga misura affidata alle
parti.
Con la normativa in tema di criminalità organizzata di stampo mafioso emanata nel ’91-’92 il
legislatore ha individuato nel campo dell’esecuzione della pena il terreno privilegiato d’intervento
contro la criminalità organizzata, creando un circuito penitenziario differenziato per i soggetti che vi
fanno parte. Si è così da un lato irrigidito il trattamento penale, ma dall’altro si sono previsti sconti di
pena in forma di attenuanti e immediato accesso alle misure alternative e agli altri benefici
penitenziari per i detenuti ammessi allo speciale programma di detenzione, ossia i pentiti che
collaborano con la giustizia.
Questo modello di disciplina differenziata entra in tensione con i principi generali sottostanti al
trattamento relativo ai delinquenti comuni. Questa deroga ai principi è oggi diversamente valutabile a
seconda che si privilegino le ragioni della difesa sociale o le esigenze di unità del sistema e il primato
della funzione rieducativa della pena. Si è infatti già detto che sotto quest’ultimo profilo può sembrare
eccessivo precludere ogni beneficio penitenziario ai mafiosi irriducibili, e che la disponibilità a
collaborare con la giustizia non è necessariamente segno di resipiscenza, ma può essere anche effetto
di un calcolo utilitaristico.
È in ogni caso fuori discussione che nell’attuale ordinamento italiano il fenomeno della punizione si
presenti come una realtà complessa e caratterizzata da grossi squilibri.
180
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO DUE
PENE IN SENSO STRETTO
LE PENE PRINCIPALI
Il nostro diritto positivo distingue le pene in principali ed accessorie, e l’art. 17 c.p. stabilisce che le
pene principali stabilite per i delitti sono la pena di morte, l’ergastolo, la reclusione e la multa, e quelle
per le contravvenzioni l’arresto e l’ammenda. L’art. 18 c.p. stabilisce poi che le pene detentive o
restrittive della libertà personale sono l’ergastolo, la reclusione e l’arresto, e sono invece pene
pecuniarie la multa e l’ammenda. L’art. 20 precisa infine che le pene principali vengono inflitte dal
giudice con sentenza di condanna, e quelle accessorie inseguono di diritto alla condanna come effetti
penali di essa.
Il decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, ha introdotto due nuove pene principali da
applicarsi solo ai reati di competenza del giudice di pace, ed esse sono la permanenza domiciliare e il
lavoro di pubblica utilità. La legge delega n. 67 del 2014 ha poi introdotto due nuove pene principali,
ossia la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare.
1. Pena di morte: l’art. 17 c.p. enuncia per prima la pena di morte tra le pene principali, ma essa
è stata soppressa nel 1944 per i delitti previsti dal codice penale, nel 1948 per i delitti previsti
dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, e infine nel 1994 per gli illeciti previsti
dalle leggi militari di guerra. Con l’art. 27 comma 4 Cost. come modificato dalla legge
Costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007 si è infine sancito l’espresso divieto della pena di morte
nel nostro ordinamento (mentre prima si leggeva “se non nei casi previsti dalle leggi militari di
guerra”).
La pena di morte viene ancora considerata necessaria da alcuni, ma all’interno della più
accreditata scienza penalistica moderna predomina il contrario convincimento che la pena di
morte sia un residuo arcaico, e che essa sia inoltre, al contrario dell’opinione comune, un
inefficace strumento di controllo della criminalità, come approfondite indagini (sopratutto
americane) hanno dimostrato.
2. Ergastolo: l’art. 22 c.p. stabilisce che l’ergastolo è una pena perpetua, scontata in uno degli
stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro (può essere ammesso il lavoro all’aperto) e
con l’isolamento notturno.
Il problema della compatibilità dell’ergastolo con la Costituzione è controverso, in particolare a
causa del principio di rieducazione dell’art. 27 comma 3. La Corte costituzionale ha ritenuto
legittimo l’ergastolo sostenendo che la funzione della pena non deve essere solo il
riadattamento sociale dei delinquenti, ma anche la prevenzione generale e la difesa sociale, e
questo può attuarsi con la neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati delinquenti.
Bisogna in ogni caso riconoscere che la natura perpetua dell’ergastolo è andata in concreto
sempre più ridimensionandosi, ed è dunque andato parallelamente a sdrammatizzarsi il
problema della sua compatibilità costituzionale. Infatti, l’art. 176 comma 3 stabilisce che dopo
26 anni, se appare sicuro il suo ravvedimento, egli può essere ammesso alla liberazione
condizionale (in presenza di accertato ravvedimento l’ammissione a questo beneficio va anzi
considerata dovuta, a seguito della giurisdizionalizzazione dell’istituto con la sent. cost. n.
204/74). Inoltre, con la sent. n. 274 del 27 settembre 1983 è stato dichiarato
incostituzionale il divieto di ammettere gli ergastolani al godimento degli sconti di pena
consentiti dall’istituto della liberazione “anticipata”, con conseguente riduzione ulteriore dei
tempi necessari per la liberazione condizionale.
In seguito, gli artt. 14 e 18 della legge n. 663/1986 hanno esteso espressamente agli
ergastolani anche l’applicabilità della semilibertà (con il limite dell’espiazione di almeno 20
anni di pena) e della liberazione anticipata. Questa legge consente, più in particolare, che ai fini
del computo dei 20 anni di pena scontata necessari per la semilibertà si possano detrarre 45
giorni per ogni semestre di pena scontata se egli partecipa all’opera di rieducazione. Inoltre,
181
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
dopo 10 anni possono essere concessi permessi-premio per non più di 45 giorni all’anno.
Per quanto riguarda invece i minorenni imputabili, con la sent. n. 168 del 28 aprile 1994 la
Corte costituzionale ha ritenuto che sia incostituzionale per essi l’ergastolo, in virtù del
significato cha ha la rieducazione letta in connessione con la speciale protezione dell’infanzia e
della gioventù data dall’art. 31 Cost.
3. Reclusione: l’art. 23 c.p. stabilisce che la pena della reclusione può andare da 15 giorni a 24
anni, e viene scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro (anche
all’aperto, dopo un anno di reclusione) e con l’isolamento notturno.
La reclusione è dunque la pena temporanea per i delitti, e il minimo e massimo edittale dati dal
codice sono invalicabili solo per il giudice in relazione al caso concreto, mentre il legislatore
può liberamente fissare questi limiti (es. per il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione della pena il minimo è di 25 anni e il massimo è di 30).
Oggi è la legge sull’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975) a
disciplinare l’esecuzione della reclusione, sulla base dei principi seguenti:
l’esecuzione della reclusione avviene nelle case di reclusione
è previsto l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno
il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni del condannato
il trattamento si fonda sull’istruzione, sul lavoro, sulla religione, sulle attività culturali
ricreative e sportive
sono agevolati i rapporti con il mondo esterno e con la famiglia
il lavoro non deve avere carattere afflittivo e deve essere remunerato in misura non
inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali
Nel codice sono inoltre previste alcune cause di differimento dell’esecuzione della reclusione:
Differimento obbligatorio: se l’esecuzione deve avere luogo contro una donna
incinta, o che ha partorito da un anno, o una persona affetta da HIV, e nei casi di
incompatibilità con lo stato di detenzione enunciati all’art. 286 bis comma 1 c.p.p. (art.
146)
Differimento facoltativo: se è stata presentata domanda di grazia, se il soggetto ha
una grave infermità fisica, o se la donna ha partorito da più di un anno ma meno di tre
(art. 147)
4. Arresto: l’art. 25 c.p. stabilisce che la pena dell’arresto si estende da 5 giorni a 3 anni, ed è
scontata in uno stabilimento a ciò destinato o in sezioni speciali degli stabilimenti di
reclusione, con l’obbligo di lavoro (anche diverso da quelli organizzati nello stabilimento, con
riguardo alle sue attitudini e precedenti occupazioni) e con isolamento notturno.
L’arresto è una pena detentiva temporanea per le contravvenzioni, e valgono per esso gli stessi
principi valenti per la reclusione, con una sola differenza riguardante la disciplina della
semilibertà.
5. Multa: l’art. 24 c.p. stabilisce che la multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma tra
50 euro e 50.000 euro. Inoltre per i delitti determinati da motivi di lucro se la legge stabilisce
solo la pena di reclusione il giudice può anche aggiungere la multa da 50 a 50.000 euro.
La multa è dunque la pena pecuniaria prevista per i delitti, e il suo pagamento può avvenire in
rate mensili (da 3 a 30), il cui ammontare non può essere inferiore a 15 euro. Se la multa non
viene eseguita per insolvibilità del condannato, la pena di multa si converte in una sanzione di
conversione, che nella previsione originaria del codice era una pena detentiva, ma che, in
seguito alla sua dichiarazione di incostituzionalità, può essere oggi la libertà controllata (forte
limitazione della libertà personale con una serie di obblighi) e il lavoro sostitutivo (prestazione
di un’attività non retribuita a favore della collettività, prestata presso Stato, regioni, province,
comuni o enti, organizzazioni, corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile o di tutela
dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale).
182
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
La conversione avviene sulla base di un ragguaglio fissato dalla legge, ossia 1 giorno di libertà
controllata ogni 250 euro di pena pecuniaria, sia essa multa o ammenda.
La multa può essere inoltre prevista in modo fisso - senza minimo e massimo - o in modo
proporzionale, e il suo ammontare va adeguato alle condizioni economiche del reo.
6. Ammenda: l’art. 26 dispone che la pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di
una somma tra 20 euro e 10.000 euro (formulazione che risale, anch’essa, alla legge n.
94/2009, così come la nuova formulazione dell’art. 24 sulla multa).
L’ammenda è quindi la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni, e la sua disciplina
ricalca quella della multa riguardo a pagamento, conversione e forma fissa/proporzionale.
7. Permanenza domiciliare: l’art. 53 del [Link]. n. 274 del 2000 stabilisce che “la pena della
permanenza domiciliare comporta l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro
luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e
domenica”, salvo diversa disposizione del giudice, o richiesta del condannato di eseguirla
continuativamente. La permanenza domiciliare può durare da 6 giorni a 45 giorni, e il
condannato è in questo periodo considerato in stato di detenzione.
8. Lavoro di pubblica utilità: l’art. 54 del [Link]. n. 274 del 2000 stabilisce poi che il lavoro di
pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività
da svolgere presso Stato, regioni, province, comuni o enti o organizzazioni di assistenza sociale
o di volontariato. Le ore massime di lavoro settimanale sono sei, e da svolgere in modalità e
tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del reo. Il giudice, se
il condannato lo richiede, può anche ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per più
di 6h/settimana, fino a un massimo di otto.
9. Le nuove sanzioni penali della reclusione e dell’arresto domiciliare sono caratterizzate dal
fato che si espiano presso l’abitazione del condannato o un altro luogo pubblico o privato di
cura, assistenza e accoglienza denominato “domicilio”. La loro applicazione è obbligatoria per i
reati puniti con la reclusione o l’arresto non superiore nel massimo a tre anni, mentre la
reclusione domiciliare può essere discrezionalmente applicata dal giudice per i reati puniti con
la reclusione da tre a cinque anni.
Il giudice può inoltre prescrivere misure di controllo elettronico.
Queste sanzioni non si possono però applicare a delinquenti abituali, professioni e per
tendenza.
LE PENE ACCESSORIE
Nell’originario disegno del codice Rocco, le pene accessorie sono considerate sanzioni che per il loro
intrinseco carattere mancano di un’efficienza tale per cui possano da sole essere sufficienti a realizzare
gli scopi intimidatori ed afflittivi della repressione, e vanno dunque sempre comminate insieme ad
altre pene. L’art. 19 prevede come pene accessorie per i delitti:
1. l’interdizione dai pubblici uffici
2. l’interdizione da una professione o da un’arte
3. l’interdizione legale
4. l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
5. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
5 bis. l’estinzione del rapporto di impiego e di lavoro
6. la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale
Lo stesso articolo prevede invece come pene accessorie per le contravvenzioni:
1. la sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Una pena accessoria comune sia a delitti che a contravvenzioni è poi la pubblicazione della sentenza
penale di condanna.
183
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Le pene accessorie enunciate dall’art. 19 non sono comunque un numero chiuso, infatti le pene
accessorie previste in altri settori dell’ordinamento sono molteplici, e sono state anche introdotte due
nuove pene con la legge n. 172 del 2012, applicabili nei confronti dei condannati per i delitti contro la
personalità individuale: queste due nuove pene accessorie sono:
la perdita del diritto agli alimenti
l’esclusione dalla successione della persona offesa
Il legislatore ha anche ampliato la sfera di applicazione di alcune sanzioni accessorie, ad esempio ha
reso applicabile l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio di una
professione o un’arte anche al condannato per un delitto contro la libertà sessuale. Inoltre, ai
condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione si applicano, in base alla l. 190/2012,
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l’estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego.
Si ritiene comunemente che l’automaticità di applicazione sia una caratteristica tipica delle pene
accessorie, nel senso che esse conseguono di diritto alla sentenza di condanna. In realtà esistono casi
in cui l’applicazione delle pene accessorie non è automatica, ma rimessa alla discrezionalità del giudice
di cognizione. L’unica caratteristica comune delle pene accessorie è quindi la loro complementarietà
astratta, ossia il loro essere accessorie ad altre sanzioni.
L’opinione tradizionale ritiene che la funzione delle pene tenda ad un obiettivo di prevenzione
generale o di difesa sociale. Più di recente la dottrina ha però cominciato ad evidenziare anche una
funzione di prevenzione speciale, nel senso che esse fungono da misure volte ad evitare che il reo
ricada nel delitto.
Una volta le pene accessorie non erano sospendibili condizionalmente, ed avevano quindi di fatto un
ruolo sostitutivo delle pene principali, ma con l’art. 4 della legge n. 19/1990 questa disciplina è stata
modificata, ed è stato introdotto il principio antitetico della sospendibilità delle pene accessorie, e
questo per rendere più omogenee la disciplina delle pene principali e di quelle accessorie; tuttavia, la
scelta di rendere sostenibili anche le pene accessorie finisce con l’accentuare la tendenza
indulgenzistica del nostro sistema sanzionatorio.
Le pene accessorie possono essere perpetue o temporanee: quando la legge stabilisce che la
condanna comporti l’applicazione di una pena accessorie e non ne determina la durata, la pena
accessoria ha durata uguale a quella della pena inflitta (o che dovrebbe scontarsi, in caso di
conversione per insolvibilità del reo), e in nessun caso può superare il limite minimo e massimo
stabilito per ciascuna specie di pena accessoria dall’art. 37 c.p.
L’art. 389 c.p. sanziona penalmente la mancata osservanza delle pene accessorie, infatti con la legge n.
689 del 24 novembre 1981 (legge di Modifiche al sistema penale) è stato modificato anche il delitto di
inosservanza di pene accessorie, prevedendo la sola pena della reclusione ma più elevata nel minimo,
ed estesa a tutte le fattispecie di pena accessoria.
LE SINGOLE PENE ACCESSORIE
Le pene accessorie previste per i delitti sono le seguenti:
1. Interdizione dai pubblici uffici: l’art. 28 prevede l’interdizione dai pubblici uffici, che è la
nostra sanzione interdittiva più importante. Il suo contenuto infittivo è stato ridotto dalla Corte
costituzionale con due interventi che hanno dichiarato incostituzionale la privazione di
stipendi, assegni e pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.
L’interdizione dai pubblici uffici priva il condannato:
A. del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico
B. di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico, non obbligatorio, di pubblico servizio
C. di gradi e dignità accademiche, titoli, decorazioni e di diritti onorifici
L’interdizione può essere:
Perpetua: consegue, in base all’art. 29, alla condanna dell’ergastolo o alla reclusione
184
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
oltre i cinque anni, alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto e alla
dichiarazione di tendenza a delinquere
Temporanea: va da uno a cinque anni, e quella di cinque anni consegue alla condanna
alla reclusione oltre tre anni; l’interdizione temporanea consegue anche alla condanna
per un reato realizzato con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla
pubblica funzione o al pubblico servizio
2. Interdizione da una professione o da un’arte (art. 30 c.p.): questa pena accessoria consiste
nella perdita della capacità di esercitare durante l’interdizione una professione, un’arte,
un’industria, un commercio, un mestiere, per cui è necessario uno speciale permesso o
autorizzazione o abilitazione o licenza dell’autorità. Questa interdizione, secondo l’art. 31, si
applica alle ipotesi di condanna per un delitto commesso con abuso di una professione, arte,
industria, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti.
La pena accessoria può andare da un mese a cinque anni, salvo i casi stabiliti espressamente
dalla legge, e decorsa la durata della pena i permessi, licenze, ecc. possono essere riottenuti.
Ha sollevato particolari problemi l’applicazione di questa pena accessoria nei confronti di
giornalisti: una posizione dottrinale minoritaria nega che l’attività giornalistica rientri in quelle
“per cui è necessario uno speciale permesso [...] dall’autorità”, ma la disciplina complessiva
desumibile dalla legge n. 69 del 3 febbraio 1963 sull’ordinamento della professione
giornalistica sembra dire il contrario. Nell’orientamento maggioritario vi sono poi due tesi
distinte, una che sostiene che solo il giornalista professionista potrebbe essere interdetto se
commette un reato con “violazione dei doveri inerenti alla sua funzione”, e l’altra che sostiene
che questa violazione possa esserci solo nella violazione del dovere di controllo da parte del
direttore responsabile.
3. Interdizione legale (art. 32 c.p.): l’interdizione legale è la pena accessoria per i delitti di
maggiore gravità, e priva il soggetto della capacità di agire (vi si ricollegano le norme civili
sull’interdizione giudiziale riguardo alla disponibilità e amministrazione dei beni e alla
rappresentanza negli atti relativi, con il limite dato dal fatto che l’interdizione legale non
impedisce a detenuti ed internati l’esercizio dei diritti che vengono loro riconosciuti
dall’ordinamento penitenziario).
In base all’art. 32 c.p., l’interdizione legale segue alla condanna all’ergastolo e alla condanna
alla reclusione per oltre cinque anni, e salvo che il giudice non disponga altrimenti, durante la
pena la condanna produce anche la sospensione della responsabilità genitoriale.
4. L’interdizione dagli uffici direttive delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis
c.p.). Con la legge di Modifiche al sistema penale (689/1931) è stata introdotta questa nuova
pena accessoria, che ha la funzione di irrobustire la sanzione nei confronti di alcune forme di
criminalità tipiche dei “colletti bianchi”, ossia i reati strettamente collegati all’attività
imprenditoriale.
L’art. 32 bis, che sostituisce quello che prima era l’art. 2641 del codice civile, dispone che
“l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato
della capacità di esercitare durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonché ogni altri uffici con potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell’imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per
delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio”. Importante è
notare che vietando anche ogni altro ufficio dotato di potere di rappresentanza della persona
giuridica o dell’imprenditore, introduce anche nuovi divieti prima non comprendi nell’art.
2641 c.c., come il direttore non generale, il procuratore, ecc.
La durata della pena accessoria, in mancanza di esplicitazione normativa, equivalente a quella
della pena principale ex art. 37. L’interdizione dagli uffici direttivi non si applica, però, in caso
di condanna per delitto colposo alla reclusione per meno di tre anni.
185
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
5. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 ter c.p.): anche questa
pena accessoria è stata introdotta con la legge di Modifiche al sistema penale, ed è espressione
dell’indirizzo politico-criminale che tenta di irrobustire la risposta sanzionatoria con il ricorso
ad una strategia differenziata di intervento punitivo. Il nuovo articolo 32 ter dispone che
“l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere
contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni”.
Questa interdizione, che riguarda solo la persona fisica e non anche l’impresa nell’esercizio
della quale ha commesso il reato, consegue ipso iure alla commissione dei delitti
espressamente e tassativamente previsti dalla legge, ossia concussione, corruzione per un atto
d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio, turbata libertà degli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche
forniture, frode nelle pubbliche forniture, associazione per delinquere, rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggiotaggio, manovre speculative su merci, truffa
a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio
militare (art. 32 quater). Per potere applicare la pena accessoria dell’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione è anche necessario che i suddetti reati siano stati commessi a
causa o nell’esercizio di un’attività imprenditoriale (art. 32 quater).
La pena accessoria consegue alla commissione del reato di omissione o falsità in registrazione
o denunce obbligatorie, del reato di cui all’art. 21 della legge Merli, e di alcuni reati fiscali e
valutari.
6. Decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 34 c.p.):
la legge di Modifiche al sistema penale ha anche modificato questa pena accessoria (prima
“perdita o sospensione dell’esercizio della patria potestà o dell’autorità maritale”) per
armonizzarla con la riforma del diritto di famiglia del 1975.
La legge determina i casi in cui la condanna comporta la decadenza dalla potestà dei genitori, e
la condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori comporta la sospensione
dell’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Dispone inoltre
con con la decadenza e con la sospensione (in questo caso solo durante la sospensione) della
potestà genitoriale, i genitori perdano anche ogni diritto ad essi spettanti sui beni del figlio.
La decadenza della potestà genitoriale consegue ipso iure alla condanna all’ergastolo e alla
condanna per determinati delitti, in particolare contro la moralità pubblica e il buon costume,
mentre la sospensione della potestà consegue alla condanna alla reclusione per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni.
7. Estinzione del rapporto di impiego o di lavoro è invece una nuova pena accessoria
introdotta con la legge n. 97/2001.
Le singole pene accessorie previste per le contravvenzioni sono le seguenti:
1. Sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte (art. 35 c.p.): questa pena
accessoria ha un contenuto afflittivo identico all’interdizione dall’esercizio di una professione o
di un’arte disposta dall’art. 30, ma si distingue da essa perché non comporta la decadenza per
permesso, abilitazione o licenza già regolarmente ottenuti, ma ne comporta la sospensione.
Questa pena accessoria consegue ad ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa
con abuso della professione, arte, industria o del commercio o mestiere, o con violazione dei
doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore ad un anno di arresto, e può
avere inoltre una durata che va dai 15 giorni ai 2 anni.
2. Sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35 bis
c.p.): questa pena accessoria è stata introdotta dalla legge di Modifiche al sistema penale (legge
n. 689 del 1981), ed essa ha un contenuto afflittivo identico all’interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese dell’art. 32 bis. Questa pena accessoria consegue ad
186
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso di poteri o violazione dei
doveri inerenti all’ufficio e può avere una data che va dai 15 giorni ai 2 anni.
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA
All’art. 36 c.p. viene prevista una pena accessoria comune a delitti e contravvenzioni, ed è la già citata
pubblicazione della sentenza penale di condanna, la quale deve essere ordinata dal giudice ed eseguita
con la pubblicazione (di regola per estratto e sempre una sua volta) della sentenza di condanna in uno
o più giornali stabiliti dal giudice, ed a spese del condannato, oppure sul sito internet del Ministero
della giustizia.
Questa pena accessoria consegue alla condanna per delitti o contravvenzioni nei casi stabiliti della
legge. Inoltre, la sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo viene pubblicata mediante affissione nel
comune in cui è stata pronunciata, in cui in cui è stato commesso il delitto e in quello in cui il
condannato aveva l’ultima residenza, e viene anche pubblicata (per effetto della legge n. 11/2011) sul
sito internet del Mistero della giustizia.
In dottrina sono stati sollevati alcuni problemi di costituzionalità di questa pena accessoria, in
riferimento al principio di umanità ex art. 27 comma 3 Cost.
LE PENE SOSTITUTIVE
Con la legge di Modifiche del sistema penale (legge n. 689/1981) sono state introdotte, tra le novità
più significative, le sanzioni sostitutive delle pene detentive di breve durata, infatti è prevalente
l’orientamento che ritiene che le pene detentive di breve durata siano inefficaci, nonché
desacralizzanti e potenzialmente criminogene. Nel nostro ordinamento le sanzioni sostitutive previste
sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria. Questi tipi di pene più che alla
risocializzazione (cui non sono particolarmente idonee) tendono alla dissuasione dal commettere
futuri reati e ad evitare la desocializzazione della carcerazione breve. La semidetenzione e la libertà
controllata sono sanzioni autonome, collocabili sullo stesso piano delle pene principali, mentre la
multa e l’ammenda come sanzioni sostitutive non si discostano dalle pene principali corrispondenti.
LE SINGOLE PENE SOSTITUTIVE
1. Semidetenzione: ex art. 55 l. 689/1981, è la misura sostitutiva delle pene detentive fino a due
anni, e comporta l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno negli istituti penitenziari, il
divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, la sospensione della patente di guida, il ritiro
del passaporto, la sospensione della validità, ai fini dell’espatrio, di ogni altro documento
equipollente, e l’obbligo di conservare e di presentare agli organi di polizia l’ordinanza
contenente le prescrizioni imposte.
La semidetenzione ha quindi un contenuto in parte analogo a quello della semilibertà.
2. Libertà controllata: ex art. 56 l. 689/1981, è la misura sostitutiva delle pene detentivo fino ad
un anno, e comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo autorizzazione
per motivi di lavoro, studio, famiglia o salute), l’obbligo di presentarsi almeno una volta al
giorno, nelle ore fissate, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il
comando dell’arma dei carabinieri territorialmente competente, il divieto di detenere armi,
munizioni ed esplosivi, la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto e la
sospensione di validità di documenti equipollenti ai fini dell’espatrio, e l’obbligo di conservare
e presentare agli organi di polizia l’ordinanza contenente queste prescrizioni.
3. Pena pecuniaria: è la sanzione sostitutiva delle pene detentive fino a sei mesi. Il ragguaglio tra
la pena detentiva e le pene sostitutive è il seguente: un giorno di detenzione equivale ad un
giorno di semidetenzione, a due giorni di libertà controllata, o a 250 euro di multa o ammenda.
Le sanzioni sostitutive si applicano in presenza di condizioni fissate dalla legge, che si distinguono in:
187
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Condizioni oggettive: la pena in concreto irrogata dal giudice e il tipo di reato
Condizioni soggettive: se vi è una precedente condanna superiore a due anni, ecc
È a discrezione del giudice se e come applicare le sanzioni sostitutive, sulla base di precisi criteri-
guida; esse possono inoltre essere applicate d’ufficio o su richiesta dell’imputato mediante l’istituto del
patteggiamento. Le pene sostitutive possono poi essere revocate o convertite in caso di inosservanza
delle prescrizioni imposte al condannato, ma è molto controverso se esse possano essere sospese
condizionalmente (non può tuttavia non rilevarsi come l’eventuale sospendibilità sarebbe incongrua
dal punto di vista politico-criminale perché cancella i vantaggi special-preventivi della sostituzione
delle pene detentive brevi, e inoltre indebolisce il sistema sanzionatorio).
La disciplina positiva delle pene sostitutive è comunque in continuo cambiamento per effetto delle
contingenti esigenze che emergono nel settore penitenziario.
LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Le misure alternative alla detenzione sono uno degli strumenti più significativi nella prospettiva
dell’attuazione del principio del finalismo rieducativo della pena ex art. 27 comma 3 Cost.
A seguito di un lungo e complesso processo di riforma, ossi le misure alternative alla detenzione sono
le seguenti:
1. Affidamento in prova al servizio sociale: questa misura, che è la più importante delle misure
alternative, si ispira alla misura anglosassone del probation, ma quest’ultima lascia il soggetto
in libertà con determinate prescrizioni e il controllo e l’aiuto di personale specializzato, mentre
l’affidamento in prova presuppone invece quasi sempre iniziata l’esecuzione della pena
detentiva (viene infatti definito probation penitenziario a causa della sua natura ibrida).
L’art. 47 ord. pen. stabilisce che il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni
(quattro anni a seguito del d.l. n. 146 del 2013) può essere affidato al servizio sociale fuori
dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
Il contenuto di questa misura alternativa consiste nelle prescrizioni imposte all’affidato, alcuni
delle quali sono espressamente previste, mentre altre sono invece genericamente indicate
nelle loro direttive d’ordine generale, e rispetto a queste - se non agevolassero il reinserimento
del reo e avessero un contenuto concretamente afflittivo - potrebbero esservi problemi
costituzionali.
L’affidamento in prova viene revocato se il comportamento del soggetto è incompatibile con la
prosecuzione della prova perché contrario alla legge o alle prescrizioni, ma non viene
comunque revocato ipso iure con la commissione di un altro reato (serve infatti comunque la
valutazione di incompatibilità).
L’art. 47 ord. pen. stabilisce altresì che l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena e
ogni altro effetto penale, ma non estingue le pene accessorie e le obbligazioni civili che
derivano dal reato.
2. Affidamento in prova per tossicodipendenti o alcooldipendenti: questa è una particolare
ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale, previsto in considerazione delle particolarità
legate allo stato di dipendenza del condannato, il quale potrà usufruire di questa misura
alternativa se ne fa domanda e se ha in corso un programma di recupero o che intende
sottoporvisi, e se deve inoltre scontare una condanna non superiore a quattro anni. Questa
misura ha l’obiettivo di non vanificare l’effetto positivo del programma di recupero intrapreso
o che vuole intraprendere il reo.
3. Detenzione domiciliare: costituisce, in realtà, una mera modalità di esecuzione della pena per
alcune categorie di condannati verso i quali non sortirebbe l’effetto “risocializzante” la
sanzione penale normalmente eseguita.
Questa misura, le cui modalità e prescrizioni sono stabilite dal tribunale di sorveglianza, viene
revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge e alle prescrizioni dettate,
appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
188
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Per i soggetti affetti da HIV o altra grave forma di immunodeficienza è prevista una particolare
forma di detenzione domiciliare, se essi hanno in corso o intendono sottoporsi ad un
protocollo di cura ed assistenza presso strutture ospedaliere o universitarie attrezzate a
questo fine.
4. Semilibertà: prevista dall’art. 48 ord. pen., consiste in un regime (che può essere concesso ab
initio) di parziale limitazione della libertà personale, alternata con un periodo di libertà in cui il
soggetto deve svolgere “attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento
sociale”. Anche questa è più una modalità di esecuzione della detenzione più che una misura
alternativa, perché attenua lo stato di privazione della libertà. Il tempo trascorso in semilibertà
viene sempre considerato come pena detentiva scontata.
La semilibertà può essere revocata se il soggetto si dimostra inidoneo al trattamento o rimane
ingiustificatamente assente dall’istituto per più di 12 ore.
5. Liberazione anticipata: l’art. 54 ord. pen. stabilisce che al condannato a pena detentiva che
ha provato di partecipare all’opera di rieducazione viene come riconoscimento concessa una
detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata (valutando anche il periodo di
custodia cautelare e di detenzione domiciliare). Questo sconto è un incentivo per il detenuto a
partecipare alla rieducazione, ed esso era stato aumentato a 75 giorni per semestre con il d.l. n.
146 del 2013 (ma questa era misura temporanea di durata biennale).
6. Permessi premio: la funzione dei permessi premio è analoga a quella delle misure alternative
alla detenzione, ed essi si concedono ai condannati che hanno tenuto regolare condotta, ossia
hanno manifestata senso di responsabilità e correttezza nella vita carceraria, e che non
risultano socialmente pericolosi, con l’obiettivo di consentire loro di coltivare interessi
affettivi, culturali o di lavoro. L’esperienza dei permessi premio è parte integrante del
programma di trattamento, e va seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in
collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
I permessi non possono andare oltre i 45 giorni in ciascun anno di espiazione.
7. Art. 4 bis ord. pen.: con l’introduzione dell’art. 4 bis ord. pen. (ad opera dell’art. 1 del d.l. n.
152 del 13 maggio 1991) si è soddisfatta l’esigenza di una disciplina penitenziaria
differenziata per i condannati appartenenti alla criminalità organizzata od eversiva. Con
questa disposizione si realizza un doppio binario tra condannati per reati comuni e condannati
appartenenti alla criminalità organizzata ed eversiva, salvo eccezioni per coloro che
collaborano con la giustizia, e a certe condizioni per quelli per cui si possano sicuramente
escludersi collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
L’odierna art. 4 bis ord. pen. stabilisce dunque che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione, tranne la liberazione anticipata, possono essere
concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi dell’art. 416 bis c.p. o al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e anche per delitti degli
articoli 416 bis e 630 c.p. e art. 74 del d.p.r. n. 309 del 9 ottobre 1990, solo nei casi in cui
collaborano con la giustizia a norma dell’art. 58 ter ord. pen. o se non risultano collegamenti
attuali con la criminalità organizzata o eversiva.
Ai detenuti per gli stessi delitti, cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste
dall’art. 62 n. 6 c.p., 114 c.p., o 116 comma 2 c.p., questi benefici possono essere concessi anche
se la collaborazione offerta risulti irrilevante, purché siano stati acquisiti elementi tali da
escludere il collegamento attuale del detenuto con la criminalità organizzata.
Per i detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordinamento costituzionale o per i delitti degli artt. 575, 628 comma 3, 629 comma 2 c.p., e
73 e 80 comma 2 del d.p.r. n. 309/1990, questi benefici possono essere concessi solo se non vi
sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o
eversiva.
189
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Questa rigorosa disciplina vuole essere un forte deterrente contro la pericolosità sociale di
questi particolari rei, ma sollecitare anche il pentitismo attraverso i “premi”.
190
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO TRE
COMMISURAZIONE DELLA PENA
IL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE
La commisurazione della pena è la determinazione, da parte del giudice attraversi suo potere
discrezionale (art. 132 comma 1 c.p.), della quantità di pena da infliggere in concreto al reo entro
minimo e massimo edittali, e la scelta del tipo di sanzione da applicare al reato, indicando anche i
motivi che giustificano l’uso del suo potere discrezionale (art. 132 comma 2 c.p.). La scelta di quantità
e tipo della pena viene affidata al potere discrezionale del giudice perché il legislatore non è in grado di
valutare tutte le sfumature contenute in ogni singolo e concreto caso, e dunque ciò va valutato caso per
caso dal giudice.
L’opinione dominante sostiene che il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena
sia però vincolato da limiti legislativamente predeterminati:
il quadro edittale della pena (deve scegliere entro minimo e massimo edittali), in quanto le
pene hanno carattere mobile, ovvero oscillano tra un minimo e un massimo
la previsione esplicita degli indici di commisurazione dell’art. 133 c.p.
l’obbligo di motivazione ex art. 132.2 c.p
La discrezionalità, dunque, proprio perché vincolata, si limiterebbe a proseguire l’opera del legislatore,
concretizzandone le scelte e realizzando i fini in rapporto al fato concreto oggetto di giudizio.
Bisogna però verificare se e fino a che punto questa discrezionalità vincolata si sia tradotta in realtà:
nella prassi applicativa si registra una tendenza giurisprudenziale a svilire l’obbligo della motivazione
ex art. 132, inoltre l’art. 133 indica solo apparentemente criteri di commisurazione della pena capaci di
vincolare il potere discrezionale del giudice, poiché non fornisce in realtà indicazioni univoche, ma fa
riferimento a fattori che a seconda della finalità prevalente dell’interprete assumono un significato e
una rilevanza diversi.
L’attribuzione al giudice di un potere di scelta della misura concreta della sanzione risulta inoltre
compatibile con il principio di legalità riferito non solo al precetto penale, ma anche alle conseguenze
sanzionatorie, e la Corte costituzionale nel difendere la legittimità dell’art. 132 ha escluso che il
principio di legalità ostacoli l’attribuzione all’organo giudicante di un adeguato ambito di
discrezionalità.
La stessa Corte ha più di recente affermato il principio della tendenziale illegittimità delle pene
fisse, ritenendo che l’individualizzazione della pena in rapporto alle specifiche esigenze del caso
concreto sia una naturale conseguenza del principio di uguaglianza e dei principi della responsabilità
personale e del finalismo rieducativo che la Costituzione prevede con riguardo alla materia penale.
CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA DEI CRITERI DI COMMISURAZIONE
La dottrina si è sforzata di sviluppare una sistematica dei criteri o indici di commisurazione della pena,
tra i quali vi sono:
1. Criteri finalistici: significa che il primo nodo che il giudice deve risolvere riguarda i fini da
raggiungere con l’irrogazione della pena. A seconda che si privilegi la finalità di prevenzione
generale, speciale, e retributiva potrebbero sembrare più adeguate pene diverse, e questo
richiede l’istituzione di una gerarchia tra i diversi scopi della pena per evitare antinomie nella
fase di commisurazione
2. Criteri fattuali: una volta chiarite le finalità dell’irrogazione della sanzione il giudice deve
preoccuparsi di selezionare le circostanze di fatto che assumono rilevanza alla stregua dei
criteri finalistici: se ad esempio si considera che debba dominare il principio retributivo, allora
verrà attribuita rilevanza ad indici fattuali come la gravità obiettiva del reato commesso e il
grado di colpevolezza, mentre se si considera prevalente la prevenzione speciale prevarranno
le circostanze di ordine soggettivo che rilevano nella prognosi di ricaduta nel reato.
3. Criteri logici: infine, dovrà valutarsi il rispettivo peso degli indici fattuali ai fini di un giudizio
191
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
sulla complessiva gravità del reato e di un corrispondente dosaggio della sanzione tra il
massimo e il minimo edittali
GLI INDICI DI COMMISURAZIONE PREVEDUTI DALL’ART. 133 C.P.
LA GRAVITÀ DEL REATO
I criteri elencati dal legislatore all’art. 133 c.p. vengono differenziati a seconda che si riferiscano alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere del soggetto.
Il comma 1 dell’art. 133 c.p. stabilisce che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale dato
dall’art. 132, deve tenere conto della gravità del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità
dell’azione: il disvalore dell’azione può anche desumersi in via analogica dalle circostanze di
fatto che il legislatore stesso valuta come aggravanti o attenuanti.
2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato: gravità del danno
o del pericolo si valuta assumendo come punto di riferimento l’offesa tipica intesa
nell’accezione penalistica, e non le conseguenze dannose in senso civilistico; e va inoltre
osservato che un pericolo concreto è sempre più grave di un pericolo astratto riferito allo
stesso bene
3. dall’intensità del dolo o dal grado della colpa: si misura considerando la forma in cui esso si
manifesta, nel senso che nel dolo intenzionale la volontà colpevole è di maggiore intensità, e
diventa sempre meno intensa nel dolo diretto e nel dolo eventuale. Per accertare invece il
grado della colpa bisogna fare riferimento ad una seri di criteri come il quantum rispettivo di
esigibilità della condotta doverosa e di divergenza tra la condotta tenuta e la regola
precauzionale applicabile al caso concreto, ecc.
gli indici qui elencati hanno riguardo alla gravità del reato considerato nelle rispettive componenti
materiale e psicologica, per cui nella prima fase dell’iter commisurativo si valutano tutti gli aspetti
capaci di incidere sul disvalore della condotta e dell’evento, nonché sulla natura e sull’intensità
dell’elemento soggettivo.
LA CAPACITÀ A DELINQUERE
L’art. 133 comma 2 afferma che nell’esercizio del potere discrezionale il giudice deve anche tenere
conto della capacità a delinquere del reo, che viene desunta:
1. Motivi a delinquere e carattere del reo: il motivo o movente è la causa psichica o stimolo che
induce l’individuo a delinquere, ed esso può essere anche inconscio e dunque ignoto al reo
stesso (anche se non è così scontato che i motivi inconsci possano assumere rilevanza penale,
soprattutto per l’incompetenza del giudice ad emettere giudizi attendibili sulle pulsioni
inconsce del reo)
Gli psicologici tendono a concepire il carattere come il termine di transizione tra i fattori
endogeni, ossia il temperamento, e i fattori esogeni, ossia l’ambiente, che contribuiscono ad
integrare la sua personalità, dal momento che il carattere è in un certo senso la combinazione
di questi fattori, ed esso ha un ruolo centrale come elemento diagnostico della capacità
criminale. Il risultato di questa tensione rappresenta una struttura di autocontrollo e uno
strumento di orientamento dell’individuo nella scelta tra diverse possibilità di azione.
Il comportamento cui allude l’art. 133 è comprensivo di tutte le componenti biologiche,
psichiche ed etiche della personalità, richiamandone una concezione lata.
2. Vita e condotta del reo antecedenti al reato: la personalità di un soggetto si deve ricostruire
tenendo conto di tutti gli aspetti capaci di illuminarla, compresi dunque anche gli antecedenti
idonei a fungere da elementi indizianti. Antecedenti intesi non solo come precedenti penali o
giudiziali, ma in generale come tutti gli episodi che possono essere indice del modo di essere e
192
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
di comportarsi del reo.
3. La condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato: questi indici sono
significativi per la loro vicinanza al reato commesso, e possono influenzare il giudizio (in
positivo ad esempio nel caso del rimorso o della collaborazione processuale, o in negativo ad
esempio nel caso della soddisfazione o del compiacimento).
4. Le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo: la valutazione di questi
elementi serve a valutare l’incidenza dell’ambiente esterno nel processo criminogeno.
La previsione di questi ulteriori indici fattuali serve ad estendere la valutazione giudiziale del fatto
oggettivo alla personalità del reo, e in questo senso il primo comma dell’art. 133 è segno del
compromesso tra le scuole opposte del diritto penale, mentre il secondo comma sembra tenere conto
delle istanze del positivismo criminologico, orientato a considerare l’attitudine a delinquere ai fini di
una prognosi di pericolosità sociale.
Questo suo carattere di “compromesso” tra le due teorie ha fatto nascere interpretazione diverse
dell’art. 133 e della capacità a delinquere, dovute alla sua equivocità. Alcuni hanno dunque proiettato
la capacità a delinquere nel passato, facendola consistere in una sorta di attitudine al reato
commesso, nel quale del giudizio di colpevolezza, mentre altri l’hanno invece proiettata nel futuro,
identificandola con l’attitudine a commettere nuovi fatti delittuosi. Inoltre, all’interno della teoria della
proiezione nel passato della capacità a delinquere, una parte della dottrina si sforza di riportare la
capacità criminale sul terreno della colpevolezza; all’interno della teoria della proiezione nel futuro,
invece, alcuni autori tendono ad identificare la capacità a delinquere con la pericolosità sociale, mentre
altri propongono una distinzione quantitativa dei due concetti (la capacità a delinquere
identificherebbe la possibilità di violare la legge penale in futuro, e la pericolosità sociale
identificherebbe invece la probabilità di ciò).
Vi è infine un ulteriore orientamento, che tende ad individuare una duplice funzione della capacità a
delinquere, ossia:
una funzione di graduazione della colpevolezza, sul presupposto che tanto più riprovevole è il
fatto, quanto maggiore è l’attribuibilità morale del fatto stesso all’autore
una funzione prognostica, volta ad accertare la potenzialità criminosa del soggetto in una
prospettiva di prevenzione speciale
Fondamentale, nel discernere quale delle due teorie debba prevalere, è l’aggancio delle stesse al testo
costituzionale.
AMBIGUITÀ E INSUFFICIENZE DEL MODELLO DI DISCIPLINA CONTENUTO NELL’ART. 133 C.P.
Si può notare come i criteri dell’art. 133 siano ambigui anche guardando il pur meno controverso
criterio della gravità del reato, infatti essa può assumere rilevanza non solo in un’ottica
tradizionalmente retributiva orientata all’entità del danno e/o del grado della colpevolezza, ma anche
in una prospettiva di prevenzione generale (in questo senso il reato è più grave più attenua la fiducia
dei consociati nella capacità dell’ordinamento di arginare la criminalità) e di prevenzione speciale (in
questo senso il reato è tanto più grave quanto maggiore è il livello di criminosità latente che denuncia
nel soggetto). L’ambiguità si ritrova comunque anche nel secondo comma, nel terreno della capacità a
delinquere.
Non è comunque chiaro in che rapporto gerarchico stiano i due commi dell’art. 133, e ci si chiede
dunque se il principale criterio di commisurazione della pena sia la gravità del reato o la capacità a
delinquere, o un contemperamento dei due. La fondamentale equivocità della norma dipende però
soprattutto dal fatto che essa si limita a enumerare indici fattuali di commisurazione, senza però
prendere posizione esplicita sui criteri finalistici che dovrebbero presiedere all’irrogazione della
sanzione, e rimane dunque poco chiaro quale ruolo nella fase interrogativa sia rispettivamente da
attribuire alla retribuzione, alla prevenzione generale e/o a quella speciale. Perciò, si può dire che i
criteri dell’art. 133 non siano sufficienti a vincolare davvero l’esercizio del potere discrezionale del
193
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
giudice, infatti la sua applicazione giurisprudenziale è stata nel complesso di “cattiva riuscita”, tanto
che l’obbligo di motivazione dell’art. 132 è stato sostanzialmente eluso, e la motivazione è spesso
dipesa non solo dai criteri, ma dall’intuito o persino arbitrio del giudice. Un’altra tendenza
giurisprudenziale è stata inoltre quella di irrogare il minimo - o quasi - della sanzione, forse per
contrastare il rigorismo del codice Rocco; tuttavia, si rischia che questo fenomeno sfoci in
un’indulgenza poco controllata e che rischia di collidere con le specifiche esigenze della
commisurazione della pena.
ESIGENZA DI UNA RILETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL’ART. 133 C.P.
Per supplire al silenzio dell’art. 133 c.p. sui criteri finalistici che presiedono all’irrogazione della
sanzione bisogna tentate un approccio costituzionalmente orientato ai problemi della commisurazione
della pena. L’art. 27 comma 1 Cost. ha implicitamente riconosciuto il principio della responsabilità
personale e colpevole, e riflette dunque un orientamento del sistema penale diretto alla
valorizzazione dell’elemento soggettivo del reato. Coerenza impone dunque di ritenere che il requisito
della colpevolezza abbia un ruolo centrale nella commisurazione della pena, e dunque l’art. 133
comma 1 va interpretato ritenendo come prevalenti l’intensità del dolo o il grado della colpa tra gli
indici di gravità del reato.
Prendendo le mosse sempre dall’art. 27 comma 1 Cost. si può dire che, dal momento che non è
consentita la responsabilità per fatto altrui, dovrà essere scoraggiata la valorizzazione giudiziale
dell’indice della gravità del danno o del pericolo (valorizzazione che avrebbe il fine di far prevalere
preoccupazioni di prevenzione generale), dal momento che, se essa venisse valorizzata e fossero
comminate “pene esemplari”, il reo finirebbe con lo scontare una pena che eccede la sua colpevolezza.
L’art. 27 comma 3 Cost. afferma invece il principio della rieducazione, il quale impone che debba
essere irrogata una sanzione idonea sia nel tipo che nella misura a favorire la risocializzazione del reo.
Il principio di rieducazione implica che la categoria della capacità a delinquere dell’art. 133 comma 2
venga ricostruita in chiave di prevenzione speciale, e dunque il giudizio sulla capacità a delinquere del
reo dovrà essere proiettato nel futuro, e fungerà da criterio di scelta e/o dosaggio di una pena che
andrà determinata in vista del reinserimento sociale del soggetto (sempre entro i limiti della
colpevolezza, anche perché se essi non venissero rispettati la pena non verrebbe più percepita come
giusta dal reo, e ciò comprometterebbe la sua disponibilità psicologica alla rieducazione). Il giudice
potrà dunque applicare una pena meno elevata rispetto a quella che il grado di colpevolezza
esigerebbe, solo quando ritenga che ciò serva a facilitare il processo di reinserimento sociale del reo.
Dunque si può dire che il principale parametro di commisurazione della pena è quello dato dall’art.
133 comma 1, che indica al giudice di stabilire il massimo edittale di pena entro i limiti della
colpevolezza relativa al fatto oggetto di giudizio, mentre l’art. 133 comma 2 svolge un ruolo
subordinato, come dimostrato dal fatto che viene usato l’avverbio “altresì" per introdurre il
riferimento alla capacità a delinquere, e infatti il giudizio sulla capacità a delinquere può indurre il
giudice a ridurre la pena al di sotto del limite massimo segnato dalla gravità del fatto colpevole.
I TERMINI DELL’ATTUALE DIBATTITO TEORICO
Non tutti gli appartenenti alla dottrina condividono la tesi che nega alla prevenzione generale il ruolo
di autonomo criterio “finalistico” di commisurazione della pena. Una parte della dottrina sottolinea
infatti che se si include la prevenzione generale tra gli scopi principali della pena, la coerenza
imporrebbe di riconoscerle il medesimo spazio nello stadio della sua concreta irrogazione.
All’obiezione che a riconoscerle questo spazio si finirebbe col violare il divieto di responsabilità per
fatto altrui si replica che se l’argomento fosse davvero valido esso dovrebbe impedire anche al
legislatore di tenere conto delle esigenze di prevenzione generale dei minimi e massimi edittali, nel
senso che un diritto a non essere punito per fatto altrui l’imputato lo avrebbe anche quando si
pretenda di assegnargli il minimo della pena. Vi è poi chi obietta che il giudice non avrebbe la
competenza per conoscere adeguatamente le esigenze di prevenzione generale, ma a questo si
risponde che questa competenza gli mancherebbe anche per valutare le esigenze di risocializzazione
194
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
del reo, e in ogni caso ai giudici si dovrebbe chiedere solo una conoscenza intuitiva, basata
sull’esperienza della vita giudiziaria.
Questi rilievi diretti a giustificare l’inclusione della prevenzione generale tra i criteri finalistici della
pena da irrogare in concreto non sembrano in realtà decisivi. Questa impostazione trascura inoltre che
in uno Stato di diritto spetta al legislatore soddisfare le istanze di prevenzione generale, mentre ai
giudici spetta solo di scegliere la pena adeguata al caso concreto oggetto di giudizio (anche se
l’infliggere una pena in giudizio ha anche valenze generalpreventive, nel senso che in questo modo
viene avvalorata la credibilità della minaccia contenuta nei precetti astratti).
Per quanto riguarda poi l’argomento secondo cui il divieto di responsabilità penale per fatto altrui
dovrebbe valere anche per il legislatore preoccupato di orientare secondo la prevenzione generale i
livelli di pena, si può dire che questo argomento pretenda di provare troppo, e che ad esso si può
replicare che a livello di previsione legislativa dell’entità della sanzione, non ci si trova di fronte ad
alcun soggetto da giudicare, mentre lo stadio della commisurazione della pena presuppone proprio un
fatto già commesso.
Infine, si può anche ammettere che il giudice non sia in grado di stabilire scientificamente quale
trattamento sia il più idoneo a favorire la risocializzazione, ma questo non basta per rivalutare
l’attitudine dei giudici a conoscere le esigenze di prevenzione generale, infatti si può dire che il giudice
possa scegliere una pena potenzialmente rieducativa o quanto meno non desocializzante anche con
una conoscenza meramente intuitiva.
Un’eccessiva fiducia in una commisurazione generalpreventiva della pena sembra poi trascurare che
l’efficacia di una simile operazione dipende da condizioni empiriche che sono difficilmente verificabili
e/o accertabili, e dunque occorre che il messaggio giudiziale sia comunicato ai destinatari attraverso
mass media o altri canali di informazione, che i destinatari comprendano il significato delle sentenze
esemplari, che facciano sì che esse motivino la loro condotta, ecc.
Qualunque sia l’effettiva portata delle divergenze dottrinali in atto, è facile pronosticare che qualsiasi
nuova proposta diretta razionalizzare la prassi della commisurazione della pena incontrerà ostacoli
negli orientamenti giurisprudenziali. Dunque è da auspicare una riforma dell’art. 133 che recepisca i
criteri finalistici di commisurazione della pena di derivazione costituzionale.
LA COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA (ART. 133 BIS C.P.)
Il codice Rocco si limitava a prevedere la possibilità di un aumento fino al triplo della multa e
dell’ammenda qualora le pene pecuniarie dovessero presumersi inefficaci per le condizioni
economiche del reo, anche se applicate nel loro massimo. La legge di Modifiche al sistema penale (n.
689/1981), invece, ha introdotto l’art. 133 bis del codice penale, che dispone che “nella
determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei
criteri indicati nell’articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo”, e dunque le
condizioni economiche del reo vengono incluse tra i criteri di commisurazione della pena pecuniaria
già all’interno degli spazi edittali.
L’articolo dispone però che le condizioni economiche del reo vanno tenute in conto in aggiunta ai
criteri indicati all’art. 133, e dunque tra i modelli di pena pecuniaria il legislatore ha comunque
prescelto quello tradizionale della somma complessiva, in cui gli indici di commisurazione sono
quelli generali della gravità del reato e della capacità a delinquere. Tale scelta disattende. Però,
l’orientamento della dottrina più consapevole, la quale propende per i diverso modello dei “tassi
giornalieri”, che separa in due autonomi momenti la fase della commisurazione: nel primo momento
viene fissato il numero dei tassi sulla base dei criteri generali, mentre nel secondo momento si
determina l’ammontare del tasso giornaliero sulla base delle condizioni economiche del reo. Forse
questo modello non è stato seguito per cercare di eludere i problemi dell’accertamento del reddito
degli imputati.
Sul piano dell’interpretazione della formula normativa una grave lacuna è quella costituita dal fatto
che il legislatore tace sugli indici di cui il giudice deve tenere conto in sede di valutazione delle
195
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
condizioni economiche del condannato. Poiché mancano indicazioni legislative, sono gli interpreti a
dover suggerire criteri di valutazione: il giudice deve innanzitutto riferirsi al reddito del reo al
momento della condanna, ma è più controversa l’incidenza del patrimonio all’interno della situazione
economica del reo, e a questo proposito una parte della dottrina ritiene che i beni patrimoniali
incidano solo se superano uno standard medio rispetto alla contingente situazione economico-sociale.
Bisognerà comunque sottrarre dal novero delle disponibilità economiche le obbligazioni pecuniarie
che gravano sul reo. L’accertamento del reddito, in assenza di disposizioni normative, non può che
essere rimesso ai poteri di indagine del giudice e, dunque, ai generici accertamenti della polizia
giudiziaria. Ruolo rilevante, tuttavia, deve essere attribuito alle dichiarazioni del condannato.
L’art. 133 bis comma 2 stabilisce poi che il giudice può aumentare la multa e l’ammenda stabilite dalla
legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga
che la misura massima sia inefficace o che la misura minima sia eccessivamente gravosa, entrambe
circostanze che vanno valutate in funzione degli scopi di afflizione e intimidazione-ammonimento
(valutazioni comunque molto difficili, dal momento che sull’incidenza della pena pecuniaria
influiscono anche dati psicologici).
Infine, vanno disattesi i dubbi di costituzionalità che hanno circondato questo articolo, in quanto
rappresenta in realtà una concreta attuazione dell’art. 3 Cost.
POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NELLA SOSTITUZIONE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
La legge di Modifiche al sistema penale ha esteso i limiti del potere discrezionale del giudice,
prevedendo nuove possibilità di sostituzione, ex art. 58, delle pene detentive brevi, nel senso che
dopo avere scelto la pena il giudice, tenendo conto dei criteri dell’art. 133 c.p., deve valutare se
sussistano i presupposti per l’adozione delle misure sostitutive, e una volta risolto il quesito deve
scegliere la misura più idonea al reinserimento sociale del condannato (a meno che la pena detentiva
non sia superiore ai tre anni).
I “presupposti” per applicare la misure sostitutive sono il fatto che la personalità del reo non deve
poter risultare danneggiata dall’applicazione di una pena detentiva breve. Nel pronunciarsi sulla
misura sostitutiva più idonea, il giudice deve adottare invece il criterio dell’idoneità a favorire il
reinserimento sociale del condannato, ma questo obiettivo è troppo ambizioso rispetto alle reali
caratteristiche delle pene sostitutive, e infatti il giudice dovrà piuttosto valutare quale sia la sezione
più idonea ad ammonire e a non desacralizzare il reo.
La stessa legge predetta impone però al giudice di non sostituire la pena detentiva breve quando
presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. La preclusione conseguente ad
una presunzione negativa ha, evidentemente, per scopo di impedire complessi procedimenti di
sosdtituzione e revoca delle misure sostitutive per fare ritorno all’applicazione della pene sostitutiva
breve.
Infine, obbliga poi il giudice ad indicare specificamente i motivi che giustificano la scelta del tipo di
pena irrogata (ultimo comma) per rendere più trasparente l’esercizio del potere discrezionale nella
scelta della sanzione sostitutiva.
POTERE DISCREZIONALE E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Anche nell’applicazione delle misure alternative alla detenzione (introdotte con la legge n. 354/75 e
modificate dalle leggi n. 663/86 e 165/98) vi è potere discrezionale, potere che il tribunale di
sorveglianza istituito presso ogni Corte d’Appello deve esercitare in base a criteri finalistici
legislativamente predeterminati.
L’art. 47 comma 2 ord. pen. stabilisce, rispetto all’affidamento in prova al servizio sociale, che
il provvedimento può essere disposto nei casi in cui si possa presumere che il provvedimento
stesso anche attraverso le prescrizioni contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
L’art. 50 comma 4 ord. pen. stabilisce poi che l’ammissione alla semilibertà viene disposta in
relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento quando vi sono le condizioni per un
196
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
graduale reinserimento del soggetto nella società.
L’art. 54 comma 1 ord. pen. stabilisce che per potersi applicare la liberazione anticipata, il
condannato a pena detentiva deve avere dato prova di partecipazione all’opera di
rieducazione.
L’art. 30 ter ord. pen. richiede, per i permessi premio, che il magistrato di sorveglianza accerti
che i condannati abbiano tenuto una regolare condotta e non risultino di particolare
pericolosità sociale.
L’art. 47 ter ord. pen. indica infine le ipotesi in cui si può concedere la detenzione domiciliare.
197
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO QUATTRO
VICENDE DELLA PUNIBILITÀ
CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ
Vi sono casi in cui il legislatore subordina la punibilità del fatto alla presenza di particolari condizioni,
che si aggiungono ai tipici elementi costitutivi essenziali del reato. L’art. 44 c.p. (sotto “condizioni
obiettive di punibilità”) stabilisce che quando la legge richiede il verificarsi di una condizione per la
punibilità del reato, il colpevole risponde comunque del reato anche se l’evento da cui dipende il
verificarsi della condizione non è da lui voluto.
L’istituto delle condizioni obiettive di punibilità è uno dei più controversi del nostro codice penale,
infatti l’unico dato certo è che esse devono consistere in eventi futuri e certi, concomitanti o
successivi rispetto alla condotta dell’agente (e non antecedenti, perché, dal momento che la
prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui si verifica la condizione, se essa potesse essere
antecedente al reato vorrebbe dire che si avrebbe una prescrizione che comincia a decorrere prima
ancora che il reato sia avvenuto).
Le questioni che sono invece problematiche riguardano: la funzione politico-criminale dell’istituto,
la posizione delle condizioni obiettive nella struttura del fatto di reato, il loro rapporto con l’offesa
tipica insita nel reato, la compatibilità delle condizioni con il principio di colpevolezza, e i criteri di
individuazione delle condizioni. Nella nostra dottrina è molto diffuso l’orientamento che sostiene che
l’origine storica delle condizioni obiettive di punibilità rifletta la necessità di conciliare esigenze
contrapposte: da un lato vi sono da sempre ragioni di convenienza pratica e opportunità politico-
criminale che inducono a subordinare l’aggettiva punibilità di alcune condotte al verificarsi di
determinate circostanze, e dall’altro queste valutazioni di convenienza non possono essere affidate al
giudice, da quando in materia penale vige il principio di stretta legalità. Da questo punto di vista,
dunque, l’introduzione legislativa delle condizioni obiettive di punibilità svolge la doppia funzione di
delimitare o ridurre la rilevanza penale di determinati comportamenti, e una funzione di garanzia
connessa al rispetto del principio di legalità.
Per quanto riguarda la posizione delle condizioni obiettive rispetto alla struttura del reato, l’art. 44
dispone che il colpevole risponde anche se l’evento che integra la condizione obiettiva di punibilità
non è da lui voluta, e ciò significa che l’evento condizione può in concreto anche essere lambito dalla
volontà del reo, ma che l’esistenza di questo nesso psichico non è requisito indispensabile per la
punibilità del fatto.
Ci si chiede però se la condizione obiettiva di punibilità debba essere legata all’azione tipica da un
rapporto di causalità materiale, e si può dunque dire che nulla impedisce che la condizione obiettiva di
punibilità derivi casualmente dall’azione, ma non si può invece pretendere che il nesso causale
rappresenti sempre un requisito indefettibile.
Per quanto riguarda i criteri di individuazione della categoria delle condizioni obiettive di punibilità,
bisogna fare ricorso ad un contemperamento di:
Indici strutturali: relativi alla collocazione dell’elemento in questione all’interno della
fattispecie astratta. Applicando i criteri strutturali vanno esclusi dal novero delle condizioni gli
eventi legati da un rapporto di causalità necessaria con l’azione tipica, o da un rapporto
psicologico necessario con l’agente.
Parametri sostanziali: relativi alla determinazione dell’interesse tutelato dalla norma.
Applicando gli indici di natura sostanziale dovrebbero escludersi (e considerarsi dunque
elementi costitutivi del fatto, e non ad esso estranei) gli eventi in cui s’incentra l’offesa
all’interesse protetto.
Le condizioni obiettive possono poi essere distinte i:
Intrinseche: le quali incidono sull’interesse protetto, nel senso di approfondire una lesione già
implicita nella commissione del fatto
198
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Estrinseche: le quali non aggiungono nulla alla lesione dell’interesse protetto dalla norma
incriminatrice, ma si limitano a riflettere valutazioni di opportunità connesse ad un interesse
esterno al profilo offensivo del reato.
Secondo una parte della dottrina, dalla constatata mancanza di ogni collegamento delle
condizioni estrinseche con il piano della lesione all’interesse tutelato, deriverebbe la loro
assimilabilità alle condizioni di procedibilità dell’azione penale. Questa tesi non si può però
accogliere, poiché la pretesa natura processuale delle condizioni in esame dovrebbe fare sì che
la loro mancanza inibisca non la punibilità del fatto, ma la conoscibilità dello stesso al capo al
giudice, e se inoltre le condizioni avessero una dimensione meramente processuale non si
capirebbe il perché della loro presenza nel codice, e in particolare nella sede relativa alla
disciplina della struttura del reato, di una norma come l’art. 44 c.p. Infatti, se questa ha il fine di
chiarire la non necessarietà del collegamento psicologico dell’evento-condizione all’autore del
fatto, allora ne deriva la sua inutilità ove essa vada riferita alle modalità e ai tempi
dell’esercizio dell’azione penale.
Comunque, quale che sia l’effettiva estensione che occupano oggi le condizioni obiettive di punibilità,
rimane comunque indubbio che l’istituto si esponga a riserve critiche, infatti spesso le condizioni
obiettive vengono introdotte per superare le difficoltà di accertamento del dolo rispetto all’evento-
condizione, ma proprio questo fa sorgere la questione della compatibilità di questa scelta con il
principio della responsabilità penale personale, nel senso di colpevole. Questo problema di
compatibilità si aggrava quanto più si tratta di eventi condizionanti che hanno la capacità di incidere
sull’offesa insita nel fatto tipico, approfondendola o aggravandola. Si impone, dunque, un
ripensamento a seguito della sent. cost. 364/1988, la quale ha sancito che la colpevolezza (almeno nel
grado minimo della colpa) deve coprire tutti gli elementi significativi del fatto, nel senso che si può
sostenere che non possono sottrarsi al principio di colpevolezza le condizioni di punibilità intrinseche,
ossia gli eventi capaci di incidere sull’offesa insita nel fatto tipico, le quali dovranno essere coperte
almeno dalla colpa, infatti l’art. 44 dice che non è richiesto il dolo, ma non dice nulla sulla colpa, e
dunque l’articolo può essere interpretato in questo senso.
Per risolvere l’incompatibilità tra condizioni obiettive e principi di colpevolezza si potrebbe seguire
una strada più diretta, ossia respingere come infondata la distinzione tra condizioni intrinseche ed
estrinseche, nel presupposto che tutte le condizioni di punibilità soddisfano interessi esterni ed
antagonistici rispetto al bene giuridico sottostante al reato, e perciò ininfluenti rispetto all’offesa
tipica. Le condizioni obiettive di punibilità dunque, in questa tesi, mantengono solo la funzione di
ridurre la rilevanza penale di fatti altrimenti punibili, e dunque, poiché avvantaggiano il reo, non
porrebbero alcun problema di imputazione soggettiva, e ne deriva dunque la loro estraneità o
indifferenza rispetto al principio di colpevolezza. Questa impostazione, però, convince poco sul piano
del diritto vigente, dal momento che non vi sono ancora prove decisive sull’esistenza di condizioni
intrinseche nell’ordinamento attuale.
LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO
Nel titolo VI del codice penale viene disciplinata l’estinzione del reato e della pena, che può essere
causata da cause eterogenee che hanno l’effetto di paralizzare la punibilità come effetto tipico
dell’illecito penale.
Il codice penale distingue:
Cause di estinzione del reato: che operano antecedentemente all’intervento di una sentenza
definitiva di condanna e incidono sulla punibilità astratta
Cause di estinzione della pena: che presuppongono invece l’emanazione di una sentenza di
condanna ed estinguono la punibilità in concreto, paralizzando l’esecuzione della sanzione
inflitta dal giudice
Una parte della dottrina rigetta però questa distinzione tradizionale, constatando anche che tra le
cause estintive del reato vi è l’amnistia impropria e la sospensione condizionale, che sono due cause
che operano però successivamente alla sentenza di condanna. Questa parte della dottrina finisce
dunque col riconoscere che sia le cause estintive del reato, sia le cause estintive della pena si limitano
199
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
soltanto ad escludere tutti o alcuni effetti del reato, e sono quindi in questo senso solo cause di
esclusione o estinzione di effetti penali del reato, e la differenza consisterebbe soltanto nella più
intensa e profonda incidenza delle prime rispetto alle seconde su ciò che il reato normalmente
comporta.
Sulla qualificazione dogmatica delle cause di estinzione del reato vi sono state molte opinioni
differenti (chi le ha ritenute cause di estinzione della responsabilità penale, chi degli effetti penali, chi
della punibilità, ecc.), ma è meglio continuare a definirle cause di estinzione del reato per ragioni di
convenzione, ma è comunque impropria come denominazione, poiché del reato dal punto di vista
storico non si può eliminare, e dal punto di vista giuridico esso continua ad avere effetti anche dopo
l’estinzione (es. per la dichiarazione di abitualità e professionale nel reato, ecc.).
Le cause di estinzione del reato vengono solitamente distinte dalla dottrina secondo criteri eterogenei
in:
Generali: appartenenti alla parte generale del codice ed applicabili a tutti i reati
Speciali: se applicabilii ad uno o più reati determinati e previste in leggi speciali o nella parte
speciale del codice
Condizionate (es. sospensione condizionale della pena
Incondizionate (es. morte del reo prima della condanna
A seconda che tra i requisiti di applicabilità vi siano o meno requisiti riconducibili alla volontà
del soggetto
Fatti naturali (in cui è irrilevante la volontà umana, come nella morte del reo)
Atti di clemenza (come la grazia)
Comportamenti dello stesso autore (come l’oblazione)
Si può dire che le regole comuni alle cause di estinzione siano le seguenti:
1. hanno efficacia personale, nel senso che operano solo nei confronti della persona cui si
riferiscono, salvo che la legge disponga diversamente
2. devono essere immediatamente dichiarate dal giudice in ogni stato e grado del processo, salvo
che sia evidente il proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.)
3. sottostanno al principio del favor rei nell’ipotesi di concorso tra più cause estintive, nel senso
che l’effetto estintivo del reato o della pena dovrà essere prodotto dalla causa
comparativamente più favorevole
il codice Rocco sembra aver accolto l’orientamento per cui la natura giuridica delle stesse sia
sostanziale e non processuale.
Le singole cause estintive del reato sono:
1. la morte del reo prima della condanna
2. la remissione della querela (unico istituto puramente processuale)
3. l’amnistia propria
4. la prescrizione
5. l’oblazione nelle contravvenzioni
6. la sospensione condizionale
7. il perdono giudiziale
8. la sospensione del procedimento con messa alla prova
LA MORTE DEL REO
L’art. 150 c.p. dispone che la morte del “reo” prima della condanna (anche se non può essere
colpevole prima della condanna) estingue il reato, sulla base del principio mors omnia solvit, per cui
la morte produce i suoi effetti sui rapporti giuridici di cui è titolare il soggetto deceduto, ossia la morte
estingue tutto, le pene principali, quelle accessorie ed ogni altro effetto penale, mentre non tocca le
obbligazioni civili che nascono dal reato, ossia il risarcimento del danno, e quelle relative al pagamento
200
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
delle spese processuali e al mantenimento in carcere.
Ci si chiede invece se, nel caso in cui la morte avvenga prima della condanna definitiva, sia applicabile
la misura della confisca. La tesi dominante ritiene di sì, dal momento che essa è una misura di
sicurezza reale e non personale, e inoltre l’art. 236 comma 2 esclude, con riferimento alla confisca, il
ricorso all’art. 210 c.p., ossia alla disposizione che afferma la regola dell’inapplicabilità delle misure di
sicurezza a seguito del fenomeno estintivo.
La morte del reo non esclude comunque il proscioglimento nel merito quando ex art. 129 c.p.p. il
giudice riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. La morte del reo non esclude neanche la
possibilità per il giudice civile di accogliere la pretesa risarcitoria.
Va invece sospeso il processo in caso di fondato dubbio sull’esistenza in vita dell’imputato, come nel
caso della dichiarazione di assenza.
L’AMNISTIA PROPRIA
L’amnistia è un provvedimento generale ed astratto con cui lo Stato rinuncia a punire un
determinato numero di reati, e, in caso di condanna già avvenuta, fa cessare l’esecuzione della
condanna e delle pene accessorie, così come stabilito dall’art. 151 c.p. In realtà questo articolo non
distingue la disciplina, anche se sarebbe più opportuno, per amnistia propria, che si verifica quando
non vi è ancora stata condanna definitiva, e rappresenta una causa estintiva del reato, e amnistia
impropria, che presuppone la condanna definitiva e che è una causa di estinzione della pena.
Tradizionalmente l’amnistia viene considerata una causa di clemenza e giustificata dalla presenza di
situazioni oggettivamente eccezionali e per certi versi irripetibili.
Unitamente all’indulto e alla grazia, l’amnistia sorge storicamente come manifestazione
dell’indulgentia principis, con la quale cioè il monarca rinunciava a perseguire determinati delitti
commessi o faceva cessare condanne già inflitte.
L’art. 79 della nostra Costituzione disponeva che fosse il Presidente della Repubblica a concedere
l’amnistia, su legge di delegazione del Parlamento, ma non era chiaro se il Presidente della Repubblica
avesse in merito un potere decisionale o se si dovesse soltanto limitare a ratificare il provvedimento
parlamentare. In via di fatto la soluzione che si è prospettata è quest’ultima, e la Corte costituzionale
ne ha riconosciuto la legittimità, avallando così la prassi.
Questo strumento si è valso molte ostilità a causa del suo troppo frequente utilizzo, cui si accusa di
essere spesso un uso demagogico o elettoralistico, e che esso svilisca anche l’autorità dello Stato e la
forza intimidatrice della legge penale, e faccia inoltre aumentare i delinquenti liberi. L’uso di questo
strumento crea anche forti tensioni con le finalità razionali della sanzione penale, tanto la funzione di
deterrenza della pena, quanto la rieducazione del reo, in quanto manca la positiva prognosi circa le
chances di reinserimento sociale del beneficiario.
Va comunque notato che spesso l’amnistia viene utilizzata come strumento per fronteggiare
l’altissimo tasso di inflazione carceraria rispetto alla capienza degli istituti penitenziari, fungendo
così da surroga di mancata riforma, nonché da forma di decriminalizzazione surrettizia perché
equivale a riconoscimento della sostanziale inoffensività di alcuni reati.. Tuttavia, l’amnistia può anche
assolvere una funzione di pacificazione sociale, necessaria in alcuni momenti della vita perché,
limitando l’efficacia della legge penale dopo un periodo di gravi conflitti sociali, opera come strumento
di ricomposizione, e infatti, non a caso, la Corte costituzionale ha stabilito che la ragionevolezza di un
provvedimento di clemenza dipende dal rapporto strumentale che si instaura fra esso e le finalità
proprie della legislazione generale del settore cui si riferisce.
Per reagire all’uso disinvolto dell’amnistia, con la legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992 è stato
riscritto l’art. 79 Cost., che oggi dispone che l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale, e viene così dunque assegnato tutto il potere in questo ambito al Parlamento, con la garanzia
data però dalla votazione a maggioranza dei due terzi in ogni punto della legge, che garantisce
201
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
l’impossibilità per una maggioranza interessata di pervenire alla concessione dell’amnistia o
dell’indulto, in quanto numericamente è necessario il coinvolgimento di partiti di opposizione. Al
nuovo secondo comma dell’art. 79 viene inoltre stabilito che la legge di concessione di amnistia e
indulto deve stabilire il termine di efficacia del provvedimento, ossia la data entro cui i reati devono
essere stati commessi per poter usufruire dell’applicazione del beneficio, il quale nel testo del
medesimo articolo è fissato nel momento di presentazione del relativo disegno di legge. L’art. 151
comma 3, invece, con riferimento al vecchio art. 79 Cost., limita gli effetti estintivi ai reati commessi
sino al giorno precedente la data del decreto.
Il canone del tempus commissi delicti si applica però in modo diverso a seconda del tipo di reato
preso in considerazione:
nel reato consumato ci si riferirà al momento della realizzazione della condotta (reato di
condotta) o di realizzazione dell’evento (reato di evento) o del mancato compianto dell’azione
dovuta (reato omissivo)
nel delitto tentato si considererà il momento in cui si sono realizzati gli atti idonei
inequivocabilmente diretti a commettere il delitto
nel reato permanente è controverso se si debba considerare il momento in cui cessa la
permanenza o quello in cui comincia l’azione illecita
nel reato continuato ogni singola violazione ha un “momento” proprio
nel reato sottoposto a condizioni di punibilità si farà riferimento al tempo di verificazione della
condizione
nel concorso di reati l’amnistia si deve applicare ai singoli reati per i quali viene concessa (art.
151 comma 2). Vale il principio per cui non si estende al reato complesso di cui il reato
amnistiato rappresenta elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La legge che contiene l’atto di clemenza deve indicare i reati cd. amnistiati ed a questo scopo vengono
utilizzati diversi criteri, normalmente congiuntamente: articolo, nomen iuris o tetto di pena entro cui è
concedibile il beneficio.
L’ultimo comma dell’art. 151 stabilisce che l’amnistia, salva diversa volontà legislativa, non è
applicabile nel caso in cui il soggetto autore del reato sia stato dichiarato dal giudice recidivo
aggravato e reiterato ex art. 99 comma 2 c.p., o delinquente abituale, professionale o per tendenza
(solo “delinquenti”, mentre l’amnistia è applicabile ai contravventori qualificati).
L’amnistia, propria o impropria, può essere subordinata a condizioni o ad obblighi espressamente
previsti per legge (art. 151 comma 4).
L’amnistia è rinunciabile, infatti la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 151 comma 1
nella parte in cui escludeva la rinuncia all’applicazione dell’amnistia, per violazione del diritto di
difesa. In caso di rinuncia, il giudizio prosegue nelle forme regolari e può sfociare in una pronuncia di
condanna o di assoluzione.
Va infine sottolineato che l’amnistia propria impedisce l’inflizione della pena principale, delle pene
accessorie e delle misure di sicurezza (art. 210) ma, sulla base dell’art. 198, non estingue le
obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni di cui agli artt. 196 e 197.
LA PRESCRIZIONE
La prescrizione del reato è una causa estintiva costituita dal decorso del tempo senza che alla
commissione del reato segua una sentenza di condanna irrevocabile. La pacifica condivisione
dell’opportunità di ammettere che il decorso del tempo abbia efficacia estintiva nell’ambito penale, si
spiega considerano che con il decorso del tempo appare inutile l’esercizio della repressione, perché
vengono a mancare le esigenze di prevenzione generale che presiedono alla repressione dei reati.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui
non consentiva la rinunciabilità della prescrizione, sempre per violazione del diritto alla difesa. Per
alcuni reati è però comunque stabilita l’imprescrittibilità, ossia i reati per cui vi è la pena (di morte e)
dell’ergastolo.
202
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Con la riforma del 2005 è stata radicalmente innovata la disciplina giuridica della prescrizione, infatti
si è voluto soddisfare la sentita esigenza di assicurare maggiore certezza nel calcolo del tempo
dell’oblio, rimediando all’inconveniente di far dipendere questo calcolo anche da una postuma
valutazione giudiziale discrezionale degli elementi circostanziali (dettata dall’originario art. 157 c.p.).
Tuttavia, a parte questo profilo, la nuova riforma appare molto criticabile sotto diversi aspetti:
Il nuovo art. 157 comma 1, per determinare il tempo necessario a prescrivere, abbandona il
criterio delle classi di gravità dei reati individuate per fasce di pena, e lo sostituisce con il
nuovo criterio della pena massima edittale di ciascun reato, ma contemporaneamente
introduce una soglia minima inderogabile di tempo non inferiore a sei anni per i delitti e non
inferiore a quattro per le contravvenzioni.
Il nuovo art. 157 comma 2 e 3 per rendere più certo il tempo di prescrizione elimina la
rilevanza della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le
circostanze aggravanti, con la sola eccezione delle aggravanti autonome a effetto speciale, ove
si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante. È in ogni caso precluso
il giudizio di prevalenza o equivalenza ex art. 69 c.p.
Il nuovo art. 157 comma 2 detta anche una disciplina differenziata per i recidivi, stabilendo
che ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere rilevano le circostanze aggravanti
per cui la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale, e
dispone anche che si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto.
L’art. 157 comma 6 prevede che i tempi ordinari di prescrizione si raddoppino per alcuni
tipologie di illeciti penali espressamente indicati, ossia i reati degli artt. 449, 589 commi 2-3-4,
51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p., nonché alcune ipotesi di reati a responsabilità colposa
caratterizzati da una forte carica lesiva nei confronti di beni come incolumità e vita (incendio e
altri disastri colposi e omicidio colposo commesso con violazione di norme stradali, norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, o aggravato dalla morte o lesione di più persone), e
ipotesi delittuose che rientrano nel paradigma della criminalità organizzata intesa lato sensu.
Il novero dei reati per cui è previsto il raddoppio dei tempi è stato poi allargato includendo
anche maltrattamenti in famiglia, delitti contro la personalità individuale, corruzione di
minorenne, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (per queste ultime due non vi è
raddoppio se è presente l’attenuante della minore gravità).
All’art. 158 c.p. vengono stabilite precise regole sulla decorrenza del termine per la prescrizione, ossia
il cosiddetto dies a quo (il quale non si computa nel termine):
A. per il reato consumato il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione
B. per quello tentato dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole
C. per quello permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza, per il reato continuato si
calcola un momento diverso per ciascun reato, così come nel concorso di reati.
D. se invece la punibilità del reato dipende da una condizione, allora il termine della prescrizione
decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata
E. se invece il reato è punibile a querela, istanza o richiesta, allora il termine della prescrizione
decorre dal giorno del commesso reato.
Il decorso della prescrizione si può sospendere o interrompere:
Sospensione: è un effetto giuridico per cui la decorrenza del termine della prescrizione si
arresta per il tempo necessario a rimuovere un ostacolo al procedimento penale, in odo che la
porzione di tempo già trascorsa rimanga valida e si possa sommare al periodo di tempo
successivo decorrente dal giorno di cessazione della causa sospensiva (art. 159). La
prescrizione si sospende in caso di:
1. autorizzazione a procedere
2. nelle ipotesi di questioni deferite ad altro giudizio
3. nelle ipotesi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di
203
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
impedimento delle parti e dei difensori o su richiesta dell’imputato o del suo difensore
4. dalla riforma del 2005, anche nei casi di separazione del procedimento penale.
La prescrizione riprenderà a decorrere dal giorno in cui cessa la causa di sospensione. In caso
di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’Autorità
competente accoglie la richiesta.
Interruzione: è un effetto giuridico per cui in presenza di alcuni atti giuridici il termine di
prescrizione già decorso viene meno e ricomincia a decorrere dall’inizio, e ciò può accadere
per:
1. sentenza o decreto di condanna non irrevocabili
2. ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o
dell’arresto
3. interrogatorio reso davanti al p.m. o al giudice
4. invito a presentarsi al p.m. per rendere l’interrogatorio
5. provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la
decisione sulla richiesta di archiviazione
6. richiesta di rinvio a giudizio
7. decreto di fissazione dell’udienza preliminare
8. ordinanza che dispone il giudizio abbreviato
9. decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della
pena
10. presentazione o citazione per il giudizio direttissimo
11. decreto che dispone il giudizio immediato
12. decreto che dispone il giudizio e decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione.
La riforma del 2005 ha apportato innovazioni rilevanti a riguardo della rideterminazione
della misura del prolungamento del tempo necessario a prescrivere che l’interruzione
comporta. L’ultimo comma del riformato art. 160 c.p., nel determinare il tetto invalicabile in
presenza di più atti interruttivi, stabilisce che in nessun caso i termini fissati all’art. 157
possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art. 161 comma 2 (dunque l’interruzione
della prescrizione può comportare l’aumento massimo di un quarto del tempo necessario a
prescrivere), eccezion fatta per i reati di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p.
Nel caso però di recidiva aggravata (art. 99 comma 2) l’interruzione può determinare un
aumento della metà del tempo prescrizionale, nel caso di recidiva reiterata (art. 99 comma 4)
un aumento di due terzi, e nel caso di abitualità o professionalità nel reato un prolungamento
del doppio.
Fanno però eccezione, come già detto, i gravi reati dell’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p.,
rispetto ai quali i termini di prescrizione sono raddoppiati ex art. 17, ma vista l’approssimativa
tecnica legislativa non è chiaro se si intenda che nel caso di questi reati ad ogni atto
interruttivo il termine raddoppiato ricomincia a decorrere, o se significhi che essendo già
previsti tempi più lunghi nessun atto interrompe la prescrizione.
Va infine detto che in caso di concorso di più persone nel reato la sospensione e l’interruzione si
applicano a tutti gli agenti, mentre in caso di concorso di reati ciascuno di essi segue la sua strada
indipendentemente da ogni considerazione relativa agli altri, salvo che si proceda congiuntamente per
più reati, nel cui caso la sospensione o interruzione della prescrizione si estende anche agli altri reati.
L’OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI
Esistono due forme di oblazione, ossia:
Oblazione comune: prevista dall’originario art. 162 c.p.
L’art. 162 dispone che nelle contravvenzioni per cui la legge dispone solo la pena
dell’ammenda, il contravventore può pagare, prima dell’apertura del dibattimento o prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento, e
204
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
questo pagamento estingue il reato. L’oblazione come causa di estinzione del reato trova la sua
ratio nell’economia processuale e nella sollecitudine a risolvere presto i casi di nomina
importanza.
L’oblazione (giudiziale), non deve confondersi né con l’oblazione amministrativa né con
l’oblazione in via breve, e si applica in presenza di tre condizioni, ossia:
1. che si tratti di contravvenzione per cui la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda
2. che il contravventore presenti domanda di ammissione all’oblazione prima
dell’apertura del dibattimento o del decreto penale di condanna
3. che il contravventore adempia tempestivamente all’obbligo di pagamento assunto, il
quale ammonta ad un terzo del massimo previsto dalla legge per la contravvenzione.
In presenza di queste condizioni l’oblazione è automatica, ed equivale ad una
depenalizzazione di fatto.
Oblazione speciale: introdotta all’art. 162 bis con la legge di Modifiche al sistema penale n.
689/1981.
L’art. 162 bis prevede l’oblazione speciale per le contravvenzioni punite con la pena alternativa
all’arresto o con l’ammenda, e va applicata dal giudice non in modo automatico, ma
discrezionale. L’oblazione consisterà nella metà del massimo dell’ammenda prevista, oltre
alle spese del procedimento. La domanda di ammissione all’oblazione in questo caso può
essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, e il
giudice può accoglierla solo se non ricorrono alcune ipotesi di esclusione, che sono: se viene
contestata la recidiva reiterata o se viene ritenuta l’abitualità nelle contravvenzioni o la
professionalità nel reato, o se permangono le conseguenze dannose o pericoloso del reato o se
il giudice ritiene il fatto grave. L’oblazione speciale è stata criticata per il suo essere
sostanzialmente una depenalizzazione giudiziale, ossia lasciata alla personale discrezione del
giudice, nonché caratterizzata da eccessiva genericità dovuta alla formula “gravità del fatto”.
LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Alcuni non ritengono che la sospensione condizionale della pena sia una causa estintiva, infatti essa va
per certi versi annoverata tra le misure sospensive, mentre per altri è un fenomeno tipicamente
estintivo. Nell’ordinamento italiano la sospensione condizionale ha subito un processo di
snaturamento che l’ha trasformata in una misura clemenziale applicata dal giudice in modo
automatico, con la conseguenza di provocare un fenomeno di inammissibile fuga dalla sanzione.
La sospensione condizionale, nata nel mondo anglosassone come forma di probation (ossia come
sospensione della pronuncia di condanna), è stata introdotta in Italia con la legge Ronchetti nel 1904,
ed è stata ripresa dal codice Rocco anche come strumento di lotta alle pene detentive brevi, fissando il
limite massimo di pena per la concessione della sospensione condizionale in sei mesi.
Essa in realtà, così come riformata negli anni, non si presenta come un mezzo di lotta alle pene
detentive brevi, ma piuttosto come elemento di prevenzione speciale fondata sulla presunzione di
sufficienza della sola pronuncia di condanna e sulla minaccia della sua futura esecuzione. In
particolare la riformata regolamentazione della seconda concessione della sospensione sembra
preludere ad un possibile futuro recupero da parte del legislatore di una dimensione sanzionatoria e di
una più razionale funzionalizzazione della misura stessa.
La legge n. 145/2004 ha poi ulteriormente snaturato l’istituto per raggiungere specifici obiettivi di
natura criminale. Questa legge ha infatti introdotto due deroghe alla disciplina della sospensione
condizionale:
1. rende virtuale il cumulo tra pena detentiva e pena pecuniaria ai fini di calcolo del requisito del
limite massimo di pena sostenibile, nell’ipotesi in cui a seguito della conversione di pena
pecuniaria si sia superata la soglia massima di concedibilità del beneficio, con l’obiettivo così di
incentivare il ricorso al patteggiamento allargato
2. accorcia il tempo necessario per l’estinzione del reato nell’ipotesi di pena sospesa inferiore ad
un anno e di contestuale adempimento degli obblighi risarcitori
205
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
I presupposti di applicazione della sospensione condizionale ordinaria sono due, ossia:
1. una sentenza di condanna a pena detentiva e/o a pena pecuniaria che non superi il limite di
due anni (tre per i minori, due anni e sei mesi per chi ha tra i 18 e 21 anni, ossia i giovani adulti,
e per gli ultrasettantenni)
2. una prognosi favorevole sulla personalità del condannato, ossia se il giudice, avuto riguardo
alle circostanze dell’art. 133, considera che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori
reati. Questo secondo presupposto, nonostante costituisca l’essenza stessa dell’istituto, viene
spesso deplorevolmente obliato.
La prima deroga prevista dal nuovo art. 163 comma 1 ult. alinea, 2 ult. alinea e 3 ult. alinea
permette la concessione della sospensione condizionale nell’ipotesi in cui i limiti massimi di
pena vengano superati per effetto della conversione della pena pecuniaria, infatti questa
deroga impone che ai fini della concessione del beneficio, la conversione della pena pecuniaria
venga “sterilizzata” se la pena detentiva rimane nei limiti legali (due anni normalmente, tre per
i minori, due e sei mesi per persone con anni 18-21 o +70).
La seconda deroga stabilita dall’ultimo comma dell’art. 163 riguarda invece l’ipotesi in cui il
giudice applichi una pena detentiva non superiore ad un anno, e il colpevole adempia agli
obblighi risarcitori, infatti in questo caso la deroga riduce sensibilmente il tempo necessario a
produrre l’effetto estintivo del reato da cinque anni ad un anno.
Vi sono però delle condizioni ostative che impediscono la concessione della sospensione
condizionale, infatti l’art. 164 comma 2 stabilisce che essa non può concedersi a tre tipologie di
persone (una quarta riguarderebbe chi, in aggiunta alla pena, ha ricevuto anche una misura di
sicurezza personale perché persona che la legge presume socialmente pericolosa, ma essa ha perso
rilevanza una volta abrogate le presunzioni di pericolosità):
1. chi ha una precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione
2. chi è delinquente o contravventore abituale
3. chi è delinquente o contravventore professionale
Il giudice può anche subordinare la concessione della sospensione condizionale:
1. all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni
2. al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o assegnata
provvisoriamente sull’ammontare di esso
3. alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, nonché, salvo che la legge
disponga altrimenti
4. all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate
dal giudice, e infine, a seguito dalla legge n. 154/2004 e salvo che il condannato non si opponga
5. all’obbligo della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo
determinato non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal
giudice
Le modifiche legislative, sollecitate da prese di posizione della Corte costituzionale, hanno reso
possibile la concessione della sospensione condizionale a chi ne abbia già usufruito una volta: la
seconda sospensione condizionale si ha quando il giudice nell’infliggere una nuova condanna, irroga
una pena che, cumulata con la precedente condanna per delitto, non supera i limiti oggettivi dell’art.
163. La seconda concessione deve essere, a meno che non sia impossibile, subordinata
all’adempimento di almeno uno degli obblighi risarcitori sopra citati (anche se sarebbe auspicabile che
anche la prima concessione lo fosse).
La sospensione condizionale viene revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna
rimane sospesa, il condannato compie un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui
venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli, o nel caso in cui riporti una
condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulate a quelle sospese, superino i
limiti dell’art. 163.
La sospensione condizionale può essere revocata dal giudice se il condannato riporta una condanna
206
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, non supera i limiti
stabiliti dall’art. 163, avuto riguardo all’indole e alla gravità del reato.
La sospensione condizionale sospende la pena principale (o accessoria, dalla legge 19/1990) per
cinque anni in caso di condanna per delitto e per due anni in caso di contravvenzione, e, se nel periodo
di sospensione il condannato non commette un delitto o una contravvenzione, il reato è estinto.
LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
La legge delega n. 67/2014 ha inserito nel nostro ordinamento una nuova causa estintiva del reato
denominata “sospensione del procedimento con messa alla prova”, che viene regolata dal nuovo art.
168 bis c.p.
Questo articolo dispone che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con
la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla
pena pecuniaria, e per i delitti indicati all’art. 550 comma 2 c.p.p., l’imputato può chiedere la
sospensione del procedimento con messa alla prova. La messa alla prova comporta la realizzazione di
condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose che derivano dal reato,
nonché, se possibile, il risarcimento del danno cagionato, e l’affidamento dell’imputato al servizio
sociale per lo svolgimento di un programma che può anche implicare volontariato di rilievo sociale o
l’adempimento di altre prescrizioni che vengono specificamente indicate dall’articolo stesso (“relative
ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento,
al divieto di frequentare determinati locali”).
La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta, ed
essa non è applicabile ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Essa provoca inoltre il
duplice effetto di sospensione della prescrizione e, se la prova dà esito positivo, estinzione del reato.
Questo nuovo istituto è stato introdotto nel nostro sistema penale a causa delle sollecitazioni della
dottrina penalistica e dell’esigenza di deflazionare le nostre carceri a seguito della condanna della
Corte EDU con la sentenza Torreggiani del 2013. Questo istituto è comunque differente da quello
speculare presente nell’ambito minorile, infatti quest’ultimo cerca più che di punire di plasmare in
termini responsabilizzanti una personalità, mentre l’istituto in esame aspira a raggiungere obiettivi di
special-prevenzione, oltre a soddisfare istanze deflative della custodia in carcere.
In dottrina, vi è chi sostiene che l’introduzione della sospensione del processo condizionata alla
prestazione del lavoro di pubblica utilità rappresenti una rivoluzione, ma altri sostengono invece che
la sua efficacia sia molto scarsa se non nulla.
IL PERDONO GIUDIZIALE E ALTRI ISTITUTI MINORILI
L’art. 169 c.p. disciplina l’istituto del perdono giudiziale per i minorenni, che ha l’obiettivo di evitare
al minore delinquente primario gli impatti deleteri sul suo sviluppo e la sua formazione.
I limiti di pena entro cui il perdono giudiziale può concedersi vengono forniti dall’art. 19 della legge sul
tribunale dei minorenni, mentre all’art. 169 c.p. vengono fissati i presupposti di applicazione del
perdono giudiziale, i quali sono:
1. che il colpevole al tempo della commissione del reato non abbia compiuto 18 anni ma abbia
compiuto i 14
2. che non sia già stato condannato a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la
riabilitazione, né sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale
3. che il tribunale dei minorenni ritenga di potere applicare una pena detentiva non superiore a
due anni o una pena pecuniaria non superiore a 1.549,37 euro anche se congiunta alla pena
4. che il giudice presuma, avuto riguardo alle circostanze dell’art. 133, che il colpevole si asterrà
dal commettere altri reati.
Per effetto della Corte costituzionale, il perdono giudiziale si può concedere anche nel caso in cui i reati
commessi dal minore siano più di uno, siano essi legati o meno dal vincolo della continuazione.
Con il passaggio in giudicato della sentenza che concede il perdono giudiziale, il reato è estinto, e la
207
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
concessione del perdono è sempre incondizionata ed irrevocabile; essa, inoltre, impedisce
l’applicazione delle misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria.
Con la legge di riforma del processo penale minorile sono stati introdotti due nuovi istituti a tutela
del minore (i quali sono comunque di qualificazione dogmatica ancora incerta), ossia il non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto, e la sospensione del processo per messa in prova:
Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: l’art. 27 del d.p.r. n. 448 del 22 settembre
1988 stabilisce che, se nell’ambito delle indagini preliminari risulta la tenuità del fatto e
l’occasionalità del comportamento, il pubblica ministero, se ritiene che l’ulteriore corso del
procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore, è tenuto a richiedere al giudice
una sentenza di non luogo a procedere, e, se la richiesta viene accolta, non si procede per
l’illecito del minore. Servono dunque tre condizioni:
1. la tenuità del fatto, la quale è una condizione oggettiva che si riferisce al “fatto” inteso
probabilmente come comprensivo anche dell’atteggiamento psicologico, e non soltanto
come fatto di reato
2. l’occasionalità del comportamento, la quale è una condizione oggettiva che fa
riferimento alla genesi del fatto, nel senso che esso deve apparire come il frutto di
particolari e momentanee condizioni psicologiche del minore e non come risultato di
un progetto, un piano (dunque si può avere occasionalità anche in caso di minore
recidivo)
3. il pregiudizio educativo derivante dall’ulteriore corso del processo, il quale è una
condizione soggettiva di natura psicologico-pedagogica di difficile ricostruzione, infatti
essa finisce per essere sostanzialmente affidata alla discrezionalità giudiziale.
Sospensione del processo con messa alla prova: essa viene disposta dal giudice quando
ritiene di dovere valutare la personalità del minorenne all’esito di una prova nel corso della
quale il minore viene affidato ai servii minorili dell’amministrazione della giustizia per le
opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. La messa in prova ha l’obiettivo di
consentire di formulare un serio giudizio prognostico sul reinserimento sociale del minore a
seguito dell’interiorizzazione di modelli di comportamento socialmente apprezzabili. Una volta
accertato l’esito positivo della prova, il giudice chiara l’estinzione del reato.
LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA
Nel capo II del titolo VI del codice penale, vengono disciplinate le cause di estinzione della pena, che,
secondo il criterio tradizionale già citato, sarebbero quelle che operano solo sulla pena concretamente
inflitta al soggetto con una sentenza di condanna (e non sul potere punitivo dello Stato, come quelle di
estinzione del reato). Queste cause presuppongono infatti l’esistenza di una sentenza irrevocabile di
condanna e non aggrediscono il reato nella sua intera dimensione giuridica, infatti esso continua a
produrre gli effetti che può ancora esplicare.
Le cause di estinzione della pena sono:
1. la morte del reo dopo la condanna
2. l’amnistia impropria
3. la prescrizione della pena
4. l’indulto
5. la grazia
6. la liberazione condizionale
7. la riabilitazione e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Hanno inoltre effetto estintivo le misure alternative alla detenzione e il patteggiamento.
MORTE DEL REO DOPO LA CONDANNA
Questa causa di estinzione della pena è prevista dall’art. 171 c.p. Sulla base del principio mors omnia
solvit vengono dunque estinte le pene detentive, le pene pecuniarie, le pene accessorie e tutti gli effetti
208
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
penali della condanna, nonché le misure di sicurezza detentive e le obbligazioni civili per il pagamento
dell’ammenda e della multa, ma non vengono meno le obbligazioni nascenti dal reato né la confisca.
L’AMNISTIA IMPROPRIA
L’amnistia impropria è regolata tra le cause di estinzione del reato dall’art. 151, come già ricordato, ed
essa a differenza dell’amnistia propria presuppone una sentenza di condanna definitiva ed
irrevocabile, ossia passata in giudicato (ma, come quella propria, riguarda solo i reati commessi prima
della presentazione del disegno di legge). L’amnistia impropria fa cessare l’esecuzione delle pene
principali (detentive e pecuniarie), delle pene accessorie e delle misure di sicurezza diverse dalla
confisca, ma permangono tuti gli altri effetti della condanna, di cui si tiene ad esempio conto per la
recidiva, l’abitualità, la professionalità, la sospensione condizionale, ecc.
LA PRESCRIZIONE DELLA PENA
Il decorso del tempo influisce, oltre che sul reato, sulla pena inflitta con la sentenza passata in
giudicato, e la ratio dell’istituto è la stessa della prescrizione del reato, ossia il fatto viene
progressivamente meno l’interesse dalla collettività a fare scontare al condannato una pena inflittagli
molto tempo prima.
Gli artt. 172 e 173 dispongono che il decorso del tempo estingue solo la pena della reclusione,
dell’arresto, della multa e dell’ammenda, e le misure di sicurezza eccetto la confisca e quelle ordinate
come misure accessorie di una condanna alla reclusione per oltre dieci anni. Non si estingue per
prescrizione, invece, l’ergastolo, le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
In particolari, i termini per la prescrizione della pena sono:
L’estinzione della pena della reclusione avviene con il decorso di un termine pari al doppio
della pena inflitta con il provvedimento di condanna, ma se il raddoppio della pena equivale ad
un tempo inferiore a dieci anni, allora l’estinzione avviene in dieci anni, e se il raddoppio
supera i trenta, allora l’estinzione avviene in trent’anni
La pena della multa si estingue in dieci anni, e se essa è stata inflitta congiuntamente alla
reclusione, allora per l’estinzione di entrambe si guarda al tempo necessario per l’estinzione
della reclusione
Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono in cinque anni, e se ammenda e arresto
sono stati inflitte insieme. allora per entrambe si guarda al tempo necessario per l’estinzione
dell’arresto
Per l’estinzione della pena nel concorso di reati si deve guardare ciascuno di essi, anche nel
caso in cui le pene siano state inflitte con la stessa sentenza
Il dies a quo del termine di estinzione decorre dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile o
dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena.
L’estinzione della pena della reclusione e della multa non ha luogo per i recidivi nei casi previsti
dall’art. 99, per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o se il condannato durante il tempo
necessario per l’estinzione della pena riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa
indole.
La prescrizione è rinunciabile, come ha stabilito la Corte costituzionale con la sent. n. 275/1990.
L’INDULTO
L’indulto è un provvedimento di carattere generale che condona in tutto o in parte la pena, o la
commuta in una pena di specie diversa ma dello stesso genere. Anche l’indulto viene concesso con
legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo
e nella votazione finale e si riferisce ai reati commessi antecedentemente alla presentazione del
disegno di legge.
L’indulto può essere:
Proprio: se il condono interviene nella fase esecutiva rispetto ad una sentenza irrevocabile di
209
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
condanna
Improprio: se il condono viene applicato al momento della sentenza dal giudice della
cognizione
L’indulto ha effetto solo sulle pene principali, e non estingue dunque le pene accessorie né gli effetti
penali della condanna, salvo che il decreto disponga altrimenti.
Se l’indulto si limita a condonare o commutare la pena, non fa inoltre cessare le misure di sicurezza,
mentre se condanna completamente la pena inflitta con la sentenza di condanna fa cessare di diritto
l’esecuzione delle misure di sicurezza, salvo che si tratti di misure di sicurezza conseguenti ad una
condanna alla reclusione per più di dieci anni o della confisca.
La legge non prevede nessun limite oggettivo per l’applicabilità dell’indulto, ma di solito sesso è
limitato ad una determinata quantità di pena, detentiva e pecuniaria, ed entro questo limite si applica
alla sentenza di condanna per qualsiasi tipo di reato.
Spesso però la legge di concessione per determinati reati prevede l’esclusione dell’indulto o una
misura di pena diversa e inferiore a quella generalmente prevista, ed essa può stabilire anche limiti
soggettivi differenti per coloro che per la stessa condanna hanno goduto o possono godere di
precedenti indulti.
L’indulto può anche essere sottoposto a condizioni o obblighi, e non si può applicare ai casi di
recidiva aggravata o reiterata, ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che sia
disposto diversamente.
LA GRAZIA
La grazia condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena prevista
dalla legge, ma non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neanche
gli altri effetti penali della condanna.
La grazia è di prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica, le sue caratteristiche essenziali
è il fatto che l’organo competente ad emettere il relativo provvedimento è solo il Presidente della
Repubblica e il fatto che la natura del provvedimento ha contenuto particolare, poiché si riferisce ad
un singolo rapporto esecutivo relativo ad una o più condanne a carico di uno stesso imputato (la grazia
presuppone dunque l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna).
Gli effetti non sono predeterminati dalla legge, infatti la grazia può estinguere in tutto o in parte la
pena principale, a seconda della valutazione discrezionale del Presidente della Repubblica. La grazia
può essere sottoposta a condizioni come il risarcimento dei danni, il divieto di soggiorno in un certo
luogo, ecc.
LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE
La liberazione condizionale è stata progressivamente riformata, tanto da avere perso la sua funzione
originaria. Una delle riforma più importanti è stata attuata con la legge n. 1634/62, con cui si è
adeguato l’istituto alle finalità di prevenzione speciale sancite dall’art. 27 comma 3 Cost.
Il nuovo testo dell’art. 176 c.p. dispone che “il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di
esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento,
può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque
almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Se si tratta
di recidivo, nei casi previsti dai capoversi dell’art. 99, il condannato per essere ammesso alla
liberazione condizionale deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno dei tre quarti
della pena inflittagli”. Inoltre, nel ’86 il terzo comma dell’art. 176 è stato modificato, rendendo
possibile la liberazione dell’ergastolano dopo venti anni di pena, e subordinando la concessione della
liberazione condizionale all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il
condannato dimostri di esservi impossibilitato.
I presupposti di applicazione della liberazione condizionale sono cinque:
1. che il condannato abbia scontato un minimo di pena
2. che la pena residua non superi i cinque anni
3. che il condannato durante l’esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far
210
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
ritenere sicuro il ravvedimento
4. che abbia adempiuto alle obbligazioni civili, salvo che abbia dimostrato di esservi
impossibilitato
5. che non abbia già usufruito del beneficio per la stessa pena
La concessione della liberazione condizionale appartiene oggi alla competenza del tribunale di
sorveglianza, ed ha come effetti immediati la cessazione dello stato di detenzione, la sospensione
dell’applicazione della misura di sicurezza detentiva, e l’applicazione della misura di sicurezza della
libertà vigilata, trasformata oggi in libertà vigilata assistita dal servizio sociale. La liberazione
condizionale produce i suoi effetti con il decorso del tempo della pena inflitta o, in caso di ergastolo,
con il decorso di cinque anni dalla data del provvedimento. La liberazione condizionale è inoltre
revocabile se durante questo periodo il reo commette un delitto o una contravvenzione della stessa
indole o trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, e in caso di revoca il reo riprende a
scontare la pena detentiva (il tempo trascorso in libertà viene contato come se fosse stato tempo di
“pena scontata”).
A seguito delle riforme si può dunque dire che la liberazione condizionale sia a tutti gli effetti una
misura alternativa alla detenzione.
LA RIABILITAZIONE
La riabilitazione svolge la funzione di reintegrare nella posizione giuridica che aveva prima della
sentenza il condannato che abbia già scontato la pena principale. La riabilitazione, secondo l’art. 178
c.p., estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga
altrimenti.
L’art. 179 stabilisce che le condizioni per la concessione della riabilitazione, che, se presenti questi
presupposti, deve essere concessa, sono:
1. che siano decorsi tre anni (otto per i recidivi qualificati e dieci per delinquenti abituali,
professionali o per tendenza) dal giorno in cui è stata eseguita la pena principale o si è in altro
modo estinta
2. che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta durante il periodo di
tempo indicato
3. che non sia stato sottoposto a misure di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello
straniero dallo Stato o di confisca o che il provvedimento sia stato revocato
4. che abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di esservi
impossibilitato
Se il riabilitato commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale venga inflitta la pena
della reclusione per non meno di tre anni o un’altra pena più grave, la sentenza di riabilitazione viene
revocata di diritto, e rivivono così le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Sulla base dell’art. 181, la riabilitazione può avere luogo anche in caso di sentenza straniera di
condanna, riconosciuta a norma dell’art. 12 c.p.
Per i minori può essere concessa una riabilitazione speciale dopo il diciottesimo e prima del
venticinquesimo anno d’età, la quale viene prevista dall’art. 24 del r.d.l. n. 1404 del 1934, e che
presuppone che il minore non sia sottoposto a pena o a misura di sicurezza e che risulti
completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale.
LA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Questo istituto ha la funzione di evitare che la condanna sia resa nota ai privati che richiedono i
certificati del casellario giudiziale, non per ragioni di diritto elettorale (dunque in sostanza per
facilitare il reinserimento del condannato nella vita sociale e nel mondo del lavoro). In realtà dunque la
non menzione più che estinguere la pena comporta una limitazione degli effetti della condanna.
La concessione di questo beneficio viene rimessa alla valutazione del giudice, tenuti presenti i criteri
menzionati dall’art. 133 c.p.
211
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
L’art. 175 fissa i presupposti della non menzione della condanna, i quali sono:
1. che si tratti della prima condanna
2. che con la condanna sia inflitta una pena detentiva non superiore ai due anni o una pena
pecuniaria non superiore a 516 euro o congiuntamente una pena detentiva non superiore a
due anni ed una pena pecuniaria che, convertita e cumulata ex art. 135, priverebbe
complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta
mesi
3. che il giudice consideri il condannato meritevole del beneficio, avuto riguardo anche alla
gravità del reato e alla capacità a delinquere
Il giudice ovviamente non deve pronunciarsi sulla possibilità di non menzione per le condanne non
soggetto ad iscrizione o che non debbano essere menzionate nei certificati rilasciati ai privati, mentre
invece la legge di Modifiche al sistema penale n. 689/81 ha modificato l’art. 604 c.p.p., sottoponendo a
menzione nel casellario le sentenze relative a contravvenzioni oblabili ex art. 162 bis.
L’ordine di non menzione della condanna viene revocato di diritto se il condannato commette un
altro delitto, ma non una contravvenzione (senza termini di tempo, e per questo la non menzione
sembra più una sospensione a tempo indeterminato dell’effetto penale, che non una causa di
estinzione vera e propria).
212
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO CINQUE
MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza detentive sono una grande novità del codice Rocco, e l’intento del legislatore
era quello di conformare il sistema penale alle tendenze politico-criminali dell’epoca, favorevoli al
potenziamento della difesa sociale con l’introduzione di un sistema “del doppio binario”, in cui alle
pene si affiancassero nuove misure sanzionatorie per neutralizzare la pericolosità sociale di alcune
categorie di rei.
Coerentemente con le vedute dominanti al momento dell’emanazione del codice, che tendevano a
sottolineare il differente carattere della funzione repressiva e di quella preventiva, alle misure di
sicurezza venne originariamente attribuita natura amministrativa, ma ad oggi questi tutta la dottrina
considera che esse siano sanzioni criminali di competenza del diritto penale.
In seguito al riconoscimento costituzionale all’art. 27 del finalismo rieducativo delle pene, è venuta
ormai meno la distinzione di scopi che originariamente giustificava lo “sdoppiamento”, ed è diventato
così problematico legittimare la sopravvivenza delle misure di sicurezza.
I destinatari delle misure di sicurezza sono:
i soggetti imputabili socialmente pericolosi
i soggetti semi- imputabili
A queste due categorie le misure si applicano cumulativamente con la pena
i soggetti non imputabili: cui le misure si applicano in modo esclusivo
L’originario impianto codicistico è stato innovato dalla riforma attuata con la legge n. 81/2014
(originariamente unicamente destinata alla riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari), le cui
innovazioni più importanti sono tre:
1. la previsione di un limite massimo di durata per tutte le misure di sicurezza detentive
2. l’introduzione di due nuovi criteri per l’accertamento della pericolosità sociale ai fini
dell’applicabilità alle misure del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa
di cura o custodia
3. l’introduzione del principio di sussidiarietà come criterio-guida per l’applicazione di queste
misure, nel senso che possono essere disposte solo quando ogni altra misura risulti inadeguata
in rapporto alle esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale
PROFILI GARANTISTICI DELLA DISCIPLINA
Principio di legalità: anche le misure di sicurezza sono sottoposte al principio di legalità,
come stabilito dall’art. 199 c.p. e dall’art. 25 comma 3 Cost., infatti la legge deve determinare il
tipo di misura applicabile ed elencare tassativamente i casi in cui il giudice può adottarla.
Con la sent. n. 157/72 la Corte costituzionale ha sancito che il principio di legalità in materia di
misure di sicurezza implica l’esigenza di una completa, tassativa e non equivoca previsione
legislativa delle ipotesi di applicabilità delle misure, ma va comunque detto che in questo
campo la tassatività va intesa più elasticamente, poiché le fattispecie soggettive di pericolosità
sono ricostruibili con meno precisione delle fattispecie incriminatrici (proprio perché sono
soggettive, e legate quindi alla personalità del reo), e perché il giudizio prognostico sulla
pericolosità è per natura esposto a inevitabili margini di incertezza. Questo comunque non
solleva il legislatore dal suo obbligo di indicare in modo sufficientemente preciso gli elementi e
i criteri alla cui stregua effettuare l’accertamento giudiziale di probabile ricaduta nel delitto
(essi vengono infatti indicati all’art. 133 c.p.).
Divieto di retroattività: le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo
della loro applicazione, e se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è
diversa, allora si applica la legge in vigore al tempo dell’esecuzione (art. 200 c.p.). Questo
articolo va però interpretato restrittivamente alla stregua dell’art. 2 c.p., ossia riferendolo
soltanto all’eventualità che una legge successiva disciplini in maniera diversa mere modalità
esecutive di una misura di sicurezza già legislativamente prevista al momento della
213
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
commissione del fatto.
I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
IL FATTO PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO
L’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all’esistenza di due presupposti:
uno oggettivo, ossia la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato
uno soggettivo, ossia la pericolosità sociale del soggetto.
L’art. 202 c.p. dispone infatti che le misure di sicurezza possono essere applicate solo alle persone
socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato.
Due eccezioni previste dalla legge sono però quelle dei “quasi-reati”, infatti il giudice può applicare
una misura di sicurezza sia nell’ipotesi del reato impossibile, sia nel caso di accordo criminoso non
eseguito o istigazione a commettere un delitto, se l’istigazione non viene accolta.
LA PERICOLOSITÀ SOCIALE
Il secondo presupposto è quello soggettivo che richiede, per l’applicazione delle misure di sicurezza, la
pericolosità sociale, categoria scelta dal legislatore e recepita secondo la specifica elaborazione
maturata nell’ambito del positivismo criminologico di fine ‘800, nel cui contesto essa coincideva con la
probabilità che un soggetto a causa delle sue caratteristiche psichiche e/o dell’influenza esercitata
dall’ambiente, commetta in futuro fatti di reato. La categoria della pericolosità sociale si discosta in
questo senso da quella della colpevolezza, infatti quest’ultima presuppone una sufficiente signoria
dell’individuo sulle proprie azioni, mentre la pericolosità riflette l’insieme delle inclinazioni che
spingono il soggetto a delinquere in maniera quasi necessitata.
L’art. 203 afferma dunque che agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche
se non imputabile o non punibile, che ha commesso uno dei fatti indicati all’art. 202, quando è
probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati. La pericolosità è intesa dunque
come probabilità di ricadere nel delitto, mentre la semplice possibilità di ricadere nel delitto,
secondo un orientamento accreditato, coinciderebbe con la capacità a delinquere.
Oggi pressoché si concorda nel considerare la pericolosità sociale come risultato di un giudizio
prognostico effettuato dal giudice sulla probabilità di ricaduta nel delitto, giudizio che va fatto
utilizzando gli indici dell’art. 133 c.p. Nella disciplina codicistica originaria, la regola generale del
previo accertamento in concreto della pericolosità da parte del giudice subiva rilevanti deroghe in
alcuni casi, espressamente previsti, di presunzione di pericolosità (art. 204 comma 2), e dunque era la
legge stessa che in presenza di determinati presupposti relativi alla gravità del fatto commesso e/o alle
particolari condizioni psicologiche dell’agente, attribuiva la qualità di persona socialmente pericolosa
con una presunzione che non ammetteva prova contraria.
La disciplina delle misure di sicurezza è stata radicalmente rinnovata dalla legge Gozzini, dopo essere
stata modificata da alcune pronunce della consulta, in tema di “miniriforma” penitenziaria (legge n.
663/86), la quale ha proceduto con l’abolizione di ogni forma di presunzione legale di pericolosità,
abrogando l’art. 204 c.p. e stabilendo che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo
accertamento che chi ha commesso il fatto è socialmente pericoloso.
Questa innovazione è però intervenuta in un momento di caduta in crisi della categoria della
pericolosità sociale, sia per il suo fondamento teorico sia per la sua funzionalità pratica (es. tendenza
ad astenersi da pronunce di abitualità). L’abolizione della pericolosità sociale presunta assume però
un grande rilievo rispetto alla pericolosità degli infermi di mente, tanto che ne è derivata
un’acutizzazione del problema del rapporto tra malattia mentale e pericolosità.
A determinare l’attuale crisi della pericolosità sociale contribuisce anche la crescente presa d’atto
delle incertezze e difficoltà connesse al suo accertamento concreto nel processo. L’accertamento
giudiziale della pericolosità sociale ripropone infatti il problema dei limiti di validità scientifica della
prognosi criminale (il giudizio che tende a predire il futuro comportamento criminale del reo). Infatti,
214
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
alcuni dei metodi utilizzati hanno una maggiore dignità scientifica degli altri, ma la possibilità di
emettere prognosi un minimo affidabili deve in ogni caso fare i conti con le condizioni di praticabilità
offerte dalle strutture processuali, mentre il processo vigente lascia emergere pochissimi dati empirici
utili al giudizio prognostico, per cui gli elementi su cui basarsi sono spesso solo quelli documentali.
Questo spiega perché nella nostra prassi giudiziaria il metodo più diffuso sia quello intuitivo, nel
senso che il giudice si fa un quadro generale della personalità dell’imputato sulla base della sua
esperienza e personale attitudine a conoscere gli uomini, seguendo sempre gli indici dati dall’art. 133, i
quali sono però troppo generici, tanto più che l’articolo stesso non indica i criteri con cui valutare gli
elementi da esso menzionati. Per questi motivi spesso il giudizio sulla pericolosità sociale è arbitrario
e poco affidabile.
In ogni caso, proprio per cercare di rendere meno aleatorio l’accertamento della pericolosità sociale, il
legislatore ha recentemente introdotto alcune novità riguardo all’accertamento della pericolosità dei
soggetti inimputabili e semi-imputabili, precisando i limiti di applicabilità in proposito del generico
art. 133.
TIPOLOGIE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE “SPECIFICA”
Il legislatore del codice Rocco ha codificato alcuni tipi legali che riflettono forme di pericolosità sociale
specifica, ossia la delinquenza abituale, professionale e per tendenza, ai quali corrispondono
soggetti imputabili e socialmente pericolosi (dunque nei loro confronti la misura di sicurezza è
applicabile in aggiunta alla pena). Queste tre categorie appaiono però, oggi, discutibili e anacronistiche.
Delinquente abituale: il delinquente abituale viene considerato socialmente pericoloso sulla
base della legge dell’esperienza, nel senso che la ripetizione di un certo comportamento
attenua sempre più i freni inibitori e rende più facile la commissione di reati.
In base alla disciplina precedente, si distinguevano tre forme di abitualità, ossia l’abitualità nel
delitto presunta dalla legge (art. 102), l’abitualità nel delitto ritenuta dal giudice (art. 103), e
l’abitualità nelle contravvenzioni (art. 104). A seguito dell’abrogazione delle presunzioni di
pericolosità, un orientamento ritiene che la presa di posizione del legislatore del 1986 avrebbe
avuto come effetto di trasformare da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità dell’art.
102, nel senso che il giudice deve verificare se nella realtà sussista la pericolosità presunta
dalla legge. Nello specifico viene presunta per chi dopo una condanna alla reclusione per oltre
cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo e della stessa indole, e
commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.
La soluzione più lineare è invece quella di ritenere che la legge n. 663/86 abbia invece
abrogato l’abitualità presunta. L’abitualità nel diritto vigente è dunque oggi:
A. Per i delitti: quella dichiarata dal giudice ex art. 103 nei confronti di chi “dopo essere
stato condannato per due delitti non colposi, riporta un’altra condanna per delitto non
colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il
quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre
circostanze indiciate nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al
delitto”.
B. Per le contravvenzioni: l’art. 104, per l’abitualità nelle contravvenzioni, dispone che
chi “dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della
stessa indole, riporta una condanna per un’altra contravvenzione, anche della stessa
indole, è dichiarato contravventore abituale se il giudice, tenuto conto di specie e
gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del
genere di vita del reo e delle altre circostanze dell’art. 133 cpv., ritiene che il reo sia
dedito al reato”.
Delinquente professionale: i delinquenti professionali vengono considerati i più “incalliti”
perché sono quelli che traggono sostentamento dal reato. L’art. 105 stabilisce chi si trova nelle
condizioni richieste per l’abitualità (anche se la professionalità non presuppone l’abitualità) e
riporta una condanna per un altro reato, viene dichiarato delinquente o contravventore
215
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
professionale se il giudice ritiene (tenendo conto della natura dei reati, della condotta e del
genere di vita del reo e delle altre circostanze dell’art. 133 cpv.) che egli viva abitualmente dei
proventi del reato.
Delinquente per tendenza: l’art. 108 dispone che viene dichiarato delinquente per tendenza
chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non
colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, “anche non preveduto dal Capo I del titolo
dodicesimo del Libro II di questo codice, il quale, per sé o unitamente alle circostanze indicate
nel capoverso dell’art. 133 riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi la causa
nell’indole particolarmente malvagia del colpevole”; l’articolo dispone anche che questa
disposizione non si applica se l’inclinazione al delitto è originata da infermità ex artt. 88 e 89.
Una parte della dottrina chiede da tempo l’estromissione dal codice del delinquente per
tendenza, in quanto esso non trova riscontro nella realtà naturalistica.
Secondo la tipizzazione normativa può essere qualificato delinquente per tendenza anche un
delinquente primario purché abbia commesso un delitto di sangue (ossia in cui la vita o
l’incolumità personale sia oggetto di tutela anche indiretta. Secondo la discutibile definizione
tradizionale, deve però trattarsi di un soggetto capace di intendere e di volere che manifesti
mancanza di senso morale e che delinque per un’istintuale malvagità.
LA DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA
La misura di sicurezza ha una durata relativamente indeterminata, e questo coerentemente con lo
scopo pratico di rendere innocuo il soggetto, scopo per il quale non si può predeterminare il tempo
necessario. L’indeterminatezza della durata riguarda però solo il limite massimo, infatti secondo l’art.
207 non possono essere revocate le misure di sicurezza se le persone ad esse sottoposte non hanno
cessato di essere socialmente pericolose.
Viene però fissato un limite minimo, stabilito in via preventiva e presuntiva dal codice, per ogni
singola misura sulla base della gravità del reato e di considerazioni astratte relative alla pericolosità
dei vari soggetti. Alla scadenza di questo termine minimo il giudice viene chiamato ad effettuare un
riesame della pericolosità del reo, tenendo conto anche della sua condotta durante l’esecuzione della
misura, dei risultati del trattamento, dei contatti personali, e delle relazioni sanitaria in caso di
soggetto infermo o semi-infermo. Se il giudizio sulla pericolosità è negativo, il giudice ordina la revoca
della misura di sicurezza, e se è positivo stabilisce invece una nuova durata minima, ma dopo la prima
proroga, se vi è ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il riesame si può effettuare prima della
scadenza del termine. La revoca anticipata spetta alla sezione di sorveglianza, non più al Ministro della
giustizia.
Questa disciplina è stata però profondamente modificata dalla riforma della legge n. 81/2014, la
quale ha introdotto una regola nuova e rivoluzionaria, infatti viene stabilito il nuovo principio per cui
la durata di tutte le misure di sicurezza detentive non può superare la misura massima della pena
detentiva comminata per il reato commesso. In questo modo si è voluto evitare il fenomeno del c.d.
ergastolo bianco, ossia la permanenza a vita, dentro ad ospedali psichiatrici o case di cura e custodia,
di persone che non hanno commesso reati gravi ma che vengono considerate di pericolosità sociale
persistente.
Questa nuova disciplina ha però il difetto di essere stata concepita in maniera affrettata ed
estemporanea, senza essersi fatta carico dei numerosi problemi teorici e pratici che ne derivano.
CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza si distinguono in personali, distinte a loro volta in detentive e non, e
patrimoniali.
Misure di sicurezza detentive
1. l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
2. il ricovero in una casa di cura e di custodia
216
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
3. il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
4. il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Misure di sicurezza non detentive
1. la libertà vigilata
2. l divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province
3. il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcooliche
4. l’espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
Misure di sicurezza patrimoniali
1. la cauzione di buona condotta
2. la confisca
MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE
COLONIA AGRICOLA E CASA DI LAVORO
La scelta dell’una o dell’altra di queste misure di sicurezza personali detentive va fatta dal giudice che
la applica o dal giudice di sorveglianza nel corso dell’esecuzione, ed è pienamente discrezionale, salvo
l’obbligo di considerare le condizioni e le attitudini del destinatario.
Queste misure si applicano ai soggetti imputabili e pericolosi, più nello specifico (in base all’art.
216) a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e a coloro che
sono stati dichiarati tali e una volta non più sottoposti a misure di sicurezza hanno commesso un
nuovo delitto non colposo, che sia nuova manifestazione dell’abitualità, professionalità o tendenza, e in
ultimo ai condannati o prosciolti nei casi espressamente indicati dalla legge (artt. 212.3, 215.4, 223.2.,
226.1, 231.2).
La durata minima è di un anno, che diventa due anni per i delinquenti abituali, tre per i professionali e
quattro per quelli per tendenza.
La distinzione tra queste due misure consiste nell’attività svolta, che nella colonia agricola è di tipo
agricolo, e nella casa di lavoro è di tipo artigianale o industriale.
Tuttavia, l’intento del legislatore di conseguire il riadattamento sociale dei delinquenti più pericolosi
con il lavoro non si è mai realizzato, infatti la distinzione tra le due misure è rimasta solo sulla carta,
e nell’esecuzione di queste misure manca poi proprio il lavoro, e gli internati vengono impiegati solo
come cucinieri, portavitti, lavandai, lavori che possono tenere occupata solo una parte minima di
soggetti.
CASA DI CURA E CUSTODIA
Questa misura viene principalmente prevista per i condannati ad una pena diminuita per infermità
psichica, per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti, o per sordismo. Più in particolare vi
vengono assegnati:
1. condannati per delitto non colposo con pena diminuita per infermità psichica, per
intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti, o per sordismo
2. condannati ala reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza che sia abituale o sotto
effetto di stupefacenti cui siano dediti, quando non debba essere ordinata altra misura di
sicurezza detentiva o non possa essere applicata la libertà vigilata
3. i sottoposti ad altra misura di sicurezza detentiva se colpiti da infermità psichica che non
richieda il ricovero in O.P.G.
4. gli infermi psichici cui non si possa applicare la libertà vigilata per impossibilità o
inopportunità di affidarli ai genitori o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla loro
educazione o assistenza, e gli infermi psichici che si rivelino nuovamente pericolosi durante la
libertà vigilata.
La giurisprudenza più recente ritiene che per “infermità psichica” dell’art. 219 si debba
intendere la stessa infermità menzionata all’art. 89.
La durata minima di questa misura oscilla tra sei mesi e tre anni, ed è proporzionata alla pena
217
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
stabilita in astratto dalla legge.
La casa di cura e custodia, inoltre, non è compatibile con altra misura di sicurezza detentiva, e questo
perché le altre misure attuano lo scopo della custodia ma non tenendo alla cura dell’internato.
È possibile in via eccezionale applicare questa misura prima dell'esecuzione della pena se il giudice
lo ritiene opportuno per impedire che l’immediata esecuzione della pena possa aggravare le condizioni
psichiche del reo.
Il ricovero in casa di cura e custodia del condannato seminfermo psichico è sempre subordinato al
previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale derivante dall’infermità, dal momento che
tutte le presunzioni di pericolosità sono state abrogate.
Con la legge di riforma n. 81/2014 sono state introdotte delle novità: sono stati introdotti due nuovi
criteri di accertamento, ossia da un lato si dispone che il giudizio di pericolosità viene effettuato sulla
base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di vita individuale,
familiare e sociale del reo (evitando così che le condizioni di disagio sociale possano da sole
giustificare una diagnosi di pericolosità), e inoltre viene precisato che non costituisce elemento idoneo
a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali;
un’ulteriore novità è l’introduzione del principio di sussidiarietà, per effetto del quale il ricovero in una
casa di cura o custodia (o O.P.G.) può essere disposto solo quando ogni altre misura risulti inadeguata
in rapporto alle esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale.
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
La misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si applica ai prosciolti per infermità psichica
o per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti o per sordismo (salvo che si tratti di
proscioglimento per contravvenzione o per delitto colposo o per altro delitto punibile in astratto con la
reclusione non superiore a due anni o con pena pecuniaria), e ai sottoposti ad altra misura di sicurezza
detentiva colpiti da un’infermità psichica tale da richiedere il ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario.
La durata della misura è determinata sulla base della gravità astratta del reato, ed è dunque di:
dieci anni se per il fatto commesso la legge stabilisce l’ergastolo
cinque anni se stabilisce la pena di reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni
due anni in tutti gli altri casi
Anche in questo caso la pericolosità va accertata in concreto, a seguito della dichiarazione di
illegittimità e della conseguente abrogazione di tutte le presunzioni di pericolosità. Tuttavia, questa
eliminazione ha aggravato il problema del trattamento dell’infermo di mente, da un lato perché ne è
derivata una maggiore responsabilizzazione dei periti psichiatri (visto che il loro giudizio è
determinante per la prognosi di pericolosità del malato, essi sono gravati anche delle esigenze di difesa
sociale), e dall’altro non viene attualmente prevista dalla legge alcuna forma di trattamento per il
soggetto prosciolto per infermità mentale che sia ritenuto socialmente non pericoloso.
Una parte degli psichiatri forensi suggerisce una maggiore responsabilizzazione, rifiutando un diretto
coinvolgimento nel giudizio di pericolosità per vari motivi, ossia perché si ritiene scientificamente
superata l’equazione malattia mentale-pericolosità sociale, perché si ritiene che la perizia psichiatrica
sia inidonea a fornire al giudice indicazioni sufficientemente certe e univoche, e perché si tende a
recuperare la purezza terapeutica della psichiatria, emancipandola da deleghe di controllo sociale.
Ne consegue dunque che la prognosi relativa alla pericolosità degli infermi di mente perde così le
caratteristiche di un giudizio tecnico riservato agli esperti, ma dovrebbe essere piuttosto un giudizio
emesso alla stregua di parametri puramente giuridico-normativi e dunque di competenza del giudice.
A questa conclusione si obietta però che, se i giudizi predittivi sulla pericolosità degli infermi di mente
pongono in seria difficoltà gli esperti, a maggior ragione allora dovrebbero essere complessi per i
giudici che si possono affidare ai generici indici dell’art. 133. L’accresciuta consapevolezza
dell’insufficienza del riferimento all’art. 133 ha indotto il legislatore ad introdurre alcune novità, infatti
oggi vigono due nuovi criteri di giudizio, nel senso che la pericolosità deve essere destinata dall’esame
218
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
delle qualità soggettive della singola persona (senza che rilevino le condizioni familiari e sociali), e
vale il principio di sussidiarietà.
Alla crisi della perizia psichiatrica si aggiunge inoltre l’irreversibile fallimento del trattamento
“custodialistico” tipico dell’ospedale psichiatrico giudiziario, che è l’unica misura oggi applicabile
all’infermo giudicato socialmente pericoloso. Questa insufficienza e inadeguatezza era già stata
riscontrata nei manicomi giudiziari, che tendevano spesso a provocare disgregazione morale e
abbrutimento spirituale, e non si può certo pensare che il semplice mutamento del nome possa averne
cambiato le conseguenze. Infatti, l'esperienza maturata negli ultimi anni ha ulteriormente confermato
che l’ospedale psichiatrico giudiziario, oltre ad essere obsoleto e carente di efficacia terapeutica,
presenta quasi sempre nei fatti le caratteristiche di un’istituzione molto degradata e degradante, lesiva
della dignità umana, motivo per cui si è attivato un processo di superamento degli OPG ancora
operanti per arrivare ad abolirli, sostituendoli con nuove strutture a limitato numero di posti-letto ad
esclusiva gestione sanitaria e con l'aggiunta di attività di vigilanza e controlli di sicurezza se necessari.
RIFORMATORIO GIUDIZIARIO
Il ricovero nel riformatorio giudiziario è la misura di sicurezza personale detentiva speciale per i
minori, e si applica più in particolare:
1. ai minori di 14 e di 18 anni riconosciuti non imputabili ex art. 98 che abbiano commesso un
delitto doloso, preterintenzionale o colposo e siano considerati socialmente pericolosi
2. ai minori tra 14 e 18 anni riconosciuti imputabili e condannati come tali a pena diminuita
3. ai minori di 18 anni dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
4. ai minori tra 14 e 18 anni condannati per delitto durante l’esecuzione di una misura di
sicurezza precedentemente applicata per difetto di imputabili
5. infine ai minori di 18 anni nel caso previsto dall’art. 212 comma 3 (ossia se il giudice, cessata
l’infermità, considera che la persona sia socialmente pericolosa).
La durata minima del riformatorio è di un anno.
Con la nuova normativa che regola oggi il processo penale minorile (d.p.r. n. 448/1988) la disciplina
del riformatorio ha subito delle modifiche, infatti la misura del riformatorio giudiziario può essere
applicata solo in relazione ai delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusone non inferiore nel
massimo a 12 anni, e inoltre la misura va in ogni caso eseguita nella nuova forma del collocamento in
comunità pubblica o autorizzata, eventualmente imponendo anche ulteriori specifiche prescrizioni
inerenti alle attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua rieducazione.
La nuova normativa si è anche fatta carico di puntualizzare il concetto di pericolosità sociale del
minore non imputabile, infatti viene stabilito che può essere sottoposto a misura di sicurezza solo
“quando per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il
concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale o gravi delitti di criminalità organizzata”.
Visti questi presupposti così restrittivi, si può dire che l’applicabilità di misure di sicurezza ai minori
tende oggi ad essere un’eventualità del tutto eccezionale.
MISURE DI SICUREZZA PERSONALI NON DETENTIVE
LIBERTÀ VIGILATA
La libertà vigilata consiste in una limitazione della libertà personale del soggetto attraverso un
complesso di prescrizioni a contenuto positivo o negativo dirette ad impedire il compimento di nuovi
reati e a facilitare il reinserimento sociale.
Nella libertà vigilata coesistono due aspetti, uno relativo alla difesa sociale e uno riguardante
l’assistenza al sottoposto alla misura, e questo secondo aspetto è stato recentemente potenziato dalla
legge di riforma dell’ordinamento penitenziario, che all’art. 55 ha stabilito che i sottoposti alla libertà
vigilata sono affidati al servizio sociale ai fini del loro reinserimento nella società (quindi è piuttosto
libertà vigilata e assistita).
219
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Nel codice penale non vi sono esplicite prescrizioni da imporre al vigilato ai fini di
un’individualizzazione della misura, ma viene solo previsto all’art. 190 disp. att. c.p.p. l’obbligo per il
vigilato di non trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso da quello che gli è stato
assegnato, e l’obbligo di informare gli organi della vigilanza di ogni mutamento di abitazione
nell’ambito del comune.
La durata minima della libertà vigilata è di un anno, ma non può essere inferiore a tre anni se viene
inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni, e se per effetto di indulto o di grazia non
debba essere eseguita la pena dell’ergastolo.
L’applicazione della misura della libertà vigilata è obbligatoria, sempre previo accertamento della
pericolosità sociale, nei casi previsti dall’art. 230 c.p. e facoltativa in quelli indicati dall’art. 229 c.p.
Ai minori la libertà vigilata è applicabile secondo modalità esecutive specifiche, ossia con prescrizioni
inerenti alle attività di studio o di lavoro ed eventualmente sotto forma di permanenza in casa.
DIVIETO DI SOGGIORNO
Secondo l’art. 233 esso consiste nel divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province
designate dal giudice, e si applica facoltativamente al colpevole di un delitto contro la personalità dello
Stato o contro l’ordine pubblico o di un delitto commesso per motivi politici o dovuto a particolari
condizioni sociali e morali esistenti in un determinato luogo.
La durata minima è anche in questo caso di un anno, e in caso di trasgressione ricomincia a decorrere
il termine minimo e può essere ordinata la misura della libertà vigilata.
Questa misura solleva dubbi di costituzionalità relativi alla sua compatibilità con la libertà di
circolazione e di soggiorno ex art. 16 Cost., che ammette limitazioni solo per motivi di sanità e di
sicurezza e stabilisce espressamente che nessuna restrizione può imporsi per ragioni politiche.
DIVIETO DI FREQUENTARE OSTERIE E PUBBLICI SPACCI DI BEVANDE ALCOOLICHE
Questa misura, secondo l’art. 234 comma 2, si applica ai condannati per la contravvenzione di
ubriachezza abituale e ai condannati per delitti o contravvenzioni commessi in stato di ubriachezza, se
abituale. Questa norma si considera violata solo se la frequentazione di questi luoghi è abituale o
regolare, ma non se li si frequenta di rado.
La durata minima, anche in questo caso è di un anno, e in caso di trasgressione si può ordinare la
libertà vigilata o la cauzione di buona condotta.
ESPULSIONE OD ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DALLO STATO
Questa misura è stata riformata con il decreto-sicurezza n. 92/2008, che ha riscritto l’art. 235 c.p.
stabilendo che il giudice ordina l’espulsione dello straniero o l’allontanamento dal territorio italiano
del cittadino appartenente ad uno Stato Ue, nei casi previsti dalla legge e inoltre quando lo straniero o
il cittadino Ue sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Le novità sono
dunque l’inclusione dei cittadini Ue nella normativa, e l’abbassamento della soglia minima della pena
inflitta per il reato oggetto di intervenuta condanna, che deve essere superiore a due anni.
Tuttavia, la nuova pena minima oggi richiesta per giustificare l’espulsione o l’allentamento dello
straniero socialmente indesiderato va sempre valutata alla stregua del principio costituzionale di
ragionevolezza, e questo proposito sorgono però dubbi.
Bisogna inoltre verificare quanto la nuova disciplina sia compatibile con i vincoli imposti dal diritto
dell’Unione europea agli Stati nel limitare la libertà di circolazione di un cittadino europeo all’interno
del territorio dell’Ue, infatti secondo i principi della direttiva n. 2004/38/CE la sola esistenza di una o
più condanne penali non giustifica il provvedimento di allontanamento.
LE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI
CAUZIONE DI BUONA CONDOTTA
La cauzione di buona condotta è una misura prevista dall’art. 237 c.p. che consiste nel deposito presso
220
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
la Cassa delle ammenda di una domma di denaro non inferiore a 103 euro e non superiore a 2.065
euro, o nella prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
Questa cauzione di buona condotta, introdotta con un fine di prevenzione speciale, non è però riuscita
nella pratica ad esercitare l’attesa efficacia deterrente. Essa si applica ai liberati dalla casa di lavoro o
dalla colonia agricola se il giudice non ordina la libertà vigilata, ai trasgressori degli obblighi alla
libertà vigilata, e ai trasgressori del divieto di frequentare osterie e spacci di bevande alcooliche.
Questa misura deve avere durata minima di un anno, e non può superare la durata massima di cinque
anni, e al termine di essa - se viene adempiuto l’obbligo di buona condotta - la somma viene restituita,
l’ipoteca viene cancellata e la fideiussione si estingue, mentre se l’obbligo viene trasgredito la somma
viene devoluta alla Cassa delle ammende.
CONFISCA
La confisca, disciplinata dall’art. 240, consiste nell’espropriazione ad opera dello Stato di cose a vario
titolo ricollegabili all’attività criminosa. Una parte della dottrina non condivide la sua inclusione nelle
misure di sicurezza, ritenendola una pena accessoria o una sanzione sui generis, perché il suo
fondamento sarebbe la pericolosità della cosa. Tuttavia l’opinione tradizionale sottolinea l’identità
della funzione della confisca rispetto a quella delle altre misure di sicurezza, e ricostruisce un concetto
relazionale di pericolosità della cosa che non va inteso come attitudine a recare danno ma come
possibilità che la cosa, se lasciata al reo, possa fungere da incentivo per commettere nuovi reati.
Più recentemente vi sono state innovazioni legislative a questo proposito, che hanno introdotto le
novità dell’espansione dei casi di obbligatorietà della confisca, dell’estensione della gamma dei beni
confiscabili e dell’eliminazione o attenuazione di un diretto collegamento eziologico tra i beni
confiscabili e il reato commesso. Inoltre, è stata introdotta anche la confisca per equivalente o confisca
di valore, nel senso che in caso di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il
prezzo del reato, viene prevista la possibilità di confiscare utilità patrimoniali di valore corrispondente
di cui il reo abbia la disponibilità (tecnica estesa anche ai reati in materia di pubblica amministrazione
e contro gli interessi della comunità europea). È stata inoltre inserita, nel 1982, una nuova figura di
confisca come misura patrimoniale di prevenzione ante-delictum.
L’istituto della confisca comprende così oggi ipotesi normative eterogenee con finalità politico-
criminali differenti, ed è comunque sempre andata accentuandosi la valenza generai-preventiva e
afflittiva della confisca nei termini di sanzione accessoria, in particolare in riferimento a tipologie
delittuose che rientrano nell’ambito della criminalità economica o della criminalità organizzata.
La confisca è facoltativa, e può essere applicata solo il caso di sentenza di condanna, sul presupposto
dell’accertata pericolosità della cosa con riferimento all’uso che il reo può farne avendone al
disponibilità (la giurisprudenza ha però specificato che la pericolosità della cosa richiede l’uso diretto
e necessario di essa per commettere il reato, come ad esempio nel caso di un macchinario
appositamente costruito per commettere il reato, ad esempio, di falso).
La confisca è obbligatoria in caso di cose che costituiscono il prezzo del reato, e di cose la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata
condanna. Le ipotesi di confisca obbligatoria sono state negli ultimi tempi estese, soprattutto per
reprimere le fenomenologie delittuose tipicamente produttrici di arricchimento illecito, ed è stata così
disposta la confisca penale dei proventi mafiosi, nonché il meccanismo di “confisca aggravata” con il
quale, nei casi di condanna per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, sequestro estorsivo,
usure, ecc., viene sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il
condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità
in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito o attività economica.
APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
221
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Le misure di sicurezza detentive di casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico, e riformatorio
giudiziario, possono essere applicate in via provvisoria, secondo l’art. 206 c.p. Esse vengono eseguite
dopo che la pena è stata scontata se sono applicate congiuntamente alla pena detentiva, e dopo che la
sentenza è passata in giudicato se sono applicate congiuntamente a pena non detentiva.
In caso di concorso di misure temporanee non detentive con misure detentive si esegue prima quella
detentiva; se per più reati si devono applicare più misure di sicurezza della stessa specie allo stesso
reo, si procede alla loro unificazione, mentre se sono di specie diversa il giudice valuta
complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e applica una o più misure di sicurezza.
L'esecuzione della misura di sicurezza viene sospesa se la persona sottoposta deve scontare una pena
detentiva, e riprende il suo corso una volta eseguita la pena. Se invece il reo è colpito da infermità
psichica la misura viene trasformata dal giudice in ricovero in OPG o casa di cura o di custodia.
Il giudice, nel corso dell’esecuzione, può modificare le modalità di esecuzione della misura senza
mutarne la specie.
Se il sottoposto a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione, la durata
minimo ricomincia a decorrere dal giorno in cui viene nuovamente eseguita, tranne nel caso di
ricoverati in OPG o casa di cura e di custodia.
L’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione,
eccetto la confisca. Mentre l’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misura tranne quelle
per cui la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (e in ogni caso non vene impedita
l’esecuzione delle misure già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena di
reclusione superiore a dieci, caso nel quale alla colonia agricola e alla casa di lavoro si sostituisce la
libertà vigilata).
Se la pena dell’ergastolo non viene eseguita in tutto o in parte per amnistia o indulto, il condannato è
sottoposto alla libertà vigilata per non meno di tre anni.
222
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO SESTO
SANZIONI CIVILI
Nel titolo VII del libro I del codice penale vengono disciplinate le sanzioni civili, dal momento che un
comportamento umano può avere il doppio effetto sia di costituire un fatto di reato, sia di realizzare
un illecito civile per il quale vanno applicate le relative sanzioni. Le sanzioni civili della parte generale
del codice penale sono le restituzioni, il risarcimento del danno patrimoniale e non, l’obbligo del
rimborso delle spese per il mantenimento del condannato, l’obbligazione civile per l’ammenda e
l’obbligazione civile per la multa, mentre il codice civile prevede anche altre sanzioni come l’indegnità
a succedere, la revocazione della donazione, ecc.
LE SINGOLE SANZIONI
Restituzione: stabilita dall’art. 185 comma 1 c.p., consiste nella reintegrazione dello stato di
fatto preesistente alla commissione del reato. L’obbligo alla restituzione presuppone solo la
possibilità, naturalistica o giuridica, della restituito in integrum, e può avere ad oggetto cose
mobili o immobili di cui si sia venuti in possesso, ed è, inoltre, un obbligo indivisibile (art. 187).
Risarcimento del danno: consiste nella corresponsione di una somma di denaro equivalente
al pregiudizio arrecato con il reato, e vi si ricorre quando non è possibile la restituito in
integrum o quando essa non è sufficiente a riparare il danno (e, sulla base dell’art. 2059 c.c., i
danni non patrimoniali sono risarcibili solo nei casi determinati dalla legge).
Il danno risarcibile ex art. 185 comma 2 è un sanno patrimoniale risultante dalla lesione degli
interessi civili che fanno sorgere il diritto al risarcimento in sede civile (ossia per danno
emergente o per lucro cessante), oppure un danno non patrimoniale o morale, consistente
nella sofferenza fisica o psichica patita in conseguenza del reato.
Riguardo al termine “reato” si è tradizionalmente ritenuto che occorresse accertare in
concreto tutti i requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie, dunque anche dolo e colpa, ma
l'evoluzione normativa con l’introduzione di nuovi casi, e l’evoluzione giurisprudenziale che ha
individuato ulteriori ipotesi di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi
costituzionalmente garantiti, hanno spinto la Corte costituzionale a modificare questa
interpretazione e a ritenere che il termine reato vada inteso come “fattispecie corrispondente
nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato”, ritenendo così che la
responsabilità a fini civilistici possa fondarsi anche su presunzione di legge.
Il risarcimento del danno morale avviene mediante la corresponsione di una somma di
denaro la cui funzione non è quella di reintegrare il patrimonio, ma si soddisfare per il male
sofferto. Per quanto se ne sia discusso in dottrina, la natura giuridica del danno morale, avendo
carattere spiccatamente afflittivo, rientra tra le sanzioni penali, piuttosto che nell’ambito del
diritto privato.
Il danno risarcibile deve essere ovviamente conseguenza del reato (dunque se non vi è reato,
non vi è danno), e il titolare del diritto al risarcimento si chiama “danneggiato dal reato” che
può anche essere una persona diversa dalla persona offesa dal reato.
Una forma particolare di risarcimento del danno non patrimoniale è la pubblicazione della
sentenza di condanna, nel caso in cui essa sia un mezzo per riparare il danno non patrimoniale
cagionato dal reato. Sono obbligati al risarcimento del danno l’autore del reato e coloro che
devono rispondere per il fatto da lui commesso, ossia genitori, proprietario dell’autoveicolo,
ecc.
La dottrina penalistica è sempre più interessata all’argomento del risarcimento del danno per
diversi motivi: la considerazione sempre maggiore della “vittimologia”; la crisi dell’ideologia
del trattamento penitenziario dei delinquenti, che spinge verso la ricerca di nuove forme di
reazione al delitto; l’intenzione di valorizzare il pensiero sociale che ormai non crede più che
l’unico modo per ristabilire l'ordine giuridico violato sia la sanzione afflittiva; la sempre
maggiore integrazione tra penale e civile
223
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
Rimborso delle spese per il mantenimento del condannato: il condannato viene anche
civilmente obbligato a rimborsare allo Stato le spese per il mantenimento negli istituti di pena,
e ne risponde con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri. Questa obbligazione non
si estende alla persona civilmente responsabile né agli eredi.
Vengono inoltre poste a carico del condannato le spese per il suo mantenimento durante la
custodia cautelare.
La nuova legge sull’ordinamento penitenziario prevede la possibilità della remissione del
debito per le spese del procedimento e del mantenimento nei confronti dei condannati e degli
internati che versino in condizioni economiche disagiate e si siano distinte per regolare
condotta.
Obbligazione civile per la multa e per l’ammenda: questa è una forma di responsabilità
civile di carattere sussidiario, che in passato ha sollevato dubbi riguardo alla sua compatibilità
con il principio della personalità della responsabilità penale.
L’obbligazione civile per la multa e per l’ammenda inflitta a persona dipendente viene
disciplinata dall’art. 196, che dispone che nei reati commessi da dipendenti, chi ne ha
l’autorità, direzione o vigilanza, in caso di insolvibilità del reo è obbligato al pagamento di una
somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflittagli, se si tratta di violazioni di
disposizioni che egli era tenuto a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Nel caso di insolvibilità anche di questa persona, si applica al condannato la conversione della
pena a norma di legge ex art. 136 c.p.
L’obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende è
prevista dall’art. 197, che dispone che gli enti forniti di personalità giuridica, eccetto Stato,
regioni, province e comuni, se viene pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la
rappresentanza o l’amministrazione o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato
che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole o sia
commesso nell’interesse della persona giuridica, in caso di insolvibilità del reo, sono obbligati
al pagamento di una somma corrispondente all’ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
Nel caso di insolvibilità anche di questa persona, si applica al condannato la conversione della
pena a norma di legge ex art. 136 c.p.
LE GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI CIVILI
Per l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato il codice ha previsto una serie di
garanzie, ossia il sequestro conservativo penale, la cauzione, l’azione revocatoria e il prelievo sulla
remunerazione corrisposta ai condannati per il loro lavoro (mentre è stata abrogata l’ipoteca penale, e
sostituita con il sequestro conservativo).
1. Sequestro conservativo: il sequestro conservativo penale dei beni mobili o immobili
dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne consente il
pignoramento, può essere chiesto dal p.m., in ogni stato e grado del processo, se vi è fondata
ragione di ritenere che manchino o si disperando le garanzie per il pagamento della pena
pecuniaria, delle spese del procedimento o di ogni altra somma dovuta all’erario statale.
Il sequestro conservativo ha come effetto quello di rendere privilegiati questi crediti rispetto
ad ogni altro credito non privilegiato anteriore e rispetto ai crediti posteriori, salvi i privilegi
stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
2. Azione revocatoria: l’azione revocatoria riguarda determinati atti stabiliti dagli artt. 192-194
c.p., i quali sono inefficaci rispetto ai crediti di cui si è detto; questi atti sono: gli atti a titolo
gratuito compiuti dal reo dopo il reato (che si presumono fraudolenti). Gli atti a titolo oneroso
compiuti dal reo dopo il reato, che eccedono la semplice amministrazione o la gestione
dell’ordinario commercio, presunti relativamente in frode, purché sia fornita la prova della
malafede dell’altro contraente; gli atti a titolo gratuito compiuti dal reo nell’anno anteriore al
reato, qualora si provi la frode da parte del colpevole; gli atti a titolo oneroso compiuti dal reo
224
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
nell’anno anteriore al reato, che eccedono la semplice amministrazione o la gestione
dell’ordinario commercio, purché si provi la malafede dell’altro contraente.
3. Prelievo sulla remunerazion: il prelievo sulla remunerazione dei condannati per il lavoro
prestato viene regolato dall’art. 24 della legge sull’ordinamento penitenziario
225
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
PARTE OTTAVA
STRUMENTI AMMINISTRATIVI DI CONTROLLO SOCIALE
CAPITOLO UNO
DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVO
Negli ultimi anni è emerso l’orientamento di politica criminale che tende alla depenalizzazione, ossia
alla trasformazione delle contravvenzioni meno gravi in illeciti amministrativi, e questo per l’eccessiva
dilatazione del diritto penale e per il numero sempre (e troppo) crescente di processi penali che
impegnano la macchina giudiziaria.
Con l’affermarsi degli ordinamenti giuridici ispirati allo Stato di diritto si è assistito alla tendenza a
trasferire nel campo penale molti degli illeciti che nell’ancien régime erano contravvenzioni
amministrative, e questa tendenza inversa a quella gli auspicata costituita l’attuazione del principio di
giurisdizionalizzazione, ed era sollecita dall’esigenza di apprestare una più efficace garanzia dei diritti
dei cittadini nei confronti degli eventuali abusi della p.a.
L’illecito depenalizzato crea due problematiche, ossia la necessità di costruire un nuovo modello di
illecito amministrativo che sia davvero idoneo a surrogare lo strumento penale nella repressione delle
“microlesioni" dei beni giuridici, e la necessità di preoccuparsi di creare un sistema depenalizzato così
garantistico da consentire una ragionevole tutela del cittadino.
Il legislatore con la legge n. 689/81 ha mirato a questo duplice obiettivo, ed ha così proceduto alla
depenalizzazione di tuti i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda (eccetto alcuni reati
a tutela di beni di particolare rilievo sociale), ed ha anche introdotto un insieme di nuovi principi
destinati a regolare organicamente e in via generale la materia dell’illecito depenalizzato, fondando
così un nuovo sistema di illecito. Alcuni collocano questo sistema in una posizione intermedia tra
quello penale e quello degli illeciti amministrativi, mentre altri lo definiscono un sottosistema penale,
che entrerebbe a far parte di una superiore categoria dogmatica del c.d. illecito di diritto pubblico,
ricomprendente l’illecito penale e quello amministrativo nelle sue varie forme (contrapposto
all’illecito civile).
Sembra più valida l’opinione “intermedia”, che dà sufficiente autonomia all’illecito depenalizzato
rispetto a quello penale.
I PRINCIPI GENERALI DELL’ILLECITO DEPENALIZZATO
Buona parte della nuova disciplina dell’illecito depenalizzato si ispira a principi e criteri d’imputazione
tipici del diritto penale, mentre sono minoritario le posizioni ispirate a principi civilistici o
amministrativi. Vengono di seguito esposti i nuovi principi generali contenuti negli artt. da 1 a 12 della
legge n. 689/1981 e attinenti agli aspetti sostanziali della disciplina.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione della normativa in questione è circoscritto alle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sia che si tratti di violazioni
in origine amministrative, sia che si tratti di violazioni depenalizzate, mentre non vi sono
ricompresi gli illeciti punti con sanzioni non pecuniarie e gli illeciti disciplinari.
I principi di ispirazione penalistica
L’art. 1 comma 10 sancisce esplicitamente il principio di riserva di legge e quello di
irretroattività, stabilendo che nessuno possa essere assoggettato a sanzioni amministrative se
non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
L’art. 2 stabilisce invece che non può essere assoggettato a sanzioni amministrative i minori
incapaci di intendere e di volere (salvo che lo stato non derivi da sua colpa o sia stato da lui
preordinato). Il secondo comma dell’art. 2 introduce invece un’ipotesi di colpa in vigilando
modellata sull’art. 2047 c.c., infatti si dispone che - eccetto i casi in cui lo stato di incapacità
226
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
derivi da colpa del trasgressore o sia dallo stesso preordinato - della violazione risponde chi
era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
L’art. 3 ricalca poi la disciplina dell’art. 42.4 c.p., disponendo cioè che nelle violazioni in cui è
applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa.
L’art. 5, a proposito del concorso di persone, afferma un modello di responsabilità concorrente
analogo a quello del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.
L’art. 8, riguardo al concorso formale di più violazioni, stabilisce la disciplina del cumulo
giuridico, analogamente a quanto previsto dall’art. 81 c.p.
Inoltre, dal momento che viene stabilito all’art. 7 che l’obbligazione di pagare la somma di
denaro dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi, sembra che venga accolto un
principio personalistico riguardo alla commissione della sanzione.
L’art. 9, a proposito del concorso apparente di norme, stabilisce che vada applicata la norma,
così come avviene nel codice per il principio di specialità ex art. 15, ma viene anche stabilito
che in caso di concorso tra norma penale e norma amministrativa regionale, prevale la prima
(se si fosse ammesso il contrario si sarebbe disatteso il principio di riserva di legge statale in
materia penale ex art. 25 Cost.).
LO SCHEMA CIVILISTICO DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Di ispirazione civilistica è invece l’art. 6, che introduce una triplice ipotesi di responsabilità solidale, a
carico:
1. di chi sia proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa
che servì o fu destinata a commettere la violazione (a meno che non provi che fu utilizzata
contro la sua volontà)
2. di chi sia titolare di un potere di autorità, direzione o vigilanza sul soggetto autore della
violazione (a meno che non provi di non aver potuto impedire il fatto)
3. della persona giuridica, entro od imprenditore di cui l’autore della violazione sia
rappresentante o dipendente, sempre che la violazione sia stata commessa nell'esercizio delle
funzioni o incombenze di questo soggetto. In tutte e tre le ipotesi, però, chi ha pagato può
ottenere il regresso per l'intera somma dall'autore della violazione. Il ricorso allo schema
civilistico della solidarietà si scontra però con alcune obiezioni, infatti il suo utilizzo,
consentendo il recupero della somma versata attraverso il diritto di regresso, attenua
sensibilmente l'efficacia dissuasiva della minaccia di sanzione amministrativa. Inoltre,
attribuendo all’ente una mera obbligazione solidale con anche il diritto di regresso, ci si limita
ad accollare all’ente una semplice forma di garanzia per il pagamento della sanzione
pecuniaria. In questo modo il legislatore ha perso un’occasione in cui poteva superare il dogma
societas delinquere non potest, infatti se si fosse prevista una disciplina imperniata sulla
responsabilità concorrente dell’ente collettivo e del reo, la minaccia della sanzione
amministrativa avrebbe avuto più possibilità di scoraggiare la realizzazione di spregiudicate
“politiche d’impresa”.
227
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
CAPITOLO DUE
MISURE DI PREVENZIONE
Le misure di prevenzione sono misure special-preventive considerate tradizionalmente di natura
formalmente amministrativa, le quali hanno l’obiettivo di evitare la commissione di reati da parte di
certe categorie di soggetti, considerati socialmente pericolosi. Esse vengono applicate
indipendentemente dalla commissione di un precedente reato (caratteristica che le distingue dalle
misure di sicurezza) e vengono per questo chiamate misure ante o praeter delictum.
La legge di pubblica sicurezza che ha rappresentato in buona parte il modello di tutta la legislazione
successiva è stata emanata nel 1865, e da quel momento perdura la disputa sulla legittimità nello Stato
di diritto di misure restrittive della libertà del cittadino che prescindono dalla previa commissione di
un reato. In dottrina infatti l’opinione pressoché unanime ritiene che nonostante si definiscano di
"prevenzione", queste misure non siano mai riuscita ad avere un effetto autenticamente
preventivo/rieducativo, ma siano piuttosto state utilizzate come strumento di controllo sociale di tipo
sostanzialmente repressivo.
Fino all’emanazione del codice delle leggi antimafia del 2011, il testo normativo fondamentale è
sostanzialmente rimasto quello della legge n. 1423/1956, così come modificato dai vari interventi
legislativi. Le tradizionali misure preventive personali della sorveglianza speciale e dell’obbligo o
divieto di soggiorno, con la legge n. 575/1965 sono state estese agli indiziati di appartenere ad
associazioni mafiose, e nel 1982 anche agli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche e
assimilabili. Con la legge Reale (n. 152/1975) queste misure sono poi state estese anche a determinate
categorie di soggetti ritenuti politicamente pericolosi. In seguito la legge Rognoni-La Torre (n.
646/1982) ha potenziato il sistema della prevenzione antimafia introducendo misure a carattere
patrimoniale; la legge n. 327/1988 ha introdotto importanti modifiche di questa normativa per
eliminare gli inconvenienti più vistosi e intollerabili.
La legge n. 401/1989 ha previsto una nuova misura di prevenzione personale, ossia il divieto di
accedere nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, a carico di coloro che siano stati coinvolti
in episodi di violenza negli stadi o vi si rechino portando armi improprie, e anche a carico di chi, in
passato, sia astato denunciato per episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
nel 1993 si è poi estesa la misura di prevenzione personale del divieto di accesso agli stadi anche ad
una vasta cerchia di soggetti (chi si rechi allo stadio con simboli o emblemi di associazioni aventi come
scopo l’incitamento alla discriminazione e alla violenza razziale, chi sia stato denunciato o condannato
per incitamento alla violenza razziale o alla diffusione di idee fondate su superiorità di razza o odio
razziale, ecc.).
Nel 2011 è stato inoltre emanato il testo unico del codice delle leggi antimafia, che è in realtà frutto
di una consolidazione normativa incentrata in gran parte sulla materia delle misure di prevenzione.
LE SINGOLE MISURE DI PREVENZIONE “PERSONALI”
La disciplina normativa delle misure di prevenzione personali ha subito modifiche con riguardo sia
alle tipologie di misure applicabili, sia alle cerchie di soggetti destinatari.
Per quanto riguarda le tipologie soggettive di pericolosità, la legge del 1956 contemplava
originariamente cinque categorie di destinatari (oziosi e vagabondi, soggetti dediti a traffici illeciti,
proclivi a delinquere, sospetti sfruttatori di prostitute o contrabbandieri o trafficanti di stupefacenti, e
soggetti abitualmente dediti allo svolgimento di attività contrarie alla morale pubblica o al buon
costume). Nel 1988 si è cercato di “svecchiare” queste categorie, eliminando quella degli oziosi e dei
vagabondi e quella dei soggetti abitualmente dediti allo svolgimento di attività contrarie alla morale
pubblica o al buon costume.
Le misure di prevenzione personali possono essere applicabili dal questore o dall’autorità
giudiziaria, e quelle applicabili dal questore sono riferibili a queste tre categorie:
228
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
1. coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fato, che sono abitualmente dediti a traffici
delittuosi
2. coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose
3. coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano
dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale
dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
In tutti i casi bisognerebbe dunque basarsi su “elementi di fatto”, e non dovrebbero quindi mai essere
sufficienti indizi o sospetti di pericolosità, ma di fatto è possibile che la prassi continui ad orientarsi in
senso meno garantistico, infatti se fosse sempre necessaria una prova indiziaria, allora verrebbe meno
lo stesso motivo pratica che giustifica il ricorso al procedimento di prevenzione.
Le misure applicabili dal questore sono l’avviso orale e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio:
Avviso orale: è una misura che sostituisce la vecchia diffida, emendandola dai principali
inconvenienti che comportava. L’art. 3 del codice antimafia stabilisce che il questore può
avvisare oralmente una delle persone delle categorie predette che esistono indizi a suo carico,
indicando i motivi che li giustificano, ed invita la persona a tenere una condotta conforme alla
legge (redigendo anche il processo verbale dell’avviso per dargli data certa). L’unico fine di
questa misura è dunque quello di costituire presupposto per la richiesta di applicazione della
sorveglianza speciale nei confronti degli avvisati che non abbiano “mutato vita”. L’avviso orale
ha efficacia solo per tre anni e può essere revocato se ne fa richiesta l’interessato (se il
questore non provvede entro 60 giorni, la richiesta si intende accolta).
Rimpatrio con foglio di via obbligatorio: che stabilisce che nel caso in cui una delle persone
delle categorie predette sia pericolosa per la pubblica sicurezza e si trovi fuori dai luoghi di
residenza, il questore può rimandarla lì con provvedimento motivato e con foglio di via
obbligatorio, inibendo loro di ritornare nel comune dal quale viene allontana, senza preventiva
autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni. La Corte costituzionale ne ha
riconosciuto la legittimità, ma su di essa sussistono ancora dubbi da parte di molti (per
violazione del diritto al contraddittorio, alla difesa e alla libertà di circolazione).
Le misure di prevenzione personali applicabili dall’ autorità giudiziaria mediante un apposito
procedimento di competenza del tribunale hanno come destinatari nove categorie di soggetti, tra i
quali i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e quelli indiziati di avere agevolato
gruppi o persone che hanno in più occasioni partecipato a manifestazioni di violenza sportiva.
A tutti questi soggetti è applicabile la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, se risulta in concreto accertata la loro pericolosità per la sicurezza pubblica. Alla
sorveglianza speciale si accompagnano anche le prescrizioni di vivere onestamente, di rispettare le
leggi e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso dell’autorità locale di pubblica
sicurezza, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a
misure di prevenzione o di sicurezza, di non detenere e portare armi, ecc. oltre a tutte le prescrizioni
ulteriori che il Tribunale ritenga necessarie.
Alla sorveglianza speciale può poi essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni (o
province) diversi da quelli di residenza o dimora abituale e/o l’obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o dimora abituale, nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee
alla tutela della sicurezza pubblica. La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale e
dell’obbligo/divieto di soggiorno costituisce reato.
È stata inoltre prevista l’applicabilità a questi soggetti anche delle misure patrimoniali del sequestro e
della confisca dei beni (prima riservate ai soli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose).
LA PREVENZIONE ANTIMAFIA
La legge n. 575/1965 ha esteso l’applicazione delle misure di prevenzione personali agli indiziati di
appartenere ad associazioni mafiose, con alcuni adattamenti per quanto riguarda le misure di
prevenzione della sorveglianza speciale, dell’obbligo e del divieto di soggiorno: il processo di
229
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
prevenzione non presupponeva che vi fosse stato un precedente avviso orale del questore a cambiare
vita; poteva essere iniziato su proposta del procuratore della Repubblica e verteva esclusivamente
sull’accertamento della qualità di indiziato di appartenere ad associazione mafiosa.
Nel 2008 e 2009 si sono attuate ulteriori modifiche, prevedendo la possibilità di applicare le misure
anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p., ed estendendo la
titolarità dell’azione di prevenzione anche al Procuratore nazionale antimafia, ai Procuratori
distrettuali e alla Direzione investigativa antimafia.
Con la legge Rognoni-La Torre del 1982 è stata potenziata la prevenzione antimafia, creando il reato
di associazione di tipo mafioso, e introducendo nuove misure di natura patrimoniale, ossia il sequestro
e la confisca dei patrimoni di sospetta provenienza illecita, e sono applicabili indipendentemente dalle
misure personali e anche nel caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (se la morte
sopraggiunge nel corso del procedimento esso continua nei confronti degli eredi o aventi causa).
Il sequestro è un provvedimento provvisorio e cautelare disposto dal Tribunale sui beni dei quali la
persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività
economica svolta o quando sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il
frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
La confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, consiste
in un provvedimento di natura ablativo che comporta la devoluzione allo Stato di beni che ne
costituiscono oggetto, ossia beni di cui la persona non possa giustificare la provenienza e di cui sia
titolare o risulti avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività
economica, e beni che risultino essere frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. Punto
controverso è dato dal fatto che il legislatore sembra qui introdurre un’inversione dell’onere della
prova, violando così i principi costituzionali della difesa e della presunzione di non colpevolezza.
Alcuni configurano la confisca come una misura a carattere repressivo e sanzionatorio, altri come una
misura di prevenzione a carattere patrimoniale, ma la giurisprudenza tende ad affermarne la natura
ibrida.
La legge Rognoni-La Torre del 1982 ha assunto la fattispecie di associazione di stampo mafioso come
presupposto sia del processo penale sia del procedimento di prevenzione, ma così facendo si è reso
ancora più complesso il problema del coordinamento tra i due tipi di procedimenti. Infatti, vista la
rispettiva assimilazione sul piano strutturale, la fattispecie penale e quella di prevenzione sono
differenziabili solo alla stregua del diverso livello di prova raggiungibile circa l’appartenenza dei
singoli associati all’associazione, e più precisamente, mentre al processo penale finisce col
corrispondere l’area probatoria avente come estremi l’indizio suscettivo di approfondimento e la
prova vera e propria, il processo di prevenzione dovrebbe invece ricomprendere l’area che va dal
sospetto oggettivamente suffragato all’indizio confinante con quello sufficiente ad attivare la normale
repressione penale.
Però, dal momento che nella prassi è difficile tracciare delimitazioni nette, vi è il duplice rischio di
creare inutili sovrapposizioni di procedimenti oppure di degradare a labili sospetti gli indizi sufficienti
ai fini dell’attivazione della procedura preventiva (infatti se gli indizi si rilevano tanto corposi non si
vede perché si dovrebbe ricorrere al procedimento di prevenzione al posto del processo penale).
LA LEGGE N. 152 DEL 22 MAGGIO 1975 (C.D. LEGGE REALE)
Un’ulteriore estensione dell’ambito di applicabilità delle misure di prevenzione è stata realizzata con
la c.d. legge Reale del ’75, con cui si sono estese le misure di prevenzione ai soggetti politicamente
pericolosi, ossia, più nello specifico:
1. coloro che, in gruppo o isolatamente, compiano atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti
a sovvertire l’ordinamento dello Stato con la commissione di uno dei reati previsti dal cap. I,
titolo VI, libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 c.p.;
230
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
lOMoARcPSD|7662442
2. coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte e nei confronti dei quali per il
comportamento successivo debba ritenersi che continuino a svolgere un’attività analoga a
quella precedente
3. coloro che compiano atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti alla ricostruzione del
partito fascista
4. coloro che, fuori dai casi sopra citati, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
legge n. 865/67 e negli artt. 8 e ss. della legge n. 497/74, quando per il loro comportamento
successivo debba ritenersi che siano proclivi a commettere reati della stessa specie con fine di
sovvertire l’ordinamento dello Stato.
Il carattere più rilevante di questa estensione, recepita nel codice antimafia, consiste nell’avere
ricollegato le misure di prevenzione non più a condotte presuntive e a modi di essere del soggetto, ma
ad atti preparatori. Tuttavia, non è chiaro cosa vada inteso per “atti preparatori”, infatti se li si
intende come attività che manifestino all’esterno e che non siano ancora giunte all’inizio della fase
esecutiva, si rischia di non riuscire più a distinguere la fattispecie preventiva da alcuni delitti di
attentato. Se invece li si interpretasse in senso soggettivo, ossia come espressione dello scopo
dell’agente, essi finirebbero per coincidere spesso con le fattispecie di diversi reati che puniscono
autonomamente il compimento di atti preparatori di altri delitti.
INSUFFICIENZE E PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL VIGENTE SISTEMA PREVENTIVO
Le principali critiche che vengono mosse al vigente sistema preventivo riguardano soprattutto le
misure di prevenzione personali, che sembrano essere talvolta in conflitto con alcuni principi
costituzionali, ossia il principio della personalità della responsabilità penale, quello di presunzione di
non colpevolezza, e quello di risocializzazione, nonché il principio dell’inviolabilità della libertà
personale ex art. 13 Cost. e quello di tassatività ex art. 25 comma 2 Cost. (poiché molte fattispecie
preventive usano concetti indeterminati).
In realtà, nella pratica, le misure di prevenzione personali hanno finito col far incrementare i fenomeni
criminosi che si volevano estirpare.
Tuttavia, non si deve pensare che la funzione preventiva sia in assoluto un “corpo estraneo” in una
società ispirata ai principi dello Stato sociale di diritto. La funzione trova infatti giustificazione anche
nel nostro ordinamento, non soltanto perché appartiene alla stessa essenza logica dello Stato impedire
la commissione dei reati e salvaguardare la vita e i beni dei cittadini, ma anche perché uno Stato
sociale di diritto dovrebbe rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la
libertà dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione dei
cittadini all’organizzazione statale. La prevenzione viene in questo senso intesa come un impegno
solidaristico e reale volto ad assicurare lo sviluppo della persona e prevenire il reato con la rimozione
delle sue cause.
La prevenzione, in questo modo, smette di essere un comodo “alibi” con cui lo Stato si sottrae ai suoi
compiti sociali e di riforma, come è attualmente, ma diventa un obiettivo che la società persegue
attraverso meccanismi di recupero e integrazione.
231
Scaricato da Mtl Crsh (mirkosepi@[Link])
Potrebbero piacerti anche
- Diritto Penale Tra Essere e ValoreNessuna valutazione finoraDiritto Penale Tra Essere e Valore43 pagine
- Diritto Penale Fiore in 100 PagineNessuna valutazione finoraDiritto Penale Fiore in 100 Pagine100 pagine
- Diritto Penale Dell'Informatica Prima Parte0% (1)Diritto Penale Dell'Informatica Prima Parte213 pagine
- Diritto Penale I (I Parte) 2020 PelisseroNessuna valutazione finoraDiritto Penale I (I Parte) 2020 Pelissero115 pagine
- (Ebook - Var - Ita) Compendio Di Diritto PenaleNessuna valutazione finora(Ebook - Var - Ita) Compendio Di Diritto Penale23 pagine
- FIANDACA 20160922170234 Musco Fiandanca Diritto Penale GeneraleNessuna valutazione finoraFIANDACA 20160922170234 Musco Fiandanca Diritto Penale Generale152 pagine
- Simone Start Up Ipercompendio Di Diritto Dell'unione EuropeaNessuna valutazione finoraSimone Start Up Ipercompendio Di Diritto Dell'unione Europea202 pagine
- D 1 711 Bertaccini - Fondamenti Di Critica Della PenaNessuna valutazione finoraD 1 711 Bertaccini - Fondamenti Di Critica Della Pena321 pagine
- Docsity Riassunto Di Elementi Di Diritto Penale Parte Generale Cadoppi e VenezianiNessuna valutazione finoraDocsity Riassunto Di Elementi Di Diritto Penale Parte Generale Cadoppi e Veneziani168 pagine
- Fiandaca Musco.I Delitti Contro La Pubblica Amministrazione PDFNessuna valutazione finoraFiandaca Musco.I Delitti Contro La Pubblica Amministrazione PDF24 pagine
- Diritto-Sindacale-Persiani RiassuntoNessuna valutazione finoraDiritto-Sindacale-Persiani Riassunto44 pagine
- Diritto Penale Ragionato CompletoNessuna valutazione finoraDiritto Penale Ragionato Completo167 pagine
- Diritto Penitenziario Varraso MancusoNessuna valutazione finoraDiritto Penitenziario Varraso Mancuso3 pagine
- Compendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014Nessuna valutazione finoraCompendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014109 pagine
- Compendio Di Diritto Penale Parte Generale CompletoNessuna valutazione finoraCompendio Di Diritto Penale Parte Generale Completo172 pagine
- Riassunto Diritto Penale Fiandaca MuscoNessuna valutazione finoraRiassunto Diritto Penale Fiandaca Musco159 pagine
- Delitti Contro La Persona - Diritto Penale100% (1)Delitti Contro La Persona - Diritto Penale63 pagine
- Manuale Di Giustizia Amministrativa ClarichNessuna valutazione finoraManuale Di Giustizia Amministrativa Clarich143 pagine
- Programma Del Corso Di Diritto Criminale by Francesco CarraraNessuna valutazione finoraProgramma Del Corso Di Diritto Criminale by Francesco Carrara20 pagine
- Riassunto Dei Delitti e Delle PeneNessuna valutazione finoraRiassunto Dei Delitti e Delle Pene6 pagine
- Criminologia e Psicopatologia ForenseNessuna valutazione finoraCriminologia e Psicopatologia Forense52 pagine
- 4 Lezioni Di Storia Della Codificazione. Ilcode Civil - DEZZANessuna valutazione finora4 Lezioni Di Storia Della Codificazione. Ilcode Civil - DEZZA22 pagine
- Il Diritto Penale in Mappe MentaliNessuna valutazione finoraIl Diritto Penale in Mappe Mentali241 pagine
- ENTILOCALI - VU - LEZ 2.1 - Nuovo Codice Della StradaNessuna valutazione finoraENTILOCALI - VU - LEZ 2.1 - Nuovo Codice Della Strada6 pagine
- F Giuffre Ia Nicotra F Paterniti Diritto Pubblico e CostituzionaleNessuna valutazione finoraF Giuffre Ia Nicotra F Paterniti Diritto Pubblico e Costituzionale131 pagine
- Appunti Di Diritto Civile Nella Legalità Costituzionale Dal PerlingeriNessuna valutazione finoraAppunti Di Diritto Civile Nella Legalità Costituzionale Dal Perlingeri49 pagine
- Riassunti Orestano - Il Problema Delle Persone Giuridiche in Diritto RomanoNessuna valutazione finoraRiassunti Orestano - Il Problema Delle Persone Giuridiche in Diritto Romano42 pagine
- Lineamenti Di Dottrina Pura Del Diritto KelsenNessuna valutazione finoraLineamenti Di Dottrina Pura Del Diritto Kelsen31 pagine
- Penal Eee Eeeeeeeeeeeeeee EeeeeeeeeeeeeeeNessuna valutazione finoraPenal Eee Eeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeee209 pagine