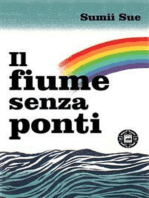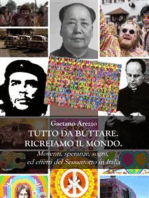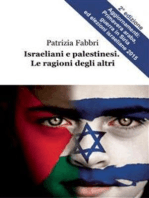Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
SPEROTTO Dirittidelledonne 2011 Fatto
SPEROTTO Dirittidelledonne 2011 Fatto
Caricato da
riostefaniaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
SPEROTTO Dirittidelledonne 2011 Fatto
SPEROTTO Dirittidelledonne 2011 Fatto
Caricato da
riostefaniaCopyright:
Formati disponibili
I diritti delle donne in Afghanistan
Author(s): FEDERICO SPEROTTO
Source: Rivista di Studi Politici Internazionali , GENNAIO-MARZO 2011, Nuova Serie, Vol.
78, No. 1 (309) (GENNAIO-MARZO 2011), pp. 81-88
Published by: Maria Grazia Melchionni
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/42740997
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Rivista di Studi Politici
Internazionali
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
I diritti delle donne in Afghanistan
FEDERICO SPEROTTO
Introduzione
L'Afghanistan è un paese devastato da una guerra che prosegue ininterrotta
dal 1973, quando la monarchia fu spodestata da una congiura di palazzo sostenu-
ta dall'Unione Sovietica, protagonista dal 1979 di un'invasione durata dieci anni,
conclusasi con un bilancio devastante. Questo continuo sconvolgimento ha scos-
so il paese nel profondo, esasperando una frammentazione politica e sociale già
esistente per ragioni legate alla nascita stessa dell'Afghanistan come Stato indi-
pendente, alla fine del Grande gioco tra gli imperi russo e britannico1. Tra le con-
seguenze dirette della guerra trentennale c'è stato un blocco nel processo di seco-
larizzazione e modernizzazione inaugurato con la costituzione del 1964.
I Taliban, che presero il potere nel 1996 ponendo fine alla guerra civile
seguita alla cacciata dei russi, crearono uno Stato teocratico, nel quale non c'era
posto per istituzioni secolari. Diffusero in tutto il paese una rete di corti in cui si
applicava la Sharia, penetrando nella struttura sociale dei villaggi, imponendo
un ethos particolarmente rigoroso per la popolazione maschile, e assumendo una
visione alquanto restrittiva del ruolo sociale delle donne2.
Dopo gli sconvolgimenti avvenuti nel paese in seguito agli attacchi dell' 1 1
settembre 2001, la costituzione del 2004 ha creato, formalmente, un moderno
Stato islamico, con una struttura tripartita, costituita da un governo centrale con
un esteso potere di normazione, un organo propriamente legislativo a struttura
bicamerale e una magistratura indipendente. Nondimeno, una caratteristica
dell'Afghanistan di oggi è la coesistenza di due distinti sistemi giudiziari, quello
formale, rappresentato da organi dello Stato, e quello informale, basato su leggi
e consuetudini tribali.
Questo dualismo nasce dal localismo che ha saputo resistere a tutti i tentati-
vi di cambiamento. Dipende altresì dalla portata limitata dell'autorità dello Stato
nelle zone rurali, che è una caratteristica dell'Afghanistan risalente alla sua stes-
sa nascita come Stato indipendente nel 1747, sotto la guida di Ahmed Shah
1 Ahmed Rashid, Taliban. Islam, oil and the New Great Game in Central Asia, New Haven, Yale University Press, 2000.
Peter Hopkirk, Il Grande gioco, Milano, Adelphi, 2010.
2 Barnett R. Rubin, The fragmentation of Afghanistan. State formation and collapse in the international system, Oxford,
Oxford University Press, 2002, p. XV.
81
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
FEDERICO SPEROTTO
Durrani. Vi sono dunque terre remote, dove nessun governo afgano è stato in
grado di imporre la sua legge.
La società afgana è tribale nel senso che gli accordi interpersonali prevalgo-
no sulla regolamentazione giuridica. La vulgata vuole che ciò abbia permesso
all'Afghanistan di non precipitare nel caos durante le numerose guerre che lo
hanno attraversato, di resistervi grazie alla flessibilità del governo locale fornita
dalle strutture tradizionali come le s hura e le jirga , cui è spettato, tra l'altro, il
compito di punire i crimini e pacificare le dispute tra le famiglie. In termini con-
creti, in Afghanistan, dove vivono almeno 14 diversi gruppi etnici, le pratiche
locali hanno una rilevanza tutta particolare3, specie considerando che non esiste
una interpretazione uniforme della legge islamica, ma un vasto conglomerato di
leggi e precetti, manipolati dagli studiosi del diritto e fortemente adattati al con-
testo socio-economico.
Il sistema di giustizia ufficiale è relativamente forte nei centri urbani, ma
debole nelle aree rurali, dove vive oltre il 72% della popolazione. Qui il sistema
tradizionale di regolamentazione delle dispute, farhang , e la sua versione più
rigorosa, pashtunwali , è il più usato nella soluzione delle controversie di tutti i
giorni4. È da tenere presente che si non si tratta di un'esclusiva pashtun, nel senso
che gli abitanti del Baluchistan, un'etnia che condivide con i pasthun l'area di
Quetta, in Pakistan, al confine meridionale con l'Afghanistan, usano distinguersi
dai pashtun richiamandosi al modo di vita baluchi , il razm-e-baluch5.
Il pashtunvali rappresenta il diritto consuetudinario. Emerge dai diktat di
élites patriarcali, e include processi e rimedi per la violenza e i gravi abusi contro
i diritti individuali6. A parte le zone nelle quali i Taliban, riemersi progressiva-
mente dopo essersi mimetizzati per sfuggire alle operazioni americane del 2001,
mantengono una presenza significativa, dove corti islamiche somministrano la
più intransigente versione della Shari'a - e dove il taglio delle dita, le percosse,
ma anche l'impiccagione e la decapitazione, sono comuni -, nelle aree rurali sono
jirga e shura , e le decisioni degli anziani, il mezzo primario per la soluzione di
casi penalmente rilevanti e per la gestione delle dispute di diritto civile.
Le regole tradizionali sono ritenute costituire un sistema di giustizia popola-
re in grado di risolvere le dispute e i conflitti locali in modo spedito e a costo zero.
Di certo, questi strumenti di giustizia tradizionale sono altamente lesivi dei dirit-
ti delle donne7.
Una società tribale
Il tradizionalismo e il localismo in Afghanistan sono stati favoriti dalla
morfologia della regione. L'Afghanistan è diviso in due parti da una monumen-
3 Carol Mann, The law's the problem in Afghanistan, «The Guardian», Saturday 26 December 2009.
4 Ali Wardak, "Jirga: power and traditional conflict resolution in Afghanistan", in John Strawson (eds.), Law after
Ground Zero , Sydney, Portland, Glasshouse Press, 2002, p. 189.
5 Ugo Fabietti, Culture in bilico. Antropologia del Medio Oriente, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 205.
6 Mark A. Drumbl, Atrocity, punishment, and international law, New York, Cambridge University Press, 2007, p. 192.
7 Mohammad Hašim KamãlT, Law in Afghanistan : a sudy of the Constitutions, matrimonial law and the judiciary,
Leiden, Brill, 1985, p. 4.
82
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
I diritti delle donne in Afghanistan
tale catena montuosa, 1' Hindu Kush, che si estende lungo la direttrice Nord-Est
Sud-Ovest. Le pendici dell' Hindu Kush sono caratterizzate da spettacolari e spes-
so impervie valli, che sono poi le sole zone coltivabili. Il resto del paese è fatto di
lande semi-desertiche. Parte di queste, se propriamente irrigate, permettono una
modesta coltura di sussistenza.
In termini politici e sociali, il relativo isolamento delle comunità ha favorito
una società che si articola a partire dai vincoli patriarcali, e mentre a Kabul un
certo senso di cosmopolitismo ha rappresentato la spinta verso la modernizzazio-
ne, le aree rurali non hanno registrato alcun mutamento strutturale. La famiglia è
l'unità minima, e dipende completamente dal maschio più anziano. È inserita in
un contesto più ampio, basato sul legame etnico, il clan, o qawm , per poi conver-
gere all'interno di una tribù. Le strutture di potere nei villaggi e nei distretti sono
costituite da notabili. Il legame fiduciario personale è alla base di tutte le relazio-
ni. Le strutture patriarcali si combinano con una sorta di feudalesimo tribale, nel
quale i matrimoni sono alleanze e le donne sono considerate allo stesso tempo
beni materiali e ricettacoli dell'onore dei maschi8.
II pashtunwali
L'Afghanistan è la terra dei pashtun. La popolazione che parla il pashto
assomma a una quota compresa tra il 42 e il 55% della popolazione complessi-
va9. L'intero gruppo etnico avrebbe un solo comune progenitore, Qais 'Abd Al-
Rashid10. Gli adulti si differenziano all'interno dell'etnia per discendenza patrili-
neare.
La rivalità, anche tra cugini, tarburwali11 , è molto marcata. In ass
Stato moderno, in senso post-westfaliano o weberiano, le faide rap
principale veicolo della giustizia. Il pashtunwali può essere visto co
per evitare le faide e lo spargimento di sangue.
Le tribù pashtun si dividono in nang pashtun e qalang pashtun. La d
za è determinata dalla morfologia della terra che la tribù occupa. Qalan
to agli abitanti delle pianure, e riflette un tipo di società basata sulla r
pagamento di affitti, rendite o tasse. Nang è riferito alle tribù che viv
montuose, e riguarda una società più egualitaria, nella quale i masc
pari, liberi ed eguali12. Questo egualitarismo tribale si esprime in un e
terno della tribù e fra le tribù. La condizione paritaria è una condi
sociale. Livelli sbilanciati di benessere tra i membri delle tribù nan
8 David B. Edwards, Heroes of the age: moral fault lines on the Afghan frontier , Berkeley, University
1990, p. 75.
9 Oggi sono i Tajiki, nerbo dell'Alleanza del Nord, ad esprimere Y élite politica. Selig S. Harrison, Afghanistan 's tyranny
of the minority, «The New York Times», August 17, 2009. Il 10 ottobre 1996 i capi tribali, eroi della jihad anti-sovie-
tica, Dostum, Massoud, Rabbani e Khalili si incontrarono per fondare, in funzione anti-Taliban, la Jahba-i Muttahed-
e Is lami Milli bara-i Nejat-e Afghanistan, vale a dire il Fronte islamico nazionale unito per la salvezza
dell'Afghanistan, meglio conosciuto come Alleanza del Nord. William Maley, The Afghanistan wars, New York,
Palgrave, 2002, p. 229.
10 Hugh Beattie, Imperial frontier. Tribe and State in Waziristan, Richmond, Curzon, 2002, p. 4.
" Edwards, Heroes of the age: moral fault lines on the Afghan frontier , cit., p. 64.
12 Rubin, Op. cit., p. 28.
83
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
FEDERICO SPEROTTO
infatti le condizioni per una trasformazione in qalang, ma innescano rivalità san-
guinose e faide che hanno effetto dirompente sull'intero tessuto sociale.
Il pashtunwali è un elemento costitutivo della società tribale, che è costruita
sull'idea di autodeterminazione ( ghayrat ), sull'onore e sulla vendetta per ogni
diminuzione sociale subita13. Altri attributi sono il rispetto per l'autorità degli
anziani, il coraggio in combattimento, e una visione campanilistica del mondo
esterno alla tribù.
Non esistono istituzioni, ma solo uomini potenti. Ogni villaggio si autogo-
verna. Gli individui moderano i loro comportamenti attraverso l'influsso della
tradizione e la minaccia della faida. Ciascuna disputa, anche minima, scatena una
sorta di guerra privata, combattuta da un clan contro l'altro.
Il pashtunwali è lo scrigno che contiene l'identità collettiva dei pashtun. Ë
allo stesso modo un codice e un'ideologia14. Il senso di appartenenza dei pashtun
è complesso e sfaccettato. A dispetto della profonda adesione degli afgani
all'islam, le tradizioni tribali sono resistite e hanno tenuto testa alle pratiche volu-
te dalla legge religiosa in vaste aree della cosiddetta cintura pashtun, lungo la
frontiera con il Pakistan. Singolarmente, più questo stile di vita è messo in discus-
sione da condizionamenti esterni, più si rafforza.
I pashtun si sentono profondamente osservanti, anche quando applicano le
regole del pashtunwali , che vedono come estrinsecazione in senso tradizionale
della SharVa 15. Tuttavia, il pashtunwali non ha quell'intento ecumenico che è
alla base della SharVa , che detta le regole alla umma intera, ed è libero da con-
siderazioni di tipo etnico. Il pashtunwali non è per nulla permeato da un afflat-
to ecumenico, è strettamente legato a considerazioni etniche, ed è per natura non
inclusivo e riservato alle genti pashtun. C'è anche da notare che il Corano, lad-
dove impone l'obbedienza al sovrano, si pone in contrasto con il tribalismo dei
pashtun.
Una vita onorevole
Aderendo alle prescrizioni del pashtunwali , l'uomo pashtun possiede onore.
L'onore è il pilastro della società tradizionale afgana. Il pashtunwali è il modello
da seguire per condurre una vita onorata. Serve come sistema di attenuazione del-
l'intensità della rivalità, sostituendo il sangue con il denaro. Piuttosto che mezzo
per perseguire un ideale di giustizia, è considerato permettere una efficace riso-
luzione delle dispute che soddisfi le parti e soprattutto elimini ulteriori conflitti.
Propone un approccio ristorativo agli abusi.
Gli elementi strutturali del pashtunwali sono i concetti di coraggio ( nang ),
vendetta (badai), ospitalità (melmastia), barriere di genere {purdah e namus) e
assemblea tribale (jirga) 16.
13 Christine Noelle-Karimi, State and tribe in nineteenth-century Afghanistan, Richmond, Routledge, 1997, p. 152.
14 Oliver Roy, Islam and resistance in Afghanistan , Cambodge, Cambridge University Press, 1986, p. 12.
15 Asta Olesen, Islam and politics in Afghanistan , Richmond, Curzon, 1992, p. 33.
16 Victoria Schofìeld, Afghan frontier: feuding and fighting in Central Asia, London, Tauris Parke, 2008, p. 116.
84
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
I diritti delle donne in Afghanistan
La norma posta a difesa dell'onore è badai , la vendetta, che è la sanzione
tipica di una società a potere diffuso come quella dei pashtun. Melmastia , l'ospi-
talità, include il fornire cibo agli ospiti e agli amici, nella guest-house che tutte le
famiglie benestanti possiedono. L'ospite è protetto e i suoi nemici respinti, fin-
tanto che rimane nella casa. In cambio gli viene chiesto di combattere le battaglie
di colui che lo ospita.
Nella casa, lo spazio riservato agli ospiti, che è la parte pubblica della dimo-
ra, è chiamato melmastum. Tale spazio può essere equiparato dWandron, cioè la
sala da pranzo per soli maschi usata nell'antica Grecia per socializzare, che era
completamente separata dai quartieri riservati alle donne, detti gynaikeion11 .
Melmastum è uno spazio di incontri come anche lo spazio dove occasionalmente
si riunisce una jirga.
Le violazioni della santità della casa (qala) sono causa di perdita di onore,
specialmente quando consistono in intrusioni nelle parti più interne, riservate ai
membri della famiglia di sesso femminile.
Questioni di diritto penale
Il diritto penale ufficiale, nell'Afghanistan di oggi, è modellato secondo
principi occidentali, ma prevede punizioni di diritto islamico18. Come le altre
grandi religioni monoteistiche, l'islam è fortemente legato al principio della
dignità umana, e si fonda sulla compassione e sul perdono. Principi che dovreb-
bero porre una barriera contro le crudeltà. Nondimeno quei principi non sono suf-
ficienti ad impedire ad alcuni di interpretare le norme della SharVa nel loro più
crudele letterale rigore, e di sostenere una visione estrema di giustizia divina
dispensata dagli uomini.
Nel momento attuale, in Afghanistan, il sistema giudiziario statale si occupa
di questioni criminali legate all'insorgenza e alla sicurezza dello Stato. Nelle altre
questioni di diritto penale riguardanti la violazione di diritti individuali, così
come nelle dispute riguardanti la terra, la famiglia e il diritto civile, la vigenza del
pashtunwali continua ad impedire alla giustizia di Stato di occuparsene. Il coin-
volgimento di un giudice alieno alle parti è considerata un'intrusione dello Stato
nella sfera dell'onore personale, ed un fallimento, dal momento che l'intervento
del giudice indica che le parti non sono in grado di confrontarsi direttamente con
le loro forze e di difendere il loro onore.
Come in altre società a potere diffuso, la risposta ad un delitto dovrà essere
una rappresaglia o una vendetta di sangue, ed è sempre affidata al gruppo19. Il
diritto consuetudinario permette alla famiglia di farsi giustizia con le proprie
mani, ma lascia ampio spazio anche alla negoziazione tra i gruppl. L'onore è
17 Sue Blundell, Women in Ancient Greece , Cambridge, Harvard University Press, 1995, p. 139.
18 Le sanzioni differiscono in base alla categoria dei crimini, secondo una tripartizione: hudüd (plurale di hadd, il limite
voluto da Dio) comprende sanzioni ben precise, riferite ai delitti di apostasia, rivolta, furto, rapina, adulterio, bere alcol;
con Ta'azir, la punizione decisa discrezionalmente dal giudice, sono puniti tutti i comportamenti dannosi che non
hanno precisa sanzione; Qisãs è la legge del taglione, per i casi di omicidio e lesioni personali.
19 Rodolfo Sacco, Antropologia giuridica, Bologna, il Mulino, 2007, p. 317.
85
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
FEDERICO SPEROTTO
ristabilito così dalla vendetta o da una procedura detta nanawati, con la quale alla
faida si sostituisce la consegna di beni, denaro o fanciulle.
Quando vi è una violazione del namus , che si compone di zan, zar, zamin20,
vale a dire di donne, oro e terra, il maschio si deve vendicare. In questo modello
di giustizia ristorativa, un comportamento privato come la vendetta è un istituto
di diritto pubblico, dal momento che la sua minaccia preserva la pace sociale
limitando il diffondersi del conflitto. Badaly la vendetta, è considerata un potente
deterrente, poiché incorrervi equivale a diventare un bersaglio per l'intero clan
dell'offeso.
In caso di assassinio, la jirga potrà raccomandare badal , o in alternativa la
consegna di beni e denaro. L'omicidio potrà essere dunque punito con la morte
del reo, con la consegna di beni e animali alla famiglia dell'ucciso, o, in casi
estremi, con la consegna di una giovane donna, previa concessione del perdono
da parte della famiglia che ha subito il lutto.
Nanawati , che sta per richiesta di perdono o di cessazione delle ostilità, è una
procedura complessa. La richiesta indirizzata alla famiglia della vittima è tra-
smessa da una delegazione, che include alcune donne che recano copie del
Corano, e una pecora o una capra, che viene sgozzata sulla soglia della casa della
vittima. Se accettato, il nanawati rimuove ogni residuo di inimicizia21.
Poar , la dazione di beni e denaro, è usata per impedire il sorgere di faide che
possono perpetuarsi per generazioni22. L'ammontare del poar è determinato dalla
jirga. In accordo con le nerkhs , precedenti decisioni, esistono diversi ammontare
per diversi torti.
I diritti delle donne
Le disposizioni del pashtunwali concernenti la responsabilità per atti di natu-
ra criminale e violazioni di quelli che nell'idea occidentale sono diritti umani
incorporano la soggiogazione delle donne. Includono il trasferimento forzato di
ragazze - in alcuni casi anche di sei o sette anni d'età - e negano alle donne i dirit-
ti di possedere beni, di essere proprietarie e di ereditare, a dispetto della legge
islamica, che prevede che la donna erediti la metà di quanto posseduto dal mari-
to. Può accadere che due o più donne siano date in compensazione per l'omicidio
o il ferimento di un maschio.
V Afghanistan Human Development Report per il 2007 (Bridging modernity
and tradition )23 considera i due sistemi di giustizia, quello formale e quello infor-
male, come politiche alternative per il rafforzamento, in Afghanistan, del gover-
no della legge (o regime di legalità, rule of law). Il rapporto riferisce di un siste-
20 Rubin, Op. cit., p. 378.
20 David B. Edwards, Before Taliban. Genealogies of the Afghan Jihad , Berkeley, University of California Press, 2002,
p. 140.
21 Nadjma Yassari, The Sharf'a in the Constitutions of Afghanistan, Iran, and Egypt: implications for private law,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, p. 51.
21 The 2007 Afghanistan Human Development Report: Bridging modernity and tradition, http://origin-hdr.undp.org/en/
reports/nationalreports/asiathepacific/afghanistan/name.3408.en.html.
86
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
I diritti delle donne in Afghanistan
ma di giustizia informale per la risoluzione pacifica delle controversie analogo a
quello rappresentato in Occidente dall'arbitrato e dalla mediazione. Di fatto, quel
sistema informale evita gli ostacoli che in Occidente sono conosciuti come giu-
sto processo. Da una prospettiva di genere, le donne sono in ultima analisi la parte
soccombente.
Il rapporto finisce poi per riconoscere il difetto intollerabile della giustizia
tradizionale, e cioè che le decisioni della jirga possono essere estremamente noci-
ve per donne e ragazze. Fa l'esempio della jirga che può - e occasionalmente lo
fa - raccomandare baad , una pratica che viola le leggi afgane, i principi islamici
della SharVa , e i diritti umani, per finire dicendo che baad e l'incendio della casa
dell'assassino sono comunque soluzioni che non vengono adottate spesso24.
Baad è il modo in cui una giovane donna viene forzata a sopportare la colpa
di altri (maschi). In alternativa al baad , sarebbe possibile dare al patriarca una
forte somma, walwar25. Tuttavia, la dazione di una o più ragazze per pacificare
una faida appare più conveniente. Presenta un doppio vantaggio: per la famiglia
della vittima, che risparmia il costo proibitivo di una sposa26, e per la comunità,
dal momento che viene così sanata una divisione tra famiglie creata dal crimine27.
Com'è evidente, si tratta di un elemento cardine della politica tribale.
Le strutture patriarcali hanno interesse a mantenere le donne allo stato di
beni materiali. La legge denominata Evaw, The elimination of violence against
women (Evaw) law , promulgata nel 2009, criminalizza la violenza contro le
donne, inclusi lo stupro, le percosse e la violenza domestica (molto diffusa) e il
matrimonio forzato per le bambine. Durante la storia dell'Afghanistan, la tradi-
zionale forma di sessismo intrinseca nella società è stata messa in discussione
almeno in due altre occasioni. Negli anni Venti del secolo trascorso, sotto re Amir
Amanullah, distintosi per un atteggiamento di apertura egualitaria nei confronti
delle donne, e nel 1978, quando Amin, primo ministro di Daud, emanò il cosid-
detto Decree No. 7, il cui scopo era dichiaratamente la rimozione delle ingiuste
relazioni patriarcali e feudali tra moglie e marito. Il decreto proibiva il matrimo-
nio con ragazze minori di 16 anni, e si inquadrava nel generale sforzo di rinno-
vamento della società afgana promosso dai consiglieri sovietici.
Nel 1996, i Taliban hanno introdotto una rigorosa forma di apartheid di
genere, proibendo alle donne di lavorare fuori casa e di andare a scuola, di usci-
re senza essere accompagnate da un maschio adulto della famiglia, e forzandole
a vestire il burqa.
Oggi, in tempi di diffuso gender main-streaming , in Afghanistan il sessismo
rimane ampiamente diffuso e non limitato ai pashtun, nel senso che si presenta
24 Idem, p. 97.
25 Irene Schneider, Recent developments in Afghan family law: research aspects , «Asien», 2007, 104, 106-1 18, p. 111.
26 Hašim Kamäll ha scritto nel 1985 che «In Afghanistan, a man may acquire a wife in any one of the following four ways:
he may inherit a widow, gain a bride in exchange marriage, gain a bride as compensation for a crime of which he or
his relatives were the victim, or pay a bride price». KamâlT, Op. cit., p. 84.
27 Sarah Chayes, The punishment of virtue, New York, Penguin Books, 2006, p. 35.
87
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
FEDERICO SPEROTTO
pressoché ovunque, ma con diversi gradi di intensità. Quello dei pashtun è più
intransigente28.
Le donne sono categoricamente inferiori, ma allo stesso modo sono deposi-
tarie dell'onore dei maschi29. L'onore richiede la segregazione delle donne, pur-
dah, che è confino in spazi riservati alle donne ma anche hijab , obbligo di vesti-
re il velo. Il purdah influenza anche il comportamento dei maschi, dal momento
che è loro vietato accedere agli spazi riservati alle donne. La vita ritirata e il
coprirsi in pubblico può ben essere considerato un modo per le donne di manife-
stare la loro devozione religiosa. Per i maschi la segregazione può essere un modo
per proteggere la famiglia. Comunque sia, il purdah , nella sua forma rigorosa,
impedisce alle donne anche l'istruzione di base e le cure mediche30.
La costituzione afgana prescrive che ogni sorta di discriminazione sia proi-
bita, avendo i cittadini afgani, donne e uomini, eguali diritti. All'articolo 7 pro-
clama la vigenza della convenzione per l'eliminazione della discriminazione con-
tro le donne (Cedaw, ratificata nel 2003 senza alcuna riserva). Nel suo articolo 3
la costituzione medesima dichiara che nessuna legge in Afghanistan può essere in
contrasto con il credo e i precetti della sacra religione dell'islam. Da una parte,
una simile disposizione pone nel nulla qualsiasi regola consuetudinaria che con-
trasti con l'islam, favorendo i diritti delle donne. D'altro canto, c'è sempre
incombente il rischio di una interpretazione radicale della legge islamica. È bene
ricordare che mentre effettivamente i Taliban misero a tacere numerose regole tri-
bali, la loro interpretazione e manipolazione della SharVa ha causato alle donne
afgane un detrimento ancora peggiore delle pratiche legate al pashtunwali.
Conclusione
Il pashtunwali è un'immagine piuttosto fedele della società tribale afgana,
che è egualitaria e basata sulle relazioni di parentela. In parte aiuta ad abbassare
i livelli di conflittualità e di prevenire le animosità, in una società caratterizzata
da un ethos marziale, definitivamente obsoleto ed altamente pericoloso, fondato
sull'onore e di conseguenza sulla vendetta. La sua funzione di barriera contro il
conflitto sociale e una forma di intollerabile sentimento di anarchia convive con
la sostanziale negazione di diritti di base, specialmente a detrimento della popo-
lazione femminile. Fintanto che rimane in vigore, le prospettive di miglioramen-
to della qualità della vita per un consistente numero di donne afgane rimangono
limitate.
28 Olesen, Op. cit., p. 137.
29 Huma Ahmed-Ghosh, A history of women in Afghanistan: lessons learnt for the future. Or yesterdays and tomorrow:
women in Afghanistan, in «Journal of International Women's Studies», 2003, 4 (3), p. 2.
M Jonathan Steele, Afghanistan: is it time to talk to the Taliban?, «The Guardian», 4 May 2010. Rod Nordland, Alissa J.
Rubin, Child brides escape marriage, but not lashes, «The New York Times», May 30, 2010.
88
RSPI 78:1, 2011
This content downloaded from
31.156.128.209 on Fri, 30 Jun 2023 09:52:54 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Potrebbero piacerti anche
- Enigma Multiculturale Baumann RiassuntoDocumento16 pagineEnigma Multiculturale Baumann RiassuntopianolysNessuna valutazione finora
- Chaos Magic - Teoria e Pratica Della Magia - Richard Reuss PDFDocumento36 pagineChaos Magic - Teoria e Pratica Della Magia - Richard Reuss PDFAlfredoNessuna valutazione finora
- Tesi:L'evoluzione Della Condizione Della DonnaDocumento122 pagineTesi:L'evoluzione Della Condizione Della Donnabatrix_8883% (6)
- Riassunto Diritto Pubblico Delle Religioni, ColaianniDocumento19 pagineRiassunto Diritto Pubblico Delle Religioni, ColaianniFrancescoGenualdoNessuna valutazione finora
- Claude Levi-Strauss - La Famiglia, 1956Documento32 pagineClaude Levi-Strauss - La Famiglia, 1956Cataldo Marino100% (1)
- L'Unione Africana e Il Suo Ruolo Per Il Mantenimento e Il Ristabilimento Della PaceDocumento111 pagineL'Unione Africana e Il Suo Ruolo Per Il Mantenimento e Il Ristabilimento Della PaceGuja LucheschiNessuna valutazione finora
- Mauro Martini PDFDocumento230 pagineMauro Martini PDFGIOVANNI NICCOLINessuna valutazione finora
- ANTROPOLOGIA POLITICA (CHIEFDOM E TRIBU) - Documenti GoogleDocumento3 pagineANTROPOLOGIA POLITICA (CHIEFDOM E TRIBU) - Documenti GoogleAle Todaro0% (1)
- Abenante Storia Dei Paesi AfroasiaticiDocumento95 pagineAbenante Storia Dei Paesi AfroasiaticindueNessuna valutazione finora
- Legalità e CostituzioneDocumento31 pagineLegalità e CostituzioneFrancesco MunafóNessuna valutazione finora
- Appunti Storia e Sistemi Dell'africa ContemporaneaDocumento73 pagineAppunti Storia e Sistemi Dell'africa Contemporaneagaroffolo24Nessuna valutazione finora
- Diritto Costituzionale Comparato Delle Minoranze Linguistic HeDocumento46 pagineDiritto Costituzionale Comparato Delle Minoranze Linguistic HeAlessandro SchillaciNessuna valutazione finora
- Le Peggiori Dittature Nel 2014Documento3 pagineLe Peggiori Dittature Nel 2014Anonymous SAuK4CNessuna valutazione finora
- LA DONNA-il Diritto Di ContareDocumento19 pagineLA DONNA-il Diritto Di Contarelorenzo centonzeNessuna valutazione finora
- Introfada (Hamja Ahsan (Ahsan, Hamja) )Documento156 pagineIntrofada (Hamja Ahsan (Ahsan, Hamja) )Wytze KNessuna valutazione finora
- Il Caso Attanasio Strategia Della Tensione in AfricaDocumento53 pagineIl Caso Attanasio Strategia Della Tensione in Africasanti91Nessuna valutazione finora
- Riassunto Antropologia PDFDocumento9 pagineRiassunto Antropologia PDFAlice BormoliniNessuna valutazione finora
- Sulle Regole TestidocDocumento5 pagineSulle Regole Testidocapi-255431727Nessuna valutazione finora
- La Condizione Della Donna Nel Mondo Boscolo GiuliaDocumento20 pagineLa Condizione Della Donna Nel Mondo Boscolo GiuliaesterNessuna valutazione finora
- Laboratorio Rojava: Confederalismo democratico, ecologia radicale e liberazione delle donne nella terra della rivoluzioneDa EverandLaboratorio Rojava: Confederalismo democratico, ecologia radicale e liberazione delle donne nella terra della rivoluzioneNessuna valutazione finora
- La Tutela Dei Minori Nella Legislazione PDFDocumento8 pagineLa Tutela Dei Minori Nella Legislazione PDFChiara VenutoNessuna valutazione finora
- LA DONNA-il Diritto Di ContareDocumento20 pagineLA DONNA-il Diritto Di Contarelorenzo centonzeNessuna valutazione finora
- Tesi Di Laurea TriennaleDocumento57 pagineTesi Di Laurea TriennaleChristine WeiseNessuna valutazione finora
- Capitolo 2Documento5 pagineCapitolo 2giulialaguardia16Nessuna valutazione finora
- Afghanistan en ItDocumento14 pagineAfghanistan en ItjessystepjagoNessuna valutazione finora
- Esercizi Da Consegnare AntropologiaDocumento10 pagineEsercizi Da Consegnare AntropologiaSharon LabbateNessuna valutazione finora
- Geostoria-La Nazione Arcobaleno e UbuntuDocumento2 pagineGeostoria-La Nazione Arcobaleno e UbuntuFabrizio DelcurtoNessuna valutazione finora
- Il Governo Mondiale EbraicoDocumento233 pagineIl Governo Mondiale Ebraicokantinmyself100% (1)
- ARCHIVIO ANTROPOLOGICO MEDITERRANEO Anno - XIIXIII - 2009-2010 - 12-2Documento126 pagineARCHIVIO ANTROPOLOGICO MEDITERRANEO Anno - XIIXIII - 2009-2010 - 12-2mangiacarrubeNessuna valutazione finora
- Faccetta Nera Bellabissina RappresentaziDocumento9 pagineFaccetta Nera Bellabissina RappresentaziViviana CalmasiniNessuna valutazione finora
- C Riassunto La Radio e Il Machete Il Ruolo Dei Media Nel Genocidio in RwandaDocumento10 pagineC Riassunto La Radio e Il Machete Il Ruolo Dei Media Nel Genocidio in RwandaBen DrameNessuna valutazione finora
- Il Percorso Di Una Società InterculturaleDocumento11 pagineIl Percorso Di Una Società InterculturaleFondazione Guido Piccini onlusNessuna valutazione finora
- Corpo Potere e MalattiaDocumento21 pagineCorpo Potere e MalattiaDeruxaNessuna valutazione finora
- Tesina Di Antropologia Apartheid Un Grave Caso Di Discriminazione Razziale in Sud-Africa. Breve Storia.Documento8 pagineTesina Di Antropologia Apartheid Un Grave Caso Di Discriminazione Razziale in Sud-Africa. Breve Storia.pierpaolo soroNessuna valutazione finora
- Le Risorse e Il PotereDocumento3 pagineLe Risorse e Il PotereciroNessuna valutazione finora
- Kymlicka, La Cittadinanza MulticulturaleDocumento8 pagineKymlicka, La Cittadinanza MulticulturaleIlaria D'ArcangeloNessuna valutazione finora
- Contempo 2Documento18 pagineContempo 2Raymart M. YgoniaNessuna valutazione finora
- A. Ocalan - Confederalismo Democratico (Ebook)Documento14 pagineA. Ocalan - Confederalismo Democratico (Ebook)Bazarov72Nessuna valutazione finora
- Brooooo Di ItalianoDocumento2 pagineBrooooo Di ItalianoDaudNessuna valutazione finora
- Storia Ed Istituzioni Dei Paesi AfroasiaticiDocumento48 pagineStoria Ed Istituzioni Dei Paesi AfroasiaticiFederico FaleschiniNessuna valutazione finora
- Il Ruolo Della Donna Nella Società Nel Passato e Nel PresenteDocumento1 paginaIl Ruolo Della Donna Nella Società Nel Passato e Nel Presenterox bNessuna valutazione finora
- Ocalan 3 LaRivoluzioneDelleDonne DefDocumento56 pagineOcalan 3 LaRivoluzioneDelleDonne DefmariaelenacuguNessuna valutazione finora
- I due Imperi: Epiche battaglie ed avventure mozzafiato in un eroico scontro di Civiltà.Da EverandI due Imperi: Epiche battaglie ed avventure mozzafiato in un eroico scontro di Civiltà.Nessuna valutazione finora
- Lezione Sui NUERDocumento35 pagineLezione Sui NUERSara RevelliNessuna valutazione finora
- Evelgasparini 2Documento282 pagineEvelgasparini 2antoniopesceNessuna valutazione finora
- Qual È La Storia Del Continente Asiatico?: Che Cosa Significa?Documento9 pagineQual È La Storia Del Continente Asiatico?: Che Cosa Significa?solounaparolaNessuna valutazione finora
- Corpo Potere e MalattiaDocumento13 pagineCorpo Potere e MalattiaElisa CorsiNessuna valutazione finora
- Zomia, ScottDocumento4 pagineZomia, ScottMarco GreppiNessuna valutazione finora
- Ferrari Introduzione Al Diritto Comparato Delle ReligioniDocumento9 pagineFerrari Introduzione Al Diritto Comparato Delle Religionifedet92Nessuna valutazione finora
- Dichiarazione per una fratellanza universaleDa EverandDichiarazione per una fratellanza universaleNessuna valutazione finora
- Casate e Politica Nell'iraq Post-SaddamDocumento13 pagineCasate e Politica Nell'iraq Post-SaddamRaffaele MaurielloNessuna valutazione finora
- Parisoli ArborDocumento12 pagineParisoli ArborLuca ParisoliNessuna valutazione finora
- Antropologia CulturaleDocumento25 pagineAntropologia Culturalesofiaananni3Nessuna valutazione finora
- Regno 103 Int Mena LopezDocumento3 pagineRegno 103 Int Mena Lopezmaurocrema13Nessuna valutazione finora
- 68: Moventi, speranze, sogni ed effetti del Sessantotto in ItaliaDa Everand68: Moventi, speranze, sogni ed effetti del Sessantotto in ItaliaNessuna valutazione finora
- Le Condizioni Delle Donne IslamicheDocumento2 pagineLe Condizioni Delle Donne IslamicheChiara ImperatoNessuna valutazione finora
- Il Cammino Delle DonneDocumento16 pagineIl Cammino Delle Donneantoniott2005Nessuna valutazione finora
- Riassunti - Lingue e SpaziDocumento46 pagineRiassunti - Lingue e SpaziChiara Grasso100% (2)
- Riassunto Libro Sociologia Generale Capitoli 6 7 8 9 10 11 12 13Documento36 pagineRiassunto Libro Sociologia Generale Capitoli 6 7 8 9 10 11 12 13Edoardo CutiniNessuna valutazione finora
- Lezione Storia Della CosmesiDocumento5 pagineLezione Storia Della CosmesiMatteo TanziNessuna valutazione finora
- Borges La Ricerca Di AverroeDocumento10 pagineBorges La Ricerca Di AverroeDaria SesinaNessuna valutazione finora
- Il Cremasco 230313Documento36 pagineIl Cremasco 230313promedia3Nessuna valutazione finora
- Anello NibelunghiDocumento26 pagineAnello NibelunghiMariella GiorginiNessuna valutazione finora
- Storia e Civiltà Del GiapponeDocumento37 pagineStoria e Civiltà Del GiapponeDiana PalmaNessuna valutazione finora
- La Tradizione Dei CenacoliDocumento130 pagineLa Tradizione Dei CenacoliMarco PioppoNessuna valutazione finora
- Viaggiare MedioevoDocumento4 pagineViaggiare MedioevoION GĂNGUȚNessuna valutazione finora