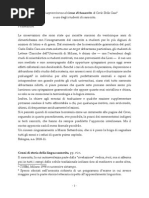Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
272 visualizzazioni11 pagineOratio Numerosa
Il documento riassume i concetti chiave della teoria della prosa ritmica discussi da Cicerone nel suo trattato Orator. Cicerone descrive i piedi metrici che possono essere utilizzati nella prosa ritmica, come il cretico, il dicretico e il trocheo. Discute anche le sostituzioni irrazionali di questi piedi e fornisce esempi tratti dalle sue opere.
Caricato da
DaliaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
272 visualizzazioni11 pagineOratio Numerosa
Il documento riassume i concetti chiave della teoria della prosa ritmica discussi da Cicerone nel suo trattato Orator. Cicerone descrive i piedi metrici che possono essere utilizzati nella prosa ritmica, come il cretico, il dicretico e il trocheo. Discute anche le sostituzioni irrazionali di questi piedi e fornisce esempi tratti dalle sue opere.
Caricato da
DaliaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd