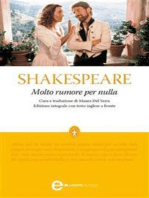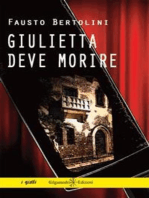Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Teatro Di Pirandello
Caricato da
A GioTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Teatro Di Pirandello
Caricato da
A GioCopyright:
Formati disponibili
IL TEATRO DI PIRANDELLO
La grande fama di Pirandello, anche fuori d’Italia, si deve soprattutto alla sua opera teatrale, a cui
si dedica essenzialmente dal 1916 in poi e che da quel momento assorbirà la maggior parte delle
sue energie creative.
I temi che mette in scena anche nel suo teatro sono gli stessi testimoniati dalla produzione
narrativa, e in particolare dal “campionario” di casi umani offerto dalle novelle: la scoperta delle
crisi dell’uomo moderno, la scomposizione del soggetto in parti relative e provvisorie.
Il teatro di Pirandello prende le mosse dalla stessa poetica umoristica che presiede all’universo
narrativo: il titolo di “MASCHERE NUDE” allude proprio alla funzione di “svelamento umoristico”
delle parti, delle maschere che lo scrittore assegna al suo teatro e che ne costituisce la cifra
distintiva e innovativa.
Tra i testi più noti ricordiamo “PENSACI GIACOMINO”, “LA GIARA”, “LA PATENTE”, “L’UOMO
DAL FIORE IN BOCCA”, “IL GIOCO DELLE PARTI”; le ultime tre sono tratte direttamente da
novelle.
È un teatro che approda con profonda amarezza alla dimensione grottesca e surreale.
IL METATEATRO
(il teatro nel teatro)
“Un teatro d’avanguardia”
“Sei personaggi in cerca d’autore” – 1921
“Ciascuno a suo modo” – 1924
“Questa sera si recita a soggetto” – 1930
Lo spettatore si trova davanti a uno “spettacolo nello spettacolo”: il sipario non si apre sul
tradizionale scenario di un interno borghese ma sul palcoscenico stesso, in cui una compagnia sa
preparando una recita nella quale se ne inserisce un’altra.
Ma l’aspetto più interessante investe la sfera concettuale, perché in questi testi il soggetto teatrale
è infatti occasione per un dibattito polemico sul teatro e le sue funzioni (la vita è già una recita ma il
teatro, in quanto recita di una recita, si dissolve in una impossibilità di fondo anche se più vera).
“SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE” – 1921 TEATRO VALLE DI ROMA
Il dramma si apre su un palcoscenico vuoto dove una compagnia sta provando un’opera di
Pirandello “il gioco delle parti”. Ad un certo punto un usciere annuncia al capocomico, che è anche
il regista, che un gruppo di persone chiede di parlargli. Si tratta di sei personaggi, designati con il
nome relativo al ruolo che avrebbe dovuto rappresentare in un’opera non completata. Chiedono
che la loro storia sia portata in scena e il capocomico alla fine accetta. I personaggi sono; il padre,
la madre, il figlio, la figliastra, il giovinetto, la bambina. Il figlio è nato dal matrimonio tra il padre e la
madre, gli altri tre da una unione adulterina della madre, che è stata spinta dal padre a formarsi
una nuova famiglia con il suo amante. Morto questo, la figliastra è costretta a prostituirsi in una
equivoca sartoria, gestita da Madame Pace, dove lavora come sarta anche la madre. Ed è proprio
la madre ad impedire che il padre possa avere un incontro con la figliastra.
La scena rappresentata parte proprio da quest’ultimo episodio ma i sei personaggi ad un certo
punto si ribellano perché non si sentono ben rappresentati dagli attori e vogliono farlo
personalmente.
L’ultima parte è ambientata nel giardino della casa del padre, dove la famiglia si è riunita ma la
tragedia non è finita: la bambina annega nella vasca e il figlioletto si spara uccidendosi. Accorre la
madre con un grido straziante. Sulla scena si crea una drammatica confusione; non si sa se il
ragazzo è davvero morto o se si tratta di finzione scenica. Alla fine il capocomico grida: “luce, luce,
luce” e invita tutti ad andarsene.
Sullo sfondo appariranno le ombre dei personaggi (tranne quelle dei due morti).
La figliastra con una risata scenderà tra il pubblico e correrà fuori dal teatro.
Potrebbero piacerti anche
- Recensio: Stagioni di Prosa e di Lirica del Teatro Comunale di FerraraDa EverandRecensio: Stagioni di Prosa e di Lirica del Teatro Comunale di FerraraNessuna valutazione finora
- Sei PersonaggiDocumento3 pagineSei PersonaggiNoemi Di MonteNessuna valutazione finora
- Sogno di Una Notte di Mezza Estate: Versione di BedrettinDa EverandSogno di Una Notte di Mezza Estate: Versione di BedrettinNessuna valutazione finora
- Dalla Novella Alla Pièce MetateatralitàDocumento22 pagineDalla Novella Alla Pièce MetateatralitàElena ValigiNessuna valutazione finora
- Pirandello e Castri inDocumento3 paginePirandello e Castri inGaia AmmaturoNessuna valutazione finora
- Pirandello. Vita, Opere e Pensiero - InstapaperDocumento16 paginePirandello. Vita, Opere e Pensiero - InstapaperMaria Elisa Ferraro100% (1)
- Le Origini Del Teatro ModernoDocumento5 pagineLe Origini Del Teatro ModernoBiancaNessuna valutazione finora
- Sei personaggi in cerca d'autore - Questa sera si recita a soggetto - Ciascuno a suo modoDa EverandSei personaggi in cerca d'autore - Questa sera si recita a soggetto - Ciascuno a suo modoNessuna valutazione finora
- Teatro PirandellianoDocumento13 pagineTeatro PirandellianoGiuseppe Prete100% (1)
- Pirandello Teatro 1 - 220627 - 111415Documento12 paginePirandello Teatro 1 - 220627 - 111415Emanuele IzzoNessuna valutazione finora
- Luigi PirandelloDocumento9 pagineLuigi PirandelloMartina RizzardoNessuna valutazione finora
- 5 Monologhi TeatraliDocumento2 pagine5 Monologhi TeatraliFRANCESCO CASELLANessuna valutazione finora
- Nodo Alla GolaDocumento2 pagineNodo Alla GolaFilippo Salaris IolaoNessuna valutazione finora
- Il Mondo Tra Realtà e FinzioneDocumento31 pagineIl Mondo Tra Realtà e FinzioneAndrea MalpezziNessuna valutazione finora
- Sei Personaggi in Cerca D'autoreDocumento1 paginaSei Personaggi in Cerca D'autoreMartina PrestiaNessuna valutazione finora
- Claudio Meldolesi Su de FilippoDocumento4 pagineClaudio Meldolesi Su de Filippocrux95Nessuna valutazione finora
- Era Licenziato Per Fare Il Viaggio Prima A Monaco Poi A ParigiDocumento1 paginaEra Licenziato Per Fare Il Viaggio Prima A Monaco Poi A ParigiAna SpNessuna valutazione finora
- CYRANO DE BERGERAC Foglio Di SalaDocumento5 pagineCYRANO DE BERGERAC Foglio Di SalaGiovanniNessuna valutazione finora
- Pirandello e Il Teatro - Questa Sera Si Recita A Soggetto VicentiniDocumento2 paginePirandello e Il Teatro - Questa Sera Si Recita A Soggetto VicentiniKataNessuna valutazione finora
- TURANDOT: La Genesi, Il Melodramma, La CriticaDocumento14 pagineTURANDOT: La Genesi, Il Melodramma, La CriticaStefano Bertora100% (1)
- PirandelloDocumento6 paginePirandellodesiree.misiti23Nessuna valutazione finora
- 14 - Il TritticoDocumento19 pagine14 - Il TritticoRahelaVlasaNessuna valutazione finora
- Pirandello e Il Relativismo - Mo - InstapaperDocumento44 paginePirandello e Il Relativismo - Mo - InstapaperAntonella La TorreNessuna valutazione finora
- Questa Sera Si Recita A Soggetto - OdtDocumento3 pagineQuesta Sera Si Recita A Soggetto - OdtManabilo FrancoNessuna valutazione finora
- Appunti e Collegamenti PirandellianiDocumento5 pagineAppunti e Collegamenti PirandellianiLeonardo MontagnaNessuna valutazione finora
- Luigi Pirandello È Considerato Uno Tra I Più Grandi Drammaturghi Del Ventesimo SecoloDocumento1 paginaLuigi Pirandello È Considerato Uno Tra I Più Grandi Drammaturghi Del Ventesimo SecoloMartina BaglioniNessuna valutazione finora
- Analisi Di Cleopatràs Di Giovanni TestoriDocumento7 pagineAnalisi Di Cleopatràs Di Giovanni TestoriRensavoNessuna valutazione finora
- Curriculum ScriptoriumDocumento12 pagineCurriculum Scriptoriumandrea salomonNessuna valutazione finora
- Elettra PDFDocumento14 pagineElettra PDFFiammettaNessuna valutazione finora
- Luigi PirandelloDocumento6 pagineLuigi PirandelloStellaNessuna valutazione finora
- Quando È Di Scena La FolliaDocumento9 pagineQuando È Di Scena La Folliagiacomorandazzo65Nessuna valutazione finora
- RiassuntoDocumento144 pagineRiassuntoGiorgiaLoretti100% (1)
- Puccini - Turandot - FeniceDocumento172 paginePuccini - Turandot - FenicegrboxNessuna valutazione finora
- 46 - Lucia Di Lammermoor PDFDocumento22 pagine46 - Lucia Di Lammermoor PDFAntonio GiontiNessuna valutazione finora
- Luigi PirandelloDocumento4 pagineLuigi PirandelloDonatella Di GiulioNessuna valutazione finora
- Così Fan TutteDocumento5 pagineCosì Fan TutteDomenico CameraNessuna valutazione finora
- Full Text of - Il Pipistrello Operetta Comica in Tre Atti. (Versione Dal Tedesco) Rappresentata La Prima Volta in Italia Nel Teatro Nuovo Di Napoli, Impresa Sadowsky, La Sera Di Sabato 26 Giugno 1875.Documento80 pagineFull Text of - Il Pipistrello Operetta Comica in Tre Atti. (Versione Dal Tedesco) Rappresentata La Prima Volta in Italia Nel Teatro Nuovo Di Napoli, Impresa Sadowsky, La Sera Di Sabato 26 Giugno 1875.Ermeneziano100% (1)
- ItalianoDocumento7 pagineItalianoMarta ValentiniNessuna valutazione finora
- GUIDA DIDATTICA - Il Barbiere A Spasso - ROC 2019Documento13 pagineGUIDA DIDATTICA - Il Barbiere A Spasso - ROC 2019Marypy De BNessuna valutazione finora
- Bartòk - Il Mandarino MiracolosoDocumento6 pagineBartòk - Il Mandarino MiracolosoAnonymous LbA4uvdANessuna valutazione finora
- Luigi PirandelloDocumento5 pagineLuigi PirandelloGiordano Dal BonNessuna valutazione finora
- Pirandello e Svevo AppuntiDocumento6 paginePirandello e Svevo AppuntiFlavio BanniNessuna valutazione finora
- Herry - Il Ventaglio PDFDocumento16 pagineHerry - Il Ventaglio PDFRaGnanaNessuna valutazione finora
- Prefazione A V Mejerchold Sul Teatro SCRDocumento16 paginePrefazione A V Mejerchold Sul Teatro SCRina_neckel1186Nessuna valutazione finora
- Assia Anniballi PDFDocumento4 pagineAssia Anniballi PDFAntonija BralićNessuna valutazione finora
- Rondine - PucciniDocumento154 pagineRondine - PucciniTecnico100% (1)
- Buchi Nella SabbiaDocumento260 pagineBuchi Nella SabbiaDonatella S.Nessuna valutazione finora
- Seconda Lezione Storia Del MusicalDocumento2 pagineSeconda Lezione Storia Del MusicalIlaria CossuNessuna valutazione finora
- William ShakespeareDocumento10 pagineWilliam Shakespeare5ara_bluesnowNessuna valutazione finora
- IonescoDocumento2 pagineIonescoirelorisNessuna valutazione finora
- 800Documento4 pagine800Ilaria GhirardelloNessuna valutazione finora
- Il Gioco Dell'amore e Del CasoDocumento5 pagineIl Gioco Dell'amore e Del CasoSilviaarosioteatroNessuna valutazione finora
- István Homolya - Il Mandarino Miracoloso (Hungaroton)Documento6 pagineIstván Homolya - Il Mandarino Miracoloso (Hungaroton)ju15loNessuna valutazione finora
- Le Eroine Dantesche Di Inferno e Purgatorio - A ConfrontoDocumento5 pagineLe Eroine Dantesche Di Inferno e Purgatorio - A ConfrontoCristian AlbaniNessuna valutazione finora
- 2 Letteratura Per Linfanzia Definizione NascitaDocumento19 pagine2 Letteratura Per Linfanzia Definizione NascitaVera GarcíaNessuna valutazione finora
- GK 40kDocumento7 pagineGK 40kFederico RaffaelliNessuna valutazione finora
- Gianni Celati ANGELICADocumento20 pagineGianni Celati ANGELICAFulvio FabbroniNessuna valutazione finora
- Metodologie Di Indagine StoricoDocumento1 paginaMetodologie Di Indagine StoricoFrancesca TamponiNessuna valutazione finora
- Incantesimi ChiericoDocumento9 pagineIncantesimi ChiericoMichele CremoneseNessuna valutazione finora
- Fonetica e Fonologia Da Lingua KanoeDocumento327 pagineFonetica e Fonologia Da Lingua KanoeJéssicaNessuna valutazione finora
- La PoesiaDocumento18 pagineLa PoesiaFrancesco BertoliniNessuna valutazione finora
- Nietzsche e DostoevskijDocumento12 pagineNietzsche e Dostoevskijscagnozzo11100% (1)
- Introdução À Sagrada EscrituraDocumento220 pagineIntrodução À Sagrada EscrituratomascbNessuna valutazione finora
- Condizionale CompostoDocumento3 pagineCondizionale CompostoCecilia PerreraNessuna valutazione finora
- Letteratura TedescaDocumento43 pagineLetteratura TedescaBlaBlaAabc100% (1)
- Competenze 1 Analisi NovellaDocumento2 pagineCompetenze 1 Analisi NovellaAnonymous P3zb5WCNessuna valutazione finora
- Shirley Jackson, L'autrice Che Svela Il Lato Mostruoso Dell'Ordinario. MediumDocumento24 pagineShirley Jackson, L'autrice Che Svela Il Lato Mostruoso Dell'Ordinario. MediumManuela CavallaroNessuna valutazione finora
- LeiDocumento10 pagineLeiVlad CocuzNessuna valutazione finora