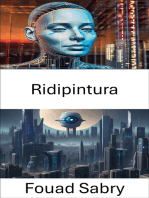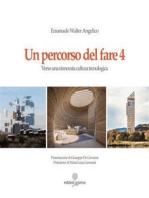Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Atlas 90296 Preview
Caricato da
Villa ClaudioCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Atlas 90296 Preview
Caricato da
Villa ClaudioCopyright:
Formati disponibili
Gillo Dorfles - Annibale Pinotti
NUOVA
COMUNICAZIONE
VISIVA
ISBN 978-88-268-9029-6
Edizioni La casa editrice ATLAS opera con il Si-
stema Qualità conforme alla nuova nor-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ma UNI EN ISO 9001:2008 certificato
2011 2012 2013 2014 2015
da CISQ CERTICARGRAF.
Direzione editoriale: Roberto Invernici
Progetto grafico e videoimpaginazione: Andrea Guarneri, Nicola Marchetti
Copertina: Vavassori & Vavassori
Stampa: Castelli Bolis S.p.a - Cenate sotto (BG)
L’editore si impegna a mantenere invariato il contenuto di questo volume, secondo le norme vigenti.
Il presente volume è conforme alle disposizioni ministeriali in merito alle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo.
Con la collaborazione della Redazione e dei Consulenti dell’I.I.E.A.
L’autore ringrazia per la collaborazione la professoressa Tiziana Lazzaretti.
I disegni al computer sono stati realizzati da Andrea Guarneri e Nicola Marchetti.
Disegni di Berta Olivella, Alessandra Ghisleni, Alessia Gusmini.
Fotografie di Andrea Guarneri, Nicola Marchetti, Annibale Pinotti.
Ogni riproduzione del presente volume è vietata.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE
del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello
personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano
20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.
© 2011 by Istituto Italiano Edizioni Atlas
Via Crescenzi, 88 - 24123 Bergamo - Tel. 035.249711 - Fax 035.216047 - www.edatlas.it
PRESENTAZIONE
Il testo Nuova Comunicazione visiva si pone come obiettivo primario quello di presentare gli elementi fondamentali
della percezione e della comunicazione visiva, fondamenti imprescindibili per un corretto approccio alla lettura e analisi
dell’immagine, sia essa opera d’arte o elemento di visual design. In secondo luogo il testo vuole stimolare la motivazione
degli studenti verso una maggiore e più consapevole attenzione al mondo dell’immagine e dell’immaginario visivo. Se è
vero che siamo nella cosiddetta “civiltà delle immagini”, è altrettanto vero che è necessario attrezzarsi per potersi districare
agevolmente tra le miriadi di immagini (fisse e in movimento) in cui siamo immersi nella nostra quotidianità.
a. Articolazione dei contenuti
La prima parte del testo è dedicata agli aspetti fisiologici e mento costante per la conoscenza e l’interpretazione delle
alle leggi che regolano la percezione visiva. Sono presen- immagini. Viene poi presentato il processo comunicativo
tate le principali teorie della percezione e indagate le più nelle sue implicazioni semiologiche e nel rapporto fra testo
frequenti illusioni ottiche. visivo e testo narrativo, con particolare attenzione alle me-
Nei capitoli successivi sono analizzati gli elementi con- tafore visuali.
cettuali del linguaggio visivo (punto, linea, superficie e I vari aspetti della comunicazione (verbale, non verba-
texture, colore, luce e spazio) singolarmente e nelle loro le, iconica e multimediale) sono affrontati nelle loro linee
interazioni. Capitoli specifici sono riservati al colore e agli essenziali e aprono ampi spazi di operatività e di creativi-
elementi della composizione (simmetria, modulo, ritmo, tà. Un’ampia sezione è riservata alle modalità di lettura e
equilibrio, peso). Vengono quindi trattate, in modo sinteti- analisi delle opere d’arte e delle immagini in genere (foto-
co, le principali tecniche grafico-plastiche. grafia, pubblicità, design e video). Concludono il testo due
Un ampio modulo viene riservato ai temi e generi icono- raccolte di immagini, diverse ma tra loro complementari: un
grafici della pittura: storia, religioni, mitologia, natura mor- Atlante di segni, simboli e allegorie dedicato agli aspetti
ta, scene di genere, paesaggio, ritratto e autoritratto... simbolici delle immagini e un Atlante delle immagini e del-
È un primo concreto approccio all’universo della rappre- le illustrazioni. Sono strumento di conoscenza e al tempo
sentazione artistica, antica e moderna, utile strumento pro- stesso aprono nuovi spazi operativi e orizzonti di ricerca e
pedeutico allo studio della Storia dell’arte ma anche riferi- approfondimento, da ampliare anche con contributi on line.
b. Metodologia didattica
Il testo si pone come fine principale lo sviluppo di compe- immagini e delle opere artistiche. Nell’ambito dell’istruzio-
tenze nella lettura consapevole e autonoma della realtà ne professionale e tecnica, dove si privilegiano gli aspet-
visuale con cui è posto a confronto. ti operativi e tecnici dell’analisi grafica, la percezione e gli
L’acquisizione di abilità tecniche sia di disegno e di rappre- elementi del linguaggio visuale potranno essere esplorati
sentazione grafica, sia di analisi degli elementi del linguag- nel biennio, mentre la comunicazione e la lettura completa
gio visuale diviene il prerequisito essenziale per un approc- delle immagini saranno di pertinenza del triennio.
cio, anche pluridisciplinare, che si fonda strutturalmente Preoccupazione sottesa all’opera nel suo complesso è la ri-
sull’interiorizzazione di un metodo. cerca costante della massima chiarezza e della pressoché
Il testo offre la possibilità di progettare percorsi didattici immediata operatività, in considerazione delle attitudini e
diversi in relazione al tipo di scuola e agli obiettivi di ap- delle motivazioni degli studenti.
prendimento stabiliti dal Docente. A fronte di un’esaustiva esposizione teorica degli argomen-
Ad esempio, nei Licei è possibile creare un percorso indut- ti, è posta la massima attenzione alla selezione delle infor-
tivo, partendo dalle schede di lettura delle opere d’arte e mazioni e alla loro naturale esemplificazione pratica, me-
introducendo di volta in volta gli aspetti prevalenti degli diante numerose attività di apprendimento operativo per
elementi del linguaggio visuale (punto, linea, texture, luce, livelli di conoscenze ed elaborati più complessi. Gli esercizi
volume, spazio, colore, composizione, ecc.), oppure seguire sono graduati per difficoltà: in tal modo è possibile indivi-
un percorso deduttivo, in base al quale in un primo tem- dualizzare l’apprendimento, così da garantire il livello mini-
po si presentano i fenomeni percettivi, il processo della co- mo agli studenti che presentano maggiori difficoltà e, allo
municazione visiva e i vari elementi del linguaggio visuale, stesso tempo, consentire a quelli più motivati il raggiungi-
per poi applicare le conoscenze acquisite alla lettura delle mento di un livello di approfondimento superiore.
Un’opera mista: materiali on line e multimediali
Nuova Comunicazione Visiva è un’opera mista. Disponibili on line sulla Libreria web, accessibile dalla home page del sito dell’At-
las (www.edatlas.it) è possibile trovare:
1. Atlanti iconografici, vere e proprie gallerie di immagini, cui attingere per ampliare le risorse disponibili per la lettura e la pro-
duzione di messaggi visivi. Sono materiali già predisposti per l’utilizzo con la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
2. Animazioni interattive sulla percezione, sulle illusioni ottiche e sul colore, da utilizzare, durante le lezioni, con la LIM.
3. Altri esercizi inerenti i principali argomenti del corso.
4. Schede di lettura integrata di opere d’arte e immagini di Visual Design.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
INDICE
Presentazione 2 10. IL COLORE NEL COMPUTER 79
11. IL LINGUAGGIO DEL COLORE 80
1. La percezione visiva 5 LABORATORIO: Colori espressivi 81
1. LE VIE DELLA PERCEZIONE VISIVA 6 12. USO DEL COLORE 82
2. LE TEORIE DELLA PERCEZIONE 8 13. IL SIGNIFICATO DEI COLORI 84
3. LE LEGGI DELLA GESTALT 9 LABORATORIO: Ad ogni colore il suo significato 85
4. LE COSTANZE PERCETTIVE 12 LABORATORIO: Giochi di colore 86
PROTAGONISTI: Attilio Marcolli e la “Teoria del campo” 13
5. LA FIGURA E LO SFONDO 14
• Altri esercizi
ON-LINE
6. LE AMBIGUITÀ NELLA PERCEZIONE VISIVA 15
• Approfondimenti: Il significato simbolico dei colori
7. LE ILLUSIONI OTTICHE 18
PROTAGONISTI: Maurits Cornelis Escher 20 • Galleria di immagini
8. ARTE E ILLUSIONI OTTICHE 21
LABORATORIO: Percezione e illusione 22
4. La composizione 87
• Altri esercizi 1. LA SCELTA COMPOSITIVA 88
ON-LINE
• Approfondimenti: Un mondo di illusioni ottiche 2. POSIZIONE E DIREZIONE 90
• Galleria di immagini 3. COLLOCAZIONE SPAZIALE 92
4. PESO ED EQUILIBRIO 94
5. NUCLEI E LINEE DI FORZA 96
2. Elementi del linguaggio visivo 23 LABORATORIO: Composizione 97
1. IL PUNTO 24 6. ESPRESSIVITÀ DELLA COMPOSIZIONE 98
2. IL SEGNO 26 LABORATORIO: L’importanza della cornice 99
3. LA LINEA 28 7. IL MOVIMENTO: STATICITÀ E DINAMISMO 100
LABORATORIO: La linea 32 8. SIMMETRIA E ASIMMETRIA 102
PROTAGONISTI: Vasilij Kandinskij e “Punto, linea, superficie” 33 9. MODULO E RITMO 104
4. DAL PIANO AL VOLUME 34 LABORATORIO: Fregi ornamentali 106
LABORATORIO: Dal piano al volume, il packaging 36 LABORATORIO: Simmetrie alla Escher 108
PROTAGONISTI: Jean Arp e le sue sculture 37 10. LA GEOMETRIA SEGRETA DEGLI ARTISTI 110
5. LE FORME 38 LABORATORIO: Leggere la composizione 112
Le forme della natura 38 LABORATORIO: Le sculture in movimento di Calder 114
Le forme geometriche 40
a. Triangolo 40 • Altri esercizi
ON-LINE
b. Quadrato 42 • Approfondimenti: Analisi della composizione di immagini
c. Cerchio 44 • Galleria di immagini
d. Poligoni regolari 46
PROTAGONISTI: Max Bill e le 15 variazioni sui poligoni 48
LABORATORIO: Poligoni 49
6. LA TEXTURE 50 5. Tecniche artistiche 115
7. IL PATTERN 52 Matita, Matite colorate, Pastelli 116
LABORATORIO: Texture e pattern 53 Penne e inchiostri, Pennarelli, Acquerello 117
8. LUCE/OMBRA 54 Tempere, Colori a olio, Affresco, Pittura murale 118
Le ombre 56 Pittura spruzzo, Graffito, Mosaico, Graffiti urbani,
LABORATORIO: Luce/Ombra 57 Frottage, Collage 119
9. LO SPAZIO 58 Scultura: Scolpire, Modellare, Assemblare 120
LABORATORIO: Prospettiva 62 Tecniche di stampa: Stampa in rilievo, in piano, in cavo 121
Computer art: Disegnare, Dipingere, Modellare 122
• Altri esercizi Fotografia e Video Art, Net Art, Performance e allestimenti 123
ON-LINE
• Approfondimenti: Il linguaggio visuale nell’arte e nella LABORATORIO: Le tecniche dell’arte 124
comunicazione visiva
• Galleria di immagini
• Altri esercizi
ON-LINE
• Approfondimenti: Piccola storia delle tecniche artistiche
3. Il colore 63 • Galleria di immagini
1. LUCE E COLORE 64
2. LE TEORIE DEL COLORE 66
3. ASPETTI PERCETTIVI DEL COLORE 68
4. FATTORI CHE INFLUENZANO LA PERCEZIONE DEI COLORI 69 6. Pittura: temi e generi iconografici 125
5. IL CERCHIO DI ITTEN 70 LA PITTURA: TEMI E GENERI ICONOGRAFICI 126
PROTAGONISTI: Johannes Itten e l’Arte del colore 71 LABORATORIO: I generi artistici della pittura 127
6. E GLI ALTRI COLORI? 72 1. LA PITTURA DI STORIA 128
LABORATORIO: Colore, teorie e pratica 73 2. LA RELIGIONE CRISTIANA 134
7. ARMONIE E CONTRASTI DI COLORE 74 3. LA PITTURA DI GENERE 139
8. GLI ACCORDI CROMATICI ARMONICI 77 4. LA NATURA MORTA 145
9. COLORIMETRIA 78 5. IL PAESAGGIO 153
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
6. IL RITRATTO 162 2. LEGGERE UNA SCULTURA 230
7. L’AUTORITRATTO 171 LABORATORIO: Scultura greca 232
8. MITI E ALLEGORIE 175 LABORATORIO: Scultura contemporanea 233
3. LEGGERE UN’ARCHITETTURA 234
LABORATORIO: Architettura barocca 236
• Altri esercizi
ON-LINE
LABORATORIO: Architettura contemporanea 237
• Approfondimenti: Temi, soggetti e argomenti
4. LEGGERE UN OGGETTO DI DESIGN INDUSTRIALE 238
• Galleria di immagini 5. LEGGERE UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO 240
LABORATORIO: Leggere un messaggio pubblicitario 242
LABORATORIO: Come lavora un’agenzia pubblicitaria 244
7. La comunicazione 179
1. GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 180 • Altri esercizi
ON-LINE
2. IL SISTEMA COMUNICATIVO UMANO 181 • Approfondimenti: Schede di lettura e analisi di immagini
LABORATORIO: La comunicazione non verbale 182
• Galleria di immagini
3. SEMIOLOGIA 184
4. LA TRIADE DEL SEGNO DI PEIRCE 185
5. IL SEGNO VISIVO: ICONA, INDICE, SIMBOLO 186
LABORATORIO: Segni visivi 188 11. Atlante di segni, simboli e allegorie 245
6. MODELLO DI PROCESSO DELLA COMUNICAZIONE 190
1. Segnaletica stradale 246
LABORATORIO: Come si comunicano messaggi 191
2. Segnaletica per la sicurezza 247
7. LE FUNZIONI DELLA COMUNICAZIONE 192
3. Segnaletica di aeroporti e stazioni 248
LABORATORIO: La semiotica applicata alle arti visive 194
4. Icone del computer e del telefono 249
5. Pittogrammi per i Giochi Olimpici 250
• Altri esercizi 6. Mappe di città e metropolitane 252
ON-LINE
• Approfondimenti: Semiotica visiva 7. Cartografia 253
• Galleria di immagini 8. Araldica 254
9. Bandiere 255
10. Monete e banconote 256
11. Francobolli 257
8. Semiotica visiva e creatività 195 12. Iconografia dei santi 258
1. IMMAGINI E REALTÀ 196 13. Rappresentazioni allegoriche di mesi e stagioni 259
LABORATORIO: Immagini e realtà 197 14. Rappresentazioni mitologiche 260
LABORATORIO: Iconografia/Iconologia 198 15. Segni zodiacali e costellazioni 262
2. LINGUAGGIO NATURALE E LINGUAGGIO ICONICO 200 16. Le carte dei Tarocchi 263
LABORATORIO: Lettura comparata di testo narrativo/testo visivo 201 17. I cinque sensi 264
3. TESTO NARRATIVO E IMMAGINI 202
4. COMUNICARE CON LE IMMAGINI: LA RETORICA VISIVA 204
• Altri esercizi
ON-LINE
LABORATORIO: Metafore e prosopopee in pubblicità 208
LABORATORIO: Classificare le figure retoriche visive 209 • Approfondimenti: Iconografia/Iconologia
5. LA CREATIVITÀ VISIVA 210 • Galleria di immagini
LABORATORIO: Sperimentazioni di creatività visiva 212
• Altri esercizi 12. Atlante di immagini e di illustrazioni 265
ON-LINE
• Approfondimenti: Sviluppare la creatività visiva 1. Copertine di libri 266
• Galleria di immagini 2. Copertine di riviste 267
3. Custodie di dischi in vinile 268
4. Cover di CD musicali 270
9. La comunicazione multimediale 213 PROTAGONISTI: Mina e le copertine di Mauro Balletti 271
5. Manifesti cinematografici 272
1. IL SISTEMA MULTIMEDIALE 214 6. Locandine teatrali 273
2. L’IMMAGINE FOTOGRAFICA 216 7. Manifesti di propaganda politica 274
3. IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 217 8. Manifesti pubblicitari - Mezzi di trasporto 275
4. I GENERI FOTOGRAFICI 218 9. Manifesti pubblicitari - Bevande per tutti i gusti 276
LABORATORIO: Analisi di una fotografia 219 10. Manifesti pubblicitari - Moda e vanità femminile 277
5. L’IMMAGINE IN MOVIMENTO 220 11. Illustrazioni scientifiche 278
LABORATORIO: Analisi di immagini in movimento 221 12. Favole illustrate 279
LABORATORIO: Videoclip 222 13. Illustrazioni per bambini 280
14. Fumetti 281
• Altri esercizi PROTAGONISTI: Walt Disney e Topolino 282
ON-LINE
PROTAGONISTI: Pinocchio 284
• Approfondimenti: Dallo storyboard all’editing video
15. Caricature 286
• Galleria di immagini
16. Ticket di musei, mostre, concerti e mezzi pubblici 287
• Altri esercizi
ON-LINE
10. Come leggere immagini e opere d’arte 223
• Approfondimenti: La grafica commerciale
1. LEGGERE UN’OPERA PITTORICA 224 • Galleria di immagini
LABORATORIO: Lettura globale di un dipinto 226
LABORATORIO: Lettura di un’opera di pittura astratta 228 - Indice analitico delle immagini 288
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
1 La percezione visiva
Jasper Johns, Cup 4 Picasso, 1972. Litografia. Collezione privata, New York.
La percezione, in generale, è un meccanismo complesso, preposto alla raccolta ed elaborazione, in tempi molto
brevi, di una grande quantità di informazioni utili, se non addirittura indispensabili, al nostro sistema cognitivo e a
quello motorio per raggiungere i loro obiettivi, prima di tutto quello della sopravvivenza.
La percezione visiva, in particolare, ha come oggetto di studio l’esperienza percettiva della visione, ovvero ciò che
noi vediamo, così come lo vediamo.
Vedere non significa riflettere passivamente le cose, come in uno specchio: noi non percepiamo direttamente le
cose, ma la luce che gli oggetti riflettono.
Infatti, quando un fascio di luce colpisce un oggetto, questo riflette la luce nello spazio circostante. Parte di questa
luce riflessa penetra nell’occhio, dove sono collocati recettori specifici, che inviano l’informazione al cervello attra-
verso impulsi elettrici.
Nel cervello avviene poi la decodifica dell’immagine.
Conoscenze Abilità
• I meccanismi della percezione visiva. • Individuare e spiegare i meccanismi percettivi.
• Le teorie della percezione. • Riconoscere e applicare le leggi della configurazione.
• Le leggi della Gestalt. • Riconoscere e costruire immagini ambigue.
• Le illusioni ottiche.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
1. LE VIE DELLA PERCEZIONE VISIVA
L’atto di vedere un uccello in volo inizia quando il nostro occhio mette a fuoco l’immagine, rovesciata, sulla retina. La retina
contiene milioni di elementi fotorecettori, sensibili alla luce e in grado di immagazzinarla, che analizzano e suddividono
La percezione visiva
l’immagine nelle sue componenti specifiche.
I colori, la forma e il movimento sono quindi recepiti come fotoni di luce e codificati in piccoli impulsi elettrici: velocemente
gli impulsi vengono canalizzati verso la corteccia cerebrale, dove sono analizzati e interpretati.
Alla fine, il cervello crea la nostra percezione dell’uccello in volo, anche se alcuni aspetti sono ancora da definire, dal punto
di vista scientifico. In queste pagine viene visualizzato, schematicamente, il processo della percezione visiva.
cornea cristallino
1. L’occhio è come una macchina fotografica
Le onde luminose riflesse dall’uccello in volo passano anzi-
tutto attraverso la cornea, la lente più esterna dell’occhio.
L’iride, i cui pigmenti danno all’occhio il suo colore caratte-
ristico, si contrae in situazioni di alta luminosità, e si espan-
de in caso di buio, in modo da regolare la quantità di luce
che entra nella pupilla.
Sviluppandosi attorno alla lente più interna, i corpi ciliari si
flettono per mettere a fuoco l’immagine. Quando questa è
a fuoco esattamente sulla retina, si ha una vista normale. fovea
iride
muscoli ciliari retina
2. La retina
I fotoni che compongono la luce proveniente
dall’uccello (nell’immagine, la freccia grande)
attraversano la retina per attivare i fotore-
cettori, chiamati rispettivamente coni e ba-
stoncelli per via della loro forma. I coni sono
specializzati nel “catturare” la luce più brillan-
te (luminosa) e sono concentrati nella zona
centrale della retina, chiamata fovea, che ci
fornisce quella che chiamiamo visione acuta
centrale, ricca di colori.
Distribuiti lungo la periferia della retina, i ba-
stoncelli sono molto sensibili, ma non distin-
guono i colori, e ci permettono di vedere in
condizioni di bassa luminosità.
I segnali provenienti da coni e bastoncelli
sono processati da una serie di altre cellule e
mandati alla corteccia cerebrale. Si ipotizza
che grandi cellule, dette gangli, siano specia-
lizzate nel catturare dati quali il contorno e il
movimento dell’uccello. Gangli più piccoli si
occupano dei colori dell’uccello e dei dettagli
più fini. I messaggi provenienti da queste cel-
lule lasciano l’occhio (a destra, freccia piccola
nera) ed entrano nel nervo ottico.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
6 LA PERCEZIONE VISIVA
3. Destra e sinistra
Alcuni canali del nervo ottico (sotto, in giallo nell’immagine) traspor-
lobo lobo
tano i segnali provenienti dalla metà sinistra della retina di ciascun
occhio. Altri canali (in rosso nell’immagine) forniscono l’informazione frontale parietale
proveniente dalla metà destra di ciascuna retina.
Nel chiasma ottico i nervi si dividono, distribuendo gli input prove-
nienti da ciascun occhio a stazioni di transito situate nel talamo, chia-
mate corpi genicolati.
Dai corpi genicolati, altri percorsi di neuroni ritrasmettono i messaggi
alla corteccia visiva primaria e alle regioni più alte del cervello.
Questo percorso circolare ci permette di vedere l’uccello anche con un
occhio solo.
lobo lobo
temporale occipitale
4. Il centralino
Come cavi in sezione incrociata, sei colonne
di cellule situate nei corpi genicolati ricevo-
no e ritrasmettono informazioni neurali. Le
due colonne inferiori trasmettono dati sui
movimenti dell’uccello e sulle sue caratteri-
stiche generali. Le quattro colonne superiori
trasmettono impulsi relativi ai colori e ai
particolari più dettagliati.
Quindi il cervello continua il proprio proces-
so di suddivisione delle informazioni visuali
in flussi paralleli, per ulteriori elaborazioni.
5. Ricomposizione dell’immagine
L’analisi delle informazioni continua nella corteccia
visiva primaria e in decine di altre aree visive nel
cervello. Ad esempio, un’area visuale nella corteccia
temporale, i cui neuroni sono sensibili alle forme,
identifica l’uccello come tale.
Un’area nella corteccia parietale, sensibile alla posi-
zione, localizza l’uccello nello spazio.
colore movimento forma profondità
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 7
2. LE TEORIE DELLA PERCEZIONE
Tra empirismo e innatismo
La percezione visiva
Secondo le più recenti teorie scientifiche, le nostre perce- parte superata dalle attuali concezioni scientifiche. Secon-
zioni dipendono, principalmente, da due fattori: do gli empiristi, ogni processo percettivo è frutto di un ap-
a. conoscenza del mondo, e quindi dall’esperienza passata; prendimento, cioè dell’esperienza passata che è in grado di
b. informazioni sensoriali che arrivano al cervello, cioè dal influenzare la percezione attuale.
modo in cui il nostro sistema organizza e dà forma agli stimoli. La posizione degli innatisti, invece, sostiene che gli stessi
La percezione ha rappresentato un tema centrale negli fenomeni possano essere spiegati sulla base di leggi innate
studi psicologici, fin dallo sviluppo della psicologia speri- che guidano e organizzano i processi percettivi.
mentale. Una questione chiave è stata la disputa tra innato Numerose sono comunque state le teorie formulate sulla
e acquisito nella percezione, disputa comunque in buona percezione. Vediamo le più importanti.
1 Hermann von Helmholtz (1821-1894) 2 Scuola della Gestalt (anni ‘20 del XX secolo)
La teoria empiristica (1870) La posizione innatista, basata sull’indirizzo fenomenologico,
ha come rappresentante più si consolida in Europa grazie agli esponenti della Scuola di
eminente Helmholtz, il qua- Berlino: Wertheimer, Koffka, Koehler (Psicologia della Ge-
le parte dal presupposto che stalt), i quali sostengono che i processi percettivi sono go-
le ripetute esperienze con vernati da principi innati, che guidano e danno un senso alla
l’ambiente influiscano sul- percezione del mondo fenomenico.
la percezione degli oggetti, La percezione è quindi il risultato dell’organizzazione inter-
mediante specifiche asso- na di “forze” generate dai vari
ciazioni tra le sensazioni ele- aspetti di un oggetto o di un
mentari già apprese. evento: è la tesi sostenuta dalla
Il bambino, alla nascita, sa- Psicologia della forma.
rebbe in grado di effettuare L’esperienza passata non può
solo discriminazioni grosso- modificare le leggi di organiz-
lane, che tendono a specifi- zazione strutturale, al limite
carsi e specializzarsi gradual- impone dei vincoli che fanno
mente, con il ripetersi delle prevalere alcune organizzazioni
esperienze. del campo visivo su altre. Max Wertheimer (1880-1943)
3 La teoria ecologica di Gibson (1966-1979)
Secondo Jerome James Gibson (1904-1979), la percezione non è arricchita da esperienze passate, né da schemi o categorie: le
informazioni percettive sono già contenute nella stimolazione “nuda e cruda”.
Tali informazioni presenti nella stimolazione sono chiamate AFFORDANCES (disponibilità). Il soggetto deve solo cogliere le af-
fordances che sono già presenti nell’ambiente (approccio ecologico). Non serve quindi fare ulteriori elaborazioni, costruire una
strategia di utilizzo di tale ricchezza di informazioni, mediante un processo evolutivo di adattamento all’ambiente.
4 New Look, Stati Uniti (anni ’50-’60)
Gli psicologi del New Look, invece, partono da una visione funzionalista della perce-
zione, che, secondo loro, dipende anche dai bisogni, dagli stati emotivi e dalle aspet-
tative del soggetto. Questi fattori, infatti, sono in grado di alterare o condizionare le
nostre percezioni.
Ad esempio, in uno studio di Jerome Bruner i bambini percepivano come più grande
una moneta da un dollaro rispetto ad un cerchio di cartone di uguale misura, ma ciò
accadeva solo ai bambini poveri!
Questa teoria è sostenuta anche dal Costruttivismo: la percezione è un processo at-
tivo e costruttivo nel quale il soggetto interviene con le sue aspettative, conoscenze,
motivazioni. Il processo percettivo dipende quindi dall’interazione tra le caratteristi-
che dello stimolo esterno e le caratteristiche del soggetto che percepisce.
Jerome Seymour Bruner (1915)
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
8 LA PERCEZIONE VISIVA
3. LE LEGGI DELLA GESTALT
“Nella percezione visiva il tutto è più della somma delle sue parti”
Le leggi di unificazione figurale
Le leggi della configurazione, o meglio, di unificazione figurale, sono dovute
a Wertheimer. Nel 1923, egli arrivò a spiegare come alcune parti del campo
visivo si uniscono ad altre per dare forma ad un ogetto (figura) che risalta, se-
parandosi da altre parti del campo le quali costituiscono lo sfondo, che rimane
escluso dalla configurazione.
Queste leggi, che stabiliscono con precisione cosa sta insieme nel campo vi-
sivo e viene percepito come figura, sono le seguenti:
1 Vicinanza (o della maggiore densità) Il titolo di un lavoro di Franco Battiato, Inneres
Le parti che sono tra loro più vicine nello spazio e nel tempo auge (Occhio interiore, in tedesco), del 2009, ri-
tendiamo a percepirle insieme. prende la principale affermazione della Gestalt.
Organizzazione debole per
- righe
- colonne 2 Somiglianza per forma, colore o dimensione
- diagonali
Nessuna di queste si impone in modo privi- Tendiamo a percepire insieme le parti che sono somiglianti
legiato. per forma, colore o grandezza.
a. Esempio di somiglianza per forma:
Organizzazione stabile per
- colonne
Prevale sulle altre e disgrega la figu-
ra, che diventa un rettangolo.
Organizzazione stabile Organizzazione per righe, raf-
su righe. forzata dal variare dei simboli.
Distanziando le colonne di quadrati in
modo diverso, si ha un’organizzazione b. Esempio di somiglianza per colore:
stabile per La similarità del colore fa sì che una serie di punti neri e grigi
- colonne venga percepita come una serie di quadrati neri che si alter-
Le ultime due colonne sono percepite nano a quadrati grigi.
come una singola colonna di quadrati
appaiati.
Il processo di segregazione lavora in accordo a quello di
unificazione: più si disgregano le righe di punti, più si raf-
forzano le colonne.
c. Esempio di somiglianza per dimensione:
Anche le dimensioni degli oggetti favoriscono la creazione
di configurazioni per gruppi. Nella figura sotto, ad esempio,
siamo portati a percepire due gruppi, uno di tre e l’altro di
quattro quadrati, in relazione alla loro dimensione.
Il processo di segregazione lavora in accordo a quello di
unificazione: più si disgrega la matrice, più si rafforzano
quadrati e croci.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 9
3 Continuità di direzione (o della curva passante) 4 Chiusura
Se abbiamo un insieme di elementi disposti in modo da se- La porzione di campo visivo che è racchiusa da un contorno
guire traiettorie diverse e tra loro intersecanti, gli elementi senza interruzioni, emerge come una figura separata dal re-
La percezione visiva
che fanno parte di una stessa traiettoria tendono a unificarsi sto. Tendiamo quindi a colmare le eventuali lacune nel con-
in un’entità autonoma. torno della figura.
Siamo infatti portati a percepire le linee come continue, pre- Negli esempi, percepiamo sempre la figura del quadrato e
ferendole sempre ai cambiamenti bruschi. del cerchio, poiché completiamo spontaneamente ciò che ci
Nell’esempio, abbiamo una serie di tratti disposti su una li- appare incompleto.
nea curva e un’altra serie di tratti disposti su una linea ret-
ta: nella figura preferiamo vedere due linee continue che si
incrociano, piuttosto che due forme a V che si toccano nel
punto P.
5 Buona forma (o semplicità) 6 Simmetria
Le forme più regolari si impongono immediatamente come La simmetria trasmette un senso di ordine e regolarità, fa-
figura percepita. vorendo la percezione di configurazioni equilibrate, come
Ad esempio, lo spazio centrale con contorno mistilineo, che possiamo osservare in molteplici esempi nell’arte e nella co-
doveva risultare vuoto, appare invece pieno. municazione visiva.
Al posto delle due figure concave appaiono due figure con-
vesse chiuse e sovrapposte.
Qui percepiamo con chiarezza le colonnine della balconata
che sono simmetriche tra loro. Ma forse c’è qualcosa di ri-
conoscibile anche nello sfondo, tra una colonnina e l’altra...
7 Pregnanza a. Le figure geometriche regolari, con alta simmetria, sono esempi
di pregnanza. Qui a sinistra si vede chiaramente un cubo, mentre la
Forme “uniche” (pre-
figura di destra, anch’essa rappresentazione tridimensionale di un
gnanti) sono facilmente
cubo, è più difficile da vedere in terza dimensione: essa ci appare
riconoscibili e si impon-
come un esagono diviso a spicchi dalle sue diagonali.
gono come figura per-
cepita, staccandosi dal-
lo sfondo. Osserviamo
qualche esempio.
b. Nella configurazione sopra a destra compaiono figure regolari c. La superficie nera di sinistra viene vista come cornice (ed il bianco
e uguali: ciò la obbliga a “rimanere” nel piano; la configurazione a è lo sfondo), perché questa è la soluzione più economica data la
sinistra viene invece vista in terza dimensione: se infatti fosse vista regolarità della superficie nera, che ha sempre la stessa larghezza.
piana, sarebbe il risultato di tre parti irregolari. La superficie nera di destra non ha la stessa larghezza: invece di ve-
Vederla in 3D semplifica il risultato finale: abbiamo due rettangoli dere l’irregolarità della cornice, si è portati a visualizzare due qua-
che delimitano un angolo di spazio. drati sovrapposti, regolari.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
10 LA PERCEZIONE VISIVA
Tony Cragg, La Gran Bretagna vista dal Nord, 1981. 4,4x8 m. Tecnica mista. Londra, Tate Modern.
Questa grande installazione dell’artista inglese rende bene l’idea delle leggi dell’unificazione figurale della Gestalt. A sinistra, in basso, la figura
di un uomo osserva la forma geografica della Gran Bretagna, che si riconosce, a destra, pur ruotata di 90° in senso antiorario.
Le figure sono composte da una serie di oggetti di vario genere, con forme, colori e dimensioni diverse: dopo un primo momento di incertezza,
noi percepiamo tranquillamente le due figure, poiché, per la Gestalt, “il tutto è più della somma delle sue parti”.
8 Destino comune 9 Esperienza passata
Immaginiamo un insieme di punti disposti casualmente. Nes- Qualora gli stimoli siano parte di una configurazione ben co-
sun fattore di organizzazione è particolarmente attivo a pro- nosciuta, e perciò familiare, tenderanno a organizzarsi in una
durre una strutturazione stabile: unità che percepiremo come figura.
Ad esempio, nella figura percepiamo la lettera E, che ci è
b familiare nell’alfabeto latino, poiché le tre linee spezzate si
unificano in questo significato. Attenzione, però: per attivare
a questo fattore le componenti devono essere significative e
non scelte a caso, altrimenti non avviene il riconoscimento.
Se i punti a, b e c cominciassero a muoversi nella stessa dire-
zione e alla stessa velocità, si verrebbe a costituire una forma
unitaria, solida e coesa, formata dai 3 punti (somiglianza per
movimento).
10 Direzionalità e orientamento
In un insieme di punti equidistanti, disposti su una griglia rettan-
golare, l’organizzazione (univoca) è data all’asse principale.
Nelle figure a destra percepiamo un andamento verticale e uno
orizzontale, nelle prime due, mentre nella terza i punti sembrano
appartenere a una sola fascia, che si ripiega nello spazio.
11 Percezione e parsimonia
Può capitare che due o più fattori di configurazione siano
presenti nello stesso campo visivo e in conflitto tra loro. In
questo caso prevale il fattore che genera il risultato percetti-
vo più semplice e regolare, pur tra molte eccezioni.
Continuità di direzione Chiusura
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 11
4. LE COSTANZE PERCETTIVE
Gli oggetti sono sempre gli stessi
La percezione visiva
Quando osserviamo un oggetto, l’immagine proiettata sul-
la nostra retina varia a seconda dell’angolo di osservazione,
della luminosità dell’ambiente, dell’orientamento e del mo-
vimento dell’oggetto, ecc.
La costanza percettiva ci permette di percepire un og-
getto come sempre lo stesso, nonostante i cambiamenti
dell’immagine retinica. Gli psicologi hanno identificato una
serie di costanze percettive: la costanza della grandezza,
della forma e del colore.
Stanza di Adalbert Ames
1 La costanza della grandezza La Stanza che Ames costruì
È la tendenza a percepire gli oggetti come dotati di dimensio- nel 1946 rappresenta un
ni costanti. La percezione della profondità gioca un ruolo im- interessante esperimento
Posizione
sulla percezione: è costru-
portante in questo meccanismo. Quando un oggetto è vicino reale della
ita in modo tale che, guar- persona B
a noi, l’immagine che proietta sulla nostra retina è grande, dandoci dentro attraverso
quando è lontano è più piccola. Nonostante questi cambia- un foro, l'immagine che
menti nell’immagine retinica, noi percepiamo l’oggetto come proietta sulla retina è quel-
dotato di grandezza costante. la di una stanza di dimen- Posizione
apparente
Ad esempio, quando vediamo una persona molto lontana, sioni e proporzioni norma- della persona B Posizione
nonostante la sua immagine retinica sia piccola, non pensia- li, mentre le due persone reale della
mo che la persona sia piccola, ma pensiamo appunto che sia all'interno sembrano avere Perimetro persona A
lontana. altezze diverse. In realtà, la apparente
persona a destra è molto della stanza
Le spiegazioni possibili di questo fenomeno sono varie: anzi-
più vicina di quella a sini-
tutto, impariamo da piccoli quali sono le dimensioni medie stra, il soffitto a destra è Punto di osservazione
di un oggetto, e perciò giudichiamo le dimensioni dall’espe- più basso che a sinistra, e
rienza precedente; vediamo poi gli oggetti con dimensioni infine la parete posteriore
costanti per la loro grandezza relativa, perché li confrontia- è posta obliquamente. Planimetria della Stanza di Ames,
mo con gli oggetti che li circondano. a forma trapezoidale.
2 La costanza della forma 3 La costanza del colore
Percepiamo gli oggetti sempre con la stessa forma, nono- Il colore di un oggetto viene percepito come costante, no-
stante la loro immagine retinica cambi a seconda dell’ango- nostante cambino le condizioni di luminosità dell’ambiente.
lo di osservazione. Questo fenomeno si verifica, ad esempio, quando ci met-
Ad esempio, proviamo a osservare un libro di fronte a noi; tiamo gli occhiali da sole: nonostante le lenti modifichino il
la sua forma è certamente rettangolare, ma avviciniamo il colore della luce che raggiunge la retina, continuiamo a per-
bordo inferiore del libro, in modo che il bordo superiore cepire il bianco come bianco e il blu come blu.
risulti più lontano: l’immagine retinica sarà trapezoidale. Probabilmente ciò avviene perché le lenti ci fanno percepire
Nonostante ciò, continuiamo a vedere il libro rettangolare. modificato nello stesso modo tutto l’ambiente circostante, e
Questo perché il nostro sistema visivo tiene conto della pro- quindi probabilmente noi “sottraiamo” automaticamente il
fondità e della distanza. colore aggiunto, percependo così i colori originali.
Grazie alla prospettiva lineare e a quella tissurale (o gradiente di Nella scacchiera, la tonalità di grigio del quadrato A è identica a
densità microstrutturale) riusciamo ad avere una percezione uni- quella del quadrato B, anche se l’ombra portata dal cilindro sulla
ficata della forma. scacchiera falsa la nostra percezione.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
12 LA PERCEZIONE VISIVA
PROTAGONISTI: Attilio Marcolli e la “Teoria del campo”
Nel suo testo Teoria del campo, Marcolli riassume il lavoro svolto in un corso di
Educazione alla visione. In questa occasione definisce chiaramente ciò che si inten-
de per “campo”: il campo è uno spazio che presenta alcune caratteristiche costanti in
ogni suo punto.
Divide poi lo studio del campo in quattro parti:
a. Campo geometrico intuitivo
b. Campo ghestaltico
c. Campo topologico
d. Campo fenomenologico
Per capire meglio, leggiamo alcuni brani dell’introduzione.
Che cos’è il campo visivo?
“Teniamo presente che il campo è una cosa, come lo è la percezione, anche se si esplica
in quattro tipi distinti perché molteplice è il modo di vedere.
Osserviamo questo tavolo, che qui, in quest’aula, si chiama cattedra.
Prima di tutto questo tavolo lo vediamo nella sua fisionomia geometrica, fisionomia
che ci fa dire appunto che è un tavolo prima ancora di conoscere le sue misure, gli
spessori, ecc. Attilio Marcolli (1930-2010)
Lo vediamo cioè dal punto di vista del campo geometrico-intuitivo, e la percezione Architetto, designer, pittore e scultore, è
visiva è di tipo oggettivo: per tutti noi infatti è un tavolo, e con quella fisionomia. stato docente di Tecnologia dell’archi-
Però ciascuno di noi vede anche questo tavolo da una posizione diversa, individuale. tettura, Comunicazione visiva e Disegno
Industriale presso il Politecnico di Milano.
Uno lo vede di fronte e l’altro di scorcio, uno più in ombra e l’altro più in luce. Studioso di problemi morfologici e percet-
Nessuno di voi vede i cassetti. Se uno di voi si siede per terra lo vede dal basso, o se sale tivi, ha pubblicato diversi testi, tra cui Teo-
su una scaletta lo vede dall’alto. ria del campo 1 e 2 (Sansoni, Firenze 1971
E per di più ciascuno di voi lo vede anche con i suoi sentimenti di simpatia o di an- e 1978), che hanno costituito un preciso
tipatia, a seconda dello stato d’animo in cui oggi si trova di fronte a questo tavolo; riferimento per gli studenti di Comunica-
può piacergli o può non piacergli a seconda delle sue preferenze personali, o della sua zione visiva.
cultura sulle forme.
Ora il tavolo è stato osservato dal punto di vista ghestaltico (Gestalt in tedesco signi- Alcune opere di Attilio Marcolli, basate sul
fica “forma in mutazione, in cambiamento”), e la percezione visiva è di tipo psico-fisico. rapporto figura-sfondo.
Ma questo tavolo lo vediamo anche ambien-
tato: è situato alla vostra sinistra di fronte a
voi, su questa pedana in legno, con dietro, alla
parete, una lavagna e, di fronte, i vostri banchi
allineati. Lo vediamo cioè in relazione con tutti
gli altri oggetti con i quali forma un insieme,
un certo ambiente, uno spazio in cui viviamo e
facciamo qualcosa insieme.
Il tavolo lo vediamo dal punto di vista topo-
logico (topos in greco vuole dire “spazio” nel
senso della relazione fisica, concreta, materia-
le), e la percezione visiva è di tipo associativo.
D’altra parte noi possiamo vedere questo ta-
volo come è fatto, cioè con quali materiali è
stato costruito, come è stato progettato, quali
particolari costruttivi possiede. E vediamo an-
che come le sue gambe si collegano al piano
d’appoggio, cioè i collegamenti delle varie
parti, i nessi costruttivi e logici che lo tengono
insieme. Lo vediamo in questo caso dal punto
di vista fenomenologico (nel fenomeno inte-
so come momento concreto, essenziale della
realizzazione), e la percezione visiva è di tipo
caratterizzante”.
Da Teoria del campo di Attilio Marcolli, Sansoni,
Firenze 1971.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 13
5. LA FIGURA E LO SFONDO
Il campo visivo e la percezione degli oggetti
La percezione visiva
Uno dei problemi fondamentali affrontati dalla Gestalt è Per “vedere” con chiarezza dobbiamo essere in grado di
quello della modalità di percezione delle figure nel piano separare, rapidamente e senza esitazioni, la figura dallo
e degli oggetti nello spazio. Quando noi osserviamo una sfondo, cioè dal resto del campo visivo.
illustrazione, un oggetto o un paesaggio, percepiamo im- Non sempre questo avviene con rapidità e chiarezza: ana-
mediatamente un campo visivo, cioè lo spazio organizzato lizzeremo quindi i casi più frequenti di ambiguità visiva nel
fenomenico della visione. Nel campo si collocano i “fenome- piano, cioè quei casi in cui l’esito della configurazione per-
ni” visivi, cioè gli oggetti e le figure, che si devono staccare cettiva è instabile, poiché si possono presentare due o più
visivamente dallo sfondo, che rimane in secondo piano. interpretazioni diverse.
a. Il ruolo di “figura”
I fattori che determinano l’assunzione del ruolo di figura di una certa parte del campo visivo possono essere diversi.
Tra i più comuni ricordiamo:
1. Grandezza relativa
All’interno del campo visivo, ci appare come figura l’area
con dimensioni più piccole, rispetto all’area di grandi di-
mensioni, che percepiamo come sfondo.
Nei tre esempi a lato, risulta evidente che percepiamo con
maggior facilità come figura la croce grigia più piccola Figura ambigua Figura poco ambigua Figura non ambigua
all’estrema destra.
2. Orientamento
L’area con asse orizzontale o verticale è la figura, mentre
un’area orientata liberamente ci appare, in prevalenza, In questo caso è l’orientamento verticale/oriz-
zontale che ci fa percepire con chiarezza come
come sfondo. figura la croce grigia.
3. Simmetria
L’area con bordi simmetrici rispetto a un asse principale ci
appare come figura, mentre se i bordi sono asimmetrici la
percepiamo come sfondo.
4. Inclusione La forma irregolare stellata ci appare come
L’area inclusa è la figura, mentre l’area che la include è lo figura, inclusa entro uno sfondo scuro.
sfondo.
5. Convessità
Le aree delimitate da un contorno convesso sono percepite
come figura; l’area concava appare come sfondo.
6. Articolazione senza resti
In questo caso la figura appare come ripetizione di aree In questi casi percepiamo come figure le parti convesse, scure su
sfondo chiaro nei primi due esempi, chiare negli altri due.
uguali ed intere, mentre la presenza di aree tagliate fa da
sfondo. Negli esempi a destra, le figure sono praticamente
uguali, cambia il modo in cui sono organizzate: nel primo
emergono i quadrati bianchi, nel secondo i poligoni stellati
neri (anche se in modo alquanto instabile, perché le figure
sono concave).
b. Il ruolo dello sfondo
Lo sfondo è la porzione del campo visivo che resta al di fuo-
ri di ciò che abbiamo individuato come “figura”.
Non si tratta solo di uno scarto inutilizzabile, perché ricopre
il ruolo fondamentale di schema di riferimento per la figu-
ra. Infatti, ogni figura (bidimensionale o tridimensionale
che sia) è sempre inserita in uno spazio dove occupa una Articolazione senza resti: a sinistra percepiamo quadrati bianchi su
posizione, con un certo orientamento, precise dimensioni sfondo nero; a destra poligoni stellati neri su sfondo bianco.
e, talvolta, è in movimento.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
14 LA PERCEZIONE VISIVA
6. LE AMBIGUITÀ NELLA PERCEZIONE VISIVA
Numerose sono le ambiguità che si possono presentare nell’atto della percezione visiva.
I casi di ambiguità provano che l’attività percettiva è un processo attivo, poiché l’elabora-
zione dei dati in ingresso continua anche dopo aver raggiunto una prima configurazione
accettabile.
Ma quali sono le principali tipologie di ambiguità?
1. Rapporto figura-sfondo
2. Ambiguità di significato
3. Ambiguità di posizione
4. Il tutto per le parti
5. Compresenza di più ambiguità
6. Mimetismo
7. Completamento amodale
Manifesti cinematografici basati sul rapporto figura-sfondo.
1 Rapporto figura-sfondo
Abbiamo già definito cosa si intende per figura e sfondo: lo sfondo include la figura e conclude il campo visivo, schema di
riferimento della visione. Un’eventuale linea di contorno appartiene alla figura.
In alcuni casi, l’esito della configurazione percettiva è alquanto instabile, perché si possono presentare due o più modalità di
interpretazione. Vediamo alcuni esempi.
In questo disegno osserviamo frecce nere Questa antica stampa raffigura In questo disegno percepiamo, alternati-
che si dispongono, simmetricamente, in la tomba di Napoleone all’isola vamente, un gruppo di ragazzi che scende
verticale, su sfondo bianco, oppure, in di Sant’Elena. Ma, osservando le scale (se guardiamo da destra verso sini-
alternanza, frecce bianche che si contrap- bene... dove si nasconde l’Impe- stra) oppure due file di frecce blu contrap-
pongono in orizzontale su sfondo nero. ratore? poste.
2 Ambiguità di significato
Alcune immagini, a prima vista, sembrano raffigurare un oggetto, un animale, una persona. Osservando con maggior atten-
zione, ecco avvenire un fenomeno di inversione figurale, una vera e propria metamorfosi di significato, per cui ci appare una
figura completamente diversa, di tutt ’altro significato. Ecco qualche curioso esempio.
a. Giovane donna o b. Viso di giovane donna c. Anatra o d. Viso di capo indiano o
profilo di vecchia signora? o suonatore di sax? coniglietto? esquimese che scruta nella notte?
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 15
3 Ambiguità di posizione
L’ambiguità di posizione è un tipo di inversione figurale che si verifica quando per-
cepiamo, nella stessa immagine, un cambiamento di giacitura o una variazione del
La percezione visiva
punto di vista. Alcuni solidi 3D posti in assonometria, ad esempio, riescono di difficile
lettura, poiché facciamo fatica a capire se sono rivolti verso l’alto o verso il basso. In
alcuni casi si possono creare anche fenomeni di “assonometrie impossibili”, ampia-
mente utilizzati nella grafica commerciale, per attirare l’attenzione dell’osservatore.
Nell’immagine a de-
stra, non riusciamo
bene a capire da che
Il cosiddetto cubo di parte guardano i due
Necker si presta a di- ragazzi: a destra o a
verse interpretazioni sinistra? In questa as-
percettive, esemplifi- sonometria, probabil-
cate a fianco attraver- mente, c’è qualcosa
so l’eliminazione di che non va...
alcuni segmenti.
4 Il tutto per le parti
In questo caso non avviene inver-
sione figurale, ma l’osservatore
deve restare sempre consapevole
e porre grande attenzione nell’in-
dividuare la figura che risulta dalla
somma di altre figure più piccole,
di tutt ’altro significato.
È così che vediamo apparire volti
umani da paesaggi montuosi o in-
trichi di fogliame.
Alcune di queste immagini, inven-
tate per gioco da artisti del XVI-
XVII secolo, sono stupefacenti. Anonimo, Paesaggio metamorfico, 1600 ca. Olio su
Osserviamo qualche esempio. tavola. Che cosa si vede, nel paesaggio?
Giuseppe Arcimboldo, Autunno, 1573. Olio su tela.
Le sue figure sono composte da svariati elementi.
5 Compresenza di più ambiguità 6 Mimetismo e mascheramento
Esistono alcune figure che presentano contemporaneamen- Alcune figure si mascherano en-
te più di un tipo di ambiguità. L’esempio più celebre è la co- tro configurazioni più complesse,
siddetta coppa di Rubin (1915), con ambiguità sia di rappor- risultando di difficile lettura. Si
to figura-sfondo sia di significato. verificano quindi veri e propri fe-
nomeni di mimetismo (camoufla-
Fisicamente, il campo visivo è co- ge, in francese e inglese). Vedia-
stituito da aree bianche e nere mo, nell’esempio di Gottschaldt
omogenee, contigue e collocate
(1926), come risulti difficile indivi-
sullo stesso piano.
duare la forma del parallelepipedo
Fenomenicamente percepiamo
una specie di coppa bianca su nella figura a destra.
sfondo nero uniforme oppure, in
alternanza, due visi di profilo di
colore nero su sfondo bianco.
Le figure hanno carattere ogget-
tuale, cioè appaiono come oggetti
Coppa di Rubin, 1915. reali, mentre gli sfondi hanno ca-
rattere di supporto alla figura.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
16 LA PERCEZIONE VISIVA
7 Processi di completamento a. Completamento amodale
Capita sovente, nella realtà e nelle immagini che
osserviamo, che le figure non siano complete e
chiaramente separate dallo sfondo; anzi, il più del-
le volte sono incomplete, magari perché coperte
da qualche altra immagine o elemento di disturbo.
In tal caso si attivano due forme distinte di com-
pletamento: “amodale” e “modale”.
a. Completamento amodale
Nel completamento “amodale” alcune zone della In questo disegno percepiamo Qui percepiamo 4 quadrati
figura risultano poste sotto ad altre superfici opa- l’immagine di un cubo, sotto neri sotto forme bianche.
che e vengono completate nell’atto percettivo. Si strisce diagonali bianche.
creano l’effetto schermo (la superficie da comple-
tare appare posta sotto) oppure l’effetto tunnel, b. Completamento modale
quando l’oggetto completato sembra entrare da
una parte e fuoriuscire dall’altra, rispetto ad una
superficie coprente.
b. Completamento modale
In questo caso avviene una produzione di forma
vera e propria, pur in assenza di qualsiasi stimolo.
L’oggetto “inesistente” viene percepito come rea-
le, delimitato da contorni netti o sfumati chiamati
“contorni illusori”. Nel triangolo illusorio (1955) Qui percepiamo una croce
Gli studiosi definiscono come “anomale” queste di Gaetano Kanizsa (1913- bianca, arrotondata, tra cop-
superfici che percepiamo ma che non hanno un 1993) vediamo più di quanto pie di settori circolari neri.
corrispettivo a livello fisico. non ci sia nello stimolo fisico.
Come distinguere, praticamente, la figura dallo sfondo
Perché avvenga la distinzione tra figura e sfondo occorre che, in un campo visivo
omogeneo, esista una discontinuità, cioè che il contrasto sia sufficientemente mar-
cato, altrimenti l’immagine ci apparirà confusa, fino all’indeterminatezza. Tra i fattori
che consentono di individuare nettamente la figura, i più importanti sono:
a. nitidezza della forma della figura rispetto allo sfondo;
b. contrasto di colore: percepiamo più facilmente come figura una forma di colore
chiaro su sfondo scuro;
c. differenza di dimensione: se tra due aree una è più grande e include l’altra, è pro-
babile che la più piccola e inclusa sia vista come figura; Figura ambigua
d. posizione delle figure nello spazio, che può anche determinare la percezione di
vicinanza o di lontananza per ognuna;
e. diverso tipo di superficie: avremo percezioni diverse se, per esempio, come sfondo
c’è una una texture fatta di linee, puntinata oppure perfettamente liscia, piatta ed
omogenea.
Come risolvere le ambiguità percettive
L’interpretazione delle figure ambigue può essere considerata un’attività di problem
solving, procedendo cioè come per la soluzione di un problema di logica o di geome-
tria.
Bisogna attivare una ricerca ricorsiva, cioè a più riprese, dell’oggetto che ha maggior Figura poco ambigua
probabilità di produrre quella determinata stimolazione retinica.
I processi dell’attività percettiva sono fondamentalmente due:
- il processo di riorganizzazione, che avviene in modo automatico, che serve a ri-
strutturare la figura nel complesso o in qualche sua parte specifica, in seguito al mu-
tamento di un’altra parte (che viene soppressa, trasformata, spostata o inserita men-
talmente);
- il processo di reinterpretazione: dopo aver data una prima interpretazione allo sti-
molo visivo (con l’attribuzione di un primo significato), si passa ad una seconda inter-
pretazione, pur senza cancellare la prima.
Applicando questi due processi, insieme o separatamente, riusciremo a districarci
nella interpretazione anche delle figure più complesse, le cosiddette illusioni ottiche. Figura non ambigua
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 17
7. LE ILLUSIONI OTTICHE
Percepire di più, di meno, diversamente
La percezione visiva
Nella creazione artistica, nella grafica 1 Johann Zöllner, 1860 2 Franz Müller-Lyer, 1889
pubblicitaria, ma soprattutto nel dise-
gno geometrico, incontriamo spesso Sovrapponendo una serie fitta di tratti- Se agli estremi di due segmenti poniamo
situazioni visive che provocano, al di là ni trasversali e in direzione alternata su delle frecce in direzione opposta, i seg-
rette parallele orizzontali, abbiamo la menti non ci sembrano più della stessa
delle nostre intenzioni, difficoltà di in- sensazione che le linee non siano più né lunghezza.
terpretazione. rette né parallele tra loro.
Ci troviamo così di fronte a figure ambi-
gue, di dubbia decodificazione se non,
come talvolta accade, ad autentiche
illusioni ottico-geometriche, o illusioni
visive. L’illusione consiste in un vero e
proprio errore di valutazione della re-
altà, compiuto dal nostro cervello. Nu-
merosi sono gli esempi di figure ambi-
gue costruite e studiate dagli psicologi,
senza riuscire a dare una spiegazione
completa di questi fenomeni.
3 Ewald Hering, 1861 4 Wilhelm Wundt, 1898 5 Johann Christian Poggendorff, 1860
Se dal punto centrale di un fascio di ret- Se da due punti esterni al fascio di pa- Tracciando una retta trasversale che
te parallele tracciamo una serie di seg- rallele tracciamo una serie di segmenti passi sotto le rette parallele, percepia-
menti divergenti prospetticamente, le a ventaglio, verso lo spazio centrale, le mo un’interruzione nella direzione, per
rette sembrano curvarsi verso l’esterno, rette sembrano curvarsi verso l’interno, cui i terminali della trasversale non ci
dando un senso di concavità. dando un senso di convessità. sembrano ben allineati.
6 Louis Sander, 1926 7 Joseph Delboeuf, 1865 8 Robert Jastrow, 1889
Le due diagonali dei parallelogrammi Il cerchio rosso delle tre configurazioni è Nonostante le apparenze, le due porzio-
vengono percepite di lunghezza diversa, sempre della stessa dimensione, anche ni di corone circolari sono perfettamen-
pur avendo la stessa dimensione. se la nostra percezione ci inganna. te uguali.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
18 LA PERCEZIONE VISIVA
9 James Fraser, 1908 10 Mascheramento 11 Richard Gregory, 1973
Seguendo il tracciato con un dito, sco- Dove di trova la stella a cinque punte? Nel suo Café Wall descrive un curioso
priremo che la spirale non esiste, trat- effetto che si crea nella decorazione a
tandosi di cerchi concentrici. piastrelle del bar che frequantava a Bri-
stol: le rette orizzontali sono parallele
tra loro, nonostante l’apparenza.
12 Concavo convesso 13 Lettera o numero? 14 Il punto verde
Alcuni cerchi sembrano concavi (delle In relazione all’ordine di lettura (orizzon- Nonostante le apparenze, la dimensione
cavità) altri convessi (delle sporgenze). tale o verticale) percepiamo l’elemento del punto verde si mantiene costante
Ma cosa succede su ruotiamo l’immagi- centrale come lettera B (in orizzontale) nelle due configurazioni.
ne di 180°? o come numero 8 (in verticale).
15 Oscar Reutersvärd, 1934 16 Il triangolo di Penrose (1950) 17 Assonometrie impossibili
Il geniale artista svedese disegnò nu- “È l’impossibilità nella sua forma più In relazione al pun-
merose altre figure “impossibili”, ba- pura”, così affermò, negli anni ‘50, il to di vista (dall’alto
sandosi sull’assonometria isometrica. matematico Roger Penrose a proposi- o dal basso) in al-
to di questa figura impossibile, ispirata cune assonometrie
a quella di Oscar Reutersvärd. si possono creare
curiose quanto im-
possibili configura-
zioni visive.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 19
PROTAGONISTI: Maurits Cornelis Escher
Le figure alternate di Escher
L’incisore olandese Maurits Cornelis Escher analizzò la realtà con la straordinaria
La percezione visiva
precisione del grafico.
A partire da forme reali, organizzate entro complesse maglie geometriche di ispi-
razione araba, egli creò combinazioni che si possono estendere all’infinito. Alla fine
degli anni ‘30, raggiunta una padronanza grafica straordinaria, tentò di orientare la
sua attività verso una ricerca più rigorosa sotto l’aspetto espressivo-creativo.
Molte tra le sue opere presentano figure ambivalenti (o ambigue).
Le forme si incastrano in modo perfetto, come tasselli, e la linea di contorno che le
individua disegna contemporaneamente più figure. Maurits C. Escher (1898-1972), olan-
dese, è stato un celebre incisore e gra-
fico. Dopo aver frequentato scuole di
disegno e architettura, visitò la Spa-
gna (dove fu impressionato dai motivi
ornamentali delle piastrelle arabe) e
visse a lungo in Italia, ammirandone
Modulo base. i paesaggi e visitando città e borghi
medievali.
Prima di fare l'artista illustrò libri, di-
segnò tappezzerie, francobolli e deco-
razioni murali. Eseguì 448 litografie,
incisioni e stampe e oltre 2000 disegni.
Con le tassellazioni del piano e le ar-
chitetture impossibili influenzò altri
artisti e continua oggi a stupire per il
fascino e la suggestione delle sue im-
magini.
Alto e basso.
Motivo simmetrico. Solido impossibile.
Relatività, 1967.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
20 LA PERCEZIONE VISIVA
8. ARTE E ILLUSIONI OTTICHE
La fantasia degli artisti, per stupire
Nella creazione artistica, in ogni epoca e per ogni stile, uno
degli obiettivi principali è sempre stato quello di stupire l’os-
servatore per l’abilità tecnica espressa o per l’immaginifica
creatività. Osserva le immagini di questa pagina, appartenenti
ad epoche e culture diverse, e cercane altre analoghe, basate
sulle illusioni ottiche.
Giuseppe Arcimboldo, Il bibliotecario, 1566 ca. Olio su tela. Skok-
losters Slott, Balsta, Svezia.
Sandro Del Prete, The folded Chess Set, 1975. Pastello.
René Magritte, La condizione umana, 1933. Olio su tela. 100 x 81 cm.
National Gallery of Art, Washington DC, USA.
Salvador Dalì, Volto paranoico, 1935.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
LA PERCEZIONE VISIVA 21
LABORATORIO: Percezione e illusione
1. Le leggi della percezione visiva e le illusioni ottiche
a. Si vede quello che non c’è
La percezione visiva
b. Si vede quello che non può esistere
c. Si vede una stessa cosa da punti di vista differenti
d. Si vedono più cose in luogo di una sola
e. Non si vede quello che c’è
f. Trompe l’oeil
g. Illusioni ottiche
a. Si vede quello che non c’è, ad esempio un quadrato. b. Assonometria impossibile. c. Scala saliscendi.
d. Si vedono più cose e. Non si vede quello che c’è. f. Trompe l’oeil. g. Illusioni ottiche.
in luogo di una sola. Dove è nascosta la signora?
Seguendo gli esempi di questa pagina e delle precedenti, cerca altre immagini che si possano prestare a giochi percettivi
o a vere e proprie illusioni ottiche. Crea un catalogo collocando le immagini nelle categorie elencate sopra.
2. Le leggi della Gestalt
Spesso nella stessa figura possiamo indi-
viduare l’applicazione di più leggi della
Gestalt. Osserva, negli esempi, il logo
del WWF e quello dei programmi RAI, e
individua altre immagini analoghe.
Rapporto figura-sfondo, somi-
glianza, chiusura, esperienza
passata, simmetria.
Vicinanza, chiusura, buona forma, sim-
metria, pregnanza, esperienza passata.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
22 LA PERCEZIONE VISIVA
2 Elementi del
linguaggio visivo
1. Evidente è l’uso del punto, in di- 2. Una spessa linea di contorno segna 3. Le forme sono stilizzate, realizzate
mensioni diverse, che crea sfondi reti- le figure. con archi e segmenti lineari; lasciano
nati per meglio definire il volume. Gli andamenti lineari sono retti, curvi intendere la figura, senza staccarla de-
Il segno è diretto ed immediato, tipico e spezzati: l’opera, infatti si ispira al cisamente dal fondo.
della pop-art. Futurismo.
Roy Lichtenstein, Cavaliere rosso, 1974. Olio su tela, 213,4x284,5 cm. Vienna, Museo d’arte moderna.
4. La retinatura dei punti crea una tex- 5. I colori sono pochi (giallo, blu, ros- 6. La composizione è fortemente di-
ture graduata, collocata in varie zone so e nero), stesi a tinta piatta e molto namica, secondo i dettami del Futuri-
dell’opera. La texture aiuta anche a saturi. Lo stile e la tecnica di Lichten- smo. I cavalli in corsa si sovrappongo-
definire luci e ombre. stein, infatti, ricordano le modalità di no, creando il senso dello spazio senza
stampa in quadricromia dei fumetti. l’uso della prospettiva.
Conoscenze Abilità
• Elementi concettuali e geometrici • Individuare e comprendere l’uso degli elementi del linguag-
(punto, linea, piano, volume). gio visivo nei messaggi visivi (opere d’arte, pubblicità, illu-
• Elementi visuali concreti strazioni, ecc.).
(forma, texture, luce e ombra). • Realizzare composizioni grafiche usando correttamente i
principali elementi del linguaggio visivo.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
1. IL PUNTO 1 Il punto in geometria 2 Il cielo stellato
Elementi del linguaggio visivo
Il punto indica una posizione e non Il punto indica una posizione nello spa-
possiede dimensioni (lunghezza o zio geometrico, definita da coordinate.
larghezza), non occupa area né spa- Nell’esempio sotto, il punto A ha coordi-
zio, anche se quando lo indichiamo nate 10 e -6: significa che, rispetto allo
nel disegno occupiamo una porzione spigolo in alto a sinistra della pagina
del foglio, in relazione allo strumento (origine degli assi) dista 10 cm in oriz-
zontale (ascissa x) e 6 cm in verticale
che usiamo.
(ordinata y).
In geometria viene contrassegnato
da una lettera maiuscola e può indi-
care anche gli estremi di un segmen- A
to, i vertici di un poligono, l’interse-
zione di rette o l’origine di semirette.
Nel linguaggio visuale costituisce A (10, -6)
l’elemento minimo disegnabile dota-
to di espressività.
3 Il punto genera linee e forme 4 Dal punto alla texture 5 Il punto tipografico
Mettendo in sequenza un certo numero L’accostamento di punti crea, in natura e Nella scrittura, il punto indica la fine di
di punti, si possono formare linee e altre nel disegno, superfici texturizzate, por- una frase, di un periodo; il punto e vir-
forme geometriche. zioni di piano (e di volumi) in cui il pun- gola spezza la frase, i due punti aprono
to mantiene la sua individualità visiva, una spiegazione o un dialogo, tre punti
integrata in una trama che percepiamo indicano invece una sospensione...
omogena. In tipografia il punto è l’unità di misura
del carattere (o font): si dice, ad esem-
pio, “Arial in corpo 12”. Il punto tipogra-
fico misura esattamente 0,370 mm.
Il punto indica la
fine di una frase.
5 Addensamento/Rarefazione 6 Figure “puntuali” 7 Stippling dots
Mediante addensamento, rarefazione e È una tecnica particolare per produrre
variazione della dimensione dei punti, è immagini mediante una grande quantità
possibile creare forme e immagini. di punti accostati tra loro, tutti perfetta-
Osserva l’esempio. mente uguali o variabili per dimensione.
In alcuni casi si usa perforare il suppor-
to (cartoncino o carta pergamena) con
l’ago, per avere forellini identici e vicini.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
24 ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO
Il punto nell’espressione artistica
Possiamo considerare come “punti” le innumerevoli tes-
sere dei mosaici che, accostate, disegnavano ornamenti
e figure, nei pavimenti di domus romane o sulle pareti
delle basiliche bizantine del V-VI secolo d. C.
Alla fine dell’800, in Francia, gli artisti del Puntinismo,
come Seurat e Signac, seguendo le nuove teorie del
colore, usavano accostare piccoli punti di colori primari
puri, in modo da creare una miscela visiva di colori se- Georges Seurat, Ballerina in scena, 1889. Olio su tavola, 21,5x16,5 cm.
condari e terziari. Londra, Courtauld Institute Galleries.
1 Punto e astrazione
La pittura non figurativa fornisce numerosi
esempi di uso di punti (colorati e non) in sem-
plici disegni o composizioni più complesse e
articolate. Osserviamone alcuni.
Kasimir Malevič, Il cerchio nero, 1913. Vasilij Kandinskij, Paul Klee, La Vrille, 39,5x34,5 cm. Olio su
105,5x105,5 cm. Olio su tela. 9 punti in ascesa, 1918. tavola ovale. Collezione privata.
2 Alexander Calder (1898-1976) Esercizi
Calder utilizza i punti in modo giocoso a. “Raccolta” di punti
e creativo, sia in pittura sia nella com- Raccogli, da giornali, riviste o fotografie
posizione dei suoi famosi mobiles. da te scattate, immagini che evidenziano il
punto negli elementi naturali, negli ogget-
ti di uso comune, nella grafica e nell’arte.
b. Composizioni “puntuali”
Osservando gli esempi proposti in queste
pagine puoi trarre utili spunti per creare
composizioni basate sull’uso del punto.
Traccia sul foglio una serie di quadrati (8-
10 cm di lato) e, in ciascuno di essi, disegna
composizioni di tua creazione, con matita,
penna, matite colorate o pennarelli.
Puoi anche disegnare su quadrati ritagliati
da un foglio da disegno bianco da incolla-
re poi su cartoncino nero o colorato.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO 25
2. IL SEGNO 1 Segni grafici casuali
Elementi del linguaggio visivo
Quanti tipi di segni visivi? Gli “scarabocchi al telefono”
di Bruno Munari, sono un di-
Al di là del valore semiologico (vedi pag. 184), il segno è l’espressione visiva elementare, vertente esempio di sponta-
la più semplice e immediata, per comunicare un fatto, un pensiero o uno stato d’animo. nei accostamenti di segni, che
Può essere un elemento naturale, una parola, un suono, un gesto, un tratto inciso nella talvolta formano curiose figu-
pietra o disegnato sulla carta. I segni possono essere naturali o artificiali, realizzati in- re ornamentali.
tenzionalmente dall’uomo. Come entità elementare li riconosciamo in un puntino nero
lasciato sul foglio da una matita, in una macchia di colore su una superficie, ma anche
nella scia di un aereo nel cielo, nell’orma del piede sulla sabbia o su un terreno fangoso.
Possiamo quindi distinguere vari tipi di segni:
a. Segni grafici: tracciati su un foglio o incisi sulla pietra, sono parte integrante di una
superficie, sulla quale si dispongono come entità isolate o in configurazioni complesse.
b. Segni pittorici: sono quelli realizzati dai pittori, spesso con l’uso esclusivo del colore.
c. Segni plastici tridimensionali: sono i segni in rilievo, fondamentali nella scultura, ma
fatti propri anche dai pittori, almeno in certe opere d’arte contemporanea.
d. Segni architettonici: sono presenti nelle facciate o all’interno degli edifici, nell’arti-
colazione dei volumi, in una decorazione continua, nel ritmo delle aperture, e cosi via.
2 Segni naturali 3 Segni plastici della scultura
È facile trovare, con un po’ di osservazione, molti segni par- Molti scultori sono riconoscibili per
ticolari nell’ambiente naturale, non creati dall’intervento il loro segno plastico. Osserva, ad
dell’uomo ma liberamente generati dalle forze della natura. esempio, i segni astratti, corrosi,
all’interno della sfera di Arnaldo
Arcobaleno, fulmine Pomodoro e le superfici grumose e
ed erosione del terreno segnate dalle dita di Alberto Giaco-
sono segni naturali. metti nella sua Donna alta.
Arnaldo Pomodoro Alberto Giacometti
4 Segni dell’architettura 5 Segni del visual design
Molti architetti usano ripetere, in contesti diversi, elemen- Sono “segni” del visual
ti architettonici particolari, che ne rendono riconoscibile lo design, ad esempio, alcu-
stile anche se la forma architettonica varia. Pensiamo, ad ni logo di aziende famose,
esempio, alle strutture di Santiago Calatrava, che riprendo- le tag dei writer, i brush
Tag di un graffitaro
no segni organici che ricordano elementi naturali. (pennelli) dei software di
grafica, ecc.
Marchio Nike
Marchio Citroen Brush di Photoshop
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
26 ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO
I segni (e i gesti) 1 Lucio Fontana Giuseppe Capogrossi
Alberto Burri
degli artisti
Alcuni artisti devono la loro
fama e l’immediata rico-
noscibilità non solo e non
tanto allo stile delle com-
posizioni, quanto al “segno”
plastico che le connota.
Può essere un colore, una
forma particolare, un effetto
visivo dovuto al gesto istin-
tivo o a tecniche sperimen-
tali, che lasciano una traccia
visiva che diventa quasi un
“marchio di fabbrica”.
Osserva gli esempi propo- Sacchi forati e ricuciti; Tagli e fori nella tela. Segno a forma di forchetta,
sti e cerca conferma in altre plastica e legno bruciati. ripetuto ritmicamente.
opere degli stessi artisti.
2 Alberto Giacometti Georges Mathieu Keith Haring Hans Hartung
Emilio Vedova
Pierre Soulages
3 Jack “the dripper” Esercizi
Jackson Pollock (1912-1956), Jackson Pollock al lavoro a. Tanti segni intorno a noi
esponente dell’Action painting con la tecnica del dripping.
Ogni giorno siamo a contatto con tutta
(pittura gestuale) usava far goc- una serie di segni visivi, naturali o artifi-
ciolare o “lanciare” i colori sulla ciali (creati dall’uomo), che non costitui-
tela, liberamente, senza pensa- scono una figura vera e propria ma hanno
re di realizzare un’opera d’arte, la loro autonomia e un preciso significato.
ma lasciando fluire emozioni e Cercane alcuni e compila un elenco visua-
pensieri nascosti. le da confrontare e discutere con i tuoi
compagni e con il docente.
b. Inventa la tua “tag”
Le tag dei writer sono un esempio eviden-
te della funzione del segno: la tag, più che
una firma, è infatti un segno che identifica
l’autore del murale.
Osserva alcune tag e, se già non la possie-
di, realizzane una personale.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO 27
3. LA LINEA
Elementi del linguaggio visivo
La linea può essere...
Un punto in movimento genera un tracciato lineare. La linea 3
possiede lunghezza, posizione e direzione ma non ha spessore. 2
Rappresenta anche il limite di un piano.
Osserva la figura a destra, in cui, quasi per gioco e in un semplice
disegno, sono riassunte le funzioni principali della linea.
La linea, quindi, può rappresentare: 6
1. un filo sottile;
2. il bordo di un’area colorata;
3. la cornice di una finestra; 1
4. il morbido profilo di una collina;
5. il perimetro di un oggetto squadrato;
6. il limite di un’area interna; 4
7. un cerchio che interrompe una forma squadrata;
8. l’intersezioni di due piani ortogonali;
9. il limite materiale di una strada.
La linea è alla base del disegno e si presta a numerosi utilizzi:
9
schizzi, disegni preparatori, tracciati geometrici e disegni scien- 7
85
tifici. Come elemento visuale può possedere una precisa forza
espressiva, è cioè in grado di attirare l’attenzione dell’osservato-
re per le sue qualità visive.
1 Linea come contorno delle figure
L’uso più frequente della linea è quello di
definire il contorno delle figure, per sepa-
rarle dallo sfondo.
È questo il metodo di rappresentazione
più spontaneo e immediato, usato spesso
anche dai grandi artisti nel disegno mono-
cromatico.
Lo vediamo, ad esempio, nelle vetrate del-
le cattedrali gotiche, dove un sottile filo di
piombo lega i vetri colorati.
Vetrata della Maddalena (particolare). XIII secolo. Cattedrale di Chartres.
2 La linea secondo Klee
Nei suoi corsi al Bauhaus di Wei-
mar (1921-22), Paul Klee descri-
ve la linea come “un punto che
è uscito a fare una passeggiata”,
per indicarne la libertà e la mo-
bilità.
Dopo i primi andamenti liberi,
di cui vediamo alcuni esempi
nell’immagine di due pagine dei
suoi appunti per le lezioni, Klee
cercherà di guidare gli studenti
verso un uso più consapevole
degli andamenti lineari.
© Istituto Italiano Edizioni Atlas
28 ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISIVO
Potrebbero piacerti anche
- Percezione VisivaDocumento30 paginePercezione VisivaEduardo AccardoNessuna valutazione finora
- Rappresentare l'architettura: Note sulle categorie e le classi del disegnoDa EverandRappresentare l'architettura: Note sulle categorie e le classi del disegnoNessuna valutazione finora
- Geoturismo 2Documento30 pagineGeoturismo 2ANH TUYET NGUYENNessuna valutazione finora
- Entre Palabras: Manuel Carrera Díaz, Paolo SilvestriDocumento32 pagineEntre Palabras: Manuel Carrera Díaz, Paolo SilvestriJesusOGuardiaNessuna valutazione finora
- Bo7026 PreviewDocumento46 pagineBo7026 PreviewИгорь КравецNessuna valutazione finora
- Storia MedioevaleDocumento32 pagineStoria MedioevaleElis100% (1)
- Il PreromanticismoDocumento19 pagineIl PreromanticismosaroNessuna valutazione finora
- Metodologie e Tecniche Del Disegno Archeologico Manuale Per Il Disegno Dei Reperti ArcheologiciDocumento72 pagineMetodologie e Tecniche Del Disegno Archeologico Manuale Per Il Disegno Dei Reperti ArcheologicimorfindelNessuna valutazione finora
- Unità Di Apprendimento: UDA N. 1 Classi II ARTE E IMMAGINE A.S.2018/2019Documento21 pagineUnità Di Apprendimento: UDA N. 1 Classi II ARTE E IMMAGINE A.S.2018/2019elenalucaNessuna valutazione finora
- Sette Mari 2 - Geostoria Dalla Fine Della Repubblica All'Alto MedioevoDocumento430 pagineSette Mari 2 - Geostoria Dalla Fine Della Repubblica All'Alto MedioevoValeria BuglioniNessuna valutazione finora
- Uda Lab. 5 THE BLUE EARDocumento4 pagineUda Lab. 5 THE BLUE EARCaterina ReggioNessuna valutazione finora
- Modello UdA definitivoICONDARIA ARTE IMMAGINEDocumento6 pagineModello UdA definitivoICONDARIA ARTE IMMAGINEArcangelo CapassoNessuna valutazione finora
- Com - Google.android - Apps.docs - Fetcher.fileprovider ZrUyBlRH RrOOBvnm8pbu-LyAGJ6BwSttTTdT77qrtgDocumento384 pagineCom - Google.android - Apps.docs - Fetcher.fileprovider ZrUyBlRH RrOOBvnm8pbu-LyAGJ6BwSttTTdT77qrtgRosaria AlbaNessuna valutazione finora
- Lo Stivale Di ModaINFO VARIATADocumento34 pagineLo Stivale Di ModaINFO VARIATAandrea50% (2)
- Cittàmedievali - Produzione e CommercioDocumento32 pagineCittàmedievali - Produzione e CommerciosaroNessuna valutazione finora
- COMUNICAREDocumento2 pagineCOMUNICAREEmma SikibàbaNessuna valutazione finora
- La Comunicazione Sentimentale Un Nuovo Metodo Pedagogico: L’Educazione delle Emozioni e dei Sentimenti per l’Insegnamento della ComunicazioneDa EverandLa Comunicazione Sentimentale Un Nuovo Metodo Pedagogico: L’Educazione delle Emozioni e dei Sentimenti per l’Insegnamento della ComunicazioneNessuna valutazione finora
- Il Disegno A Mano LiberaDocumento102 pagineIl Disegno A Mano Liberaana100% (3)
- La ri-mediazione digitale nell’esperienza museale scientificaDa EverandLa ri-mediazione digitale nell’esperienza museale scientificaNessuna valutazione finora
- Progetto EducARTiamoci-Relazione Finale DolDocumento5 pagineProgetto EducARTiamoci-Relazione Finale DolClementina CroccoNessuna valutazione finora
- Arte DigitaleDocumento58 pagineArte DigitaleLuke MartiniNessuna valutazione finora
- Specimen QuiItalia ItDocumento96 pagineSpecimen QuiItalia ItFrancescoForini100% (2)
- Digital Storytelling con Scratch: raccontare storie facendo codingDa EverandDigital Storytelling con Scratch: raccontare storie facendo codingNessuna valutazione finora
- Tra teoria delle ombre e percezione visiva: Unità didattica per competenze trasversaliDa EverandTra teoria delle ombre e percezione visiva: Unità didattica per competenze trasversaliNessuna valutazione finora
- Preview PDFDocumento65 paginePreview PDFAnonymous XW6aq99INessuna valutazione finora
- Fashionable EnglishDocumento22 pagineFashionable Englishvaleria perez100% (1)
- Specimen QuiItalia ItDocumento96 pagineSpecimen QuiItalia Itflorenciab6433% (3)
- Mediatori IconiciDocumento6 pagineMediatori IconiciCinzia BocchiNessuna valutazione finora
- Comunicazione VisivaDocumento28 pagineComunicazione Visivacaterina guariniNessuna valutazione finora
- Unità Didattica Passato Trapassato Imperfetto PDFDocumento36 pagineUnità Didattica Passato Trapassato Imperfetto PDFMario RossiNessuna valutazione finora
- Lezione 1 Chiaro b1Documento23 pagineLezione 1 Chiaro b1Abril Beatle100% (1)
- Archicad ManualeDocumento293 pagineArchicad ManualeMario FriscoNessuna valutazione finora
- Il Mio CurriculumDocumento4 pagineIl Mio Curriculumhicetnunc_1Nessuna valutazione finora
- Ridipintura: Colmare le lacune nella visione artificialeDa EverandRidipintura: Colmare le lacune nella visione artificialeNessuna valutazione finora
- VolumeDocumento337 pagineVolumealessadrocapelliNessuna valutazione finora
- Le tecnologie digitali al servizio della conservazione: Dall'integrazione scultorea al restauro virtualeDa EverandLe tecnologie digitali al servizio della conservazione: Dall'integrazione scultorea al restauro virtualeNessuna valutazione finora
- UniversItalia 2.0 Guida 1 34712Documento128 pagineUniversItalia 2.0 Guida 1 34712Aléxia AndradeNessuna valutazione finora
- Allegato A Programmi Concorso 2016 PDFDocumento300 pagineAllegato A Programmi Concorso 2016 PDFGioseffoZarlinoNessuna valutazione finora
- Tesina Pedagogia: Lezione Teorico-Pratica Con Laboratorio TeatraleDocumento25 pagineTesina Pedagogia: Lezione Teorico-Pratica Con Laboratorio TeatraleGabriele PisanoNessuna valutazione finora
- Un percorso del fare 4: Verso una rinnovata cultura tecnologicaDa EverandUn percorso del fare 4: Verso una rinnovata cultura tecnologicaNessuna valutazione finora
- Il Caffè Letterario - PDFDocumento78 pagineIl Caffè Letterario - PDFVX56% (9)
- Prospettiva TeoriaDocumento33 pagineProspettiva TeorianicoleNessuna valutazione finora
- B3600 Balboni Estratto TestoDocumento34 pagineB3600 Balboni Estratto TestoNoemiCoccoNessuna valutazione finora
- Riassunto Adrian Forty Words and BuildingsDocumento38 pagineRiassunto Adrian Forty Words and BuildingsENRICA PRATAVIERA100% (1)
- COMUNICAZIONE COORDINATA PER I BENI CULTURALI 4 Progetti Italiani - Francesco GuidaDocumento39 pagineCOMUNICAZIONE COORDINATA PER I BENI CULTURALI 4 Progetti Italiani - Francesco GuidadnmarinoNessuna valutazione finora
- Avviso Procedure Di Selezione Pubblica - Graduatorie Interne Insegnamenti A ContrattoDocumento34 pagineAvviso Procedure Di Selezione Pubblica - Graduatorie Interne Insegnamenti A ContrattoFrancescoMarianoNessuna valutazione finora
- Design e Metodologia ProgettualeDocumento46 pagineDesign e Metodologia ProgettualeesmerildoNessuna valutazione finora
- Do 33 Program Ma Basic Design 08 09Documento6 pagineDo 33 Program Ma Basic Design 08 09crimivaNessuna valutazione finora
- Arte E ImmagineDocumento51 pagineArte E ImmagineMario BuonafedeNessuna valutazione finora
- UDA Linguaggi PDFDocumento6 pagineUDA Linguaggi PDFSilvia Di PaoloNessuna valutazione finora
- UDA Linguaggi PDFDocumento6 pagineUDA Linguaggi PDFSilvia Di PaoloNessuna valutazione finora
- Mario Docci, Emanuela Chiavoni - Saper Leggere L'architettura (2017)Documento224 pagineMario Docci, Emanuela Chiavoni - Saper Leggere L'architettura (2017)Luca HuettenmoserNessuna valutazione finora
- Viaggiamo1 GuidaDocumento186 pagineViaggiamo1 Guidaitaliano intermedioNessuna valutazione finora
- IIIC VulcaniDocumento9 pagineIIIC VulcaniGIUSEPPE LICCARDONessuna valutazione finora
- L C Progetto Di Potenziamento Di Storia Dellarte Iva ProtDocumento5 pagineL C Progetto Di Potenziamento Di Storia Dellarte Iva ProtPeppe BencivengaNessuna valutazione finora
- La Vita Di LeonardoDocumento22 pagineLa Vita Di LeonardoconstanzaNessuna valutazione finora
- Ceramica e Vie Di Comunicazione Nell'italia BizantinaDocumento28 pagineCeramica e Vie Di Comunicazione Nell'italia BizantinaLycophronNessuna valutazione finora
- NeoimpressionismoDocumento9 pagineNeoimpressionismoelisaNessuna valutazione finora
- Libro Sicilia 2010 IngleseDocumento159 pagineLibro Sicilia 2010 IngleseDaniel BelingherNessuna valutazione finora
- Scegliere I Font Per I Nostri ProgettiDocumento4 pagineScegliere I Font Per I Nostri Progettihal9000.1969Nessuna valutazione finora
- Animal Crossing New Leaf (Italian Electronic Manual)Documento57 pagineAnimal Crossing New Leaf (Italian Electronic Manual)Alberto CoriNessuna valutazione finora
- ASTRATTISMODocumento6 pagineASTRATTISMOLeonardo TovoNessuna valutazione finora
- Edifici Storici Vietati A Napoli Perchè in Rovina o Per Altre CauseDocumento4 pagineEdifici Storici Vietati A Napoli Perchè in Rovina o Per Altre CausedonpedrodetoledoNessuna valutazione finora
- Comic-Soon 12Documento16 pagineComic-Soon 12Daniele MancinoNessuna valutazione finora
- Andrea SabatiniDocumento7 pagineAndrea SabatiniTiziano LicataNessuna valutazione finora
- Zbrush ITADocumento33 pagineZbrush ITAmarcoavellinoNessuna valutazione finora