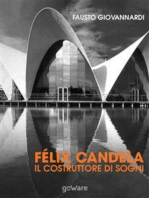Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Appunti Storia Dellarchitettura II Lart Nouveau Aa 20152016
Caricato da
ducioxCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Appunti Storia Dellarchitettura II Lart Nouveau Aa 20152016
Caricato da
ducioxCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|2098537
Appunti - Storia dell'architettura II - L'Art Nouveau - a.a.
2015/2016
Storia dell'Architettura II (Università degli Studi di Salerno)
Distribuzione proibita | Scaricato da Sebastiano Caltabiano (essebic71@gmail.com)
lOMoARcPSD|2098537
L’Art Nouveau
Quello che va sotto il nome di Art Nouveau è un movimento che nasce in Belgio intorno agli
anni ’80 dell’Ottocento. In architettura questa corrente si esprime con il rifiuto di stili storici
appartenenti a epoche diverse: gli architetti si ispirano direttamente alla natura; preferiscono la linea
continua che deve però essere curva e ondulata; credono che l’architettura non deve essere
dissociata dalle altre arti. Comincia, inoltre, a nascere la concezione che l’architetto non deve
disegnare solo la struttura dell’edificio ma anche l’arredamento, deve gestire, insomma, tutto il
processo di creazione. Lo scopo di quest’ideologia è quello di dare vita a edifici di alta qualità
applicando le tecniche della nascente produzione industriale.
Art Nouveau è il termine usato per caratterizzare il movimento in Francia, ma questa corrente
assunse nomi e caratteri diversi in tutti i paesi europei: Jugent Stil in Germania; Modernismo in
Spagna, Modern Style in Inghilterra, Liberty in Italia; Secessione in Austria.
Le origini dell’Art Nouveau sono da ricercare:
- Nella ricerca di molti architetti ottocenteschi dell’imitazione e ricreazione delle forme
naturali, in particolare attraverso l’uso del metallo;
- Nelle arti grafiche (soprattutto in Inghilterra), e nei caratteri usati nelle stampe;
- Nel movimento Arts & Crafts, a cui apparteneva William Morris, progettista della Casa
rossa, in cui gli elementi più importanti dovevano essere la pianta e la disposizione interna:
l’esterno ne doveva essere la conseguenza inevitabile. Morris disegnò tutti gli elementi della
casa, dalla carta da parati ai pavimenti, ispirandosi alle forme della natura. Gli Arts & Crafts
cercavano di recuperare l’artigianato artistico in maniera tale da contrapporsi alla recente e
dirompente industrializzazione. Già in questa esperienza si nota come non vi siano
riferimenti storici ma solo la ricerca di un buon modo di abitare, di elementi semplici;
- Nell’arte orientale, riproposta in molte esposizioni londinesi della seconda metà dell’800.
Prima della data ufficiale della nascita dell’Art Nouveau (1893) vi sono degli architetti i quali già
sembrano applicare questo nuovo gusto: si ricorda ad esempio il frontespizio del libro sulle chiese
di Londra di Mackmurdo del 1883, con delle rappresentazioni floreali, in particolare tulipani, che
anticipò le espressioni artistiche più compiute della fine del secolo.
Per definire l’Art Nouveau è possibile elencare una serie di temi molto vicini a quella che è la
sensibilità di questo movimento: l’Art Nouveau è un movimento romantico che rifiuta il dominio
della ragione prediligendo il sentimento; è una corrente che esalta l’individualismo, ed è infatti
caratterizzata da espressioni architettoniche uniche per ogni città e diverse all’interno della carriera
di uno stesso architetto; è un movimento antistorico,perché rifiuta il riferimento agli stili del
passato, e sociale perché è un tipo di arte rivolta al popolo. Inoltre è una cultura che accetta
fortemente il progresso e fa ricorso alle tecniche industriali più moderne, facendo uso dei nuovi
materiali: sarà molto utilizzato il metallo, spesso lasciato a vista e modellato secondo forme curve e
sinuose.
Sia in Francia che in Belgio si tratta di un’arte che si ispira alla natura e agli elementi vegetali e
floreali. Nei paesi anglosassoni, le forme sono più geometriche e rettilinee e perdono l’organicità
dei disegni francesi e belgi: gli elementi sono più stilizzati e astratti. In Spagna è l’aspetto scultoreo
a prendere il sopravvento sulla bidimensionalità. In Italia è un’architettura più storicista e molto
floreale dal momento che il fiore è la matrice degli elementi decorativi.
Victor Horta
Victor Horta è un architetto belga che studio all’Accademia delle Belle Arti di Bruxelles e
che ebbe il merito di realizzare l’opera considerata il primo esempio di architettura Art Nouveau.
Distribuzione proibita | Scaricato da Sebastiano Caltabiano (essebic71@gmail.com)
lOMoARcPSD|2098537
Casa Tessel (1893), Bruxelles
Quest’edificio sorge su di un lotto abbastanza profondo e affaccia su di una strada con
edifici tutti allineati ed ha la particolarità di presentare un avancorpo centrale che lo rende unico e
diverso da quelli vicini. L’architetto decise di dividere la facciata in tre parti, tra le quali quella
centrale, aggettante, è caratterizzata per l’utilizzo di elementi metallici, dipinti di verde, molti dei
quali sono modellati già con il riferimento alle forme della natura, e rimandano a questo nuovo
gusto. Il riferimento alle forme vegetali e floreali è ampiamente ripreso all’interno, nei sostegni,
nelle scale, nella carta da parati, nei pavimenti. Qui decorazione e struttura sono coincidenti:
l’elemento strutturale viene lavorato per essere non solo sostegno, ma anche decorazione e
ornamento.
Nella carta da parati della sala da pranzo si può notare una decorazione in stile inglese, a
testimonianza che l’architetto conosceva questa tendenza, indice di una notevole circolazione delle
informazioni.
Casa del Popolo (1896-99, demolita nel 1964), Bruxelles
In quest’opera il metallo è utilizzato strutturalmente e, allo stesso tempo, dal punto di vista
decorativo. Il programma di questo edificio (sede del partito socialista belga) era quello di far
diventare l’aria e la luce gli elementi fondamentali della realizzazione, in contrapposizione con gli
edifici bui e insalubri delle abitazioni degli operai che avrebbero vissuto quel luogo.
Il palazzo sorge su di un lotto che affaccia su una piazza, ed è delimitato da due strade che in
maniera radiale confluiscono in quest’ultima. La costruzione presenta quindi una parte concava, una
leggera parte convessa sulla quale è collocata l’entrata, e dei lati rettilinei. Il metallo utilizzato in
facciata, che si adatta alle curve di questa, si sposa con altri materiali in maniera tale da sottolineare
la presenza di elementi diversi.
All’interno, il luogo più importante è rappresentato da un auditorium, collocato tra terzo e quarto
piano, che, per una parte, è a sbalzo sul cortile esterno. La particolarità sta nell’utilizzo di travi
incurvate che sostengono l’edificio ma che sono, al tempo stesso, delle decorazioni, e risiede anche
nell’illuminazione paragonabile a quella delle cattedrali gotiche, il cui metodo costruttivo è
echeggiato dalla disposizione dei pilastri metallici prima descritti.
Hector Guimard
L’architetto più famoso dell’Art Nouveau francese è senza dubbio Hector Guimard. Fu
allievo della Scuola delle Arti decorative e poi di quella delle Belle Arti e fu discepolo di Viollet-le-
Duc (nella Scuola del Sacro Cuore del 1855 aveva progettato, come sostegni per i piani alti, dei
supporti a V ripresi dalle illustrazioni degli Entretiens di Viollet-le-Duc, depurati dai problemi
strutturali che i progetti di quest’ultimo presentavano).
Guimard diventò ben presto il rappresentante dell’Art Nouveau francese e divenne celeberrimo per
il progetto delle entrate delle stazioni della nascente metropolitana parigina.
Castel Berangèr, Parigi
Nel progetto di quest’opera, Guimard sperimentò il nuovo gusto ispirato all’elemento
floreale, ricorrendo all’uso del metallo. La forma di questo edificio ricorda i castelletti medievali;
esso è collocato in una strada abbastanza grande con una facciata che dà su di una strada chiusa. La
prima cosa che si può notare è l’utilizzo di materiali diversi (pietra, mattoni, metallo, pietra
sbozzata) al fine di caratterizzare elementi differenti e ciò dà l’impressione di essere davanti a un
collage di volumetrie. In origine la costruzione era stata adibita ad appartamenti in affitto.
Giumard aveva viaggiato in Belgio ed era rimasto impressionato dalla Casa Tessel di Horta, in cui
struttura e decorazione coincidevano in maniera straordinaria. Per questo motivo decise, in corso
d’opera, di modificare concettualmente il suo edificio, che doveva essere abbastanza economico,
che colpì i primi osservatori per la bizzarria delle forme e per la diversità rispetto all’omogeneità e
la monocromia degli edifici haussmanniani. La volontà di Guimard è stata quella di creare un’opera
Distribuzione proibita | Scaricato da Sebastiano Caltabiano (essebic71@gmail.com)
lOMoARcPSD|2098537
unica, e per far ciò realizzò, all’interno dello stesso edificio, piani diversi l’uno dall’altro, nelle
finestre e nelle decorazioni. Contemporaneamente si nota la volontà, abbastanza razionalista, di
mostrare, già a partire dalla facciata, la disposizione interna, come nelle finestre che illuminano la
scala, disposte obliquamente. Guimard gestì tutto il processo di creazione dell’edificio, progettando
anche gli arredi. Celebre è l’entrata principale, in metallo, in cui si ritrova il cosiddetto “colpo di
frusta”, ovvero il passaggio repentino della decorazione dalla forma rettilinea a quella curva.
È un edificio che si oppone profondamente al regolamento edilizio dell’epoca precedente che
imponeva costruzioni tutte uguali e piatte.
L’esperienza del Castel Berangèr condurrà Guimard a pubblicare un libro che farà da
manuale e da repertorio per il disegno di questo nuovo tipo di decorazioni e di arredi.
Ma l’apice della carriera Guimard lo tocca quando viene incaricato del progetto delle entrate della
metropolitana. Vi erano tre categorie diverse: il modello semplice, il modello semplice coperto, e il
modello chiuso con spazi adibiti a biglietteria e sala d’aspetto. Il modello semplice e le sue forme
evocanti le ali di una libellula poteva essere l’elemento simbolico che rimandava alla velocità del
nuovo mezzo di trasporto.
Negli ultimi edifici realizzati, Guimard abbandonò le forme curvilinee prediligendo quelle
geometriche.
Nel progetto per la sua casa, che sorge su di un lotto triangolare con la vista su due lati, gli spazi
disegnati, anche in pianta, sono curvilinei (come la sala da pranzo e il salotto), cercando di sfruttare
l’irregolarità del lotto. Egli riuscì anche a ricavare due entrate, una per i proprietari e una per la
servitù, differenti per dimensioni. L’edificio è realizzato con dei mattoni bianchi e la facciata è
caratterizzata da una certa dinamicità. Nella strada laterale trovavano luogo la stanza della signora
Guimard e il suo atelier: si nota come le aperture siano differenti da un piano all’altro per
assecondare la volontà dell’architetto di creare qualcosa di unico
Nel suo ultimo edificio progettato, la sinagoga a Rue Pavèe (1913), sia per la destinazione
dell’edificio, sia perché era alla fine della sua carriera, Guimard pose un freno alla sua sconfinata
fantasia e si orientò verso una maggiore geometrizzazione e astrazione delle forme.
In Francia lo stile e il gusto Art Nouveau divenne sempre più carico e decorativo e sempre
più orientato ad una dissociazione tra struttura e decorazione. Si ricorda il palazzo a 29 avenue
Rapp a Parigi (1899-1901) di Jules Lavirotte, sulla cui facciata trova luogo un grande portale in stile
floreale con dei fusti che partono dal basamento e arrivano quasi alla metà delle finestre del primo
piano.
Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)
Rispetto alla situazione francese il caso inglese fu caratterizzato da dinamiche molto diverse
e sarà impersonato dall’architetto scozzese C. R. Mackintosh. Studente alla School of Art di
Glasgow, compì nel 1891 un viaggio in Italia, e tornato in patria acquisì fama come disegnatore di
elementi di arredo. Il suo nome è associato alla realizzazione della nuova School of Art di Glasgow.
School of Art (1899-1907, 1907-1909), Glasgow
Per la realizzazione di quest’edificio, costruito poi in due fasi per ragioni economiche, fu
indetto un concorso vinto da Mackintosh. In accordo con in direttore della scuola, l’intento del
progetto sarebbe dovuto essere quello di dare un aspetto più culturale che tecnico alla scuola e di
moltiplicare i luoghi di lavoro creativo per gli studenti. Il progetto doveva inoltre prevedere
l’utilizzo di questi locali anche nelle ore serali e doveva perciò fronteggiare il problema
dell’illuminazione artificiale, risolto poi con l’istallazione di lampade ad energia elettrica.
Il lotto era di forma irregolare, in pendenza, ed era delimitato da due strade. Le tre facciate vennero
concepite e disegnate come completamente diverse: in quella principale è collocata l’entrata mentre
le facciate laterali sono state paragonate a due rocce che cadono sull’acqua con una certa possenza e
Distribuzione proibita | Scaricato da Sebastiano Caltabiano (essebic71@gmail.com)
lOMoARcPSD|2098537
monumentalità, e presentano delle finestre collocate in maniera irregolare sui sette piani di altezza.
Le facciate vogliono riprendere i modelli delle fortezze scozzesi e riproporre le torrette e gli
avancorpi di questa tipologia. Le tre facciate che danno sulla strada sono tutte in granito locale
mentre la quarta è in mattoni intonacati. La differenza tra prospetto est e prospetto ovest, realizzato
dieci anni più tardi rispetto al primo, è notevole soprattutto per la presenza di elementi aggettanti e
di bow window che corrispondono allo spazio della biblioteca.
La facciata principale è quella che presenta maggiormente gli elementi che caratterizzano l’Art
Nouveau. Nel prospetto della facciata si nota una certa asimmetria per la collocazione defilata della
porta. Tutto il lavoro sugli elementi metallici, le balaustre, i terrazzi, rimanda a quelle figure ispirate
alla natura proprie della corrente, anche se piuttosto tendenti alla geometrizzazione e all’astrazione.
All’interno le aule da disegno erano separate da dei tramezzi spostabili, il che permetteva di
modificare agilmente gli spazi interni, anticipando la pianta flessibile dell’architettura razionalista:
l’idea dell’astrazione che smaterializza le forme della natura è riproposta nella disposizione interna.
Ciò che differenzia Mackintosh dagli altri architetti che accettavano di buon grado il progresso e
l’industrializzazione è che lui si sentiva ancora legato alla produzione artigianale dell’elemento
unico, all’ideologia di Ruskin dell’opposizione alle nuove tecniche costruttive. Il lavoro di
Mackintosh tende ad accentuare la bidimensionalità nei disegni e nelle facciate. Questa tendenza si
troverà poi nell’architettura del movimento austriaco della Secessione mentre si contrapporrà alla
modernismo scultoreo e volumico catalano.
Si può dire che le idee e il modo di concepire l’architettura di Mackintosh accompagneranno e
favoriranno la transizione, in Scozia e in Austria, verso l’architettura moderna.
Joseph Maria Olbrich
Il caso austriaco è ugualmente importante. Tra gli esponenti della Secessione viennese è da
ricordare J. M. Olbrich, un artista di origine ceca che aveva viaggiato in Nord Africa e in Italia,
dove era rimasto colpito dalla solidità e dalla monumentalità degli edifici antichi; successivamente,
aveva compiuto un apprendistato presso Otto Wagner. Il suo lavoro è una continua ricerca di
mediazione tra la solidità e la monumentalità e la leggerezza. Tale leggerezza si materializza nella
copertura a sfera del Palazzo della Secessione, la realizzazione più celebre di Olbrich.
Palazzo della Secessione (1897-98), Vienna
La Secessione è un movimento che si poneva in contrapposizione agli insegnamenti
accademici e professava la necessità della collaborazione tra le arti e la voglia di infrangere la
schematica differenza operata fino ad allora tra arti maggiori ed arti minori.
L’edificio presenta delle pareti bianche e un impianto monumentale, sebbene sia costituito da
volumi molto semplici. È finemente decorato ed è caratterizzato da ornamenti dorati, adoperati per
accentuare la bidimensionalità. L’interno, relativamente semplice poiché si trattava di un luogo di
riunione e di esposizione, era realizzato in maniera tale che non vi fossero pareti portanti per poterlo
organizzare in funzione della destinazione d’uso.
Nel 1902, venne allestita una mostra in onore di Beethoven, con la creazione di una scenografia
degna di nota, e Gustav Klimt realizzò un fregio che correva lungo tre pareti dell’interno
dell’edificio e che doveva rappresentare, in maniera allegorica, il contenuto della nona sinfonia (le
tre Gorgoni, il gigante, la voluttà, la lussuria, l’incontinenza, l’angoscia, la redenzione impersonata
dal coro che celebra la gioia come manifestazione del divino), in cui ritorna l’uso del dorato.
L’altro grande architetto che partecipa inizialmente alla Secessione viennese è Otto Wagner,
il quale nella stazione della metropolitana di Karlsplaz (1898-99) riproduce gli stessi temi dell’Art
Nouveau della decorazione floreale, dell’uso del metallo lasciato a vista, della linea curva. Si nota
tuttavia una maggiore propensione alla bidimensionalità e alla geometrizzazione.
Distribuzione proibita | Scaricato da Sebastiano Caltabiano (essebic71@gmail.com)
lOMoARcPSD|2098537
Lo stile Liberty in Italia
L’architettura italiana liberty (da Arthur Liberty, fondatore di una ditta di oggetti di
arredamento di qualità ma con una produzione industriale) è anche detta anche stile floreale poiché
è l’elemento floreale ad essere l’oggetto preferito di disegnatori ed artisti.
Tra gli architetti italiani del movimento vi è Raimondo D’Aronco che costruì il padiglione centrale
all’esposizione Internazionale dell’Arte contemporanea di Torino.
Vi sono esempi di stile liberty ovunque in Italia: edifici molto carichi nella decorazione
(Sommaruga, Palazzo Castiglioni, Milano) che esprimono una grande volontà di decorare sena
cercare la coincidenza tra struttura e ornamento.
Un altro architetto italiano liberty è Ernesto Basile la cui realizzazione più celebre è Villino Florio a
Palermo (1899-1902). L’architettura liberty italiana non si distacca mai troppo dagli stili storici e
anche in questo esempio, l’architetto fa quasi un collage degli stili storici che dovevano rimandare
alle tappe dei viaggi e dei ricordi del suo committente, decorando il tutto con uno stile floreale che
doveva dare il tocco liberty all’edificio. L’architetto si occupò della progettazione di ogni cosa della
sua opera, dalla carta intestata del proprietario alle carte dei menu.
Antoni Gaudí (1852-1926)
Antoni Gaudí è l’incarnazione del modernismo catalano. Le sue realizzazioni sembrano
essere scaturite da due impulsi piuttosto contrastanti, il desiderio di far rinascere l’architettura locale
e la spinta a cercare forme espressive completamente nuove: in questo, senza dubbio, grazie alle sue
straordinarie doti di fantasia, Gaudí fu quasi unico. Nel 1873 entrò alla Facoltà di Architettura di
Barcellona e nel 1878 cominciò ad esercitare la professione nella città catalana, dove, a partire dal
1883, diresse la costruzione della sua opera più celebre, la Sagrada Familia.
Casa Batlò (1904), Barcellona
Gaudí progettò quest’edificio per un ricco commerciante di tessuti che era alla ricerca di un
architetto fantasioso che desse forma agli ambienti destinati alla sua attività e alla sua abitazione,
utilizzando, però, un edificio preesistente. Gaudí, essendogli stato negato il permesso a demolire
l’edificio in questione, manterrà solo la parte centrale della facciata di quest’ultimo e trasformerà
tutto il resto, adibendo i locali per il commercio al piano terra, l’abitazione al primo piano e, ai piani
superiori, tutti i restanti ambienti di servizio. Le sue forme sinuose e molto particolari hanno fatto si
che fosse paragonato ad un palazzo sottomarino, la cui struttura portante è avvolta da una pelle
scultorea; i balconi ricordano quasi la forma di una maschera: vi è un’immaginazione portata
all’estremo, fattore condizionante dell’architettura di Gaudí, che rappresentò una eccezione
sconvolgente all’interno della rigidità e della geometria degli edifici del Piano Cerdà.
Gli stessi interni riflettono una fortissima ricerca del movimento che non si ritrova nelle
composizioni geometrizzate degli altri architetti europei dell’Art Nouveau.
Casa Milà (1906-1912)
Questo grande palazzo fu progettato per una ricca coppia che voleva farsi costruire una
edificio che rappresentasse la loro casata. L’edificio, chiamato, in maniera dispregiativa, dagli
abitanti di Barcellona “la pedrera”, ovvero la pietraia, la cava, è ubicato lungo una strada molto
importante del capoluogo catalano, fatta realizzare da Cerdà, e si oppone con i suoi angoli smussati
alla regolarità degli edifici adiacenti. La struttura portante dei pilastri, che permette una
disposizione interna molto libera, è avvolta da dei muri liberi scolpiti.
La pianta si articola attorno a due grandi patii, uno ovale e uno circolare. Tale disposizione fu molto
innovativa per l’epoca poiché i cortili, al tempo, erano solitamente molto piccoli. I due patii avranno
quindi la funzione di due importanti cortili e le loro architetture sarà studiata al pari di quella delle
facciate esterne. Al seminterrato venne progettato un grande parcheggio, e Gaudí previde anche una
rampa carrabile che avrebbe permesso ad ogni inquilino di raggiungere il proprio appartamento.
Distribuzione proibita | Scaricato da Sebastiano Caltabiano (essebic71@gmail.com)
lOMoARcPSD|2098537
I balconi, in metallo, sono lavorati in maniera esuberante. Gaudí fu influenzato qui, come, del resto,
nel corso di tutta la sua carriera, dalla natura, la sua più grande fonte di ispirazione. Anche la
facciata retrostante, visibile solo dai palazzi confinanti, è scolpita ed è espressione di una volontà di
creare un effetto plastico. L’architettura dei cortili è estremamente qualificata. L’entrata principale,
costituita da una griglia in metallo, irregolare e organica, divide lo spazio esterno dai cortili dove vi
sono due scaloni per accedere all’appartamento dei Milà (1600 mq). La distribuzione interna è
molto flessibile: attorno ad ogni cortile, per ogni piano erano progettati due appartamenti. Tutti gli
appartamenti hanno in comune solo il corridoio lungo il cortile.
Gaudí decise che il metodo ascensionale prediletto sarebbe stato l’ascensore anche se nelle scale di
servizio si ritrova la linea curva e il movimento. Gaudí si inventò per la copertura la terrazza, per
costruire la quale furono realizzati una serie di archi di sostegno, si compone di elementi abbastanza
insoliti che ricoprono i camini, i vani scala, gli ascensori. Proprio per l’uso degli archi di sostegno,
la terrazza non è perfettamente piatta.
I picchi e i camini della casa Milà si levano sulla scacchiera razionale di Barcellona come la
sommità di una rupe dai fianchi ondulati, con un gesto ciclopico, il cui schiacciante senso di
pesantezza sembra contraddire la libertà e la finezza della distribuzione, attorno alle coorti di forma
irregolare.
L’Art Nouveau nel resto d’Europa. Il caso di Istanbul.
L’architettura Art Nouveau si diffuse in tutti i paesi europei, anche in città molto diverse.
Sono esempi degni di nota quello di Praga, città profondamente barocca (Casa municipale) e di
Istanbul, dove l’Art Nouveau proliferò dal 1900 e si protrasse fino alla fine degli anni ’20. in
Turchia, dove era stata forte, in architettura, l’influenza inglese e francese, fu aperta, nel 1883, una
Scuola di Belle Arti a Istanbul e da quel momento vi fu un deciso tentativo di recupero delle
tradizioni, i che diede vita ad un revival ottomano. E l’Art Nouveau venne accettata a braccia aperte
anche perché riusciva a sintetizzare quel sentimento di revival con l’aspirazione alla decorazione.
A Istanbul lavorò Raimondo D’Aronco, il quale realizzò numerosi edifici, come ad esempio la casa
Botter, ma la maggior parte degli edifici sono senza firme e, cosa più importante, si tratta di
semplici facciate: gli elementi dispositivi interni non sono contaminati dal gusto Art Nouveau,
anche se l’influenza di quest’ultima sarà tale che quel modo di trattare le superfici venne utilizzato
anche e soprattutto come simbolo di ricchezza e modernità.
A parte qualche paese in cui l’Art Nouveau assunse un carattere essenzialmente decorativo,
e anche se l’Art Nouveau è stato considerato un movimento chiuso in sé, è innegabile che essa, in
alcune sue manifestazioni, abbia permesso o comunque spianato la strada alla nascita delle
avanguardie e di un certo razionalismo in architettura.
Distribuzione proibita | Scaricato da Sebastiano Caltabiano (essebic71@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Movimento ModernoDocumento42 pagineMovimento ModernoBruna RonchettiNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Modern Architecture Since 1900 Capp 2 20Documento101 pagineRiassunto Libro Modern Architecture Since 1900 Capp 2 20ducioxNessuna valutazione finora
- ProtorazionalismoDocumento7 pagineProtorazionalismooggianniNessuna valutazione finora
- Interrogazione ArteDocumento25 pagineInterrogazione ArteFedericaNessuna valutazione finora
- Neoclassicismo e NeogoticoDocumento2 pagineNeoclassicismo e NeogoticoElisa RubessiNessuna valutazione finora
- Architettura XIX - XX SECOLODocumento172 pagineArchitettura XIX - XX SECOLOireire82Nessuna valutazione finora
- Curtis - 03 - La Ricerca Di Forme Nuove e Il Problema Dell - OrnamentoDocumento10 pagineCurtis - 03 - La Ricerca Di Forme Nuove e Il Problema Dell - OrnamentoSofia IaraNessuna valutazione finora
- Storia Dell Architettura Novecentesca IDocumento183 pagineStoria Dell Architettura Novecentesca IF.A. Kuphasael Thorosan100% (1)
- Art NouveauDocumento8 pagineArt Nouveauoggianni100% (1)
- AR.S - GS - I.4 - Dentro e Contro Il Nuovo Genere Architettonico - Gli Anni A Cavallo Del 900Documento6 pagineAR.S - GS - I.4 - Dentro e Contro Il Nuovo Genere Architettonico - Gli Anni A Cavallo Del 900Giovanni SalomoniNessuna valutazione finora
- ARCHITETTURA - Art Nouveau PDFDocumento8 pagineARCHITETTURA - Art Nouveau PDFseve75Nessuna valutazione finora
- 4) I Maestri Dei MaestriDocumento9 pagine4) I Maestri Dei MaestriGreta GiuffreNessuna valutazione finora
- Sa 22.11.2021Documento4 pagineSa 22.11.2021Mariachiara ButtòNessuna valutazione finora
- Le CorbusierDocumento26 pagineLe CorbusierJoshua BarbaciniNessuna valutazione finora
- 1.4 La Secessione Viennese. Otto Wagner e La Moderne Architektur, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffmann.Documento3 pagine1.4 La Secessione Viennese. Otto Wagner e La Moderne Architektur, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffmann.SilviaNessuna valutazione finora
- 25 FunzionalismoDocumento22 pagine25 FunzionalismoManuNessuna valutazione finora
- Il Modernismo CatalanoDocumento11 pagineIl Modernismo CatalanoAngelo PalumboNessuna valutazione finora
- Art NuveauDocumento2 pagineArt Nuveautonicooper96Nessuna valutazione finora
- Architettura RazionalistaDocumento24 pagineArchitettura RazionalistagiorgioNessuna valutazione finora
- Arte Nel 900Documento3 pagineArte Nel 900alessandro marrero gonzalezNessuna valutazione finora
- 6 - MinimalismoDocumento1 pagina6 - MinimalismogiiullioNessuna valutazione finora
- BERLAGEDocumento6 pagineBERLAGEJosé NunesNessuna valutazione finora
- Ultima LezioneDocumento2 pagineUltima LezioneGigione MonteneroNessuna valutazione finora
- L'art Nouveau (Arte)Documento2 pagineL'art Nouveau (Arte)AriannaNessuna valutazione finora
- Art Noveau PDFDocumento7 pagineArt Noveau PDFchiarachierchiacNessuna valutazione finora
- Il Razionalismo, Le Corbousier, WrightDocumento27 pagineIl Razionalismo, Le Corbousier, WrightGiulia ContuNessuna valutazione finora
- Storia Architettura ContemporaneaDocumento46 pagineStoria Architettura ContemporaneaChiara DiomaiutoNessuna valutazione finora
- Opere in Stile Liberty, Tutto Ciò Che C'è Da SapereDocumento3 pagineOpere in Stile Liberty, Tutto Ciò Che C'è Da SapereAleNessuna valutazione finora
- Mappa 09 Architettura NeoclassicaDocumento1 paginaMappa 09 Architettura Neoclassicaciccio pasticcio100% (1)
- 09 Viollet - Le-Duc La Produzioneteorica Il DictionnaireDocumento13 pagine09 Viollet - Le-Duc La Produzioneteorica Il DictionnaireSimone DeveNessuna valutazione finora
- 1463 2013 359 17775 PDFDocumento47 pagine1463 2013 359 17775 PDFAna Paula FarahNessuna valutazione finora
- Architettura Della Prima Eta' Della MacchinaDocumento10 pagineArchitettura Della Prima Eta' Della MacchinaGianluca BuzziNessuna valutazione finora
- L'apertura Al Tema Della CittàDocumento7 pagineL'apertura Al Tema Della CittàvorincNessuna valutazione finora
- Movimento ModernoDocumento4 pagineMovimento ModernooggianniNessuna valutazione finora
- (Ebook - Architettura - ITA - PDF) Storia Dell'Architettura ContemporaneaDocumento46 pagine(Ebook - Architettura - ITA - PDF) Storia Dell'Architettura Contemporaneapedro41Nessuna valutazione finora
- Horta - Van de Velde - GuimardDocumento7 pagineHorta - Van de Velde - GuimardAradialevanahNessuna valutazione finora
- Lezione Palladianesimo, Da Settecento A OttocentoDocumento6 pagineLezione Palladianesimo, Da Settecento A OttocentoChiara BandelloNessuna valutazione finora
- Storia D'architetturaDocumento7 pagineStoria D'architetturaKevin FardinNessuna valutazione finora
- Arte e Industria Nascita Design-LibreDocumento9 pagineArte e Industria Nascita Design-LibreLucio RastaNessuna valutazione finora
- Alvar AaltoDocumento8 pagineAlvar AaltogigipalestiniNessuna valutazione finora
- Gropius, Breuer, Mies Van Der Rohe: Le Opere, AppuntiDocumento6 pagineGropius, Breuer, Mies Van Der Rohe: Le Opere, Appuntigeom.dellasantaNessuna valutazione finora
- Architettura OttocentescaDocumento2 pagineArchitettura OttocentescaAlex NonniNessuna valutazione finora
- Le CorbusierDocumento9 pagineLe CorbusiergigipalestiniNessuna valutazione finora
- Dal Trattato Al Manuale Architetti Light PDFDocumento42 pagineDal Trattato Al Manuale Architetti Light PDFStefania RinaldiNessuna valutazione finora
- Arte Nella Fine Del Settecento e OttocentoDocumento10 pagineArte Nella Fine Del Settecento e OttocentoLucia BorrelloNessuna valutazione finora
- Art Nouveau PDFDocumento5 pagineArt Nouveau PDFSara SuciNessuna valutazione finora
- ArteDocumento32 pagineArtepaola.giannasiNessuna valutazione finora
- Il Liberty A TorinoDocumento3 pagineIl Liberty A TorinoFederica Tammarazio0% (1)
- Art NouveauDocumento4 pagineArt NouveaucagarenzioNessuna valutazione finora
- Storia Dell'architettura e Dell'urbanisticaDocumento63 pagineStoria Dell'architettura e Dell'urbanisticaMarina P.Nessuna valutazione finora
- Notre Dame Du Haut - RonchampDocumento46 pagineNotre Dame Du Haut - RonchampGiacomo Bergonzoni50% (2)
- Storia Dell'architettura ModernaDocumento3 pagineStoria Dell'architettura Modernavera.padulazziNessuna valutazione finora
- LibertyDocumento2 pagineLibertyAnthony ScandurraNessuna valutazione finora
- Frommel Sulla Nascita Del Disegno Architettura 1994Documento21 pagineFrommel Sulla Nascita Del Disegno Architettura 1994Gladys LamparelliNessuna valutazione finora
- Appunti Storia Dell'Architettura ContemporaneaDocumento5 pagineAppunti Storia Dell'Architettura ContemporaneaAlexandru TudorNessuna valutazione finora
- Ooooottttimo - Guidelines - Italian VersionDocumento184 pagineOoooottttimo - Guidelines - Italian VersionducioxNessuna valutazione finora
- Otttimo Scaffolding - 12 - LupiaDocumento7 pagineOtttimo Scaffolding - 12 - LupiaducioxNessuna valutazione finora
- 5Documento5 pagine5ducioxNessuna valutazione finora
- IndiceDocumento5 pagineIndiceducioxNessuna valutazione finora
- ArmataDocumento5 pagineArmataducioxNessuna valutazione finora
- Costituzione Costituzione Dell'anno VIII: Il Codice NapoleonicoDocumento5 pagineCostituzione Costituzione Dell'anno VIII: Il Codice NapoleonicoducioxNessuna valutazione finora
- Napoleone Bonaparte: Jump To Navigationjump To Search Disambiguazione Napoleone (Disambigua)Documento5 pagineNapoleone Bonaparte: Jump To Navigationjump To Search Disambiguazione Napoleone (Disambigua)ducioxNessuna valutazione finora
- Il Significato Dei Tarocchi Dell'Imperatrice - Amore, Futuro, Sentimenti e Altro - Lisa Boswell-1Documento1 paginaIl Significato Dei Tarocchi Dell'Imperatrice - Amore, Futuro, Sentimenti e Altro - Lisa Boswell-1ducioxNessuna valutazione finora
- Modifica Modifica Wikitesto: MusicheDocumento4 pagineModifica Modifica Wikitesto: MusicheducioxNessuna valutazione finora
- Modifica Modifica Wikitesto: ProduzioneDocumento3 pagineModifica Modifica Wikitesto: ProduzioneducioxNessuna valutazione finora
- I Criteri Di Progetto Safe-Life, Fail-Safe, Damage Tolerance, Hanno Lo ScopoDocumento1 paginaI Criteri Di Progetto Safe-Life, Fail-Safe, Damage Tolerance, Hanno Lo ScopoducioxNessuna valutazione finora
- Un Cenno Al Passato e Uno Sguardo Al PresenteDocumento1 paginaUn Cenno Al Passato e Uno Sguardo Al PresenteducioxNessuna valutazione finora
- I Criteri Di Progetto Safe-Life, Fail-Safe, Damage Tolerance, Hanno Lo ScopoDocumento1 paginaI Criteri Di Progetto Safe-Life, Fail-Safe, Damage Tolerance, Hanno Lo ScopoducioxNessuna valutazione finora
- Riassunto Psicologia Del Bambino Maltrattato - OrganizedDocumento25 pagineRiassunto Psicologia Del Bambino Maltrattato - OrganizedMassimo Felizzoli100% (1)
- I Beati PaoliDocumento3 pagineI Beati PaoliDario Daddà Turres100% (1)
- Legno Esempio Di Calcolo PortaleDocumento13 pagineLegno Esempio Di Calcolo PortaleserafiniNessuna valutazione finora
- Wiki Vangelo Di TommasoDocumento2 pagineWiki Vangelo Di TommasoScarbNessuna valutazione finora