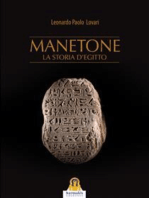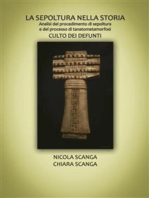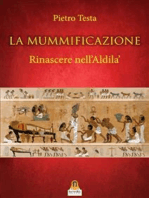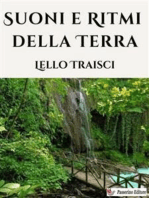Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Funerale
Caricato da
Max Berger0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
171 visualizzazioni6 pagineil funerale nell'antica Roma
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
RTF, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoil funerale nell'antica Roma
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato RTF, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
171 visualizzazioni6 pagineIl Funerale
Caricato da
Max Bergeril funerale nell'antica Roma
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato RTF, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 6
RITI:
Il funerale -
Nel momento del trapasso il parente pi prossimo dava l'ultimo bacio al
moribondo per raccogliere l'ultimo respiro con il quale l'anima
abbandonava il corpo e poi gli chiudeva gli occhi. Da questo istante il
nome del defunto veniva ripetuto a gran voce ad intervalli (conclamatio)
fino al momento della sepoltura. Alle lamentazioni partecipavano le donne
della famiglia, ma anche estranee (praeficae) pagate per questa
prestazione; oltre ad esternare il dolore per la perdita della persona cara,
questo rituale aveva lo scopo di accertare il decesso e scongiurare il
pericolo di una morte apparente (Serv., Aen., VI, 218). Il corpo, quindi, era
sollevato dal letto e deposto in terra (depositio), di seguito lavato, trattato
con unguenti per ritardarne la decomposizione (unctura) e preparato per
l'esposizione sul letto funebre (prothesis). In questa fase veniva posta
nella bocca del cadavere una moneta che sarebbe servita per pagare al
traghettatore Caronte il passaggio nell'aldil. Numerose testimonianze
confermano questa usanza, conservatasi fino in et tardoantica e
altomedievale, in tutto il bacino del Mediterraneo, ma anche nelle
province occidentali dell'Impero. Il trasporto del defunto avveniva con il
feretrum portato a spalla da quattro fino ad otto portatori, scelti tra gli
amici e i parenti maschi del defunto; seguivano i partecipanti vestiti con
abiti neri, detti lugubria, suonatori e praeficae. Le descrizioni di Polibio (VI,
53) e Plinio il Vecchio (Nat. hist., XXXV, 6), entrambe relative a personaggi
appartenenti a classi sociali elevate, informano sull'usanza di esporre
durante il funerale i ritratti degli antenati, secondo le norme dello ius
imaginum; dopo il funerale le immagini, realizzate in cera (expressi cera
vultus), venivano riposte all'interno di armadi nell'atrio della casa. Lo
svolgimento delle esequie, a seconda della disponibilit finanziaria della
famiglia, era affidato a professionisti, libitinarii (da Libitina, la divinit dei
funerali nel cui tempio erano conservati i registri mortuari) e pollinctores;
nel caso di funerali particolarmente sfarzosi i dissignatores, quali maestri
del cerimoniale, provvedevano all'organizzazione. La scelta
dell'inumazione o della cremazione non influiva sulle fasi fin qui descritte
del rituale. Giunto sul luogo dell'inumazione, prima di procedere al
seppellimento, veniva gettato sul cadavere un pugno di terra; questo
gesto garantiva il contatto tra il defunto e la terra anche nel caso in cui il
corpo non venisse deposto direttamente al suolo, ma collocato nella cassa
di un sarcofago che poteva essere di marmo, pietra, terracotta, legno o
piombo. Il contatto con la terra, anche se solo simbolico, era fondamentale
per la sua funzione purificatrice. Per questo motivo, se il defunto doveva
essere cremato, almeno una parte del corpo, quasi sempre un dito, veniva
tagliata (os resectum) e coperta di terra; alla fine del rogo la parte
asportata era riunita alle ceneri ed alle altre ossa combuste. Con la pratica
di questo rituale si pu spiegare la presenza nelle urne di una falange che
non mostra segni di combustione. Il rituale, dettagliatamente descritto da
Cicerone (Leg., II, 22, 55), Varrone (Ling., V, 23) e Festo, trova riscontro nel
cinerario di M. Nonio Balbo ad Ercolano e in molte altre sepolture pi umili,
quali un gruppo di olle rinvenuto a San Cesareo, due casi dalla necropoli
Esquilina e altre tombe trovate recentemente a Roma e ad Ostia. La
cremazione del cadavere avveniva insieme con il letto funebre sul quale
era stato trasportato e poteva aver luogo nel sito del seppellimento
(bustum sepulcrum) oppure in luoghi approntati per lo svolgimento di
questa pratica funeraria, detti ustrina. Nella necropoli orientale di Augusta
Praetoria (Aosta) stato individuato, nel 1973, il sito di una sepoltura
contenente i resti del rogo funebre, tra i quali centinaia di frammenti di
osso lavorato pertinenti al rivestimento del letto funerario; altri frammenti
sono stati ritrovati nell'urna di bardiglio che conteneva le ossa combuste.
Il letto, risalente ai primi decenni del I sec. d.C., appartiene al tipo degli
esemplari rinvenuti nelle necropoli dell'Esquilino, di Ostia, di Pompei, di
Vindonissa, di Colonia; era decorato da figure del repertorio dionisiaco e
da elementi vegetali finemente intagliati. Prima della cremazione
venivano aperti gli occhi al defunto, si collocava il corpo sulla pira
costruita in legno insieme con doni ed oggetti personali, quindi gli astanti
gridavano ancora una volta il suo nome e con le torce veniva appiccato il
fuoco. Spento il rogo, i resti combusti erano raccolti nelle urne cinerarie;
anche per questi contenitori esisteva un'ampia variet di materiali e
forme, dai pi umili contenitori di terracotta ai preziosi esemplari di
marmo decorati a rilievo. Il termine funus definiva quanto avveniva tra la
morte e il compimento delle esequie. Naturalmente lo svolgimento del
rituale presentava variazioni rispetto al funerale tradizionale ( funus
translaticum) nel caso di personaggi pubblici ( funus publicum), di militari
( funus militare), dell'imperatore o di membri della famiglia imperiale
( funus imperatorium). I funerali pubblici erano riservati a personaggi di
alto rango meritevoli di onori particolari, quali la lettura di un panegirico,
l'intonazione di canti e la partecipazione al corteo di membri della
magistratura e di grandi folle di soldati e cittadini comuni. Cos avvenne
per la morte di Silla secondo il racconto di Appiano (Bell. civ., I, 105-6). In
et imperiale a Roma i funerali pubblici furono piuttosto rari, se si
eccettuano le esequie degli imperatori, ma nelle citt italiche e nelle
province era pi frequente il conferimento di questo onore a personaggi
che si erano distinti in vita per meriti verso la cittadinanza, alla quale in
occasione del funerale venivano offerti spettacoli gladiatori o teatrali. Il
funerale dei soldati era pagato dai commilitoni con un contributo detratto
dalla loro paga; per i caduti in battaglia, invece, era prevista la
cremazione o la sepoltura collettiva; onori militari, cavalcate o marce
intorno alla pira erano riservati ai gradi pi alti della gerarchia militare
(Liv., V, 17, 5; Tac., Ann., II, 7). Dettagliate descrizioni di esequie imperiali
sono fornite dalle fonti letterarie e molte monete coniate nella media et
imperiale riproducono le pire a pi piani degli imperatori con la legenda
CONSECRATIO. Lo stesso tema svolto in scala monumentale sul rilievo
capitolino raffigurante Sabina che ascende dalla pira al cielo e sulla base
della Colonna Antonina con l'apoteosi della coppia imperiale Antonino Pio
e Faustina Maggiore. Tra i monumenti che illustrano i momenti del rituale
funerario il rilievo di Amiternum (met I sec. a.C.) e i rilievi del sepolcro
degli Haterii (fine I - inizi II sec. d.C.) sono i pi esemplificativi
rispettivamente per l'esposizione del defunto e per il corteo funebre. A
questi due esempi si aggiunge un gruppo di sarcofagi della media et
antonina decorati sulla fronte da scene di conclamatio.
Il culto dei defunti - La frattura rappresentata dalla morte all'interno della
famiglia e del corpo sociale doveva essere sanata attraverso un rituale
volto a purificare la famiglia del defunto dalla contaminazione della morte.
La suffitio, alla quale erano sottoposti i parenti al ritorno dal funerale, era
solo la prima di una serie di cerimonie di purificazione che aveva luogo
nella casa del defunto ( feriae denicales). Sempre nello stesso giorno del
funerale si consumava il primo banchetto funebre (silicernium). Il periodo
di lutto durava nove giorni e terminava con un secondo banchetto, la cena
novendialis, durante la quale veniva offerta una libagione ai Manes e
lasciate offerte alimentari. Cerimonie funebri con banchetti presso la
tomba venivano celebrate in occasione del dies natalis del defunto e nei
Parentalia, periodo dal 13 al 21 febbraio, destinato alla commemorazione
dei morti; nell'ultimo giorno, detto dei Feralia, venivano portati doni e
offerte floreali. Il giorno successivo, il 22 febbraio, presso il sepolcro
veniva consumato un solenne banchetto riservato ai parenti pi stretti
(caristia o cara cognatio; Ovid., Fast., II, 617 ss.; Val. Max., I, 1, 8). Un'altra
ricorrenza dedicata ai defunti era quella dei Lemuria: durante i giorni 9, 11
e 13 di maggio i templi erano chiusi e non venivano celebrati matrimoni.
Anche in occasione dei Rosalia, festivit legata alla fioritura delle rose e
non esclusivamente funeraria, i sepolcri erano cosparsi di fiori. Nel rito
funerario l'omaggio vegetale associa il defunto alla rinascita della natura e
all'eterna primavera della vita ultraterrena; a questa simbologia riportano
gli encarpi che ornano cos frequentemente le tombe e i loro arredi. Come
anticipazione terrena dei Campi Elisi devono essere interpretati i giardini
che talvolta circondavano il sepolcro (cepotaphia), horti lussureggianti con
fiori e frutteti (pomaria), proprio come desiderava Trimalcione per la sua
tomba. Alcuni edifici sepolcrali erano dotati di spazi dedicati
all'espletamento del rituale; forni e pozzi, costruiti presso le tombe, erano
utilizzati per apprestare i banchetti funebri. A tale scopo erano destinati
letti, sedili e mense che nel caso della necropoli di Porto nell'Isola Sacra
sono realizzati in muratura davanti alla tomba e proprio presso queste
strutture stata rinvenuta una grande concentrazione di suppellettile
ceramica. Triclini in muratura sono riconoscibili anche a Pompei, nella
necropoli fuori Porta Ercolano, costruiti presso la tomba di C. Vibio
Saturnino. Durante i banchetti ai defunti era riservata una parte del cibo e
delle bevande che venivano introdotti nei fori praticati nella sepoltura e
dovevano raggiungere le ossa o le ceneri; questo rituale, descritto anche
da Virgilio (Aen., V, 76- 77), era molto diffuso e trova numerose
attestazioni in tutto il mondo romano. In Italia tra il I e il II sec. d.C. tombe
attrezzate con tubuli per le profusiones sono state rinvenute
particolarmente numerose nelle necropoli di Albintimilium, Ostia, Isola
Sacra e Pompei. Nelle sepolture individuali il condotto era costituito da un
tubo di terracotta, ottenuto dall'unione di due coppi o semplicemente da
un'anfora spezzata; in caso di sepolture collettive, invece, nelle tombe a
camera, il condotto per le libagioni era ricavato nel pavimento per
raggiungere simbolicamente tutti i defunti. La centralit del banchetto nel
rituale funerario confermata da un'ampia documentazione iconografica
fornita da pitture e rilievi che descrivono scene conviviali. Il banchetto,
svolto all'aperto con i convitati disposti intorno ad una mensa a forma di
sigma (stibadium), torna frequentemente a decorare i coperchi dei
sarcofagi, in particolare tra il III e il IV sec. d.C., e con lo stesso schema
compositivo viene adottato dall'iconografia conviviale cristiana. In alcuni
casi, in occasione del funerale o della commemorazione del defunto,
poteva essere celebrato un banchetto pubblico, offerto per volont
testamentaria del defunto stesso o per iniziativa dei familiari. Si tratta di
una forma di evergetismo nota in Grecia e ampiamente praticata a Roma
nella tarda et repubblicana, non dissimile dalle distribuzioni alimentari o
dall'organizzazione di spettacoli scenici o gladiatori; banchetti si
svolgevano in luoghi pubblici all'aperto, preferibilmente nei fori o nei
templi. Anche il banchetto funerario evergetico fu praticato dai cristiani, i
quali investirono questa usanza di un contenuto evangelico, inteso come
offerta caritatevole ai poveri. L'esagerata ostentazione del lusso nella
celebrazione dei funerali e delle ricorrenze in onore dei defunti, nonch la
ricchezza dei corredi deposti nella tomba erano condannate dall'opinione
pubblica e potevano essere punite dalla legge. L'iscrizione relativa al
sepolcro di Gaio Cestio (CIL VI, 1375) costituisce un esempio
dell'applicazione della lex Iulia sumptuaria (18 a.C.), la quale proibiva di
introdurre nel sepolcro oggetti di valore. Nell'osservanza di questa norma,
gli Attalica, i preziosi tessuti nominati nell'iscrizione, vennero venduti e
con il ricavato furono realizzate le statue poste presso il sepolcro.
Nonostante le limitazioni delle leggi suntuarie non di rado alcune tombe
hanno restituito veri e propri tesori. Il rinvenimento nel 1993 di un corredo
a Vallerano mostra analogie di rituale e di composizione con i corredi di
Crepereia Tryphaena e quello della cosiddetta "mummia di Grottarossa",
entrambi di epoca antonina. Oltre alla giovane et delle defunte, le
sepolture sono accomunate dalla deposizione dei corpi in sarcofagi di
marmo. I tre corredi comprendono tutti oggetti preziosi provenienti
dall'area siriana che in questa epoca sembra detenere il monopolio del
mercato degli oggetti di lusso a Roma. A questo ambito geografico riporta
anche il metodo di mummificazione della fanciulla di Grottarossa, per la
quale si deve escludere un procedimento di conservazione di tipo egiziano
con l'uso del natron; il corpo, infatti, fu trattato con resine e mirra,
sostanza resinosa aromatica proveniente dall'Arabia meridionale e
dall'Oman, ampiamente citata da Plinio. Il corredo collocato nella tomba
accompagnava il defunto nell'aldil con il conforto di oggetti personali cari
al defunto nella vita terrena. Nel periodo arcaico e durante l'et
repubblicana le leggi suntuarie limitano l'esibizione del lusso nelle tombe,
ma anche nel periodo imperiale difficilmente vengono sacrificati nei
corredi gioielli importanti, tranne piccoli oggetti, orecchini e anelli. In
questo senso gli esempi citati e pochi altri costituiscono un'eccezione,
presentando un corredo completo di monili, bambola d'avorio, oggetti da
toeletta d'ambra, unguentari, specchio, pettini, cofanetti portatrucco, fuso
e conocchia. Questi ultimi due oggetti, caratteristici del ruolo della donna
nella famiglia e molto diffusi nelle sepolture femminili pi antiche,
rimasero a lungo assenti dai corredi di et repubblicana ed imperiale. La
loro ricomparsa in queste tombe stata messa in rapporto con l'origine
orientale delle defunte e con le immagini di matrone palmirene che
esibiscono questi attributi sulle loro stele. Per la presenza della bambola
nei corredi di bambine o giovani donne in et da marito pu essere presa
in considerazione l'interpretazione che vede nell'oggetto un riferimento
all'infanzia, ma soprattutto alla mancata maternit: la morte precoce non
permise a queste fanciulle di vivere la loro vita come padrone di casa e
come madri, attivit simbolicamente rappresentate dal fuso, dalla
conocchia e dalla bambola.
Il repertorio decorativo funerario - Cogliere il messaggio simbolico
dell'apparato decorativo della tomba e dei suoi arredi risulta spesso
difficoltoso, soprattutto in mancanza di fonti che esplicitino il significato di
queste raffigurazioni. La religione romana, pur nella variet delle sue
dottrine, non una religione soteriologica; a differenza del cristianesimo,
essa non prevede il concetto di salvezza nell'aldil e la vita oltre la morte
consiste in una permanenza pi o meno felice nell'oltretomba, consolata
dalla memoria aeterna dei posteri. Tra il I sec. a.C. e il I d.C., per, la
diffusione del pensiero stoico ed epicureo aveva minato la convinzione
della sopravvivenza dell'anima, la quale, mortale al pari del corpo,
sarebbe stata riassorbita da un'energia universale e quindi privata di ogni
individualit. A queste convinzioni filosofiche pu essere attribuita la
presenza negli epitaffi di espressioni come sumus mortales, immortales
non sumus (CIL XI, 856), Non fui, non sum, non curo (attestata anche nella
formula abbreviata NFNSNC in un'iscrizione di Gemona, CIL V, 1813), nil
sumus et fuimus. Mortales, respice, lector, in nihil a nihilo quam cito
recidimus (CLE II, 1495) e altre di contenuto simile. Tuttavia la convinzione
pi diffusa era quella che gli spiriti dei morti, mantenendo la propria
individualit, potessero frequentare le dimore dei viventi e dovessero
essere debitamente onorati secondo le regole del rituale. Il desiderio di
essere ricordati e, quindi, di comunicare ci che si stati da vivi affidato
al programma decorativo del sepolcro o, pi esplicitamente, il compito
assolto dalle iscrizioni che narrano la vicenda umana del defunto, sia essa
il luminoso cursus honorum di un eminente personaggio, sia che si tratti di
una pi modesta esistenza. Talora le decorazioni figurate connesse al
sepolcro illustrano in maniera diretta l'attivit del defunto; i rilievi in cotto
con scene di mestiere apposti sulle facciate delle tombe nella necropoli
dell'Isola Sacra in un linguaggio formale semplice e didascalico narrano la
professione del defunto o ne mostrano sinteticamente gli strumenti,
analogamente a quanto avviene su stele, altari funerari, sarcofagi. Pi
spesso temi figurati o singoli motivi portano un significato traslato o
simbolico riferibile al rituale, ma anche l'intenzione di rappresentare le
qualit del defunto. Quando assimilato all'eroe mitologico, egli diviene
exemplum dei valori fondamentali della societ romana: virtus e concordia
per gli uomini, pietas, castitas e pulchritudo per le donne. Nel repertorio
funerario il cacciatore costituisce l'exemplum virtutis per eccellenza, sia
che si tratti di una caccia mitica, sia che si tratti di una caccia comune. I
grandi eroi, quali Meleagro e Fetonte, non sfuggono al destino e trovano la
morte nel fiore degli anni, come spesso accade per il defunto, di qui
scaturisce il carattere consolatorio della rappresentazione. L'esplicito
riferimento al superamento della morte e al ritorno dall'aldil appare
evidente nei miti di Alcesti e di Persefone, entrambe simbolo delle virt
femminili sopra citate. Un richiamo particolare all'impegno civile e politico
era espresso nei monumenti funerari dalla presenza di magistrati. Molto
spesso questi concetti sono sintetizzati nella decorazione in pochi
elementi, a volte ridotti a motivi isolati o ad attributi delle figure. Nella
presenza delle nove Muse, in una scena di lettura con un poeta o un
filosofo, ma anche solo nella presenza di una maschera teatrale o di un
rotulus come attributo del defunto, si legge un chiaro riferimento alla
pratica della cultura, al tema globale della gloria raggiunta in questo
mondo e quindi all'immortalit attraverso la fama tra gli uomini, concetto
cantato da molti poeti latini, da Ennio a Orazio. Tra le religioni misteriche il
ciclo dionisiaco il pi frequente nelle decorazioni sepolcrali e compare
con raffigurazioni direttamente collegate alle storie della divinit o con
riferimenti simbolici al culto. In una tomba presso Porta Salaria a Roma,
stato rinvenuto un gruppo di sarcofagi decorati tutti con temi dionisiaci
per i quali si pu riscontrare la volont di manifestare attraverso un
preciso programma decorativo del sepolcro le convinzioni filosofico-
religiose dei committenti. Al viaggio verso le isole dei beati alluderebbero,
secondo alcuni, i motivi marini. Questa iconografia, frequentissima nel
repertorio funerario fu accolta anche dalla tradizione cristiana. Resta
incerto quanto i contenuti simbolici dei motivi decorativi, nei termini in cui
talora sono ricostruiti dai moderni, fossero presenti alla clientela che si
rivolgeva ai decoratori o alle officine di scultura, dove sicuramente
dovevano essere gi lavorati un certo numero di manufatti. Infatti, se a
volte le decorazioni funerarie sembrano rispecchiare precise richieste del
committente e certamente furono eseguite su ordinazione, si deve
comunque riconoscere una ripetitivit e standardizzazione della
decorazione che non sempre era motivata da particolari esigenze religiose
o di autorappresentazione.
Potrebbero piacerti anche
- 06 Alimentazione EtruscaDocumento7 pagine06 Alimentazione EtruscaDaniela SperanzaNessuna valutazione finora
- Storia Dei Riti Egizi e Della Tradizione ItalicaDocumento28 pagineStoria Dei Riti Egizi e Della Tradizione Italicaparisipromo100% (1)
- Razzismo DemocraticoDocumento257 pagineRazzismo DemocraticoFe De100% (3)
- Storia Della Musica WikipediaDocumento46 pagineStoria Della Musica WikipediaCarlos GentileNessuna valutazione finora
- Quando I Giganti Abitavano La Terra Capitoli 15 16Documento24 pagineQuando I Giganti Abitavano La Terra Capitoli 15 16Saputo Francesca100% (1)
- Qumran PDFDocumento16 pagineQumran PDFlucahuna73Nessuna valutazione finora
- Il Silenzio Degli Angeli - Riassunto e CommentoDocumento7 pagineIl Silenzio Degli Angeli - Riassunto e CommentoLaura VassalloNessuna valutazione finora
- Morte e Sepoltura Nel Mondo RomanoDocumento8 pagineMorte e Sepoltura Nel Mondo RomanoFrancesco OrtaleNessuna valutazione finora
- Tracce Nella StoriaDocumento40 pagineTracce Nella Storiacastoro007Nessuna valutazione finora
- Principi Greci e Comunità Sicule in Età Storica in Sicilia.Documento8 paginePrincipi Greci e Comunità Sicule in Età Storica in Sicilia.aguaggentiNessuna valutazione finora
- Le Catacombe - Raccolta Siti UtiliDocumento26 pagineLe Catacombe - Raccolta Siti UtiliMiriam Guerci0% (1)
- Egitto Corredi-FunerariDocumento14 pagineEgitto Corredi-FunerariMax BergerNessuna valutazione finora
- Etruschi - CortonaDocumento4 pagineEtruschi - CortonafabioriaNessuna valutazione finora
- Appunti Presentazione StoriaDocumento3 pagineAppunti Presentazione StoriaZoe CostaNessuna valutazione finora
- Principali Nozioni - Arte Etruschi-RomaniDocumento8 paginePrincipali Nozioni - Arte Etruschi-RomaniFilippo ColumbroNessuna valutazione finora
- Resumen Libro-Death and The Afterlife in Ancient EgyptDocumento9 pagineResumen Libro-Death and The Afterlife in Ancient EgyptClara BrunaNessuna valutazione finora
- Necropoli Picena Di NovilaraDocumento5 pagineNecropoli Picena Di NovilaraMax BergerNessuna valutazione finora
- 1 La Formazione Della Civilta Romana Nell'italia Protostorica (Autorecovered)Documento62 pagine1 La Formazione Della Civilta Romana Nell'italia Protostorica (Autorecovered)rebecca spezzanoNessuna valutazione finora
- Architettura Funeraria Etrusca A TuscaniDocumento3 pagineArchitettura Funeraria Etrusca A TuscaniInfinity Kawsar06Nessuna valutazione finora
- Iii TesiDocumento26 pagineIii TesisaraNessuna valutazione finora
- Archeologia FunerariaDocumento37 pagineArcheologia FunerariaClaudiaNessuna valutazione finora
- Le CatacombeDocumento5 pagineLe Catacombealice secchiatiNessuna valutazione finora
- Catacombe e Domus EcclesiaeDocumento3 pagineCatacombe e Domus EcclesiaejhfekfhNessuna valutazione finora
- Conchiglie Come Strumento Musicale 06Documento22 pagineConchiglie Come Strumento Musicale 06RENATARUPILNessuna valutazione finora
- Arte EtruscaDocumento2 pagineArte EtruscaGiulia RossiNessuna valutazione finora
- Gli Etruschi Usi & CostumiDocumento11 pagineGli Etruschi Usi & CostumimsdfliNessuna valutazione finora
- Storia Di OzieriDocumento46 pagineStoria Di Ozieriraffaele7ennaNessuna valutazione finora
- Catacombe SS Marcellino e Pietro - Santuario Martiriale Agosto 2003 R GiulianiDocumento3 pagineCatacombe SS Marcellino e Pietro - Santuario Martiriale Agosto 2003 R GiulianiStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Agnone. Un Documento Poco Conosciuto Di Una Delle Principali Civiltà Pre-Romane in ItaliaDocumento3 pagineAgnone. Un Documento Poco Conosciuto Di Una Delle Principali Civiltà Pre-Romane in ItaliapronaturaalNessuna valutazione finora
- Delia, La Donna Di Ostuni - Preistoria in ItaliaDocumento8 pagineDelia, La Donna Di Ostuni - Preistoria in ItaliaSara De GirolamoNessuna valutazione finora
- Preistoria e ProtostoriaDocumento52 paginePreistoria e Protostoriasaturnexe859Nessuna valutazione finora
- Gli EtruschiDocumento7 pagineGli Etruschimaumarco7106Nessuna valutazione finora
- La Musica Degli EgizianiDocumento3 pagineLa Musica Degli EgizianiMariano LeottaNessuna valutazione finora
- Percorsi Culturali e Riti Magici - MostraDocumento25 paginePercorsi Culturali e Riti Magici - Mostramahomax1Nessuna valutazione finora
- LA SEPOLTURA NELLA STORIA. Analisi del procedimento di sepoltura e del processo di tanatometamorfosi Culto dei defuntiDa EverandLA SEPOLTURA NELLA STORIA. Analisi del procedimento di sepoltura e del processo di tanatometamorfosi Culto dei defuntiNessuna valutazione finora
- I Tumuli Sacri Di ThuriiDocumento7 pagineI Tumuli Sacri Di Thuriialessandro cosciaNessuna valutazione finora
- Natale Romano - Saturnalia, Sol Indiges e Sol Invictus, Le Origini Del Culto Del SoleDocumento5 pagineNatale Romano - Saturnalia, Sol Indiges e Sol Invictus, Le Origini Del Culto Del SoleMax BergerNessuna valutazione finora
- Arvalia, Catacombe, Oratorio DamasianoDocumento2 pagineArvalia, Catacombe, Oratorio DamasianothemarteventiNessuna valutazione finora
- Definizione Del Luogo Di Culto Per Gli EtruschiDocumento9 pagineDefinizione Del Luogo Di Culto Per Gli EtruschiannalesVolusii2014Nessuna valutazione finora
- Punta Campanella (Promontorio Ateneo)Documento0 paginePunta Campanella (Promontorio Ateneo)Vittorio FincatiNessuna valutazione finora
- La Scultura Etrusca in Pietra: Opificio Delle Pietre DureDocumento79 pagineLa Scultura Etrusca in Pietra: Opificio Delle Pietre DureMatilde TicciNessuna valutazione finora
- Storia Dell'arte Antica 03Documento5 pagineStoria Dell'arte Antica 03Evelyn AndreottiNessuna valutazione finora
- Etruscologia - AppuntiDocumento15 pagineEtruscologia - AppuntiNicola BarbagliNessuna valutazione finora
- La Cultura Degi IstriDocumento25 pagineLa Cultura Degi IstriMax Berger100% (1)
- Forme Di Popolamento Nella Sicilia CentrDocumento9 pagineForme Di Popolamento Nella Sicilia CentrpippoNessuna valutazione finora
- Esame Storia SpettacoloDocumento96 pagineEsame Storia SpettacoloMaria Sole SquarciNessuna valutazione finora
- 2011-08-31 Venus Ericina RidensDocumento22 pagine2011-08-31 Venus Ericina RidensAlexandros KastanakisNessuna valutazione finora
- Arte Nel TempoDocumento2 pagineArte Nel TempoANDREA YONGDE OLIMPIONessuna valutazione finora
- Gli Egizi StoriaDocumento2 pagineGli Egizi StoriaLuigi PambianchiNessuna valutazione finora
- 04 Medie Musica EbraicaDocumento3 pagine04 Medie Musica EbraicaFrancesco GibelliniNessuna valutazione finora
- Castelfranco Emilia - Quaderno Didattico Museo ArcheolgicoDocumento27 pagineCastelfranco Emilia - Quaderno Didattico Museo Archeolgicomeo31Nessuna valutazione finora
- Lez. 13Documento6 pagineLez. 13luca giarrittaNessuna valutazione finora
- Gli Strumenti Musicali A Bisanzio (Fernanda de Maffei)Documento51 pagineGli Strumenti Musicali A Bisanzio (Fernanda de Maffei)michelezanellaNessuna valutazione finora
- Manetone La Storia DegittoDocumento15 pagineManetone La Storia DegittoYara LinariNessuna valutazione finora
- IL TUMULO DI CORVARO DI BORGOROSE (RI) E IL TERRITORIO DEGLI EQUICOLI - AequaDocumento3 pagineIL TUMULO DI CORVARO DI BORGOROSE (RI) E IL TERRITORIO DEGLI EQUICOLI - AequaFrancescoAnselmiNessuna valutazione finora
- Lettere Del Doge Andrea Contarini e Del Del Capitano Domenico Michel 1368 1369Documento38 pagineLettere Del Doge Andrea Contarini e Del Del Capitano Domenico Michel 1368 1369Max BergerNessuna valutazione finora
- Ritualizzazione Della Lancia - Massimiliano Visalberghi Wieselberger 2019Documento15 pagineRitualizzazione Della Lancia - Massimiliano Visalberghi Wieselberger 2019Max BergerNessuna valutazione finora
- I Druidi e La Religione Nelle Fonti ClassicheDocumento8 pagineI Druidi e La Religione Nelle Fonti ClassicheMax BergerNessuna valutazione finora
- Necropoli Picena Di NovilaraDocumento5 pagineNecropoli Picena Di NovilaraMax BergerNessuna valutazione finora
- La Via GeminaDocumento1 paginaLa Via GeminaMax BergerNessuna valutazione finora
- Gli Hirpi SoraniDocumento2 pagineGli Hirpi SoraniMax BergerNessuna valutazione finora
- Alimentazione Dei CeltiDocumento2 pagineAlimentazione Dei CeltiMax BergerNessuna valutazione finora
- Sacramentum LegionarioDocumento9 pagineSacramentum LegionarioMax BergerNessuna valutazione finora
- La Danza Circolare Greca Della Gru o Della PerniceDocumento2 pagineLa Danza Circolare Greca Della Gru o Della PerniceMax Berger100% (1)
- La Testudo, Con Riferimento Al Testo Di Dione Cassio - Errore Moderno Od AnticoDocumento2 pagineLa Testudo, Con Riferimento Al Testo Di Dione Cassio - Errore Moderno Od AnticoMax BergerNessuna valutazione finora
- Avari e SlaviDocumento10 pagineAvari e SlaviMax BergerNessuna valutazione finora
- HONESTA MISSIO Congedo Militare RomanoDocumento2 pagineHONESTA MISSIO Congedo Militare RomanoMax BergerNessuna valutazione finora
- Donne Guerriere Sarmate, Germaniche, Illire, CelteDocumento4 pagineDonne Guerriere Sarmate, Germaniche, Illire, CelteMax BergerNessuna valutazione finora
- Il Pane Nell'Alimentazione Del Mondo Greco e RomanoDocumento11 pagineIl Pane Nell'Alimentazione Del Mondo Greco e RomanoMax Berger100% (1)
- Il Potenziale ElettricoDocumento6 pagineIl Potenziale ElettricoGiada LupieriNessuna valutazione finora
- Analisi Di Segnali CampionatiDocumento12 pagineAnalisi Di Segnali Campionatifederico_1991100% (1)
- Piramo e TisbeDocumento3 paginePiramo e TisbeMaggie GarelliNessuna valutazione finora
- 02 Di 17 - Teoria Rock - Temperamento Zarlino Pitagora EquabDocumento6 pagine02 Di 17 - Teoria Rock - Temperamento Zarlino Pitagora EquabLuciana BorgesNessuna valutazione finora
- Peggoty InfoDocumento2 paginePeggoty InfoMauro LondrilloNessuna valutazione finora