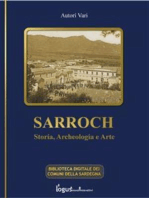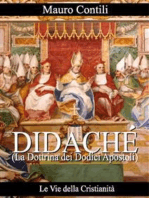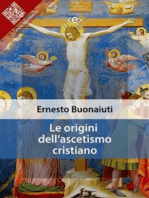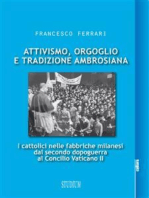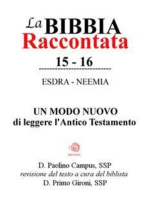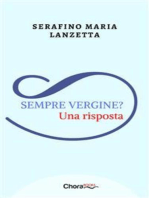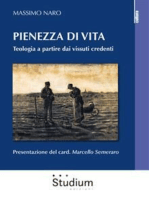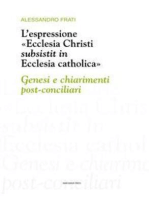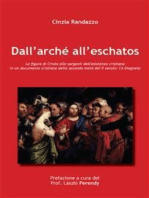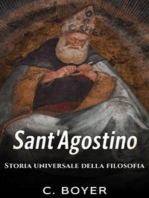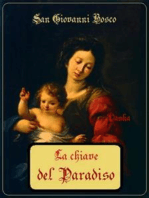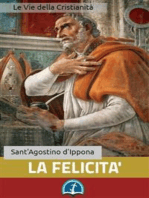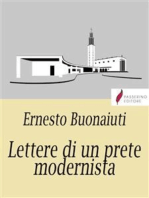Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Catacombe SS Marcellino e Pietro - Santuario Martiriale Agosto 2003 R Giuliani
Caricato da
Stefano Fedele0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
614 visualizzazioni3 pagineScoperto nell'agosto 2003 un santuario martiriale nella catacomba romana dei santi Marcellino e Pietro. L'articolo dell'ispettore della Pontificia Commissione Archeologia Sacra R. Giuliani, è la cronaca di una scoperta dovuta alla rottura di una condotta idrica...
Titolo originale
Catacombe SS Marcellino e Pietro - Santuario Martiriale agosto 2003 R Giuliani
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoScoperto nell'agosto 2003 un santuario martiriale nella catacomba romana dei santi Marcellino e Pietro. L'articolo dell'ispettore della Pontificia Commissione Archeologia Sacra R. Giuliani, è la cronaca di una scoperta dovuta alla rottura di una condotta idrica...
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
614 visualizzazioni3 pagineCatacombe SS Marcellino e Pietro - Santuario Martiriale Agosto 2003 R Giuliani
Caricato da
Stefano FedeleScoperto nell'agosto 2003 un santuario martiriale nella catacomba romana dei santi Marcellino e Pietro. L'articolo dell'ispettore della Pontificia Commissione Archeologia Sacra R. Giuliani, è la cronaca di una scoperta dovuta alla rottura di una condotta idrica...
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 3
Scoperto un santuario martiriale nella catacomba romana dei Santi Narcellino e Pietro
Tutto cominciato con un tubo rotto
di Raffaella Giuliani
!spettore delle Catacombe di Roma Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
Doveva essere assolutamente eterogeneo il bacino sociale che tra terzo e quarto secolo a Roma, per dare
una tomba dignitosa ai propri cari, affluiva numeroso alle catacombe dei Santi Pietro e Narcellino, nell'antica
localita ad duas lauros, al terzo miglio della via Labicana.
Le testimonianze epigrafiche ci conservano i nomi di uomini e donne, ricchi artigiani, commercianti, piccoli
imprenditori, operai, servi, provenienti in parte dalla popolosa Subura, dalla regione dell'Esquilino e del
Nacellum Liviae, non distanti in linea d'aria.
Un calcolo affidabile di Jean Guyon, l'archeologo francese che ha
dedicato i suoi migliori anni allo studio di questo straordinario complesso
paleocristiano, mostra che - nel solo terzo secolo - le intricate gallerie
sotterranee della catacomba accolsero almeno 15.000 sepolture, mentre
alcune migliaia si distribuirono nell'area di superficie. !n un equilibrio
difficile, ma sostanzialmente riuscito, tra comunita cristiana e potere
imperiale, effetto della tollerante politica religiosa dell'imperatore Gallieno
(253-268), il cimitero cristiano si inser in una vasta necropoli pagana, in
cui un settore distinto di proprieta imperiale era occupato dal sepolcreto
della gloriosa guardia imperiale a cavallo, gli equites singulares Augusti.
Al tempo dell'imperatore Costantino, il complesso ha subito degli
interventi edilizi radicali, con la creazione di una grandiosa basilica
circiforme dedicata ai martiri eponimi, di un mausoleo cilindrico che
accolse l'Augusta Elena, madre dell'imperatore, e altri membri della sua
famiglia, e di vasti recinti porticati.
L'importanza del complesso non sfuggita agli studiosi delle antichita
cristiane di ogni epoca: si legano al sito i nomi di Antonio Bosio,
Giovanni Battista de Rossi, Enrico Stevenson, Orazio Narucchi, e poi, per
arrivare ai tempi a noi piu vicini, del gesuita Antonio Ferrua, e del barnabita Umberto N. Fasola. !ntanto, tra
il 1953 e il 1956, Friedrich Wilhelm Deichmann e Arnold Tschira portavano alla luce, nell'area esterna, le
fondazioni della grande basilica costantiniana. S' appena menzionato Jean Guyon, al quale si deve una
fondamentale sintesi sul complesso (Le cimitire aux deux lauriers. Recherches sur les catacombes
romaines, 1987), strumento insuperato di conoscenza del sito.
Tanto fervore di studi e di scavi passati lasciava supporre che il cimitero non potesse restituire ancora
sorprendenti scoperte, specie nella sua indagatissima regione centrale, a un passo dalla cripta dei martiri
eponimi Pietro e Narcellino. !nvece, nel cuore dell'afosa estate romana, nell'agosto 2003, iniziata per puro
caso un'affascinante avventura archeologica, che chi scrive ha avuto la fortuna di vivere in prima persona.
All'origine di essa un ignaro tubo rotto. Proprio cos: la rottura di una conduttura della rete cittadina aveva
provocato l'apertura di una voragine in un giardino privato al di sopra del settore mediano della catacomba,
presso l'!stituto delle Suore della Sacra Famiglia.
Una volta fatto cessare, con l'intervento dei tecnici dell'Acea, il flusso dell'acqua, s' iniziato a rimuovere,
procedendo dall'esterno, i detriti crollati nella voragine, per raggiungere la quota catacombale e rimediare ai
danni.
Nentre si procedeva - con tutte le cautele - alla rimozione della frana, un evento inatteso scuoteva il ritmo
tranquillo dei lavori: raggiunto il livello di una galleria catacombale, tre metri sotto un prato ben curato,
tenacemente attaccati al loro supporto murario spuntano i brandelli di un affresco
parietale sfigurato dal tempo e dagli uomini.
Compaiono per prime delle testine dipinte (i fossori di oggi - gli operai in servizio presso la Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra per curare le catacombe - comunicarono eccitati la scoperta di
"capoccette" a chi scrive!). Sono in realta volti maschili che non concedono nulla alla leggiadria: forti,
espressivi, occhi spalancati, sguardi intensi, barbe ispide. Appartengono a un gruppo serrato di personaggi
vestiti tutti uguali, con corte tuniche scure. Fanno pensare istintivamente a dei soldati, o, forse, a degli
artefici.
Poco piu a destra, l'aureola d'un giovane santo, maggiorato rispetto al gruppo, accanto al quale restano,
indenni, tre belle lettere - NAR - che conducono agevolmente all'eponimo Narcellino: a sinistra di questi -
rimangono solo i piedi e i resti della bianca barba - il venerando esorcista Pietro.
Lo stile dei pochi lacerti non ammette dubbi: si tratta di pitture tarde, altomedievali (sesto-settimo secolo),
di un periodo in cui in catacomba si riservavano cure e abbellimenti ai soli loca sancta, alle tombe di martiri,
destinazione di infiniti pellegrinaggi da tutt'Europa.
Su tutto l'affresco si distribuivano didascalie dipinte che, data la lacunosita delle pitture, sono oggi purtroppo
quasi del tutto illeggibili: fatto, questo, deplorevole, perch la conservazione delle scriptae avrebbe reso
molto piu agevole la decodificazione della scena e, quindi, anche del contesto topografico cui la stessa
appartiene. Una di queste iscrizioni dipinte, su di un codice aperto su un leggio, restituisce l'espressione: hic
do[na|nt [---| scr[ini|um, forse in rapporto alla presentazione di uno scrigno, raffigurata nella scena e
affidata simbolicamente ai martiri patroni del cimitero.
!n cosa consisteva, o meglio, cosa poteva contenere questo scrigno? Per rispondere a queste fondamentali
domande, ci viene fortunatamente in aiuto l'ambito topografico e iconografico, che rinvia, a lume di logica, a
un contenitore utilizzato per conservare reliquie. L'esistenza di tale contenitore puo essere confermata
dall'apertura rettangolare - una nicchia, piu volte violata - posta al di sotto delle pitture, dove lo scrinium
doveva trovar posto.
Completavano l'allestimento del locum sanctum una transenna marmorea, che decorava la sommita del
muro affrescato, una mensa oleorum, per ospitare le lampade votive, un lucernario che rischiarava
l'ambiente, nonch numerose sepolture nel piano pavimentale. Queste ultime sono il pendant consueto delle
tombe martiriali, espressione del desiderio di massa di sepeliri ad sanctos, fenomeno di costume dell'eta
tardoantica non esente da spinte superstiziose, contro cui anche sant'Agostino aveva cercato di fare sponda.
L'insieme di testimonianze non lascia dubbi: si disvela un altro polo cultuale di questo straordinario
complesso della Roma paleocristiana, un santuario martiriale di cui finora non si era potuta sospettare
l'esistenza sul piano archeologico. A questo punto, il lavoro degli archeologi si trasferisce dalle umide, oscure
e terrose gallerie sotterranee, alle piu confortevoli sale delle biblioteche, dove si conservano le fonti
manoscritte sul cimitero (calendari, atti, passiones, itinerari, e cos via), unico strumento disponibile per
tentare di identificare il martire venerato nel santuario appena venuto alla luce.
!l martire o non piuttosto i martiri? !nfatti, due elementi farebbero propendere per un gruppo, e non per una
singola individualita, venerato nella cripta. Da un lato, la presenza dell'insieme omogeneo di personaggi
rappresentati a sinistra nell'affresco non puo essere casuale, in una rappresentazione cos essenziale.
Dall'altro, se valida l'ipotesi delle reliquie, esse trovano particolare giustificazione nel trasferimento, magari
da un paese lontano, di resti corporei di piu individui, intrasportabili nella loro interezza.
Le fonti manoscritte, in particolare gli itinerari, assegnano a questo cimitero i gruppi martiriali dei Quattro
Coronati (gia localizzati in una cripta del cimitero), dei Trenta Nartiri e dei Quaranta Nartiri. Questi ultimi due
gruppi non hanno trovato ancora una localizzazione certa.
Ebbene, molto forte la suggestione di attribuire le testimonianze archeologiche appena rinvenute a uno dei
due anonimi gruppi. !n particolare, i Quaranta della via Labicana sono ricordati dal Nartirologio Geronimiano
al 13 gennaio e sono definiti milites. !l carattere di soldati si adatterebbe bene - come s'era gia osservato - al
manipolo di uomini a sinistra della scena dipinta.
A questo punto, sarebbe meno incerta e isolata l'ipotesi che fu del Delehaye, il quale riteneva che i Quaranta
Nartiri della Labicana ricordati dagli itinerari potessero identificarsi in realta con i Quaranta Nartiri di Sebastia
(citta della piccola Armenia, odierna Siwas in Turchia), notissimo gruppo di martiri soldati, caduti sotto la
persecuzione di Licinio, condannati all'esposizione nudi ai rigori del freddo di uno stagno ghiacciato e infine
morti per assideramento, le cui reliquie furono sparse e venerate in varie localita dell'orbe cristiano antico, e,
a Roma, in un oratorio di Santa Naria Antiqua.
!noltratici nella selva ammaliante delle ricostruzioni ipotetiche, dobbiamo pero tornare celermente sui nostri
passi, nel sottosuolo appena abbandonato, dove, all'insieme di testimonianze archeologiche, di per s gia
eccezionali, appena descritte, il prosieguo degli scavi ha aggiunto altri inattesi e straordinari elementi.
!nfatti nel procedere dell'indagine, ci si imbattuti in un singolare insieme di ambienti dalla forma tozza,
scavati nel tufo a quote differenti, totalmente diversi dalle consuete gallerie catacombali. !l fatto
sorprendente che essi risultavano tutti riempiti, per un terzo della loro altezza, di strati di scheletri, disposti
regolarmente e ordinatamente, ma senza elementi di separazione fisica tra loro.
Questo portava a concludere che i depositi di scheletri si fossero formati in un breve torno di tempo. Certo, il
loro stato di conservazione lasciava molto a desiderare, visto anche il perdurare dell'infiltrazione idrica
all'origine della scoperta. Per questo si ritenuto indispensabile affrontare lo scavo dei singolari ambienti con
l'intervento, siglato da un'apposita convenzione tra la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e l'cole
Franaise de Rome, di un'equipe di antropologi dell'universita di Bordeaux 1, specializzata nell'indagine di
sepolture collettive.
Gli specialisti, guidati da Dominique Castex, hanno preso in carico lo scavo antropologico e lo studio in loco e
in laboratorio dei reperti umani rinvenuti, che tutt'ora in corso, e che ha coinvolto centri universitari di
varie citta europee. Dall'osservazione degli antropologi, si conferma, tra l'altro, la simultaneita della
formazione dei depositi, che, secondo una stima per difetto, hanno accolto circa milleduecento individui.
Altro aspetto interessante della ricerca rappresentato dal riconoscimento, nelle sepolture di massa, di
pratiche funerarie estremamente accurate, finalizzate alla conservazione ottimale dei corpi. Le prime
datazioni di laboratorio col metodo del radiocarbonio (C1+) hanno riguardato due campioni di tessuto, i quali
sono stati datati tra la meta del secondo secolo e i primi decenni del secolo seguente.
Tra i pochissimi reperti dei sepolcri collettivi vi sono alcune monete, di cui la piu recente - e dunque utile a
fini datanti - emessa da uno dei tre imperatori Gordiani (238-2++). Dunque, in base a queste prime
indicazioni cronologiche, le circostanze che hanno determinato la raccolta di corpi risultano essere precedenti
alla nascita del cimitero cristiano, la cui origine, come si diceva, si riporta all'epoca gallienica.
Al momento, per quanto riguarda il casus all'origine della formazione dei depositi, non avendo i corpi rivelato
segni evidenti di traumi violenti, l'ipotesi piu convincente appare quella dell'evento epidemico, per il quale si
puo ipotizzare, sulla base delle datazioni riportate, una recrudescenza della cosiddetta "peste antonina", la
terribile epidemia che, dalla meta del secondo secolo in poi, fino almeno alla meta del terzo, ha decimato, in
varie riprese, la popolazione dell'impero.
Su tale epidemia sono copiose le testimonianze degli antichi, tra cui Galeno, Elio Aristide, gli scrittori della
Historia Augusta, Dione Cassio, Ammiano Narcellino, Eutropio e Orosio. Di tale epidemia, tuttavia, non erano
ancora emerse delle testimonianze archeologiche dirette, il che aveva portato molti storici moderni a
dubitare del valore delle notizie fornite dagli antichi e a ridimensionare la portata dell'infezione.
!n tal senso il ritrovamento del contesto rinvenuto, se le indagini di laboratorio confermassero l'ipotesi
dell'epidemia, sarebbe una testimonianza eccezionale anche in funzione dell'approfondimento della
conoscenza degli agenti patogeni nell'antichita e della loro diffusione.
Ritornando al nostro vecchio tubo rotto, dobbiamo ringraziarlo di averci dischiuso un mondo cos complesso
e insospettato. vero, pero, che permangono ancora molti passaggi oscuri nella ricostruzione storica del
processo che ha portato allo sviluppo della catacomba cristiana a ridosso dei singolari collettori di corpi.
forse possibile che la presenza dei sepolcri collettivi sia stata determinante per la scelta dello spazio da
destinare al culto di un gruppo di martiri, mediante il trasporto di un ricettacolo di reliquie provenienti da
lontano.
Fatto meritevole di piu approfondita riflessione, del resto, il rispetto costantemente reso dal cimitero
cristiano, nella sua progressiva espansione, ai preesistenti sepolcri di massa, rispetto tanto piu rilevante se si
considera l'esigenza ivi pressante, nelle vicinanze delle tombe dei martiri eponimi Pietro e Narcellino, di spazi
sepolcrali da mettere a disposizione dei piu ferventi devoti.
A conclusione di queste note, ci auguriamo che la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, in
collaborazione con l'cole Franaise de Rome, possa attuare il suo proposito di riprendere al piu presto le
ricerche nel contesto, per riuscire a dare piena luce ai tanti dati finora emersi con l'ausilio - sul campo e in
laboratorio - delle tecniche d'indagine piu moderne e sofisticate.
{L'Osservatore Romano - 12-13 maggio 200S)
Potrebbero piacerti anche
- Sarroch - Storia, archeologia e arteDa EverandSarroch - Storia, archeologia e arteNessuna valutazione finora
- Cronologia civile e ecclesiastica di Piazza e dintorni: Palazzi, chiese, conventi, ordini religiosi, confraternite, alberi genealogici, uomini illustri e avvenimenti memorabili di una delle più belle cittadine del centro SiciliaDa EverandCronologia civile e ecclesiastica di Piazza e dintorni: Palazzi, chiese, conventi, ordini religiosi, confraternite, alberi genealogici, uomini illustri e avvenimenti memorabili di una delle più belle cittadine del centro SiciliaNessuna valutazione finora
- La sacra scrittura e san Lorenzo GiustinianiDa EverandLa sacra scrittura e san Lorenzo GiustinianiNessuna valutazione finora
- L'ombra sinistra della scuola: Memorie frustrate di un insegnante secondario, dal ’68 ai primi ‘90Da EverandL'ombra sinistra della scuola: Memorie frustrate di un insegnante secondario, dal ’68 ai primi ‘90Nessuna valutazione finora
- Attivismo, orgoglio e tradizione ambrosiana: I cattolici nelle fabbriche milanesi dal secondo dopoguerra al Concilio Vaticano IIDa EverandAttivismo, orgoglio e tradizione ambrosiana: I cattolici nelle fabbriche milanesi dal secondo dopoguerra al Concilio Vaticano IINessuna valutazione finora
- La verità sull'evoluzione e l'origine dell'uomoDa EverandLa verità sull'evoluzione e l'origine dell'uomoNessuna valutazione finora
- Clemente Di Alessandria - Protreptico Ai GreciDocumento52 pagineClemente Di Alessandria - Protreptico Ai GreciPapeSatanAleppeNessuna valutazione finora
- Monachesimo e diaconato femminile: Il caso della diaconessa OlimpiaDa EverandMonachesimo e diaconato femminile: Il caso della diaconessa OlimpiaNessuna valutazione finora
- Dizionario Sintetico Di Patristica - César Vidal ManzanaresDocumento47 pagineDizionario Sintetico Di Patristica - César Vidal ManzanaresTomasoNessuna valutazione finora
- C'è una crepa in ogni cosa: ed è così che entra la luceDa EverandC'è una crepa in ogni cosa: ed è così che entra la luceNessuna valutazione finora
- Il viaggio in età moderna: Studi di Gaetano PlataniaDa EverandIl viaggio in età moderna: Studi di Gaetano PlataniaNessuna valutazione finora
- Le Saint-Siège, les eglises et l'Europe. / La Santa Sede, le chiese e l'europa.: Études en l'honneur de Jean-Dominique Durand / Studi in onore di Jean-Dominique DurandDa EverandLe Saint-Siège, les eglises et l'Europe. / La Santa Sede, le chiese e l'europa.: Études en l'honneur de Jean-Dominique Durand / Studi in onore di Jean-Dominique DurandNessuna valutazione finora
- Ambrogio WPDocumento29 pagineAmbrogio WPBoccolone100% (1)
- La fuoriuscita del Logos modalità ed effetti nei testi patristici dei primi 4 secoliDa EverandLa fuoriuscita del Logos modalità ed effetti nei testi patristici dei primi 4 secoliNessuna valutazione finora
- Da Paolo a Paolo: Le immagini nei primi secoli del cristianesimoDa EverandDa Paolo a Paolo: Le immagini nei primi secoli del cristianesimoNessuna valutazione finora
- Delle Varie Eresie: Diversarum Hereseon LiberDa EverandDelle Varie Eresie: Diversarum Hereseon LiberNessuna valutazione finora
- Pienezza di vita: Teologia a partire dai vissuti credentiDa EverandPienezza di vita: Teologia a partire dai vissuti credentiNessuna valutazione finora
- Albert Camus - L'Uomo in RivoltaDocumento14 pagineAlbert Camus - L'Uomo in Rivoltaalex050993Nessuna valutazione finora
- Aug. 46Documento29 pagineAug. 46Alejandro Acevedo TorresNessuna valutazione finora
- La storia di Roma in 100 monumenti e opere d'arteDa EverandLa storia di Roma in 100 monumenti e opere d'arteNessuna valutazione finora
- L'espressione «Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica»Da EverandL'espressione «Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica»Nessuna valutazione finora
- Corso di greco del Nuovo Testamento: per principiantiDa EverandCorso di greco del Nuovo Testamento: per principiantiNessuna valutazione finora
- Monachesimo basiliano - nella Calabria bizantina, grecanica e arbërechë e nel Meridione d’ItaliaDa EverandMonachesimo basiliano - nella Calabria bizantina, grecanica e arbërechë e nel Meridione d’ItaliaNessuna valutazione finora
- La Tarda AntichitàDocumento77 pagineLa Tarda AntichitàALBERTO DI NAPOLINessuna valutazione finora
- Missa in scena: Riflessioni teatrali sulla liturgiaDa EverandMissa in scena: Riflessioni teatrali sulla liturgiaNessuna valutazione finora
- La Battaglia Di Ponte Milvio (Saxa Rubra) Dove Naque L'europa CristianaDocumento4 pagineLa Battaglia Di Ponte Milvio (Saxa Rubra) Dove Naque L'europa CristianaStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Costantino I - Flavius Valerius Constantinus Imperatore Detto Il GrandeDocumento6 pagineCostantino I - Flavius Valerius Constantinus Imperatore Detto Il GrandeStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Costantino e L'editto Di Milano: L'inizio Della Libertà Religiosa Di Marco FasolDocumento4 pagineCostantino e L'editto Di Milano: L'inizio Della Libertà Religiosa Di Marco FasolStefano FedeleNessuna valutazione finora
- L'Italia Che VerràDocumento276 pagineL'Italia Che VerràFrancesco Maria GalloNessuna valutazione finora
- Dossier Ad Duas Lauros 10.12.2012Documento23 pagineDossier Ad Duas Lauros 10.12.2012Stefano FedeleNessuna valutazione finora
- In Cammino Lungo Le Vie Da Roma Verso GerusalemmeDocumento95 pagineIn Cammino Lungo Le Vie Da Roma Verso GerusalemmeStefano Fedele0% (1)
- Francigena, Catacombe SS Marcellino e Pietro. Mausoleo S Elena e L'ecomuseo Casilino Ad Duas LaurosDocumento13 pagineFrancigena, Catacombe SS Marcellino e Pietro. Mausoleo S Elena e L'ecomuseo Casilino Ad Duas LaurosStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Mausoleo Di Elena, La Vita Di Flavia Julia Helena Di Gabriella Cetorelli Schivo. Parte IIDocumento19 pagineMausoleo Di Elena, La Vita Di Flavia Julia Helena Di Gabriella Cetorelli Schivo. Parte IIStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Mausoleo Di Elena Di Gabriella Cetorelli Schivo Parte IIIDocumento13 pagineMausoleo Di Elena Di Gabriella Cetorelli Schivo Parte IIIStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Francigene Del Sud Parte IDocumento106 pagineFrancigene Del Sud Parte IStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Mausoleo Di Elena e La Basilica S Marcellino e Pietro Di Gabriella Cetorelli SchivoDocumento15 pagineMausoleo Di Elena e La Basilica S Marcellino e Pietro Di Gabriella Cetorelli SchivoStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Villa Ad Duas Lauros Scavi Archeologici Nel 1995 Di Patrizia GioiaDocumento16 pagineVilla Ad Duas Lauros Scavi Archeologici Nel 1995 Di Patrizia GioiaStefano FedeleNessuna valutazione finora
- Progetto e Cantiere Mausoleo S ElenaDocumento4 pagineProgetto e Cantiere Mausoleo S ElenaStefano Fedele100% (1)
- Congresso Ecclesiae Urbis - Conservazione e Valorizzazione Del Mausoleo Di S. ElenaDocumento13 pagineCongresso Ecclesiae Urbis - Conservazione e Valorizzazione Del Mausoleo Di S. ElenaStefano FedeleNessuna valutazione finora