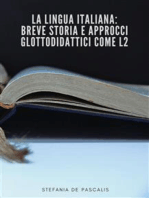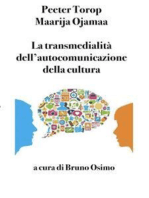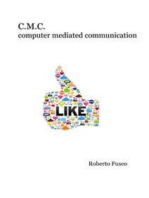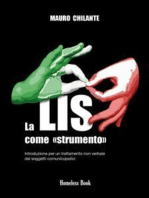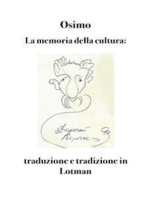Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Docsity Manuale Di Sociolinguistica
Caricato da
beatrice fischioneTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Docsity Manuale Di Sociolinguistica
Caricato da
beatrice fischioneCopyright:
Formati disponibili
Manuale di sociolinguistica
Sociolinguistica
Università degli Studi Internazionali di Roma
20 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Che così la sociolinguistica (capitolo 1)
Definizione della disciplina
La sociolinguistica si occupa dei rapporti tra lingua e società, e quindi due fatti e dei valori sociali
connessi alla lingua e ai suoi usi. Tratta quindi sia della correlazione tra fenomeni linguistici e
determinati fattori sociale, sia dell’influenza che la società e i fatti sociali hanno riguardo ai fatti
linguistici e delle conseguenze ce tale influenza produce, sia della funzione sociale che la lingua
ha e delle azioni sociali che attraverso essa si svolgono.
Poiché la gamma di fenomeni in cui si manifesta tale interazione fra lingua e la società è molto
ampia e differenziata, nella sociolinguistica si possono trovare approcci diversi.
Una prima distinzione tra fra le impostazioni di studio sociolinguistico che privilegiano la
componente sociale e le impostazioni che privilegiano la componente linguistica. La prospettiva
usata in questo caso privilegia la componente linguistica. In questa prospettiva, la sociolinguistica
si configura essenzialmente come un settore della linguistica: è la sottodisciplina delle scienze
linguistiche che si pone il compito di descrivere e chiarire che cosa succede alle lingue e alle loro
strutture quando le vediamo concretamente calate nelle comunità sociali che le usano.
La linguistica dovrebbe sempre avere un fondamento sociale, i fatti di lingua andrebbero sempre
spiegati in termini della loro distribuzione sociale: non potrebbe nemmeno esistere una linguistica
che non sia socialmente fondata. Questa posizione è stata per esempio sostenuta da W. Labov,
uno dei padri fondatori e dei massimi esponenti della disciplina.
Se si vedono come aspetto essenziale e centrale della dimensione sociolinguistica dei fatti di
lingua l’azione che la lingua svolge nei confronti della società e delle se funzioni nel regolare le
interazioni comunicative tra gli individui, allora la sociolinguistica si configura piuttosto come un
settore di confine a cavallo tra la linguistica e la sociologia, in cui hanno grande importanza non
solo i determinanti sociali del comportamento linguistico, ma anche i modi in cui attraverso la
lingua si creano e si negoziano contenuti sociali.
La prospettiva che assumiamo nel presentare i contenuti fondamentali del campo di studio vede
invece, la sociolinguistica non come una sociologia che tiene conto dei fatti linguistici, ma come
una linguistica che tiene conto dei fatti sociali.
Si avrebbe quindi una divisione dei lavori fra linguistica, che studia la lingua come sistema, e la
sociolinguistica, che studia la lingua nei termini dei suoi usi presso una comunità sociale. La
sociolinguistica è pertanto definibile come la branca delle scienze del linguaggio che si occupa di
analizzare e possibilmente spiegare tutti i fatti linguistici che hanno significato sociale.
La sociolinguistica cosi intesa copre per altro una gamma molto ampia di contenuti e approcci.
La sociolinguistica è un ramo delle scienze del linguaggio basato sull’osservazione di come si
presentano le cose sotto gli occhi di chi le osserva e si inscrive dunque nell’ambito della
linguistica sincronica.
La sociolinguistica storica cerca di ricostruire le condizioni sociolinguistiche di un’area in un
determinato momento/periodo storico, i rapporti esistenti nel relativo repertorio linguistico e la
variabilità intralinguistica come si manifesta nei testi e materiali linguistici del passato.
Fondamentali per la ricostruzione delle condizioni sociolinguistiche e della variazione nel passato
risultano gli scritti dei parlanti sericoli: biografie, diari, memorie di illetterati, appunti di mercanti.
Nell’ambito delle scienze del linguaggio, la sociolinguistica si caratterizza anche in base ad alcune
opposizioni fondamentali.
Una prima opposizione è quella tra linguistica interna e linguistica esterna
La linguistica interna è volta a studiare le caratteristiche strutturali della lingua, avente cioè come
suo oggetto la lingua come sistema, mentre la linguistica esterna guarda alla lingua nei termini di
tutto ciò che è esterno alla sua struttura ma rappresenta il contesto in cui essa vive.
Una seconda importante opposizione è quella tra orientamento formale (formalismo) e
orientamento funzionale (funzionalismo).
Il formalismo concepisce la lingua come uno strumento che riflette il pensiero e costituisce un
sistema autonomo, organizzato secondo i principi propri che lo distinguono da qualunque altra
capacità cognitiva umana.
Il funzionalismo invece concepisce la lingua essenzialmente come uno strumento di
comunicazione adattato ai bisogni degli utenti.
Per il formalismo le forme e le strutture della lingua sono autonome, indipendenti dalla funzione, la
grammatica è indipendente dall’uso dei parlanti, le nozioni elle categorie sono discrete, ben
definite, i principi e le regole che colgono e spiegano i dati empirici sono di carattere deduttivo; le
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
generalizzazioni raggiunte sono categoriche e conferiscono al modello teorico una capacità
predittiva forte, analoga a quella che si riscontra nelle scienze esatte e deduttive.
Al contrario, per il funzionalismo le forme e le strutture della lingua sono determinate, o
condizionate dalla funzione, la grammatica è atteggiata in relazione ai caratteri e alle esigenze
dell’uso e dei parlanti: le nozioni e le categorie tendono ad essere continue, sfumate.
I principi e le regole che spiegano i dati empirici sono di carattere induttivo, le generalizzazioni
raggiunte sono di carattere probabilistico e la produttività è del modello è molto debole e solo di
natura statistica.
Per sua natura la sociolinguistica condivide in generale le assunzioni della prospettiva funzionalità.
Altre opposizioni derivano dal percezione che si ha della materia e sul genere di fenomeni di cui si
occupa. Una di queste opposizioni è quella tra sociolinguistica in senso stretto che ha come
oggetto specifici fatti e produzioni linguistiche, e la cosiddetta sociologia del linguaggio/ delle
lingue, che prende come oggetto di trattazione gli interi organismi delle lingue e delle varietà di
lingua nella collocazione che esse hanno presso i parlanti e nelle società e nelle vicende che
queste conoscono.
Un’altra opposizione è quella tra microsociolinguistica e macrosociolinguistica: la
microsociolinguistica è lo studio di gruppi piccoli di parlanti, o anche singoli individui, mentre la
macrosociolinguistica è lo studio di fenomeni di ogni livello su gruppi relativamente ampi di
parlanti.
Un’ulteriore opposizione è quella tra sociolinguistica correlazionale e sociolinguistica
interpretativa. Le due correnti si caratterizzano per il diverso rapporto che pongono tra i fatti
linguistici e i fatti sociali. Quella correlazionale si occupa delle correlazioni fra lingua e società
assumendo gli aspetti o fattori sociali come variabili indipendenti, che agiscono sui fatti linguistici.
La direzionali va quindi dalla società alla lingua, si studia quindi come la lingua è influenzata dalla
società.
Capitolo 2- lingua e società
2.1 la società nella lingua: fattori sociali e lingua
Essendo il comportamento linguistico un tipo di comportamento sociale, qualunque fattore dotato
di rilevanza sociale e qualunque variabile sociale sono suscettibili di avere riflessi sulla lingua.
Fra le categorie e i fattori sociali relativi alla collocazione del parlante nella società, suscettibili di
correlare il comportamento linguistico con la variazione linguistica del parlante abbiamo le variabili
indipendenti, che vengono anche chiamate ‘’variabili sociolinguistiche’’ e sono: stratificazione
sociale, appartenenza sociale, età e fascia generazionale, sesso, collocazione spaziale e luogo di
abitazione e provenienza.
Va tenuto in mente che tutte queste variabili sociolinguistiche interagiscono assieme nelle
correlazioni con i fatti linguistici e si sommano nel condizionare il comportamento linguistico.
È inoltre necessario notare che con la complessificazione delle società nel XXI secolo e la grande
importanza e diffusione della tecnologia digitale, questo è diventato un possibile fattore di
differenziazione linguistica.
La stratificazione sociale
Lo strato sociale è il primo dei fattori che vengono presi in considerazione nelle indagini
sociolinguistiche. Con ‘’stratificazione sociale’’ ci riferiamo a una società divisa in classi o strati
sociali, anche se recentemente questa nozione viene considerata multifattoriale e problematica, in
quanto ad oggi è difficile suddividere la società per esempio in, alta borghesia, piccola borghesia,
ceto operaio poiché questa differenziazione ha perso consistenza, con un generale
rimescolamento della popolazione, dei modelli di comportamento e degli stili di vita.
Di fronte a questa difficoltà, nella ricerca sociolinguistica si prende come indicatore della
stratificazione sociale o un criterio oggettivamente misurabile o si può procedere con una somma
calibrati di differenti fattori o criteri.
Tra i fattori o i criteri che vengono utilizzati per indicare la posizione dei parlanti nella
stratificazione sociale i principali sono di tre tipi:
-criteri economici: reddito, tipo di occupazione, professione
-criteri educativi: scolarizzazione e gradi di istruzione
-criteri antropologico-culturali: modelli di comportamento e stili di vita.
Nelle indagini sociolinguistiche italiane i criteri più utilizzati sono, in primo luogo il grado di
istruzione e in secondo luogo l’attvità svolta. Lo Piparo, nel 1990, durante un’indagine
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
sociolinguistica sull’uso dell’italiano e del dialetto in Sicilia, utilizzò come unico criterio per la
stratificazione sociale il grado di istruzione, dividendolo in cinque categorie: nessuno; elementare;
medio; diploma e laurea.
Ramat (1979) e poi Francescato/Solari Francescato (1994) in un’indagine sociolinguistica sull’uso
delle varietà linguistiche presenti in aree di parlata minoritaria in Val d’Aosta, con minoranza
Walter, utilizzarono una combinazione tra sfera occupazionale e grado di istruzione espressa da
un indice, conosciuto come indice di Havinghurst, calcolato secondo una formula ponderata
equivalente a: istruzione x2 + livello professionale x3, sulla base cui si individuano quattro ceti
sociali: basso, medio basso, medio alto, alto.
Francescato/ Solari Francescato dividono la sfera di attività in due macroclassi: ‘’attività
professionali’’ e ‘’attività non professionali’’, comprendenti la prima cinque raggruppamenti e la
seconda quattro.
Attività professionali: 1. Operaio non specializzato, contadino, colf
2. Operaio specializzato, artigiano, impiegato di bassa qualifica, militare
3. Commerciante esercente
4. impiegati, insegnati, infermieri diplomati
5. Professionisti, imprenditori
Attività non professionali: 1. Casalinghe
2. Studenti
3. Disoccupati
4. Pensionati
Gruppo sociale è una nozione meno problematica rispetto a quella di ‘’stratificazione sociale’’
anche se spesso generica e a volte vaga nei fattori che la determinano. Si tratta del
riconoscimento di gruppi di individui che non implicano gerarchia o gradini e livelli in una scala
sociale, ma rappresenta compartizioni in una società. L’appartenenza a un gruppo sociale implica
la condivisione di un territorio e di valori e aspettative, e anche l’esistenza di norme esplicite o
implicite di comportamento.
La società è costituita dalla somma dei gruppi sociali.
I gruppi sociali possono essere sia autodefiniti dall’interno attraverso una consapevolezza
esplicita di identificazione dei membri, sia dall’esterno, in maniera rispondente o non rispondente
a caratteri che il gruppo considera pertinenti per la propria caratterizzazione.
L’appartenenza di gruppo e i valori di identità che la esprimono trovano manifestazione simbolica
in varianti linguistiche o comportamenti linguistici particolari.
Le varietà di lingua che sono espressione di un particolare gruppo sociale vengono chiamate
‘’socioletti’’.
In generale, il comportamento linguistico dei parlanti può variare, anche sensibilmente, a seconda
che ci si rivolga a membri del gruppo o a persone esterne. Questa opposizione, in
sociolinguistica, è chiamata: comportamento ‘’in group’’ per i membri del gruppo, e
comportamento ‘’out group’’ per coloro esterni. La varietà di lingua tipicamente utilizzata tra i
membri del gruppo viene chiamata ‘’we code’’, in opposizione al ‘’they code’’, ovvero la lingua di
coloro che non fanno parte del gruppo.
Nelle società con forte diversità a base etnica, e nei paesi dell’Europa occidentale, un fattore
rilevante di identità di gruppo è costituito da una comune origine nazionale.
In questi casi diventa importante, come fattore di differenziazione e particolarizione linguistica, la
variabile ‘’gruppo etnico’’, che può dare luogo a varietà etniche dette ‘’etnoletti’’. L’etnicità è
peraltro un concetto complesso e multiforme, che si presta ad essere considerato da diversi punti
di vista, a seconda che si mea l’accento sulla sua natura di insieme di schemi comportamentali
acquistati nella socializzazione infantile, di categorie discrete e statiche di comportamento
culturalmente ereditate; ovvero la si guardi come una categoria cognitiva dinamica, costruita dai
soggetti stessi in risposta alle differenze via via percepite.
Nell’identità etnica e nelle sue espressioni sembrano convivere aspetti da ricondurre ad entrambe
le prospettive.
Le varietà di lingua sviluppate dai parlanti non nativi di quella lingua vedo solitamente designate
come interlingue.
Un caso tipico di varietà linguistica utilizzata all’interno di un gruppo sociale sono i gerghi. Un
gergo in senso stretto è un linguaggio fondato su trasformazioni convenzionali di una lingua o di
uno o più dialetti che viene usato da chi appartiene a determinati gruppi sociali, come per
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
esempio, malviventi o sette religiose o politiche, per comunicare con gli altri membri del gruppo
sociale senza farsi comprendere da coloro che sono estranei al gruppo.
Il carattere di voluta ed esibita differenziazione sociale intrinseco dei gerghi è esaltato nei gerghi
storici di gruppi anti società o di marginali e categorie subalterne e si manifesta tramite
l’occultamento della riconoscibilità della parola attraverso diversi sistemi.
Un esempio può essere la risemantizzazione con metafore come nel caso di rosso/rossetto:
moneta d’oro, barbina: pecora, barbetta: capra. Altro esempio sono le creazioni neologiche
come nel caso di puffo: debito oppure taffiare: mangiare. Ci sono anche casi in cui vengono presi
dei termini da lingue straniere come del caso di falsi: carne dal tedesco, ma anche il termine
gaggio: contadino/sempliciotto che viene preso dalle parlate zingare. Possiamo trovare anche
casi di ristrutturazione della parola attraverso l’inversione sillabica, tipica del Verlan francese
(usato oggi dai giovani) alcuni esempi sono: neca: cane, ntinaca: cantina. O anche casi di
deformazione fonetica tramite il troncamento come nel caso di caramba: carabinieri e
pula:polizia.
Per quanto riguarda la sintassi, invece il gergo si appoggia sempre sulla varietà di lingua ospite,
vale a dire la lingua sul quale il gergo si innesta: i gerghi, in questo senso sono anche verità
parassitarie di altri sistemi linguistici.
Altra cosa rispetto ai gerghi sono i modi d’uso della lingua, chiamati anche linguaggi settoriali,
ricchi di una terminologia più o meno specifica e usata in ambienti o da categorie sociali
particolari: i cosiddetti gerghi della politica, dell’economia, dell’informatica, fino ad arrivare ai
‘’gerghi giovanili’’.
2.1.2 fattori demografici
Un’altro dei fattori presi in considerazione nelle indagini correlazioni è l’età. Essendo l’età una
grandezza continua occorre stabilire delle classi d’età. Spesso ci si accontenta delle divisioni in
classi generazionali ampie, per esempio: adolescenti, giovani, adulti e anziani, ma il problema
principale è stabilire le fasce d’età che determinano l’appartenenza ad una di queste classi.
Possiamo utilizzare una suddivisione grossolana che prevede <18 (bambini, adolescenti, post
adolescenti), 18-35 (giovani e giovani adulti), 35-60 (adulti) 60> (anziani).
Una divisione alternativa riconosce solo tre classi di età : <24, 24-54, 55>.
Una nozione rilevante in sociolinguistica che collegata alla nozione di classe d’età è quella di
gruppo dei pari. Con gruppo dei pari, ci si riferisce principalmente agli adolescenti, e si indicano i
coetanei che partecipano alle stesse attività, condividono abitudini e atteggiamenti e hanno la
stessa posizione della struttura sociale. La sociolinguistica, dimostra che il modello costituito
dagli usi linguistici dei pari prevalga su quello della famiglia e dei genitori nell’influenzare il
comportamento linguistico adolescenziale e postadolescenziale.
Negli anni settanta, tramite un’indagine sociolinguistica svolta nell’area rurale e urbana degli stati
uniti d’America Labov dimostra che lungo il percorso di apprendimento del linguaggio, i l’influenza
dei coetanei domina quella dei genitori in una larga varietà di circostanze.
Lo studio di varietà di lingua delle classi di età è interessante soprattutto per quanto riguarda la
fascia generazionale dei giovani da un lato e degli anziani dall’altro. Dagli anni novanta si sono
moltiplicati gli studi aventi come soggetto la lingua dei giovani, che si è venuta definendo come
varietà di un determinato gruppo sociale ma che oggi vede dei termini utilizzati nel parlato
colloquiale informale a valenza espressiva come sgamare, dare buca, da paura, sclerare, con
fenomeni di riduzione della parola come nel caso di raga, simpa, prof; a forestierismi e
pseudoforestierismi come in parents, sniffare. Si possono trovare anche metafore e metonimie
come nel caso di manzo ‘’stare tranquillo’’ e gergalismi e dialettici vari.
Altri esempi caratterizzanti la lingua dei giovani sono emersi in un’indagine di Ambrogio/
Casalegno del 2004, per citarne alcuni: limonare ‘’baciare con la lingua’’, sclero ‘’ammattimento,
follia’’.
Per quanto riguarda la lingua degli anziani, invece, Taddei Gheiler nel 2005 ha condotto un
indagine nel canton Ticino e questa indagine dimostra come, contrariamente ai giovani, gli anziani
non hanno una vera e propria varietà di lingua. Inoltre emerge anche che la differenza
fondamentale tra giovani e anziani non sta nella competenza e nell’uso del sistema linguistico,
pensi, nelle prestazioni in diversi compiti verbali. I risultati di alcuni test, sulla competenza
linguistica, svolti dimostrano che non vi sono differenze veramente significative ma gli anziani
raggiungono risultati mediamente inferiori nei test che coinvolgono la memoria. Inoltre risulta che
gli anziani hanno maggior accesso alle zone diverse della variazione di registro, in quanto si pensa
sia una capacità che si affina durante l’arco della vita.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Connessa con l’eta di apprendimento è molto importante la nozione di parlante nativo, con
parlante nativo si intende chi ha imparato quella lingua come prima lingua nella socializzazione
primaria. Il parlante nativo è considerato il depositario dell’effettiva competenza linguistica.
Nella sociolinguistica anglosassone, la varietà di lingua non standardizzata e spontanea usata dai
parlanti nativi è detta vernacular (mentre nella sociolinguistica italiana con il termine vernacolare
ci si riferisce ad un dialetto particolarmente marcato).
Alla nozione di parlante nativo si oppone quella di parlante non nativo, ovvero colui che
acquisisce competenze di una lingua dopo la socializzazione primaria.
La questione dei parlanti nativi in Italia è molto delicata in quanto in molte indagini di sociologia
delle lingue vengono considerati parlanti nativi coloro che posseggono padronanza dell’italiano e
provengono da famiglia italiana, anche se l’essere parlanti nativi dovrebbe riferirsi solamente alle
generazioni giovani e relativamente giovani in quanto, fino agli anni sessanta era frequente la
lingua vernacolare.
Un altro fattore demografico che costituisce una delle variabili sociolinguistiche è il sesso, ma
bisogna fare una distinzione tra sesso e genere in quanto ‘’sesso’’ è un concetto biologico, mentre
‘’genere’’ è un concetto socio-culturale.
Da alcune ricerche è emerso che le donne tendono maggiormente a prestare attenzione alle
forme di prestigio, mentre tendono ad evitare le forme stigmatizzate, inoltre è emerso anche che
le donne tendono ad utilizzare maggiormente i diminutivi, anche se queste differenze sono molto
soggette a stereotipi.
Invece le differenze di genere sembrano essere più nette per quanto riguarda i presupposti
pragmatici su cui si basano gli stili conversazionali. A livello pragmatico è stata sottolineata la
tendenza delle donne ad adottare un modello di interazione verbale basato sulla cortesia,
attraverso cui si esprimono emozioni e sentimenti, mentre per quanto riguarda gli uomini il loro
modello di interazione verbale è direttivo e pratico e questo porta alcune volte a fraintendimenti.
Stando a quello che disse Tannen nel 1992 il dialogo uomo-donna ha i caratteri di una
comunicazione interculturale , in cui uomini e donne parlano con intenzioni differenti e quindi non
si comprendono.
D’altra parte, nelle ricerche sociolinguistiche il sesso del parlante spesso correla male con la
variazione linguistica e per questo non è un fattore determinante o influente.
Secondo gli studi di Labov, da un lato quando si hanno variabili sociolinguistiche stabili, quindi
durature nel tempo, gli uomini tendono ad utilizzare le forme più instabili, quindi le donne sono più
sensibili al prestigio. Dall’altro lato quanto i mutamenti vengono dall’alto le donne li accolgono più
volentieri degli uomini, mentre per quanto riguarda i mutamenti dal basso, in questo caso le
donne sono più innovatrici, cosi creando un paradosso di genere. Il paradosso di genere
consiste nel fatto che le donne mostrano meno deviazioni quando queste deviazioni sono
apertamente censurate, mentre deviano più degli uomini quando non sono censurati.
Spesso, rilevanti per le correlazioni con il comportamento linguistico dei parlanti sono anche il
luogo di nascita, di abitazione o residenza. Non solo perché la lingua riflette diverse provenienze
regionali ma che perché risiedere in grandi città o in piccoli centri o in campagna influenza la
scelta linguistica: in italiano un esempio può essere parlare il dialetto o la varietà standard.
Negli anni novanta si è visto il proliferarsi della sociolinguistica urbana come ramo vero e proprio
della sociolinguistica, con le sue specificità. Perfino l’abitare in diversi quartieri della stessa città o
in frazioni diverse dello stesso comune può correlare con variabili linguistiche e differenti
comportamenti linguistici. Gia nella dialettologia classica dell’inizio 900 emerse l’importanza del
concetto di punto linguistico, ovvero l’unità minima socio-geograficamente rilevante dal punto di
vista della geografia linguistica e della sociolinguistica.
In generale lo spazio rappresenta comunque un fattore fra i più rilevanti dal punto di vista della
linguistica esterna.
La migrazione porta a una aumento della gamma di variazione e della complessità del repertorio
linguistico e l’adozione almeno minimale della lingua veicolare corrente nella comunità di arrivo.
La lingua materna dei migranti conosce inevitabilmente una riduzione dei domini di impiego con
una conseguente ristrutturazione del repertorio dovuta alla nuova presenza della lingua della
comunità ospite. L’uso sempre più limitato, e solo in situazioni in-group della lingua materna
d’origine porta, soprattutto nella seconda e terza generazione di immigrati a fenomeni di
decadimento di lingua, da prima sotto forma di language attrition, con una riduzione della
competenza e una semplificazione delle strutture, e poi di vera e propria perdita di lingua. Si
hanno cosi dei semiparlanti con poche competenze della lingua d’origine.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Nella seconda generazione la compresenza della lingua della comunità ospite porta spesso a
forme di bilinguismo individuali.
Gia nella seconda generazione, ma soprattutto dalla terza in poi, si viene a creare un rapporto
particolare con la lingua d’origine dei genitori, in quanto viene imparata o studiato dopo la
socializzazione primaria ha il carattere idi un’eredità culturale, per questo viene chiamata heritage
language. Con tale termine però, non si designa solamente la lingua d’origine dei genitori di
immigrati di seconda o terza generazione, bensì indica una lingua imparata o studiata, da un
parlante, diversa dalla lingua dominante nel contesto sociale, e quindi ‘’lingua ereditaria’’ diventa
un sinonimo di ‘’lingua minoritaria’’.
Un comportamento di particolare interesse è il language crossing. Viene definito cosi l’impiego
occasionale di una varietà che non fa parte del nostro repertorio consuetudinario, un esempio può
essere un giovane ragazzo milanese che con i suoi coetanei imita il dialetto napoletano parlando
di canzoni napoletane.
Un’altro concetto importante è quello di superdiversità, con cui si indica l’ammontare di diversità
socioculturali.
All’interno di questo contesto un concetto molto rilevante è quello di polylanguaging, per
indicare nel discorso l’uso di forme caratterizzanti altre lingue, anche se effettivamente non vi è
una grande competenza di esse. Il concetto che si oppone al polylanguaging è il multilinguismo,
in cui la competenza effettiva degli altri sistemi linguistici è necessaria.
2.1.3 fattori situazionali
Ogni elemento costitutivo di una situazione comunicativa è suscettibile di influenzare
l’utilizzazione della varietà di lingua e il comportamento linguistico. Riferendoci alla lista di Hymes
del 1980 vanno considerati questi elementi: l’occasione, la scena e l’ambiente, i partecipanti, gli
scopi relativi alla società e ai partecipanti, le sfere di attività e gli argomenti…. Ecc
Di rilevanza primaria è il fattore degli interlocutori, che sono anche la fonte del fenomeno di
accomodamento, ovvero, un processo in cui uno degli interlocutori modifica le sue scelte
linguistiche in base all’influenza dell’altro interlocutore.
Il processo di accomodamento può manifestarsi tramite convergenza, nel caso in cui un
interlocutore modifica le sue scelte linguistiche imitando quelle di un altro interlocutore.
Ma il processo di accomodamento può anche manifestarsi con divergenza, ovvero quando
l’interlocutore vuole sottolineare la distanza con l’altro accentua i tratti che differenziano la sua
varietà da quella dell’altro interlocutore.
I molteplici fattore che intervengono nel costituire una situazione comunicativa sono: campo,
modo e tenore.
Campo: con campo ci si riferisce al genere di attività svolta nella situazione e dall’insieme delle
esperienze, delle azioni e degli argomenti in essa compresi.
Modo: dato dal mezzo o canale fisico attraverso il quale avviene la comunicazione in una
determinata situazione e dal genere di contatto interazionale che vi si attua. La fondamentale
differenza di modo è tra scritto e parlano.
Tenore: è costituito dai ruoli sociali e comunicativi reciproci assunti e messi in atto dai
partecipanti all’interazione comunicativa e determina la maniera con la quale gli interlocutori si
rivolgono l’un l’altro.
Per dominio si intende la costellazione di situazioni sociali riferite ad una medesima sfera di
esperienza di attività, con la presenza comune di determinati ruoli, scopi e norme che organizzano
e definiscono un ambito specifico della vita sociale degli individui. Per esempio, la famiglia e il
parentado, la scuola, la religione…
La nozione di dominio risulta particolarmente rilevante per descrivere rapporti fra gli usi delle
diverse lingue in situazioni di plurilinguismo e in generale nella tipologia dei repertori.
Negli anni più vicini a noi, assume caratteristiche di un dominio a se la comunicazione on-line, che
nelle sue varie forme ha portato ad una serie di usi della lingua che mette in crisi la bipartizione tra
scritto e parlato. La lingua digitata è un parlato non sorvegliato in forma scritta che ha condotto
alla formazione del natspeack, una varietà di lingua tipica e propria della comunicazione nel web.
2.2 concetti a matrice sociale importanti in sociolinguistica
Si intende per prestigiosa valutazione sociale positiva attribuita ad un qualche oggetto,
fenomeno, fatto sociale; in particolare questo valore positivo si manifesta nella proprietà di essere
un oggetto o comportamento degno di imitazione.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Il prestigio dipende quindi dalla valutazione personale e sociale, che i membri di una comunità
ritengono desiderabili.
Il contrario di prestigio è stigma, che designa la sanzione sociale negativa, la non accettazione
sociale di un oggetto.
In senso specifico, il prestigio viene definito come valore di una lingua per l’avanzamento sociale,
inoltre la nozione di prestigio è plurifattoriale poiché comprende:
- gli atteggiamenti linguistici favorevoli dei parlanti
- Il valore simbolo dei valori della comunità attribuito alla varietà
- L’essere veicolo della tradizione letteraria
- L’essere parlata dai gruppi sociali dominanti
L’insieme di questi fattori determina una scala di prestigio che va dalle varietà che hanno grande
prestigio a quelle con poco prestigio o addirittura stigmatizzate.
La varietà linguistica di più alto prestigio è la varietà standard.
Con la nozione di rete sociale, nel senso antropologico, si intende l’insieme dei legami che vi
sono tra una determinata persona e coloro con cui interagisce.
Proprietà strutturali della rete sociale sono la densità e la molteplicità.
La densità di una rete sociale è data dalla quantità di legami diretti effettivi in relazione alla
quantità di legami diretti possibili. Più il valore è vicino a 1 più la rete sociale è densa.
La molteplicità è invece data dalla quantità di legami multipli in rapporto alla quantità totale dei
legami, più il valore è vicino a 1 più la rete sociale è molteplice.
Una zona di rete con legami più fitti è detta cluster (grappolo) e possiamo dire che la rete a una
struttura a cipolla, costituita da delle celle.
La cella centrale è quella che riguarda la parentela e i legami stretti, dopo si trova una cella
utilitaristica caratterizzata da legami con persone per ragioni pratiche. La cella utilitaristica è
seguita da una cella nominale che comprende i legami con persone che si conoscono ma non
hanno rilevanza affettiva ed infine lo strato più esterno è chiamato cella allargata, caratterizzata
dai rapporti con persone che si conoscono poco e con cui si hanno rapporti superficiali.
Le reti a maglie strette (dense e molteplici) sono ingegnere conservative, mentre le reti a maglie
larghe (poco dense e poco molteplici) sono innovative. Reti dense e con legami forti favoriscono,
negli individui che vi sono maggiormente integrati un comportamento linguistico distante dalla
lingua standard, strettamente conservativo della varietà vernacolare.
Particolarmente importanti per la diffusione delle innovazioni sono i membri della cella allargata
poiché il meccanismo percorso delle innovazioni è basato sul principio di imitazione/convergenza
e all’opposto di divergenza.
La nozione di rete sociale, è molto connessa con quella di comunità linguistica. Una comunità
linguistica infatti per certi aspetti può essere concepita come una somma o un prodotto di tante
reti sociali.
Dalla nozione di rete sociale va destina quella di comunità pratica. Con questa nozione ci si
riferisce ad un gruppo di individui che svolge insieme una particolare attività per un determinato
scopo, oppure si trovano a essere impegnati a raggiungere un obbiettivo comune, come nel caso
di una classe scolastica o una squadra di calcio. Questa nozione viene impiegata in indagini
sociolinguistiche in quanto appare molto utile per cogliere condivisioni di comportamenti.
Un concetto sociale che riveste particolare importanza in una visuale sociolinguistica
interpretativa è quello di identità, con il relativo processo di identificazione attraverso cui si
manifesta. Ogni realizzazione del comportamento linguistico di un parlante può essere
considerata un ‘’atto di identità’’ con il quale il parlante si riconosce appartenente ad un
determinato gruppo e si colloca in una posizione nella trama dei rapporti della società. Ogni
individuo crea i modelli del proprio comportamento linguistico in maniera tale da somigliare ai
membri del gruppo con il quale intende essere identificato.
In conclusione, il concetto di identità è centrale in sociolinguistica.
Capitolo 3- sociologia delle lingue
3.1 status e funzione di una lingua
Due concetti basilari per stabilire la posizione sociale di una lingua sono quelli di status e
funzione.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Con status si intendono gli usi a cui la lingua può adempiere, quindi cosa si può fare con un
determinato sistema linguistico, mentre con funzione si indicano gli usi a cui una lingua
effettivamente adempie, e quindi cosa si fa effettivamente con quel sistema linguistico.
Può accadere che una lingua sia destinata a svolgere certi compiti in base al proprio status, ma di
fatto non venga impiegata per tali attività, non sempre lo status di una lingua corrisponde alla sua
funzione. Un esempio può essere il gaelico irlandese che è lingua ufficiale nella Repubblica
Irlandese, insieme all’inglese, ma di fatto è scarsamente praticato nei domini d’uso ufficiali.
Per poter svolgere una certa funzione una lingua deve possedere determinate caratteristiche dette
attributi. Gli attributi consentono di individuare tipi funzionali di lingua. Un tipo funzionale è
identificato in base al genere di usi a cui una lingua è destinata in una comunità e dunque allo
status che le è riconosciuto.
Gli attributi che concorrono a definire lo status di una lingua sono di tre tipi: geo-politici, socio-
demografici e linguistici.
Fattori geo-politici: hanno a che fare con la diffusione geografica, i sistemi sociali e le istituzioni
di riferimento, e, lo statuto giuridico e legale di una lingua.
In base alla diffusione geografica possiamo definire un primo tipo funzionale chiamato lingua
pluricentrica, con lingua pluricentrica si intende una varietà di lingua che sia lingua nazionale in
più paesi e che in ogni paese ci sia una varietà standard differente della stessa lingua. I diversi
centri possono essere più o meno autonomi nell’elaborazione della propria normativa, per questo
si parla di lingua endonormativa o lingua esonormativa.
Con lingua endonormativa si intende una lingua più autonoma nella definizione della propria
norma, mente con esonormativa si indica una lingua meno autonoma e dipendente da modelli
esterni.
Un esempio di lingua pluricentrica è il tedesco, che è lingua nazionale in germania, in svizzera e in
Austria e che ha uno standard diverso, con specifiche peculiarità in ognuno di questi paesi.
Tra le ragione per cui vengono a formarsi lingue pluricentriche ci sono:
-colonizzazione, come nel caso dell’inglese e del francese
-immigrazione, come nel caso dello spagnolo negli USA
- ridefinizione dei confini, come nel caso del neerlandese
- Separazione politica, come nel caso del coreano
Altri tipi funzionali si possono riconoscere in baso ai sistemi sociali e le istituzioni di
riferimento. Un caso di questi tipi funzionali è la lingua di lavoro, con cui si indica una varietà
usata sin ambito ufficiale presso un dato ente o una data organizzazione internazionale. Un
esempio può essere L’ONU che ha come lingue di lavoro, l’arabo, l’inglese, il cinese, ma
possiamo prendere in considerazione anche l’Unione Europea che come lingue di lavoro 24
varietà, tutte le lingue ufficiali dei paesi membri.
Con lingua internazionale, invece ci riferiamo a una lingua adibita alla comunicazione fra stati o
istituzioni internazionali, la lingua internazionale per eccellenza oggi è l’inglese.
Con lingua nazionale si intende una lingua che sia espressione del senso di appartenenza e
identificazione nazionale.
Per quanto riguarda lo statuto giuridico e legale di una lingua è possibile distinguere tra lingue
legislativamente riconosciute e non.
Fra quelle legislativamente riconosciute è rilevante la nozione di lingua ufficiale, è lingua ufficiale
la lingua dell’amministrazione statale, ovvero la lingua adibita agli usi governativi.
Uno stesso stato può avere più lingue ufficiali, per esempio la svizzera ne conta 4: il tedesco,
francese italiano e romancio, anche se il romancio è considerata semi-ufficiale.
Una stessa lingua può essere sia lingua nazionale che lingua ufficiale, ma ci sono anche alcuni
casi in cui uno stato con più lingue ufficiali ma soltanto una di queste è lingua nazionale, come nel
caso del Lussemburgo, in cui le lingue ufficiali sono il francese, il tedesco e il lussemburghese, ma
solamente l’ultima è considerata lingua nazionale.
Si parla anche di lingue ufficiali regionali intendendo con questo termine lingue ufficiali
solamente in alcune regioni, come nel caso del basco, che è lingua ufficiale in Spagna solamente
nella regione dei paesi baschi e della navarra.
Fattori socio-demografici: concorrono poi a definire lo status di una lingua alcuni fattori, socio
demografici, da un lato il numero e il tipo dei parlanti e le loro caratteristiche socio-culturali,
dall’atro lato i domini d’uso della lingua.
Rispetto al numero di parlanti è importante il concetto di lingua minoritaria, con cui si intende
una lingua parlata da una comunità che si trova in posizione di minoranza all’interno di uno stato,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
generalmente diversa dalla lingua ufficiale. Stando alla carta europea entrata in vigore nel 1998 si
possono riconoscere 84 lingue minoritarie in Europa, come l’arabo in Spagna o l’italiano in
croazia, Slovenia e svizzera.
Per quanto riguarda il numero assoluto dei parlanti le lingue si possono dividere in: grandi, medie,
medio-piccole e piccolo.
Quelle grandi sono quelle parlate da centinaia di milioni di persone, come l’inglese, lo spagnolo o
il cinese mandarino.
Quelle medie sono quelle parlate da decine di milioni di persone, come il francese e l’italiano.
Quelle medio piccole, comprendono pochi milioni di parlanti come l’armeno e il danese e le
ultime, quelle piccole, comprendono migliaia, ma anche centinaia, di parlottanti come i sorbo o il
romancio.
Quanto al tipo dei parlanti, il principale parametro principale ad entrare in correlazione con lo
status è il carattere di parlante nativo o non nativo degli utenti di una lingua.
Con lingua vernacolare si intende una lingua che sia parlata in un paese da gruppi di parlanti
nativi.
Sull’essere strumento di comunicazione tra parlanti nativi di lingue diverse è centrato il concetto
di lingua franca, con cui si indica una lingua usata per la comunicazione tra parlanti con lingue
madri diverse. Si parla anche di ‘’lingua veicolare’’. Fra le principali lingue franche affermatesi
storicamente abbiamo alcune lingue del culto religioso, come il sanscrito o l’arabo, ma anche il
latino.
Concorrono a determinare la posizione sociale di una lingua le caratteristiche sociali dei parlanti:
l’appartenenza etnica, il sesso, la religione, la fascia generazionale e la classe sociale. Da alcune
indagine svolte a tal proposito emerge che in camerun, il francese è la varietà utilizzata dai ceti
alti, mentre nel Queensland australiano il dyirbal è utilizzato dagli anziani.
Una lingua poi può essere utilizzata in tutti i domini o conoscere impieghi diversi in relazione a
classi di situazioni differenti. In comunità plurilingue, le lingue compresenti sono utilizzate in
misura diversa a seconda dei domini, la distribuzione delle lingue nei vari domini è un indicatore
molto importante dello status. Si possono considerare degli usi ‘’bassi’’ e ‘’alti’’ della lingua, come
nel caso dell’italiano e del dialetto.
Infine il gruppo di attributi riconducibili a fattori linguistici sono: il grado di elaborazione di una
lingua, la sua standardizzazione e la vitalità della lingua.
Con il concetto di lingua per elaborazione si intende una lingua dotata di un consolidato sistema
di scrittura che riesce a soddisfare le esigenze di una società legate ad attività sociali, culturali,
scientifiche e tecnologiche. Kloss individua gradi progressivi di elaborazione in base alla
combinazione del livello educativo di sviluppo e del genere di argomenti trattati nei testi prodotti.
Una varietà deve essere usata per pubblicare testi a livello di scuola elementare per essere
sufficientemente elaborata (casella n.1 pag 66), mentre per avere il massimo grado di
elaborazione deve essere usata per pubblicare testi a tutti livelli di sviluppo su qualsiasi
argomento (casella n.9 p 66).
Hanno un grado di elaborazione relativamente basso lingue standard codificate recentemente,
mentre hanno il massimo livello di elaborazione le lingue standard completamente sviluppate,
come nel caso dell’inglese, del francese e dell’italiano.
Per Kloss lingua per elaborazione è equivalente a lingua standard.
Proprio il grado di standardizzazione è un parametro determinante per lo status di una lingua.
Seguendo il modello di Haugen del 1966 il processo di standardizzazione prevede 4 fasi.
- fase di selezione, in cui si sceglie la varietà da utilizzare
- Fase di codificazione, in quale avviene la fissazione di regole formative
- Fase di implementazione, in cui la varietà viene diffusa e accettata
- Fase di elaborazione, in cui si sviluppano le funzioni e i domini di impiego della norma.
Inoltre il processo di standardizzazione può subire periodicamente una ridefinizione di ciò che è
standard e ciò che non lo è.
L’ultimo fattore linguistico da considerare è la vitalità di una lingua. La nozione di vitalità va intesa
in due sensi: vitalità interna e esterna.
La vitalità esterna si fonda principalmente sugli usi di una lingua nella società e sulla continuità
della trasmissione da generazione a generazione. È vitale una lingua che sia non solamente
impiegata negli usi parlati, ma anche in quelli scritti e formali.
La vitalità interna riguarda il mantenimento delle caratteristiche strutturali e semantico-lessicali di
una lingua e la produttività delle sue regole.
L’essere vitale rappresenta per una lingua la situazione inversa ad essere minacciata, ovvero
quando perde progressivamente domini d’uso e parlanti e rischia di estinguersi.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Il grado di vitalità può essere misurato secondo due parametri, nove dei quali fanno parte
delll’’indice unesco e sono:
-trasmissione integenerazionale
-Numero assoluto dei parlanti
- proporzione di paranti rispetto alla popolazione totale della comunità
- Perdita dei domini d’uso
- Uso in nuovi domini e nuovi media
- Materiali per l’educazione linguistica e l’alfabetizzazione
- Atteggiamenti e politiche linguistiche delle istituzioni
- Atteggiamenti dei parlanti nei confronti della loro lingua
- Ammontare e qualità della documentazione sulla lingua
3.2 lingua standard, dialetto, lingua minoritaria
Una lingua standard è una lingua che ha una varietà standard, dove con varietà standard si
intende una varietà di lingua che dispone di una norma esplicitamente codificata e che vale come
modello di riferimento per il corretto uso della lingua. Una lingua con una varietà standard è in
grado di coprire la gamma più vasta di domini di impiego.
Il concetto di standard può essere assunto sia in prospettiva prescritti che descrittiva. Secondo la
prospettiva prescritti, lo standard è concepito come l’insieme delle norme di riferimento che
regolano l’uso corretto della lingua, mentre secondo la prospettiva descrittiva è inteso come
l’insieme di tratti linguistici unitari condivisi da un’intera comunità senza differenze.
Tenendo conto delle sue proprietà principali, possiamo dire che lo standard è:
- codificato: definito dall’esistenza di norme esplicite
- Sovraregionale: le norme che costituiscono lo standard sono unitarie e diffuse in maniera
indifferenziata in tutto il territorio
- Elaborato: adatto a tutti gli usi e ai domini d’impiego di una lingua
- Di prestigio: l’uso della varietà standard è caratteristico dei ceti alti
- Invariante: lo standard è uniforme e non prevedeva scelta di regole diverse da quelle codificate
normativamente
- Stabile ma al tempo stesso flessibile
- Scritto:lo standard esiste principalmente in forma scritta.
La formazione di uno standard è un processo che si caratterizza per l’intervento di più agenti.
Ammon nel 2003 schematizza le principali forze sociali attive (figura pag 71).
Secondo il suo modello esercitano un ruolo diretto sulla definizione dello standard: i parlanti e gli
scriventi professionisti, che forniscono testi modello per la codificazione.
Alla nozione di lingua standard si oppone quella di dialetto. In una prima accezione un dialetto è
un sistema linguistico subordinato a una lingua standard con la quale è strettamente imparentato
e in confronto alla quale ha una diffusione areale più limitata: il dialetto ha poi una propria storia e
una propria struttura diversa da quella della lingua standard. Un esempio sono i dialetti italo
romanzi e l’italiano, in cui l’italiano è la lingua standard ed è destinato agli usi alti, mentre i dialetti
italo romanzi sono destinati agli usi bassi.
I dialetti italo romanzi hanno un storia autonoma, parallela a quella del ‘’dialetto’’ che poi è stato
promosso a standard. Infatti il fiorentino venne progressivamente ad acquistare prestigio fino a
essere codificato come italiano standard.
I dialetti italo romanzi hanno una certa distanza strutturale dall’italiano, non solo nel lessico e nella
fonetica ma anche nella morfologia e nella sintassi. In alcuni dialetti la formazione del plurale non
avviene tramite l’alternanza delle desinenze ma da altri meccanismi come la sottrazione di
morfemi (es. lombardo, ‘’donna’’ dona- ‘’donne’’ don).
Con lingua per distanziazione ci si riferisce una lingua riconosciuta come lingua a se, in virtu
delle proprie caratteristiche strutturali.
La distanza linguistica è tutta via difficile da quantificare e per operare una valutazione attendibile
conviene tener conto sia di criteri sociologici sia di criteri linguistici.
Tra i criteri sociologici troviamo la reciproca comprenisibilità fa i parlanti di sistemi linguistici
diversi, tra quelli linguistici invece le differenze riscontrabili da un lato nel cosiddetto lessico
fondamentale e poi a tutti i livelli di analisi.
La nozione di lingua per distanziazione si può opporre a quella di lingua per elaborazione,
permettendo cosi di ricondurre tutte le lingue storico- naturali a tre tipi
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
1. lingue sia per elaborazione che per distanziazione, che si differenziano le une dalle altre per
la propria struttura interna, ma che sono in grado di soddisfare tutti i bisogni di una società
2. Lingue per distanziazione ma non per elaborazione, come le migliaia di lingue parlate in
Africa
3. Lingue per elaborazione ma non per distanziazione, che non si distinguono per la loro
struttura interna ma hanno sviluppato un grado di elaborazione, come il serbo o il croato.
Un dialetto può essere considerato un sistema linguistico con sufficiente grado di distanziazione,
ma con un basso o nullo grado di elaborazione rispetto alla lingua standard.
Come ogni lingua un dialetto conosce variazione interna, ovvero presenta fanone di alternanza tra
dome diverse equivalenti.
Per definizione il dialetto è poco o per nulla codificato, ma può anche succedere che un dialetto
possa acquistare progressivamente prestigio, quindi a guadagnare status, espandendosi agli usi
alti, fino a diventare una lingua standard.
In una seconda accezione il dialetto identifica una varietà che risulti dalla differenziazione
geografica e sociale di una certa lingua per effetto della diffusione di questa in un territorio. È il
caso delle varietà geografiche dell’inglese britannico e americano.
Per quanto riguarda i dialetti bisogna ricordare la distinzione di Coseriu del 1980 tra dialetti
primari, secondari e terziari. Per dialetti primari si intendo gli idiomi che si sono sviluppati nello
stesso periodo del dialetto che poi è diventato la lingua standard. Con dialetti secondari e terziari
invece ci riferiamo a varietà geografiche di una lingua che si sono sviluppate dopo la varietà
standard, come nel caso degli italiani regionali.
La diaglossia si può spiegare tramite il cono di Auer. Al vertice di questo cono si trova la varietà
standard mentre alla base si trovano i dialetti più arcaici. Questi dialetti tendono ad avvicinarsi
verso lo standard e tendono a modificare la loro struttura tramite dei processi che possono essere
di convergenza, quando le due varietà si avvicinano reciprocamente, ma in questo caso specifico
parliamo di aderenza, in quanto solamente i dialetti arcaici si muovono verso lo standard,
formando cosi quelli che Auer chiama regioletti.
Lo standard dal canto suo ‘’guarda verso il basso’’ mostrandosi ricettivo in confronti di tratti
linguistici presenti nel parlato formale, andando cosi a creare gli standard regionali.
Una nozione di particolare rilievo sul piano dei rapporti fra le lingue è quello di copertura, con cui
si intende il fatto che una lingua, nel territorio in cui è parlata sia strettamente imparentata con una
lingua di cultura e modello formativo di riferimento, in altre parole, che abbia sopra di se una
lingua usata nell’amministrazione e nella scolarizzazione.
La lingua sovraordinata è chiamata tetto, mentre quella subordinata è chiamata ‘’con tetto’’.
Si può parlare di lingua tetto solo se la copertura è sia su base socioculturale sia su base
lingusitica.
La pressione sociale e culturale di una lingua sovraordinata può minacciare la vitalità di una lingua
subordinata.
3.3 repertori linguistici e plurilinguismo
Lingua standard, dialetto e lingua minoritaria possono far tutte parte dello stesso repertorio
linguistico, ovvero l’insieme delle lingue utilizzate all’interno di una comunità linguistica. Si
possono avere sia repertori monolingui, bilingui, in cui sono compresenti due lingue e multilingui,
in cui sono presenti più di due lingue.
Con plurilinguismo ci riferiamo sia ai repertori bilingui che a quelli multilingue.
Una distinzione molto importante da fare è quella tra: bilinguismo sociale, prendendo come
riferimento un’intera comunità e bilinguismo individuale prendendo in considerazione un singolo
individuo.
(ESEMPI DI REPERTORI A PAG 82-83)
Da un lato i repertori plurilingui presentano una certa configurazione di dominanza (nozione
introdotta da weinreich nel 2008) vale a da diversa una situazione in cui una lingua prevale
sull’altra.
Dall’altro lato, molti repertori linguistici presentano una stratificazione delle lingue per diversi livelli
sociali, determinati dal prestigio di cui una lingua fruisce.
Per dare conto della diversa posizione sociale occupata dalle lingue in un repertorio si ricorre
spesso a una schematizzazione a gradini, adottando il modello di Ferguson all origine della
definizione diglossia.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
In questo sistema a gradini abbiamo due livelli in cui A e alto e b è basso, ma data la complessità
dei repertori, alcune volte è necessario introdurre un terzo gradino M (medio).
(esempio p 84).
Occorre distinguere il repertorio linguistico comunitario, da quello individuale, in quanto quello
individuale rappresenta un sottoinsieme di quello comunitario.
Possiamo introdurre alcune distinzioni utili come quella tra bilinguismo endogeno e esogeno.
Con bilinguismo endogeno indichiamo la compresenza di due o più lingue storicamente radicate e
autoctone, mentre con bilinguismo esogeno si intende la compresenza di due o più lingue dovuta
a apporti immigratori in età contemporanea.
In italia è storicamente radicata la compresenza dell’italiano con i dialetti italo romanzi, mentre è
frutto di apporti immigratori recenti la compresenza dell’italiano con altre lingue come l’arabo, il
cinese o il romeno.
Una seconda distinzione necessaria da fare è quella tra bilinguismo monocomunitario e
bicomuntitario.
Si parla di bilinguismo monocomunitario quanto in un territorio sono compresenti due lingue e
tutti i parlanti sono bilingue formando un’unica comunità linguistica, mentre si parla di bilinguismo
bicomunitario quando sin un territorio i sono presenti due lingue, ma alcuni parlanti ne prediligono
una e altri l’altra, quindi raramente si avranno parlanti realmente bilingue.
Si ha bilinguismo bilinguismo monocomunitario in valle d’aosta mentre bicomunitario in alto
adige.
Altra opposizione è quella tra bilinguismo giuridico e di fatto, si parla di bilinguismo giuridico
quando la presenza di più lingue è riconosciuta nella legislazione e nelle istituzioni.
La posizione sociale che le lingue diverse assumono in una comunità linguistica può configurare
la collocazione reciproca all’interno di un repertorio, dando cosi luogo a tipi funzionali di
repertorio.
Possiamo distinguere un tipo di repertorio che non contempla una distribuzione funzionale
gerarchica delle lingue in gioco, e tipi di repertorio che invece si basano sulla compresenza di
lingue differenziate funzionalmente.
A un repertorio del primo tipo ci si riferisce con bilinguismo sociale che consiste nella
compresenza di due lingue diverse, entrambe sia per distanziazione che per elaborazione,
adoperate senza differenza sia per gli usi bassi che per gli usi alti.
Un esempio tipico è quello della comunità di Montreal che utilizza indistintamente sia francese
che inglese.
Per quanto riguarda invece la compresenza di lingue differenziate funzionalmente si possono
riconoscere tre tipi: diglossia, dilalia e bidialettismo.
Diglossia: teorizzata da Ferguson nel 1959 identifica un tipo di repertorio linguistico che presenta
le seguenti caratteristiche. Sono usate in una comunità due lingue relativamente lontane sul piano
strutturale ma delle quali solamente è pienamente elaborata.
Questa A, che è standardizzata e gode di una tradizione letteraria ed è normalmente la lingua
della scolarizzazione. B invece è normalmente appresa nella socializzazione primaria ed è usata
solamente nel parlato informale. Esempi di diglossia sono: arabo classico e varietà locali di arabo
nei paesi arabi.
Dilalia: concetto introdotto da Berruto nel 1987, si ha dilalia quando all’interno di una stessa
comunità sono compresenti lingue strutturalmente diverse A e B (soltato a è anche per
elaborazione). vi è una chiara distinzione funzionale tra A, destinata agli usi alti e B destinata a
quelli bassi. Esistono domini in l’uso di una delle due lingue è esclusivo ma è anche possibile
incontrare domini in cui tutte e due le varietà sono accettabili, sia a che b sono impiegate nella
conversazione ordinaria.
Bidialettismo: nel repertorio coesistono non due lingue ma due varietà della stessa lingua, una la
varietà standard A, e una o più varietà geografiche e sociali B. Esistono domini in cui sono usate
entrambe anche se di norma solo B è utilizzata nella conversazione ordinaria. Non è
standardizzata, non ha impiego letterario.
3.4 contatto linguistico
La compresenza di due o più lingue nel repertorio linguistico da luogo a una situazione di
contatto linguistico. La nozione di contatto linguistico può essere considerata da alla prospettiva
dei parlanti o dalla prospettiva dei sistemi linguistici.
Si hanno tipi differenti di contatto, orizzontale o verticale.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
orizzontale: quando le lingue coinvolte sono comparabili sul piano del prestigio r dell’importanza
socioeconomica e culturale.
Verticale: quando una delle due lingue ha più prestigio e maggiore importanza socioeconomica e
culturale.
Il contatto fra le lingue provoca sempre un passaggio di caratteri strutturali e per questo può
essere bidirezionale, quando lo scambio è reciproco, o, unidirezionale, quando il trasferimento
avviene da una sola lingua. Quando un elemento viene trasferito da una lingua all’altra la lingua da
cui proviene viene detta lingua fonte, mentre quella in cui entra lingua ricevente.
L’italiano è coinvolto in diverse situazioni di contatto in quanto è in contatto verticale e
bidirezionale con i dialetti italoromanzi, mentre è in contatto verticale con il tedesco in alto adige e
il francese in valle d’sosta.
Il contatto linguistico da luogo ad un ampia gamma di fenomeni che possono avvenire sia nel
sistema che nel discorso.
I fenomeni che riguardano il sistema possono essere distinti in due tipi a seconda che il
trasferimento di elementi linguistici da una lingua all’altra coinvolga materiale di ‘’superficie’’ o
interessi un piano più ‘’profondo’’.
PRESTITI O INTERFERENZE
Il caso più tipico di prestito è il trasferimento di elementi lessicali. Il prestito di parole è proprio del
normale funzionamento di ogni lingua, l’italiano per esempio ha assunto come vari prestiti
‘’puzzle’’ ‘’reality’’ dall’inglese.
I prestiti conoscono generalmente un adattamento.
A livello lessicale si possono avere anche fenomeni di interferenze che si dividono in calchi
strutturali e calchi semantici nel calco strutturale la parola cambia la sua struttura mentre nel calco
semantico il significato.
Alcuni esempi di calco strutturali: colletti bianchi, grattacielo, guerra fredda.
Le manifestazione del contatto nel discorso prendono il nome di commutazione di codice. Si
può avere l’uso di lingue diverse nello stesso discorso con interlocutori diversi e a ciascun
interlocutore si parla in una lingua (alternanza di codice).
L’interlocutore può utilizzare differenti lingue e questo cambiamento viene a fine frase
(commutazione interfrasale).
L’interlocutore utilizza differenti lingue all’interno della frase (commutazione intrafrasale).
Capitolo 4 - sociolinguistica e variazione
La variazione sociolinguistica
È constatazione prescientifica che i parlanti di una lingua la usano in maniera diversa a seconda
della loro collocazione geografica, sociale, età.. ecc.
L’insieme di tutte queste differenziazioni costituisci il campo della variazione. La variazione è la
proprietà di un’entità di assumere forme diverse, di presentare sotto manifestazioni differenti. La
variazione sociolinguistica costituisce uno dei soggetti di studio più importanti della
sociolinguistica.
4.2 variabili sociolinguistiche
Una delle nozioni cardine della variazione sociolinguistica è quella di variabile sociolinguistica,
con cui si indica la possibilità di dire una cosa in modi differenti, ciascuno di questi modi è
chiamato variante.
In italiano un esempio può essere costituito dalla variabile (maglia). (SPEGAZIONE PAG 116)
Una delle varianti di queste variabili è sempre la variante standard.
La provenienza geografica dei parlanti è un fattore extralinguistico che entra spesso in
correlazione con varianti di variabili. Nella situazione italiana sono molto e variabili
sociolinguistiche che variano in base alla provenienza geografica del parlante, come nel caso di
(bella) (SPIEGAZIONE PAG 117).
Ciascuna di queste varianti può poi correlare con tratti extralinguistici di carattere sociale, come la
stratificazione sociale, l’eta e il livello di istruzione, oppure con tratti extralinguistici di carattere
situazionale, come il grado di formalità o informalità.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
In diverse comunità linguistiche molte variabili sono sensibili sia alla variazione sociale che a
quella situazionale. Data una certa variabile, le varianti diffuse negli usi bassi occorrono in
situazioni più informali, mentre le varianti diffuse negli usi alti in quelle più formali.
Variabili come queste prestano una distribuzione delle varianti chiamata distribuzione di
prestigio, o variabili laboviane.
I lavori di Labov negli anni sessanta/settanta utilizzano diagrammi che rappresentano strutture
sociolinguistiche che spiegano il comportamento dei parlanti.
La struttura sociolinguistica (a PAG 118) rappresenta il comportamento della variabile
sociolinguistica (th) in posizione iniziale o finale di
parola nell’inglese di New York. La variabile ha
come variante standard θ e come varianti sub-
standard t e tθ. Il diagramma rappresenta la
distribuzione delle varianti sub-standard. Sull’asse
delle ordinate troviamo le percentuali di occorrenza
mentre sulle asse delle ascisse riporta i contesti
situazionali.
Le percentuali di occorrenza delle varianti
substandard decrescono progressivamente
salendo nella scala sociale, e procedendo dal
contesto situazionale meno sorvegliato (a) a quello
più sorvegliato (d).
Una variabile come (th) che è suscettibile sia alla
variazione sociale sia alla variazione situazionale
viene chiamata marker, contrassegno
Esistono anche variabili con un comportamento
parzialmente differente. Sempre nell’inglese di New York, la variabile (r) in posizione postvocalica,
preconsonantica o finale di parola presenta la variante standard ɹ, mentre la variante substandard
è l’annullamento della pronuncia.
In questo caso le produzioni linguistiche di fasce sociali diverse tendono a convergere nei contesti
meno controllati, mentre nei contesti più controllati la lower middle class presta maggiore
attenzione alla pronuncia dando luogo cosi al fenomeno di ipercorrezione.
Il diagramma a pagina 120 si riferisce al comportamento della variabile sociolinguistica (ɑː)
nell’inglese di Norwich in father, path, cart. La variante standard è ɑː mentre le varianti
substandard sono æ e a:
Il diagramma rappresenta le varianti substandard. Qui le percentuali di realizzazione delle varianti
substandard sono suscettibili alla variazione sociale ma non variano il contesto situazionale.
Quando una variabile è suscettibile alla variazione sociale ma non a quella situazionale si
definisce indicatore.
Il diagramma a pagina 121 invece si riferisce al comportamento della variabile (æʃ) nel persiano di
Theran,
La variante standard è appunto æʃ mentre quella substandard è eʃ. Qui le percentuali di
realizzazione della variante substandard sono suscettibili al contesto situazionale, ma non a quello
sociale.
Una struttura sociolinguistica suscettibile alla variazione situazionale ma non a quella sociale
viene definita stereotipo.
4.2.1 variabili e livelli di analisi.
Una variabile sociolinguistica può essere anche definita come un punto del sistema linguistico
che ammette realizzazioni dovere equivalenti.
Due principi definitori della nozione di variabile sociolinguistica sono: equivalenza semantica e il
principio dell’identità di struttura.
I due principi esprimono le caratteristiche che devono possedere le varianti di una stessa
variabile, per definirle tali. Il primo principio afferma che l’uso alternativo delle varianti di una
variabile non deve causare cambiamento di significato, mentre il secondo principio afferma he
non vi devono essere cambiamenti nella struttura.
Questi due principi appaiono strettamente correlati ai fatti di variazione fonologica. Consideriamo
la pronuncia del suffisso inglese -ing, in cui la variante standard è ɪŋ mentre la variante
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
substandard è ɪn, essendo allofoni dello stesso fonema, queste realizzazione rispettano entrami i
principi di equivalenza semantica e identità di struttura, in quanto né il significato né la struttura
cambiano.
A livello morfologico, il trattamento di fenomeni di variazione in termini di variabili sociolinguistiche
non tradisce i due principi. La stessa variabile fonologica dell’inglese (-ing) potrebbe essere intesa
come variabile morfologica: la variabile ing avente come variante standard ɪŋ e come variante
substandard l’allofono ɪn.
L’estensione del concetto ad altri livelli di analisi comporta invece una parziale riconsiderazione
dei due principi. A livello sintattico costrutti diversi possono essere considerati varianti di una
stessa variabile nei contesti in cui questi siano equivalenti sul piano del significato contestuale e
pragmatico, e benché non identici sul piano strutturale svolgano la stessa funzione
grammaticale. Un esempio può essere dato dall’insieme delle costruzioni alternative diverse dea
frase relativa, per l’italiano poniamo il caso della relativizzazione di un oggetto indiretto, la
variabile comprende almeno queste varianti:
- con pronome relativo flesso e accordo di genere e numero (la ragazza alla quale ho spedito la
lettera)
- Con pronome relativo non flesso (la ragazza (a) cui ho spedito la lettera)
- Con che generic polivalente e pronome critico accordato (la ragazza che le ho spedito la
lettera)
- Con il solo che (la ragazza che ho spedito la lettera)
Le diverse varianti si dispongono in un ordine che si allontana sempre di più dalla variante
standard.
La nozione di variabile sociolinguistica è anche estendibile al lessico, alla variazione
onomasiologica, ovvero all’uso di nomi differenti per designare la stessa cosa. Un esempio in
italiano può essere la parola ‘’ragazzo’’, che si dice ‘’figliolo’’ in toscana, ‘’guaglione in campania,
Caruso o picciotto in Sicilia.
Questa variazione si può notare anche nell’inglese britannico e quello americano come nei casi di
lift/elevator, biscuits/cookies, flat/apartment.
4.2.2 proprietà delle varianti sub standard
Prestigio coperto: a varianti sub standard viene attribuito prestigio coperto da alcuni gruppi
sociali della stessa comunità.
Nell’indagine condotta a Norwich, la stessa in cui si studiava anche la variabile (a:), Trudgill
mostrava come le varianti substandard di alcune variabili godessero di prestigio coperto presso
gli uomini della comunità. Se a un campione di essi venivano fatte ascoltare due pronunce diverse
di una serie di parole, del tipo new: nju: standard e nu: substandard e si chiedeva di dire quale
variante fosse più simile alla propria , la metà diceva di usare la variate substandard, benché nelle
loro produzioni linguistiche effettive fosse la variante standard ad essere più frequente. Gli uomini
di quella comunità erano portati a sovrastimare il carattere substandard delle proprie produzioni.
4.4. scale di implicazione
Il modello delle scale di implicazione ha per obiettivo l’identificazione e l’analisi di relazioni di
implicazione nell’uso di variabili linguistiche nella realizzazioni delle varianti di quella variabile.
Nella sua concezione originaria, il modello delle scale di implicazione si propone come un vero e
proprio modello di descrizione e analisi della variazione intralinguistica alternativo a quello
laboviano fondato su regole variabili.
Per Decamp e Bickerton una scala di implicazione non rappresenta solo uno strumento di
descrizione di rapporti tra variabili e tra varianti, ma un modello della competenza linguistica.
(esempio di scala di implicazione pag 132)
4.5 modelli di variazione
Il concetto di variabile sociolinguistica poggia su una concezione di variazione come proprietà dei
punti del sistema linguistico di essere realizzati con forme superficiali differenti, correlate a
significati sociali diversi
Nel modello laboviano:
- la variazione opera in superficie
- Il parlante nativo ha competenza di una sola grammatica
- La grammatica dell’individuo è isomorfa alla comunità linguistica
- I membri di una stessa comunità linguistica condividono uno stesso insieme di regole
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
- Le regole sono realizzate variabilmente
- I giudizi di grammaticali dei parlanti non riflettono differenze strutturali.
Secondo l’approccio generativista la variazione è data dalla scelta fra regole diverse.
La ricerca linguistica generativa si muove nel quadro di quello che viene definito da Chomsky nel
1995 programma minimalista, in cui si mira a ridurre al minimo indispensabile l’apparato teorico
necessario per spiegare le frasi, non ci sono più ‘’regole’’, ma un numero ridotto di principi e
alcuni parametri.
Un parametro, in linguistica generativa, è un punto della grammatica universale che può assumere
due valori. Come esempio possiamo fornire quello del soggetto nullo che prevede i valori di
‘’soggette obbligatoriamente espresso’’ come nel caso dell’inglese o ‘’soggetto facoltativo’’ come
nel caso dello spagnolo e dell’italiano.
Il parametro del soggetto nullo distingue varietà alte dell’inglese (in cui il soggetto viene espresso)
e varietà basse, quindi un parlante nativo inglese ha due grammatiche distinte dal valore fissato
del parametro del soggetto nullo.
Un ulteriore esempio di parametro che possiamo fornire è quello dell’accordo di there, in cui
there are è la varietà standard e there is la varietà substandard. Henry nel 2005 osserva un
campione di parlanti nativi e argomenta come ciascuno di essi possegga varie grammatiche
differenziate in base ai contesti situazionali e alle caratteristiche individuali. Una prima grammatica
fissa il valore del parametro su (accordo) solo con forme contratte e quindi è in correlazioni con
contesti in formali, in quanto in inglese le forme contratte sono marche di informalità.
La seconda solo con forme verbali del passato (there was three book) e l’ultima con ‘’ a lot of’’
correlati in contesti informali in quanto a lot of è una variante informale di many.
4.6 mutamento e variazione
Mutamento e variazioni non sono due sinonimi poiché con variazione si indica la proprietà delle
lingue di presentarsi in forme diverse, mentre con mutamente si intende il cambiamento effettivo
di una lingua. Inoltre variazione è un fatto sincronico, mentre il mutamento è un fatto diacronico.
Le. Lingue sono in costante movimento ma ci accorgiamo dei cambiamenti quando sono attuati
completamente. Il cambiamento linguistico avviene in diverse fasi, la prima comprende
l’introduzione di una nuova forma all’interno della produzione linguistica di un parlante, la fase che
la segue consiste nell’accettazione e diffusione di questa nuova forma nel comportamento
linguistico del parlante, la terza fase è costituita dalla diffusione e estensione di questa nuova
forma ad altri parlanti e l’ultima fase consiste nell’adozione generalizzata di questa nuova forma
nella norma condivisa. I fenomeni di mutamento consistono in una sostituzione di una variante
con un’altra variante.
I processi di mutamento sono indagabili o osservando il male sviluppo temporale o osservando le
differenze generazionali. Un esempio del secondo tipo è l’indagine di Labov nell’isola di Martha’s
Vineyard. ( spiegazione p140)
Nell’impostazione laboviana è tradizionale la distinzione tra mutamenti dal basso, ovvero i
mutamenti che hanno origine tipicamente nei gradini bassi della scala sociale e nel parlato
spontaneo non accurato, e, mutamenti dall’altro, originari dei ceti alti e che non avvengono nel
parlato spontaneo non accurato.
Può rappresentare un caso di mutamento dal basso la sostituzione di una variante ‘’costosa’’ con
una variante substandard più ‘’naturale, un esempio di mutamento dall’alto invece può essere la
diffusione della variante di prestigio della variabile (r) nell’inglese di new york.
Figura pag 141-142: nelle prime fasi la frequenza d’uso di una variante conosce un aumento
graduale, inizia a crescere rapidamente nel momento in cui raggiunge una sorta di massa critica e
decelera leggermente nelle ultime fasi.
4.7 dimensioni di variazione
Esistono diversi tipi di dimensioni di variazioni:
- variazione diatopica: la lingua varia in base alla collocazione geografica dei parlanti
- Variazione diastratica: la lingua varia in base alla collocazione sociale dei parlanti
- Diafasica: la lingua varia attraverso le situazioni comunicative. Si hanno due sottodimensioni
della variazione diafasica: la variazione di registro e la variazione di sottocodice
Queste tre sono variazioni sincroniche teorizzate da Coseriu negli anni sessanta, negli anni 80
Mioni ha proposto un quarto tipo di variazione sincronica:
La variazione diamesica: la lingua varia in base al canale fisico di comunicazione, fonico oo
grafico, dando luogo all’opposizione scritto-parlato.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Inoltre a lingua varia anche nel tempo: variazione diacronica.
(esempi pag 144)
Le dimensioni di variazione sono in rapporto tra loro secondo due diversi piani, in primo luogo sul
piano della logica: secondo questa visione la variazione primaria è la diatonia, in quanto qualsiasi
messaggio linguistico si colloca in termini di provenienza geografica, poi vi è la diastratia: dato un
insieme di tratti linguistici marcati in diatonia alcuni di questi sono propri dei ceti alti e altri dei ceti
bassi. Infine vi è la dimensione diafasica che opera all’interno delle altre due.
Su un secondo piano il prevalere di una dimensione sull’altra è connesso alla fenomenologia
empirica della variazione e in particolare alla quantità di fanone di variazione attribuibili a una
dimensione e non all’altra.
4.7.1 diafasia e diamesia
Si è detto che è possibile riconoscere due sottidimensioni della variazione diafasica: la variazione
di sottocodice e di registro. Possiamo fare riferimento alle categorie di campo, modo e tenore.
Al campo è connessa una sottodimensione della variazione diafasica, la variazione di sottocodice.
Con variazione di sottocodice si intende il variare della lingua in dipendenza dalla natura
dell’attività svolta nella situazione, dall’insieme delle esperienze e azioni che questa implica . I
sottocodici (detti anche linguaggi settoriali) sono caratterizzati da un lessico speciale, connesso a
particolari settori di attività (la medicina, l’informatica, la chimica) e relative sfere di significato.
Al tenore è connessa la variazione di registro. La variazione di registro è determinata dai ruoli
sociali e comunicativi assunti dai partecipanti a un’interazione verbale, e si manifesta
principalmente nel grado di distanza sociale e comunicativa fra questi, da rapporti di ruolo e
distanza reciproca fra gli interlocutori dipende il livello di formalità/informalità.
I registri si collocano dunque su una scala che va dal massimamente formale al massimamente
informale.
I sottocodici sono caratterizzati sul piano del lessico, i registri invece sono caratterizzati a tutti i
livelli di analisi: un registro informale avrà una pronuncia più veloce e meno accurata, una sintassi
meno elaborata e poco pianificata, un lessico più generico, comune ed espressivo rispetto ad un
registro formale
(esempio p 147-148)
Capitolo 5- sociolinguistica dell’interazione verbale
5.1 analisi della conversazione
Il luogo in cui si manifesta quotidianamente l’uso della lingua è l’interazione verbale.
Con interazione verbale si indica qualunque tipo e occasione attualizzata di contatto comunicativo
attraverso il linguaggio verbale umano fra due interlocutori.
Interazione implica la presenza di partecipanti che mettono in opera in determinate situazioni le
loro risorse e competenze linguistiche.
Le diverse scelte sono rese possibili dall’azione combinata della competenza linguistica, la
conoscenza che ciascuno di noi ha della lingua o delle lingue che parla e della competenza
comunicativa. Con questo termine ci si riferisce alla capacità di mettere in pratica lo strumento
linguistico sapendo quando e come usare la lingua. Essa comprende da un lato la capacità di
produrre enunciati dotati di significato e grammaticalmente corretti in base alla grammatica, e
dall’altro la capacità di usare tali enunciati in maniera appropriata alla situazione.
La forma tipica dell’interazione verbale è la conversazione, termine che indica l’attività ordinaria
di messa in opera dei mezzi linguistici dei parlanti nelle varia circostanze comuni della vita
quotidiana in ui ci si trova a interagire con altre persone.
Usato come sinonimo di conversazione è il termine dialogo, con il quale però viene messo in
evidenza lo scambio comunicativo di due o più interlocutori incentrato sulla concatenazione
alterna di battute, domane e risposte e anche giudizi e commenti.
(ESEMPIO DI CONVERSAZIONE PAG 169-170)
L’analisi strutturale della conversazione si è sviluppata negli anni 70 a partire da ricerche effettuate
secondo la prospettiva dell’etnometodologia, una corrente delle scienze sociali cosi definita
perché si proponeva i studiare i metodi con i quali i membri di una comunità sociale cercano di
dare ordine, comprensibilità, normalità al mondo in cui vivono.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
In questa prospettiva la conversazione risulta un’attività socialmente organizzata che mostra una
struttura sequenziale, ovvero, costituita da segmenti che si susseguono seguendo delle regole
di concatenazione.
I segmenti di riferimento base coincidono con i contributi al discorso via via forniti dai singoli
parlanti diversi, detti turni (o mosse).
Un primo meccanismo fondamentale della conversazione è l’allocazione di turni, cioè il modo in
cui avviene l’alternanza dei turni. A organizzare i diversi interventi dei parlanti vi è una regola di
base che afferma che di base di prevede che ci sia almeno un interlocutore a parlare in un
determinato momento, il silenzio e la sovrapposizione di turni nonostante si possono incontrare
spesso non sono favoriti.
Da questa regola derivano due principi: uno relativo alle tecniche per evitare il silenzio e l’altro
relativo alle tecniche per evitare la sovrapposizione di turni.
Per quanto riguarda l’evitare il silenzio, il partecipante che sta parlando può esercitare tre tipi di
controllo:
- può scegliere il parlante che interverrà, nominandolo direttamente o alludendovi.
Creando cosi una coppia adiacente o sequenze complementari, termine con cui si indicano due
turni in stretta relazione tra di loro, come nel caso di domanda/risposta o saluto/saluto, in cui il
secondo intervento è obbligatoriamente richiesto dall’esecuzione del primo.
-chi sta parlando può scegliere il tipo successivo di intervento, ma non il parlante. Può effettuare
nessuna scelta, lasciando che gli altri interlocutori si autoselezionino. Come nel caso di ‘’adesso
ascoltiamo l’opinione di qualcun’altro’’.
- il partecipante che interviene successivamente capisce quando è il momento di intervenire sulla
base di un punto possibile di completamento. Il nuovo parlante può prendere la parola ogni
volta che il partecipante che sta parlando termina un enunciato o compie una pausa.
La competenza comunicativa dei parlanti rende in genere percepibili in anticipo i punti di possibile
transizione.
Ogni punto di transizione di turno teoricamente possibile viene dal parlante reso effettivo
mediante segnali di terminazione prosodici. Il parlante che prende la parola segnala a sua volta
l’avvio del suo intervento con comportamenti della stessa natura come inizio di gesticolazione,
attacco intonativo. Tipici segnali di apertura sono: allora, dunque, ecco.
Il silenzio alla fine di un turno ha anch’esso un valore comunicativo in quanto non significa
assenza di interazione ma viene generalmente interpretato come momento costitutivo di un
intervento e viene quindi attribuito, o come l’inizio del parlante successivo o come una pausa fra
le continuazioni dello stesso parlante. Un turno può anche consistere nel solo silenzio.
Per quel che riguarda l’argomento e l’andamento tematico della conversazione, secondo l’analisi
conversazione inizialmente elaborata dagli etnometodologi vige la regola generale che sia
conveniente e normale non dire agli altri ciò che si sa oppure suppone che sappiano già.
Blocchi compatti e omogenei di argomenti costituiti dal racconto di un evento da parte di un
parlante rappresentano quelle che vengono chiamate storie, una storia comporta una
sospensione del normale meccanismo di allocazione dei turni e garantisce al partecipante che
l’inizia un pezzo anche lungo di discorso ininterrotto.
Un altro fenomeno importante in chiave etnometodologica nella conversazione è la riparazione. Si
hanno meccanismi di riparazione ogni volta che avvengono disturbi e problemi che turbano o
ostacolano il flusso dell’interazione.
Casi significativi e frequenti oggetto di riparazione sono i fraintendimenti. (esempio p 175)
La nozione di contesto ha un ruolo centrale nell’analisi dell’interazione verbale. Occorre
distinguere il contesto generale, che concerne l’intorno sociale e culturale in cui si inserisce la
data interazione e un contesto locale corrispondente alla cornice definita da ogni singolo evento
comunicativo, che, ritaglia e crea un contesto particolare in quell’occasione. Il contesto locale
costituisce una realtà interattiva gestita dai parlanti stessi, nella quale ogni singolo enunciato che
viene prodotto nei diversi turni può modificare i caratteri del contesto stesso.
Le conversazioni interetniche e interculturali, fra partecipanti di diversa cultura e lingua materna,
sono perennemente esposte a problemi, specialmente quando le competenze dell’esolingua (la
lingua non materna che il parlante utilizza) sono ridotte.
Negoziazione è un concetto molto importante per l’analisi del comportamento conversazione dei
parlanti: con esso si indica genericamente l’attività che coinvolge due o più individui o gruppi che
comunicano interattivamente gli uni con gli altri allo scopo di raggiungere un accordo in merito a
qualcosa che non si può dare per scontato.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Un ruolo importante nella negoziazione è svolto dalla metacomunicazione, termine con cui si
indica la comunicazione che ha per oggetto la comunicazione stessa. La metacomunicazione può
essere attuata per esempio attraverso le cosiddette pratiche di glossa, che consistono in
formulazione dei parlanti relative a determinanti aspetti della relazione comunicativa fra i
partecipanti e dei loro ruoli o all’articolazione della conversazione in parti costitutive.
I meccanismi di riparazione hanno a che fare con un altro concetto importante quello di lavoro di
faccia. Con faccia si intende l’immagine pubblica, costituita un insieme di attributi socialmente
approvati, che un partecipante intende presentare di se nell’interazione.
Entrano qui in gioco gli aspetti della cortesia. Per manifestazioni della cortesia verbale si
intendono tutti i dispositivi, strategie e routines che vengono impiegate per rispettare la faccia dei
parlanti ed evitare conflitti internazionali. In molte lingue tali dispositivi sono codificati nel sistema
linguistico e nel lessico: in molte lingue occidentali, l’espressione di cortesia è rappresentata
attraverso distinzione di allocutore (lei, voi, noi), attraverso i saluti e i titoli onorifici. Nelle lingue
orientali, invece, come il giapponese e il coreano l’espressione di cortesia diventa una vera e
propria categoria grammaticale.
Ma anche nel caso in cui la cortesia non sia codificata lessicalmente o morfologicamente in
maniera esplicita esistono molti mezzi e diverse modalità per manifestarla verbalmente.
In italiano la cortesia può essere espressa tramite gli allocativi, il condizionale e anche tramite
diminutivi.
Un insieme importante di dispositivi e forme destinati a manifestare la cortesia va sotto la
categoria di mitigazione, termine con il quale si intende l’azione del parlante, volta a minimizzare i
rischi che possono derivare alla alla ‘faccia’, attenuanti la portata delle proprie affermazioni e
diminuendo o allontanando la possibilità di conseguenze sgradite.
L’approccio di Grice del 1975 alle regole logiche di inferenza faceva derivare da un preliminare
principio di cooperazione, 4 massime:
-quantità: il parlante deve dare un contributo tanto quanto richiesto, ne più ne meno
-qualità: il parlante deve affermare solo ciò che sa e non il falso o quello di cui non si ha prova
-relazione: chi parla deve farlo in modo pertinente, rilevante a quel punto della conversazione
-modo: afferma che chi parla deve essere chiaro e ordinato nell’esposizione ed evitare ambiguità.
Il fatto che spesso e volentieri le massime non vengano rispettate non significa che non esistano,
ma al contrario ne conferma l’esistenza, come possiamo notare nell’esempio a pag 179-180.
A questa logica della conversazione Lakoff nel 1978 ha associato una logica della cortesia
costituita da regole di competenza pragmatica che intervengono negli scambi comunicativi e che
obbediscono a criteri di convenienza sociale, a norme di conduzione senza conflitti della relazione
interpersonale a ragioni di carattere etico o estetico.
I principi elaborati da Grice e Lakoff sono poi stati sviluppati e modificati in vario modo. Sperber/
Wilsono nel 1986 hanno approfondito in direzione cognitiva l’approccio di Grice incentrandolo sul
concetto di ‘’rilevanza’’ o ‘’pertinenza’’ (la pertinenza di un fenomeno data una cetra costellazioni
di fatti). Leech, invece, nel 1983 ha ripreso la prospettiva di Lakoff elaborando un principio della
cortesia costituito da sei massime, una di queste la massima della modestia.
Brown/Levinson (1987) hanno sviluppato una teoria e tassonomia della cortesia e delle strategie
con le quali essa si manifesta organizzata attorno alla distinzione basilare tra cortesia positiva e
cortesia negativa.
Un tipico caso di cortesia positiva sono i complimenti, un tipo di scambio verbale presente in
molte culture consistente in un atto linguistico con cui il parlante esprime un apprezzamento o
una valutazione positiva vero un comportamento, un’azione o un carattere esibito
dell’interlocutore.
(esempio e spiegazione p 181)
5.2 tipi di interazione verbale
La normale conversazione è un’interazione simmetrica, a cui i partecipanti contribuiscono con lo
stesso ruolo, sullo stesso piano, mauna parte consistente delle tipiche interazioni verbali è
costituita da interazioni asimmetriche. Le interazioni asimmetriche presentano l’importante
proprietà che i partecipanti hanno diseguale potere sociale e internazionale, in quanto uno dei
parlanti ha assegnata la regia delle operazioni conversazionali, controllando l’andamento dello
scambio comunicativo, come nel caso dell’interazione medico-paziente.
Tale asimmetria è anche definita dominanza ce può essere quantitativa (in termini di quantità di
spazio internazionale), internazionale (in termini del controllo dell’organizzazione delle sequenze),
semantica ( il controllo degli argomenti) e strategica ( controllo della realizzazione delle mosse)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
In sociolinguistica le interazioni asimmetriche più studiate sono quelle professore-allievo e
medico-paziente.
Fra le interazioni asimmetrie vi sono quelle che si possono chiamare ‘’istituzionali’’ in quanto uno
dei parlanti non viene considerato un comune cittadino di una comunità, ma ha un ruolo ben
preciso. Queste interazioni istituzionali sono caratterizzate dalla dominanza in tutti i suoi aspetti di
un partecipante sugli altri. (esempio e spiegazione p 183-184).
Un altro tratto molto importante dal punto di vista internazionale è dato dalla compresenza
spaziale faccia a faccia. Il modello prototipico di conversazione è proprio questo, in cui i
partecipanti possono vedersi a distanza ridotta, possono toccarsi e hanno reazioni immediate, ma
col tempo sono diventate molto comuni interazioni non faccia a faccia.
Nel caso della conversazione telefonica è molto importante la fase di apertura della
conversazione in quanto con essa viene stabilito il canale di comunicazione e vi è il
riconoscimento degli interlocutori. (esempio e spiegazione p 185-186).
Le conversazioni telematiche presentano una struttura simile alla conversazione faccia a faccia
ma con proprietà tipiche dovute alla particolarità del mezzo o canale di comunicazione. Si tratta di
interazioni che hanno molte caratteristiche degli scambi orale ma che vengono attuate tramite un
codice grafico, dando luogo ad un particolare tipo di rapporto tra scritto e parlato che si definisce
discorso elettronico o parlato digitato. (esempio e spiegazione p 186).
5.3 iterazioni multilingue
Sul libro
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: beatricefischione (beafischione@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Manuale Di SociolinguisticaDocumento36 pagineManuale Di SociolinguisticaGiovanni PollastroNessuna valutazione finora
- 1.manuale Di Sociolinguistica BerrutocerrutiDocumento29 pagine1.manuale Di Sociolinguistica BerrutocerrutiMatteoNessuna valutazione finora
- Berr1 PDFDocumento19 pagineBerr1 PDFdolc3neraNessuna valutazione finora
- Manuele Di Sociolinguistica, Berruto CerrutiDocumento28 pagineManuele Di Sociolinguistica, Berruto CerrutiElvira PaganoNessuna valutazione finora
- Prima Lezione Di SociolinguisticaDocumento20 paginePrima Lezione Di SociolinguisticaAntonina RagusaNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di Sociolinguistica BerrutoDocumento51 pagineFondamenti Di Sociolinguistica BerrutoClau DecaNessuna valutazione finora
- Corso SociolinguisticaDocumento178 pagineCorso SociolinguisticaMary BiondiNessuna valutazione finora
- FEDERICA LAURO - Esercitazione Propedeutica All - Esame OraleDocumento2 pagineFEDERICA LAURO - Esercitazione Propedeutica All - Esame OraleFederica LauroNessuna valutazione finora
- Manuale Di SociolinguisticaDocumento17 pagineManuale Di SociolinguisticaAnonymous py5rvAzwYNessuna valutazione finora
- Linguaggio Discorso Potere 16.09.2008Documento15 pagineLinguaggio Discorso Potere 16.09.2008henripauloriqueNessuna valutazione finora
- CONTATTODocumento23 pagineCONTATTOangela.peccioliNessuna valutazione finora
- Linguistica Applicata - DefinizioniDocumento12 pagineLinguistica Applicata - Definizionianon_889082631Nessuna valutazione finora
- Sintesi SociolinguisticaDocumento46 pagineSintesi SociolinguisticaGiulio Chinaski LevoratoNessuna valutazione finora
- Pallotti L2semiotica SocialeDocumento11 paginePallotti L2semiotica SocialelindaNessuna valutazione finora
- Appunti Sociolinguistica Dell'italianoDocumento33 pagineAppunti Sociolinguistica Dell'italianoalessiochisari918Nessuna valutazione finora
- Sociolinguistica TestoDocumento20 pagineSociolinguistica TestoFrancesca LaboniaNessuna valutazione finora
- Riassunto Fondamenti Di SociolinguisticaDocumento9 pagineRiassunto Fondamenti Di Sociolinguisticaalessiochisari918Nessuna valutazione finora
- Il Binomio Lingua CulturaDocumento10 pagineIl Binomio Lingua CulturaAnonymous j2fVR6Nessuna valutazione finora
- La lingua Italiana: breve storia e approcci glottodidattici come L2Da EverandLa lingua Italiana: breve storia e approcci glottodidattici come L2Nessuna valutazione finora
- Slide Sociolinguistica 2Documento5 pagineSlide Sociolinguistica 2Giada SollaiNessuna valutazione finora
- Linguistica GeneraleDocumento39 pagineLinguistica GeneraleMariarosaria VitielloNessuna valutazione finora
- Geografia Delle Lingue e Pianificazione LinguisticaDocumento47 pagineGeografia Delle Lingue e Pianificazione LinguisticaAlessia MonacoNessuna valutazione finora
- SLDocumento5 pagineSLPaolo VagliecoNessuna valutazione finora
- Approccio Comunicativo 1 Ascolto ParlatoDocumento22 pagineApproccio Comunicativo 1 Ascolto ParlatoCeleste TesseNessuna valutazione finora
- Ling EducativaDocumento134 pagineLing EducativaSabrina CapotortoraNessuna valutazione finora
- Bathia - Analysing GenreDocumento7 pagineBathia - Analysing GenreGérard OrigliassoNessuna valutazione finora
- Domande Sociolinguistica GPTDocumento6 pagineDomande Sociolinguistica GPTalex25Nessuna valutazione finora
- Linguaggio e IdentitàDocumento7 pagineLinguaggio e IdentitàlulinjaNessuna valutazione finora
- I Codici Di Basil BernsteinDocumento8 pagineI Codici Di Basil BernsteinMaria Elena BarberaNessuna valutazione finora
- Il Concetto Di Kokugo - Una Proposta Di Analisi DiacronicaDocumento54 pagineIl Concetto Di Kokugo - Una Proposta Di Analisi DiacronicaMichele AlessandriniNessuna valutazione finora
- La Comunità LinguisticaDocumento11 pagineLa Comunità LinguisticaanopticonNessuna valutazione finora
- Benucci - Aspetti Interculturali e Interlinguistici Della Comunicazione in AmbitoDocumento9 pagineBenucci - Aspetti Interculturali e Interlinguistici Della Comunicazione in AmbitoDiana RestrepoNessuna valutazione finora
- Dispensa Fondamenti Di Linguistica GeneraleDocumento78 pagineDispensa Fondamenti Di Linguistica GeneralewcottmaneNessuna valutazione finora
- 336-Article Text-651-1-10-20160630Documento15 pagine336-Article Text-651-1-10-20160630tulio silvaNessuna valutazione finora
- Socio Linguistic ADocumento11 pagineSocio Linguistic AanopticonNessuna valutazione finora
- Terzo settore e comunità: Intrecci culturali e reti di relazioniDa EverandTerzo settore e comunità: Intrecci culturali e reti di relazioniNessuna valutazione finora
- La Linguistica GeneraleDocumento19 pagineLa Linguistica GeneraleNew LifeNessuna valutazione finora
- La transmedialità dell'autocomunicazione della cultura: articolo-saggio di semioticaDa EverandLa transmedialità dell'autocomunicazione della cultura: articolo-saggio di semioticaNessuna valutazione finora
- LinguisticaDocumento27 pagineLinguisticanoemuccia.ngNessuna valutazione finora
- Appunti Geografia IDocumento65 pagineAppunti Geografia IAlessia MonacoNessuna valutazione finora
- Linguistica Di Contatto - OdtDocumento26 pagineLinguistica Di Contatto - OdtSylviaAubergineManzioneNessuna valutazione finora
- Professione sociologo clinico: La passione spinge all'azioneDa EverandProfessione sociologo clinico: La passione spinge all'azioneNessuna valutazione finora
- Teorie Del Linguaggio PDFDocumento3 pagineTeorie Del Linguaggio PDFOrnella CurròNessuna valutazione finora
- PROPRIETà DEL LINGUAGGIODocumento16 paginePROPRIETà DEL LINGUAGGIOCarmen GurradoNessuna valutazione finora
- Italiano Come l2 - M.C.LuiseDocumento25 pagineItaliano Come l2 - M.C.LuiseElena Dalla NoraNessuna valutazione finora
- BOURENANE - LING7 - Pragmalinguistica - IntroduzioneDocumento4 pagineBOURENANE - LING7 - Pragmalinguistica - IntroduzioneZahia MazizNessuna valutazione finora
- Che cos'è la sociologia applicata: una breve introduzioneDa EverandChe cos'è la sociologia applicata: una breve introduzioneNessuna valutazione finora
- Linguistica Italiana 2, Università Degli Studi Di TriesteDocumento38 pagineLinguistica Italiana 2, Università Degli Studi Di TriesteEmilio PolitoNessuna valutazione finora
- Italiano LS in Prospettiva Interculturale REVISIONE BLANDINODocumento51 pagineItaliano LS in Prospettiva Interculturale REVISIONE BLANDINOGiulio Chinaski LevoratoNessuna valutazione finora
- Capitolo 2 - BalboniDocumento3 pagineCapitolo 2 - BalboniEshaNessuna valutazione finora
- Dieci tesi per l’educazione linguistica democraticaDa EverandDieci tesi per l’educazione linguistica democraticaNessuna valutazione finora
- La LIS come "strumento": Introduzione per un trattamento non verbale per i soggetti comunicopaticiDa EverandLa LIS come "strumento": Introduzione per un trattamento non verbale per i soggetti comunicopaticiValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Traduzione della cultura: Problemi traduttivi in relazione alle differenze culturaliDa EverandTraduzione della cultura: Problemi traduttivi in relazione alle differenze culturaliNessuna valutazione finora
- Linguistica, Lingua e TraduzioneDocumento77 pagineLinguistica, Lingua e TraduzioneAnna Di SalvioNessuna valutazione finora
- La memoria della cultura: traduzione e tradizione in LotmanDa EverandLa memoria della cultura: traduzione e tradizione in LotmanNessuna valutazione finora
- Istruzioni Lavastoviglie Bosch SMV25AX01EDocumento46 pagineIstruzioni Lavastoviglie Bosch SMV25AX01Esuper novaNessuna valutazione finora
- Air-Cooled-Condensers I Un50 01Documento12 pagineAir-Cooled-Condensers I Un50 01gustavsilverNessuna valutazione finora
- Strugackij Lo Scarabeo Nel Formicaio c4db44 88226Documento115 pagineStrugackij Lo Scarabeo Nel Formicaio c4db44 88226Igor GorNessuna valutazione finora
- CAPITOLO 6 Il Procedimento AmministrativoDocumento11 pagineCAPITOLO 6 Il Procedimento AmministrativoangeloNessuna valutazione finora
- Imparare PHP Da ZeroDocumento45 pagineImparare PHP Da ZeroBruno LuccisanoNessuna valutazione finora