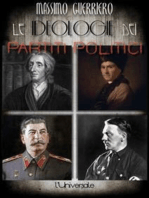Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunti Libro Partito e Democrazia Di Piero Ignazi
Caricato da
Mary BiondiTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunti Libro Partito e Democrazia Di Piero Ignazi
Caricato da
Mary BiondiCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|3193521
Riassunti libro "Partito e democrazia" di Piero Ignazi
Partiti e democrazia (Università di Bologna)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
PARTITO E DEMOCRAZIA di Piero Ignazi
Note e sottolineature
Introduzione
Il partito oggi è una sorta di Leviatano con i piedi di argilla: molto potente grazie alle risorse che ottiene dallo Stato e
all’estensione di pratiche clientelari; molto debole in termini di stima e fiducia agli occhi dei cittadini.
La parola partito viene dal verbo latino partire, che significa «dividere», e dal sostantivo derivato pars, cioè
«parte». Quindi, «partito» contiene il codice genetico della parzialità e della divisione.
Il partito politico, da sempre visto in termini di fazione – il termine politico più detestato lungo tutta la storia, e ancora
oggi – era il nemico per eccellenza.
La critica punta anche, benché non esplicitamente, alla sua natura, più che alla sua funzione.
Il punto di partenza del livello intellettuale-ideologico va dalla metà del Settecento alle rivoluzioni americana
e francese. In quei frangenti si fece strada l’idea che una «parte» potesse proporsi come alternativa all’ordine
costituito, al sovrano e alla tradizione.
Il punto di partenza del livello effettuale della politica partitica sta nel parlamento britannico del XVII secolo.
Gli aspetti ideologici ed effettuali maturarono nei primi decenni del XX secolo, quando i partiti politici finirono per
essere accettati, tanto a livello intellettuale quanto a livello pratico.
In termini politici e istituzionali, la legittimazione finale (sebbene non piena) arrivò con il superamento della
terza soglia di Rokkan [1970]: il riconoscimento dei diritti politici e la partecipazione universale a elezioni
libere e uguali per tutti i partiti abbattendo posizioni privilegiate dei partiti espressione dei poteri costituiti.
Il partito politico, sub specie di partito di massa, entrò in scena in quella fase, e lì sarebbe rimasto a lungo.
Sostanzialmente, la rappresentanza era passata dall’individuale al collettivo. Il partito era lo strumento → e nei regimi
totalitari il partito era il centro del sistema «parte totale».
Primi esempi di partiti nel XVIII° secolo: i partiti parlamentari a Westminster, i club giacobini durante la rivoluzione
francese nel 1791-1794, il partito jacksoniano in America.
La loro legittimazione è sempre in gioco. È la recente invasione del partito nello stato che ha allontanato i partiti
politici dai cittadini.
In tal modo, i partiti sono diventati più forti in termini strutturali e finanziari, al costo di perdere la risorsa immateriale,
ed essenziale, della legittimità.
È difficile metterli «dalla parte degli angeli», ma il recupero della loro legittimità è del tutto necessario per contrastare
l’onda montante, plebiscitaria e populista.
Capitolo primo — Alla ricerca dei partiti politici
1. I partiti politici nell’antichità
Il caso ateniese
Siccome «stasis» è sempre associato a «guerra civile», esso starebbe a indicare una parte rivoluzionaria e
violenta. Stasis non si riferisce ad alcun gruppo precisamente definito bensì a un sentimento di disagio
generalizzato nella polis, provocato dalla mancanza di equità e giustizia → stasis racchiude l’idea di conflitto.
Nel contesto greco, il conflitto espresso da stasis è in rapporto al rovesciamento di regime. Con il tempo ha finito per
indicare piccole cricche segrete e cospirative con carattere antisistema.
L’unico caso in cui la parola «eteria» acquistò significato politico fu quando nel IV secolo Demostene accusò il suo
nemico Midia di essere appoggiato da una di esse. Si tratta di un passaggio importante perché offre la prova più
convincente dell’esistenza di gruppi politici attivi nella polis, e chiaramente riconoscibili.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Contrariamente alcuni autori sostengono che: «non esistevano partiti politici né gruppi di interesse organizzati» e
che «i rapporti fra oratori e generali non erano neppure lontanamente simili a un partito politico».
Gli aderenti alla eteria erano sufficientemente numerosi e organizzati da influire sulle decisioni dell'assemblea.
Bearzot sostiene, basandosi sulle Elleniche di Ossirinco, che tutti i termini – eteria, stasis e sinomosia – identificano
partiti politici. In particolare, eteria, con il suo riferimento al segreto e alla cospirazione, sembra il più idoneo
a rappresentare la «fazione», i «gruppi politici» e infine il «partito».
L’assemblea (ecclesia) composta da tutti i cittadini ebbe un ruolo chiave nella risoluzione di tutte le controversie
ateniese non era limitata all’assemblea: comprendeva il consiglio (boulé), che consisteva di 500 cittadini scelti
annualmente per sorteggio; centinaia di funzionari minori nominati per sorteggio; nove arconti, magistrati i cui compiti
erano essenzialmente religiosi e amministrativi, anch’essi eletti
per sorteggio; e i tribunali o giurie popolarI (dikasteria). Infine, un’attività politica più informale aveva comunque luogo
nelle piazze di Atene. Questo complesso sistema incarna quella che viene chiamata «democrazia ateniese».
Nell’antica Grecia il partito presentava un’anatomia «protozoica»; il significato loro attribuito all’epoca era
negativo, nell’antica Grecia.
Aristotele afferma infatti che l’introduzione della costituzione democratica fu resa possibile solo perché Clistene
superò il potere di veto delle eterie facendo appello direttamente al popolo.
Pearson sostiene che la natura individuale dell’attività politica ad Atene implica l’assenza di un’entità
collettiva simile al partito.
In conclusione, il punto è che la loro presenza è unanimemente considerata un pericolo → «un’altra polis nella polis»
→ olismo e monismo contro pluralismo.
Il caso romano
La presenza nel vocabolario latino di partes e factiones implica che, all’epoca, essi avessero un significato specifico.
La sollevazione dei plebs (popolo) contro gli optimates (patrizi) proiettò nell’arena politica due partes ben distinte,
separate da una frattura socioeconomica, e destinate a rimanere tali nel tempo. Ma l’identificazione (ipotetica) di
fazioni e partiti non è limitata a questi due raggruppamenti sociali concorrenti: esistevano molti altri piani di conflitto.
Scelte politiche e affiliazioni erano imprevedibili e mutevoli e assai rara la coerenza di comportamenti: a
livello generale, [vi era un] cambiamento continuo di coalizioni, di configurazioni e, a dirla tutta, di linee di confronto.
«Gruppi» politici e interi schemi di «formazione a gruppi» erano dunque interamente dipendenti da questioni e
dissensi politici, il cui denominatore comune era il fatto di essere altamente volatili ed effimeri.
In effetti, la competizione per ottenere posti al senato o magistrature, e la frattura socioeconomica fra patrizi e plebei,
misero a rischio la convivenza pacifica lungo tutta la storia di Roma. E Cicerone aggiungeva che «dal popolo vengono
soltanto disordine e confusione». «Fazione» – che deriva da facere, fare – indica una parte che agisce contro
l’altra.
Sallustio accusò «fazioni e parti» di aver provocato tutti i guai (omnia malorum) della repubblica.
L’argomentazione è chiara: il nemico, bollato come fazione, è tanto piccolo di numero quanto pericoloso per
il bene comune della società.
In senso politico partes è usato in tre contesti diversi: per distinguere, come il termine «fazione», fra optimates e
populus; per definire i due ranghi in un’assemblea durante le sessioni di voto, quando i senatori si separano
fisicamente (discessio) per evidenziare il loro voto (come nel caucus americano).
Due importanti studiosi della scuola tedesca – Matthias Gelzer e Friedrich Münzer – negarono entrambi, seppur con
sfumature diverse, l’esistenza di qualcosa come i partiti politici a Roma.
Vi è poi un altro aspetto che induce a ritenere che esistessero legami alquanto stretti e vincolanti tra le persone e
che si trasferissero anche in arene politiche: la relazione patrono-cliente che era profondamente radicata nella cultura
politica romana (a differenza dell’antica Grecia).
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Invece, un gruppo politico, basato su relazioni personali e/o clientelari anziché sull’«interesse generale»,
con un’organizzazione molto fluida e senza «visione» tranne che la ricerca del potere, può essere
considerato un partito politico.
Il numero e la frequenza di elezioni e di votazioni nelle assemblee, così come la competizione che animava
queste circostanze, ci permette di parlare della presenza del partito protozoico (cioè, il prodromo) di cui
parlava Duverger nella forma di reti intermittenti di vincoli personali tanto fra patrizi quanto fra populares.
Il greco demokratia implicava la deliberazione, comprendendo così l’inevitabilità delle divisioni che, secondo
Tucidide, sono inerenti alla natura umana. Come ha scritto Nadia Urbinati: «In una città il cui governo si basa sulle
opinioni sono prevedibili la discussione e il disaccordo. Ciò richiede e al tempo stesso nutre un clima di libertà e
l’espressione pubblica delle idee». Un aperto confronto di opinioni e il disaccordo sarebbero dunque endogeni alla
vita politica della città.
L’apologo di Agrippa modellò per secoli la visione della res publica, dove le divisioni come quella, irriducibile, fra
plebs e optimates andavano frenate per la loro intrinseca pericolosità. Se le divisioni erano da evitare, quale doveva
essere allora la forma di governo e di convivenza civile?
2. Dall’unità in Dio al bene comune solare
Le tradizioni tomista e scolastica
Dissenso e opposizione divennero impraticabili: il sovrano è uno, Dio è uno. Più tardi, nel XIII secolo, Tommaso
d’Aquino propose la più articolata e autorevole trasposizione politica dei precetti religiosi a uso dei governanti terreni.
Secondo il fondatore della tradizione scolastica, la politica deve rimanere sotto tutela religiosa: l’autorità del
sovrano è soggetta a Dio soltanto, attraverso la mediazione della chiesa.
L’unica eccezione ammessa è la ribellione contro i tiranni, perché il tiranno vìola l’armonia – creata dalla divina
Provvidenza – che deve stendersi sul paese: cooperazione e accordo fra le parti, analogamente all’apologo di
Agrippa, sono necessari al governo giusto come alla vita eterna [Finnis 2011]. Se rovesciare il tiranno producesse
un incontenibile sviluppo di fazioni, allora si presenterebbe una discordia ben più grave, e sarebbe istituito un regime
ancor più pericoloso [Palano 2013, 52].
Quello che emerge dalle tradizioni tomista e scolastica, al di là del primato e della supremazia della religione
rispetto ai governanti laici, è l’importanza dell’unità e dell’armonia del corpo sociale e politico.
La città-repubblica: lo spirito settario
Il rifiuto delle divisioni, motivato su basi teologiche, non corrispondeva però alla realtà della politica
secolare, specialmente nelle città-repubblica dell’Italia medievale. Fu in quest’area geografica che il conflitto fra
populus e optimates, reminiscenza della frattura romana, divenne progressivamente istituzionalizzato in partes.
La celebre contrapposizione tra guelfi e ghibellini nella Firenze del XIII secolo è esemplare delle divisioni
all’interno delle città.
Tuttavia, e questa è la peculiare rilevanza dei loro contributi, essi affermano che le partialitates (le «visioni di parte»)
possono essere ammesse se finalizzate al bene comune. Per Marsilio e Bartolo le differenti partialitates possono
essere accettate a certe condizioni: vale a dire, ogni visione deve puntare al bene generale e non
rappresentare interessi limitati o settoriali.
In particolare, Bartolo riconosce una sorta di legittimità alla fazione se agisce contro i tiranni, come nella
tradizione scolastica: in questo senso la fazione diviene un modo plausibile di resistenza e ribellione.
Lo «scontro fra seguaci che agivano nell’interesse dei propri signori» fece nascere formazioni in lotta tra loro
specialmente in Francia, Spagna e Olanda.
Machiavelli e Guicciardini, i più importanti teorizzatori italiani della conquista e della conservazione del
potere politico, convengono che la fine della libertà e dell’indipendenza delle repubbliche cittadine fosse da
ascrivere alle partes, o sette.
Guicciardini poneva il massimo valore sul vivere insieme in armonia, e pensava che ogni governante dovesse
operare in modo da raggiungere un tale stato di cose. L’incapacità di agire in questo modo rovinò l’Italia.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Quando le istituzioni risultano inadeguate a gestire i conflitti e sono piuttosto guidate da ristretti interessi personali e
materiali, le sette diventano deleterie. Infatti, lo spirito fazioso impedisce al popolo di apprezzare le virtù del «buon
governante» e di accettarlo.
3. «Raison d’état» e costituzionalismo: rifiuto radicale e affermazione
embrionale dei partiti
Leviatano e Harmonia
In epoca medievale, parti, fazioni e sette erano condannati per essere di detrimento alla pace e al bonum commune.
Nel XVI e nel XVII secolo la stessa argomentazione fu impiegata per garantire la potestas del sovrano e dello «stato».
Il sovrano impone il suo governo per eliminare la discordia e garantire la pace e la sicurezza.
La massima preoccupazione di Thomas Hobbes era la sicurezza fisica all’interno dello stato, e questo lo
portò a negare legittimità a qualsiasi divergenza. Siccome tutto il potere viene trasferito da ciascun individuo al
Leviatano allo scopo di uscire dallo stato di natura dove «ogni uomo è lupo per l’altro» (homo homini lupus),
nessun’altra obbligazione politica può essere avanzata.
Ognuno deve sottomettersi all’autorità del potere sovrano e assoluto. La reductio ad unum e l’eliminazione
di ogni differenziazione in ambito politico è vitale di fronte all’incombere di guerre civili e religiose. Il
Leviatano di Hobbes consegue da quel periodo di instabilità.
Pensatori neoplatonici come Marsilio Ficino e altri sostennero un’idea più gentile della pace. Nel loro modo di vedere,
l’ordine naturale stesso porta, alla fine, all’esclusione delle divisioni.
La natura è un dono di Dio, e l’ordine divino si realizza attraverso la natura, e poiché l’ordine divino è
benevolo, oltre che meraviglioso, accettarlo diventa «naturale». Quindi, ogni frattura nel mondo terreno
infrangerebbe l’ordine naturale e andrebbe contro Dio.
La visione arcadica dei neoplatonici fu del tutto screditata a fronte della brutalità del XVI e del XVII secolo, dominati
da guerre di religione e rivolte contadine. Questi eventi rafforzarono la raison d’état e resero marginale l’ottica
neoplatonica.
L’alternativa fra una fazione in bonam e una in malam partem non reggeva perché, alla fine, la fazione di per sé
stessa era oggetto di un giudizio del tutto negativo.
Inghilterra: la culla del partito politico
In Inghilterra, queste idee «continentali» avevano trovato spazio grazie a Hobbes, ma allo stesso tempo si fece strada
anche qualcosa di nuovo, di estraneo rispetto a quella impostazione: la funzione cruciale dell’istituzione
rappresentativa e dei suoi membri, la cui centralità si palesò drammaticamente nel 1648.
Il corto circuito è completo: i partiti sono nocivi per l’ordine politico, ma, allo stesso tempo, non è accettabile
il dominio di un partito unico dominante.
Dall’altro lato, il riconoscimento di posizioni e atteggiamenti differenti (e addirittura una considerazione positiva delle
passioni), insieme con l’identificazione di un locus – il parlamento – dove le opinioni politiche potessero essere
espresse liberamente. La «normalità» delle divisioni politiche dentro il parlamento consentì di pensare alla
politica come un’attività plausibile e non necessariamente dannosa per l’ordine politico e il vivere pacifico.
Finalmente, l'istituzionalizzazione delle fazioni nel parlamento, permette la loro esistenza nella vita politica.
John Milton riconobbe che la libertà di espressione e quindi il confronto fra posizioni differenti fanno parte della vita
politica degli «uomini saggi», mentre la tirannia sopprime le voci libere.
Un esame della vita politica quotidiana nell’Inghilterra del XVII secolo rivela che i partiti, ancorché in una forma
embrionale, esistevano ed erano assolutamente riconoscibili. Queste aggregazioni erano personali e instabili
ma, a differenza dell’esperienza delle assemblee antiche e medievali, esse traevano vantaggio dalla
continuità delle istituzioni. Questo riconoscimento non implica un’accettazione consapevole e teoricamente
fondata dei partiti.
L’accusa che ciascun partito scagliava contro l’altro era sempre la stessa: attenzione esclusiva verso gli
interessi della propria cricca o fazione e insofferenza e fastidio per l’interesse generale e il bene comune.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Halifax sottolineava i pericoli di conformismo e acquiescenza verso il nuovo soggetto: «Invece di fare di ogni uomo
un individuo consapevole […] il partito dissolve ogni volontà in una massa amorfa».
L’opposizione al conflitto politico acceso rimaneva salda ma, nello stesso tempo, mentre «gli inglesi continuavano a
criticare le fazioni […] con sempre maggior frequenza […] ammettevano il valore del dissenso in politica».
L’accettazione della loro presenza era de facto: rimaneva assente la spiegazione del perché della loro
presenza.
John Bolingbroke, il primo autore che tratta in profondità il problema dei partiti [...] accettava la presenza di
differenti partiti separati da «una vera diversità di disegno e principio», ma non l’esistenza di partiti mossi
da interessi personali e settoriali: questi ultimi sono partiti solo di nome, in realtà sono soltanto fazioni.
Il partito «non fazioso» che non sta – non deve stare – in opposizione ad altri partiti perché rappresenta il tutto, cioè
l’interesse generale, contro gli interessi particolari.
{Nella definizione di Bolingbroke, c’è sia un richiamo alla definizione antica e dispregiativa dei partiti, ovvero
delle fazioni spinte da interessi personali, che a quella medievale di Marsilio e Bartolo, i quali consideravano
accettabili solo i partiti che lavoravano per il bene comune}
Solo un partito immune da spinte settarie sarebbe accettabile, perché solo un tale partito servirebbe il bene comune:
«Un partito, così costituito, è chiamato impropriamente partito. Esso è la nazione, che parla e agisce nel discorso
e nella condotta di alcuni uomini». Egli afferma con convinzione che i partiti sono legittimi semplicemente perché
sono una realtà. L’analisi di Bolingbroke rappresenta una pietra miliare nella teorizzazione sui partiti, ma anche
contro i partiti.
Se Hobbes dissolve l’individualità, cioè la parzialità, nel Leviatano, Bolingbroke analogamente sembra voler
diluire i partiti in un’unità superiore, il «re patriota». La differenza fra i due autori sul fatto del dissenso si colloca
sul piano contestuale: spaventevole e pericoloso per il primo, costituzionale e pacifico per il secondo.
Le incertezze della visione liberale
Soltanto una nuova visione del mondo, di respiro universale, poteva rompere la ferrea gabbia di assolutismo,
monismo e olismo. Questo passaggio epocale avvenne con l’affermazione del liberalismo in Gran Bretagna a
partire dai contributi di David Hume e John Locke; ma è solo con Hume e Burke che finalmente abbiamo il
riconoscimento che i partiti possono essere «connessioni onorevoli» fondati su «principi corretti».
Il conflitto politico organizzato non porta inevitabilmente a un disordine senza fine e alla perdita della libertà.
I partiti sono un’esigenza costituzionale: «In un governo libero può non essere attuabile né desiderabile l’abolizione
di tutte le distinzioni di partito» [1758; trad. it. 1974, 680].
{Il reale cambio di paradigma nell’accettazione dei partiti — e non di un unico partito o di un “partito unico”
— avviene solo alla fine del 1600, in Inghilterra, con la diffusione del pensiero liberale. Ad ogni modo i partiti
non potevano comunque essere troppo distanti dalla visione monarchica}
Gli unici partiti pericolosi sono quelli che mantengono punti di vista opposti circa gli elementi essenziali del
governo.
Hume distingue i diversi tipi di partiti e fazioni in «personali e reali». Il primo tipo è fondato «sull’amicizia
personale o sulla personale avversione», mentre il secondo si fonda «su qualche reale differenza di
sentimento o di interesse» [ibidem].
Hume accetta i partiti ma solo se collaborano a garantire il lineare e corretto funzionamento delle istituzioni
britanniche.
Il passaggio decisivo nella concezione di partiti e fazioni giunge con Edmund Burke. La sua definizione è lapidaria
e in un certo senso «definitiva»: «Il partito è un corpo di uomini uniti a promuovere il loro comune sforzo per
l’interesse nazionale, basato su particolari principi che tutti loro condividono».
Ma appaiono due rischi collegati all’istituzione di partiti. Il primo riguarda la solita divisiva e dirompente
spaccatura della società in fazioni → i partiti infatti sono accidentalmente soggetti a degenerare in fazioni →
è Burke a mettere in luce la potenziale degenerazione della politica a causa del familismo.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Il loro compito – afferma Burke nella Letter to the Electors of Bristol del 1774 – è tanto di aggregare uomini,
che manderanno i loro rappresentanti in parlamento per deliberare in vista dell’interesse generale, quanto
di controllare le attività di parlamento e governo.
Una società relativamente libera, attiva attraverso associazioni di vario tipo, club, stampa, gazzette e pamphlet,
petizioni e quant’altro, facilitò l’accettazione dei partiti. Ma essi furono concepiti come, e di fatto erano, strutture
istituzionali, qualcosa che poteva esistere (legittimamente) nel contesto delle istituzioni britanniche. Al cuore
del nuovo status dei partiti c’era lo sviluppo di prassi costituzionali e assetti istituzionali, più che di fermenti sociali.
{La definizione dei partiti nell’Inghilterra georgiana del 1700 si evolve in una visione esclusivamente
statalista: i partiti infatti potevano essere accettati solo se interni alle istituzioni — anche se realisticamente
esistevano molte organizzazioni extraparlamentari}
Capitolo secondo — Una ricezione sfasata: accoglienza selettiva e
rifiuto ostinato
1. Inghilterra: il lento percorso del partito in parlamento
Fuori dal parlamento le strutture di partito rimanevano indefinite e stentavano a prendere forma. La politica britannica
predemocratica era caratterizzata però da una specie di disgiunzione. In teoria, la politica parlamentare
rappresentativa prevaleva sull’autogoverno promosso dai cittadini. In pratica, la società inglese era mobilitata,
approfittando della tolleranza del dissenso che permetteva l’espressione della volontà pubblica sotto forma
di istanze e petizioni, la partecipazione al voto nelle assemblee di parrocchia e di contea, l’attivismo in
associazioni volontarie.
Alla fine del XVIII secolo si svilupparono «organizzazioni politiche extraparlamentari» [Black 1963, 13].
Gli echi della rivoluzione francese non furono estranei a questo sviluppo [Emsley 1985]. Essi infiammarono l’opinione
pubblica britannica (con buona pace di Burke) e alimentarono le associazioni politiche.
Allo stesso tempo, questo intervento rivelava una logica chiara: la «preferenza» per il carattere tradizionale,
individuale, della politica britannica, rispetto alle espressioni collettive.
L’idea di lasciare che le masse entrassero nel processo politico, secondo una vera «deriva demagogica», era
considerata inaccettabile all’epoca – un sentimento che continuò a persistere a lungo. Era accettabile soltanto un
grado di conflitto ordinato.
2. Francia: l’irruzione (rivoluzionaria) del partito nella società
Qui il termine stesso apparve con un connotato molto peculiare: «partito» (parti) inizialmente designava i
filosofi illuministi e la parte dell’opinione pubblica che ne sosteneva le idee.
Il parti philosophique potrebbe essere definito come un «nucleo di oppositori che si guadagna l’attenzione del
pubblico acculturato» contestando le «idee tradizionali» della classe dirigente politica e del clero [Israel 2006, 814].
Gli anni che precedettero la rivoluzione francese videro infatti un’«espansione di pubblicazioni e controversie politiche
spettacolare e senza precedenti». Negli ultimi sei mesi del 1788 furono pubblicati più di 1.500 pamphlet; nei primi
quattro mesi del 1789, fino alla riunione degli États généraux a Parigi, il loro numero superò i 2.600 [ibidem, 262-
263], In aggiunta, poco prima, a partire dagli anni Settanta del XVIII secolo, la Francia conobbe un’incredibile
proliferazione di letteratura clandestina, politica, filosofica ed erotica». Le energie e le passioni politiche che
circolavano nella società prerivoluzionaria non avevano modo di esprimersi o di manifestarsi in alcuna istituzione.
Seppure con certe limitazioni e per un periodo molto breve, dopo l’89 la politica – la politica partitica – dilagò
in tutto il paese. Allo scoppio della rivoluzione nacquero vari club e associazioni, trovando il paese ricettivo
al loro messaggio. L’improvviso e rapido sviluppo in tutta la Francia dei club giacobini, e in misura minore di altri,
fu possibile proprio grazie al fermento politico-intellettuale dei decenni precedenti. La socialità dei salotti e dei caffè
aveva rimpiazzato lo stile ammuffito delle accademie ufficiali con patente regia. Tuttavia, pur essendo
numerosissime, le associazioni prerivoluzionarie erano prive di qualsiasi carattere politico. Il movimento tettonico
provocato dalla rivoluzione consistette proprio nel riunire le persone per influenzare gli avvenimenti politici.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
{Le visioni liberali che influenzarono l’Europa Continentale tra il 1600 e il 1700 contribuirono in maniera
fondamentale all’aumento del fermento politico, intellettuale e associativo – il quale però non trovava
nessuno sbocco partitico-istituzionale}
Il club giacobino: il primo protopartito
Il club dei Bretoni, il nucleo della futura Società degli Amici della Costituzione giacobina, emerse come precursore
dei successivi club. All’inizio, l’associazione dei Giacobini puntava a coordinare i membri dell’Assemblea
nazionale per delineare una strategia comune. Poi il club parigino finì per agire come centro nazionale (société
mère) che controllava la periferia.
Alla fine del 1790, tutte le società popolari, basate sul modello del club giacobino, avevano aperto le iscrizioni a tutti
gli uomini a prescindere da reddito o condizione.
Lo sviluppo delle associazioni rivoluzionarie, e in particolare la traiettoria del club giacobino, suggerisce
un’ipotesi e cioè che in quella circostanza sia emerso, embrionalmente, un partito moderno, o almeno un
prototipo somigliante ai partiti moderni più di qualsiasi altro fenomeno incontrato fino a quel momento nella
società europea e in quella del Nord America.
I club si distinsero dalle società prerivoluzionarie e da altri esempi europei non soltanto perché erano
«pubblici, politici ed esclusivi» [ibidem], ma anche perché funzionavano con una modalità partitica. Le loro
attività interne erano strettamente codificate [Jaume 1989, 46-47, 58, 420], tanto che le riunioni seguivano uno
schema ben preciso: lettura e approvazioni di verbali (procès verbal); lettura di notizie da pamphlet e giornali;
definizione dell’ordine del giorno; dibattito; presentazione di mozioni; votazioni; definizione dei rapporti con altri club
[Boutier e Boutry 1992, 13].
I club svilupparono collegamenti verticali fra la periferia e il centro parigino, con quest’ultimo che approvava
l’affiliazione dei club locali e dava loro le linee guida politiche. Inoltre i club tenevano congressi a livello
regionale, eleggevano organi esecutivi a livello locale e regionale, incassavano quote obbligatorie
d’iscrizione (che andavano dalle 12 livres di Parigi alle 3 livres di Marsiglia).
Il principio della «sottomissione» del gruppo parlamentare al club indica la modernità dell’organizzazione
giacobina, dato che questo aspetto si affermò molto più tardi, alla fine del XIX secolo, con l’avvento del
partito socialista di massa.
«La principale accezione di questo termine significa un partito sedizioso all’interno dello Stato. Il termine partito in sé
non ha nulla di odioso, quello di fazione sempre».
La torsione ideologica dei rivoluzionari francesi: libertà individuale contro
pluralismo
L’esperimento partitico, portato avanti dai giacobini più compiutamente che da altri, collassò a
causa della contraddizione interna fra obiettivi collettivi (la rivoluzione) e libertà individuale
(retaggio dei philosophes).
Nell’Encyclopédie la voce riguardante il partito apparve, significativamente, come Faction. Voltaire, che ne era
l’autore, riconosceva la differenza fra partito e fazione e non era maldisposto verso l’esistenza di partiti: «La principale
accezione di questo termine significa un partito sedizioso all’interno dello Stato. Il termine partito in sé non ha nulla
di odioso, quello di fazione sempre».
Al di là della divergenza fra anglofili e anglofobi, il quadro culturale generale dell’illuminismo portava i leader
della rivoluzione a pensare in termini individualistici, senza concettualizzare la dimensione collettiva. O,
piuttosto, identificando la dimensione collettiva in un corpo unitario e indivisibile: la nazione, incarnata dalla
Assemblée.
La visione atomistica della società introdotta dai philosophes instillava una sorta di sospetto per qualsiasi
assetto sovraindividuale.
La volontà generale che guida l’attività umana in una comunità è il risultato della liberazione dell’uomo dalle cattive
influenze della cattiva società. La volontà generale è indivisibile e riassunta nell’assemblea rappresentativa:
l’individuo diluisce la sua individualità in essa perché solo nel corpo rappresentativo gli interessi conflittuali
possono essere risolti attraverso la deliberazione. Quindi, divisioni e parzialità non possono essere organizzate
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
«sul campo», fra i cittadini, perché ciò metterebbe a repentaglio la capacità dell’assemblea di aggregare interessi
diversi.
La società è un tutto armonioso che non può essere spaccato. Nessuna parte può seguire la propria strada,
pena il crollo di tutta la struttura istituita dal contratto.
La volontà generale non è imposta da un’autorità assoluta ma deriva dal libero consenso del popolo[2].
{Lo scontro tra monismo e pluralismo prese una paradossale piega nella Francia post-rivoluzionaria: per
quanto la nuova visione illuminista-liberale enfatizzasse l’individualismo e quindi, di conseguenza, gettasse
le basi per il pluralismo, questo veniva concepito nell’entità indivisibile dello stato-nazione. Praticamente
nessuna entità collettiva poteva essere concepita in quanto nulla poteva esserci oltre le istituzioni}
Alla fine, i rivoluzionari si schierarono, per la maggior parte, con la concezione olistica di Rousseau e con la sua
critica radicale delle divisioni presenti nella società.
Sieyès inventò anche un neologismo – adunation – per indicare la compressione in un’unità sola – una reductio ad
unum – di tutte le volontà [Gusdorf 1978, 175].
L’individuo non ha più nessuna rilevanza: ciò che conta è un’entità collettiva, il popolo e la nazione.
L’alterazione dei principi illuministi, che ponevano la massima enfasi sulla libertà individuale, era davvero
completa.
I rivoluzionari francesi riconoscevano la legittimità di opinioni diverse, ma non ammettevano lo sviluppo
organizzativo di tali opinioni per il timore che un’organizzazione politica strutturata mettesse in pericolo la
nuova società.
{Con l’adozione del pensiero di Rousseau, i post-rivoluzionari fecero un passo oltre i principi illuministi
sull’individualismo, mettendo al bando ogni organizzazione collettiva che fosse al di fuori del popolo e della
nazione}
3. Olismo controrivoluzionario e apertura liberale
I controrivoluzionari post-1815, invece, presentavano una giustificazione intellettuale solida e coerente di condanna
dei partiti. Maistre, Bonald, Lamennais e altri pensatori della fine del XVIII secolo espressero infatti una
visione «monistica, statica e organicistica». In questa loro concezione può essere contemplato soltanto un
ordine perfetto, e Dio ne costituisce l’asse. Tuttavia, poiché Dio è infinitamente distante dall’uomo, il mondo è
retto dalle ferree leggi della natura.
Nell’ottica di Rousseau l’autorità è legittimata dalla comunità umana, mentre per i controrivoluzionari
l’autorità è legittimata da Dio, attraverso la natura.
Secondo Isaiah Berlin, la visione profondamente pessimistica di Maistre «è il nocciolo di tutte le dottrine
totalitarie», di destra come di sinistra.
I movimenti di sinistra, dai comunisti agli ecologisti, hanno ceduto in vario modo alla «tentazione olistica», seguendo
una sorta di linea ereditaria rousseauiana, anelante a un’armonia e a un’unità inclusive – ma create dall’uomo.
I movimenti della destra radicale ed estrema, invece, sono in debito con il pensiero controrivoluzionario, la cui visione
organicistica e monistica fornisce le giustificazioni teoriche per sentimenti antiliberali in generale e antipartito nello
specifico [Holmes 1993; Sternhell 2006].
Monismo e olismo erano pienamente restaurati. Ciò nonostante, nel periodo tra rivoluzione e controrivoluzione
emergono due autori che presentano una giustificazione della politica partigiana basata su principi liberali: Benjamin
Constant e Alexis de Tocqueville.
Constant riconobbe la legittimità del dissenso organizzato. Riprendendo Senofonte, Constant considera le
differenze di opinione come inerenti alla natura umana. Perciò diventa del tutto legittimo articolare e
difendere le proprie idee e mobilitare risorse per promuoverle. Sarebbe innaturale ostacolare questo
processo. La competizione per il controllo del governo e la formazione di gruppi di maggioranza e minoranza
costituiscono la fisiologia della politica.
Interesse generale è «la rappresentanza di tutti gli interessi parziali».
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Tocqueville sostiene che esista una netta differenza fra partiti «grandi» e «piccoli», una distinzione che non
dipende dal numero dei loro sostenitori ma dalla qualità degli interessi che essi rappresentano. I grandi
partiti rappresentano interessi generali, e qui si possono trovare «i tratti più nobili, le passioni più generose,
le convinzioni più genuine, i comportamenti più sinceri e coraggiosi». I partiti piccoli, invece, sono più simili
a fazioni fondate su ambizioni personali, non su convinzioni genuine.
In generale, i partiti sono considerati «necessari»: essi costituiscono una barriera contro l’azione dispotica
della maggioranza.
Inoltre, sia Tocqueville sia, in misura minore, Constant intravedono uno specifico pericolo per gli assetti
liberali: l’avvento della politica di massa e l’asservimento del popolo al partito.
America: dall’accettazione per necessità all’organizzazione nel territorio
Sull’altra sponda dell’Atlantico, la rivoluzione americana portò al riconoscimento piuttosto rapido – e duraturo –
dell’inevitabilità, e quindi in una certa misura della legittimità, della politica partitica. Tale riconoscimento fu reso più
facile da una situazione completamente diversa da quella in cui avrebbero operato i rivoluzionari francesi.
Nello stesso tempo continuava la ricerca del consenso e dell’omogeneità. Questa pulsione, definita da Louis
Hartz il «pericolo dell’unanimità», può essere assunta a caratteristica costante della cultura politica
americana.
James Madison, il cui debito intellettuale verso Hume e Montesquieu è evidente , considerava inevitabili i
conflitti di interesse perché intimamente correlati alla natura umana, e più specificamente all’ineluttabile
disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza.
Allo scopo di ridurre al minimo la «violenza delle fazioni», va costruito uno stato forte basato sul «principio
repubblicano» (governo popolare, separazione dei poteri e federalismo). In tal senso, il pluralismo delle
opinioni potrebbe addirittura rivelarsi positivo se organico all’assetto istituzionale repubblicano.
Quindi «nel terzo o quarto congresso [1793-1797] i partiti politici erano già presenti». Alla fine risolse questo
dilemma anziché teoricamente in pratica, cioè nella realizzazione del sistema politico americano.
Questo processo parlamentare intra muros ricorda la lunga evoluzione secolare della politica partitica inglese; ma
con una differenza: l’adattamento alla politica partitica richiese secoli in Gran Bretagna, mentre in America soltanto
un decennio o poco più. Le nuove istituzioni, l’assenza di interessi consolidati e la pressione internazionale dovuta
all’ostilità della Gran Bretagna accelerarono il consolidamento partitico. A breve seguì poi l’insediamento dei partiti
al di fuori del parlamento. L’«invenzione» di Martin van Buren, l’embrionale partito di massa, si affermò già alle
elezioni del 1828, al momento della prima significativa estensione del suffragio anche agli uomini che non
possedevano terra o beni.
{In Nord America, grazie alle nuove istituzioni e l’assenza altri fattori che potessero influenzare i politici, i
partiti furono accettati e implementati praticamente da subito, senza un percorso giuridico-filosofico dietro
→ a dimostrazione che forse la forma “partito” è la più naturale forma di organizzazione politica per gli
uomini in condizioni neutrali}
Nulla indica il salto concettuale riguardo alla funzione dei partiti più chiaramente di un’affermazione di van Buren,
fatta nel 1827: «I principi espressi dal partito dovrebbero soppiantare la preferenza per le persone» [cit. ibidem, 107,
corsivi nell’originale]. Il concetto della rappresentanza collettiva sostituiva quello della rappresentanza
individuale. Come conseguenza, le «masse» entravano in politica.
Alla fine, fu la stabilità istituzionale che consentì ai partiti di essere riconosciuti e di radicarsi nella
società. La loro accettazione era strettamente legata all’obiettivo ultimo di un sistema politico più efficiente.
I partiti furono quindi visti come strumenti per il buon governo e le divisioni che producevano come una
sorta di costo inevitabile.
4. La nazione e lo stato contro il partito
Madison, Constant e soprattutto Tocqueville avevano previsto gli inconvenienti della nascente società di
massa. Essi temevano che tali sviluppi portassero al trionfo della passione sulla ragione, della mera forza
del numero sulla deliberazione ponderata, e quindi della demagogia sulle antiche virtù repubblicane.
In entrambi i paesi, sebbene con una diversa interpretazione, la cultura romantica esaltò l’ideale di nazionalità che,
almeno all’inizio, andava a braccetto con il liberalismo.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
I partiti al servizio del potere statale
La metà dell’Ottocento fu un periodo di contraddizione fra l’unità e l’armonia dello stato nazionale, da una
parte, e l’articolazione e la difesa dei diritti politici, nonché l’organizzazione politica di questi diritti, dall’altra.
Fino al risveglio rivoluzionario del 1848, Partei in Germania aveva lo stesso significato di parti nella Francia
prerivoluzionaria: un atteggiamento ideologico-filosofico e una Weltanschauung generale, non un’associazione
politica.
Come ammiratore del sistema inglese, Von Mohl riconosceva la legittimità dei partiti (al plurale) e ne sottolineava la
compatibilità con il Rechtsstaat. Però soltanto i «partiti statali» (staatliche Parteien) – filosistema e
rappresentativi degli interessi generali – sono conformi all’unità e alla stabilità che sono necessarie allo
stato.
Per Rosenkranz invece i partiti svolgono molteplici «funzioni significative»; ma il loro ruolo, per quanto
importante, dovrebbe essere confinato alla società civile. Non sono autorizzati a intervenire negli affari di
governo. Questo è l’ambito proprio delle élite non partitiche. Anche in un protoliberale come Rosenkranz la
matrice hegeliana è del tutto evidente.
Hegel non concepiva l’esistenza di gruppi politici che pretendessero di rappresentare la volontà popolare al
di là e indipendentemente dallo stato. Nell’ambito politico, nulla poteva evolvere fuori dalla portata dello stato, che
è «il razionale in sé e per sé […] assoluto, immoto, nel quale la libertà giunge al suo diritto supremo, così come
questo scopo finale ha il più alto diritto di fronte ai singoli, il cui dovere supremo è di essere componenti dello stato.
La tradizione filosofica hegeliana, con la sua destra e la sua sinistra, fornì gli strumenti intellettuali per la
negazione del pluralismo nello stato (etico). Quando si accetta che lo stato sia superiore all’individuo, e che
sia la sintesi di tutte le opinioni soggettive, non resta spazio alcuno per divisioni o differenze. Chiunque agisca
in contrasto con lo stato è contro la totalità. La concezione monista e olista raggiunge qui il suo apogeo. Questa
tradizione teorico-politica lascia spazio per un solo partito, e quindi solo per lo stato a partito unico. Di
conseguenza i partiti potrebbero essere accettati soltanto se si adeguassero alle esigenze dello stato, o
diventassero agenzie dello stato.
L’idealizzazione del potere statale da parte di von Treitschke rappresenta l’epitome dell’interpretazione idealistica
della funzione dei partiti alla fine del XIX secolo.
Contrariamente, per l’italiano Minghetti, ciò che risulta originale nel suo pensiero è la preoccupazione per
l’infiltrazione dei partiti nell’amministrazione statale e nella magistratura. Il titolo del suo libro è eloquente: I partiti
politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione.
In questo Minghetti anticipa un problema – il patronage – che avrebbe investito i partiti nelle democrazie mature nel
corso del Novecento.
Secondo Bluntschli, sulla scia di Machiavelli e Tocqueville, la competizione fra partiti è la condizione
necessaria per un buon governo: «nessun partito può sussistere per sé solo; la sua esistenza e il suo
sviluppo sono resi possibili soltanto dalla presenza di un contropartito [Gegenpartei]». L’esaltazione dei partiti
e della competizione politica da parte di Bluntschli prevede la distinzione fra partiti fondati su un principio, che
sono veri partiti dediti agli interessi generali, e partiti non politici, che sono fondati su interessi religiosi,
sociali e locali.
Lo spazio per il dissenso è contenuto, e infatti l’Italia e la Germania limitarono la libertà di stampa e il diritto di
associazione.
{In conclusione, alla fine del XIX secolo è la filosofia idealistica predominante a condizionare la visione del
partito, specialmente in Italia e in Germania. I partiti sono importanti, utili e anche necessari, ma solo nella
misura in cui si conformano a un certo profilo. Cioè, essi devono agire in sintonia con, e a sostegno dello,
stato. Il partito come tale, il partito in sé, sta ancora cercando legittimazione. Il pluralismo non ha sfondato
sul continente e rimane confinato alla Gran Bretagna e ad altre enclave nordeuropee. Lo stato è divenuto il
nuovo sovrano a cui ogni componente della società deve obbedire. L’antico ideale di armonia cede il passo
alla virile affermazione di una potenza monolitica; tutte le energie e le risorse devono essere concentrate in
una direzione: l’affermazione dello stato. Al di fuori dello stato c’è il vuoto. Lo spazio per il dissenso è
contenuto, e infatti l’Italia e la Germania limitarono la libertà di stampa e il diritto di associazione. In questi
paesi i partiti dovevano percorrere ancora molta strada per ottenere legittimazione.}
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Il conflitto fra partito e nazione
In Italia e in Germania il punto di riferimento cruciale era lo stato, in accordo con la filosofia idealistica.
In Francia, in linea con la sua tradizione culturale, il riferimento era la nazione.
La nazione è un organismo vivente e il nazionalismo è quindi un’etica, per la quale tutti i comportamenti
devono adeguarsi all’interesse comune e la volontà del singolo individuo è del tutto ininfluente» [ibidem,
324].
La tirannia dei numeri, la demagogia, i piccoli interessi personali e l’«apparato» erano visti come risultato inevitabile
del suffragio di massa.
Da una parte, l’emergente partito di massa comprime la rappresentanza dei veri interessi del popolo, perché la
«macchina-partito» favorisce i politiciens più ambiziosi e senza scrupoli. Dall’altra, i partiti rappresentano interessi
settari che stridono con, o addirittura compromettono, la realizzazione della volontà generale incarnata dalla nazione.
I liberali temevano di perdere la capacità di selezionare la classe dirigente (come poi sostennero Mosca e Pareto) e
quindi di governare secondo la raison, per l’interesse generale.
Capitolo terzo — Verso la definitiva legittimazione del partito
Il sentimento antipartito si orientava verso proprietà e funzioni specifiche dei partiti, piuttosto che sull’idea
di partito in quanto tale. L’ostilità era incanalata verso un particolare tipo di partito – ancora una volta quello
connotato da preoccupazioni e interessi piccoli, particolari, ristretti. Adesso erano i partiti piccoli e settari
che ricevevano l’onta precedentemente indirizzata alle fazioni. Alla fine, l’unico attore in scena rimaneva il partito
e la fazione finì per identificare, correttamente, una componente specifica del partito.
In ogni caso, si stavano affermando i partiti politici on the ground (sul territorio). La conclusione di questo processo
giunse nel 1919, quando i paesi europei adottarono il suffragio universale maschile senza limitazioni (tranne alcune
minori) [1].
1. Il partito in teoria e i partiti nella pratica
Tutti i classici, da Stein Rokkan a Robert Dahl, da Hans Daalder a Seymour Lipset, hanno insistito sul rapporto fra
lo sviluppo di assetti istituzionali liberali e democratici e la nascita dei partiti politici.
Gran Bretagna
Data la preminenza della logica della rappresentanza, nella politica britannica la limitazione del diritto di voto e il suo
lento allargamento procrastinarono l’istituzione del partito di massa extraparlamentare, on the ground (sul terreno).
Il movimento cartista determinò una regressione nel cammino verso l’accettazione di un partito di
opposizione che nascesse dal basso. La paura della «piazza», di una mobilitazione dei cittadini innescata
dalle rivendicazioni politiche delle classi popolari anche contro gli assetti costituzionali, rese ancora più
ferma la convinzione che la politica dovesse rimanere limitata all’ambito della sola attività parlamentare.
Le associazioni volontarie svolsero una funzione cruciale in quanto coinvolgevano l’opinione pubblica su temi politici,
e lo facevano in sintonia con l’assetto politico e costituzionale del paese.
Il caucus «stile Birmingham» presentava caratteristiche innovative: reclutamento aperto a tutti coloro in grado di
pagare uno scellino, sezioni locali diffuse in tutta la città, un comitato centrale eletto dai membri delle sezioni locali,
e un comitato esecutivo alla guida dell’associazione. In questo modo era ormai compiuto il passo decisivo verso
una struttura partitica formale. La novità era eclatante: «I contemporanei riconobbero subito la presenza di
un fenomeno nuovo nella politica inglese: il controllo disciplinato delle masse da parte di un apparato
rigidamente organizzato».
Queste innovazioni modificavano in profondità tanto il ruolo quanto il funzionamento del partito. Secondo
tale prospettiva, il centro della politica sarebbe dovuto passare nelle mani dei partiti, al di fuori del
parlamento. La logica di questa relazione era apertamente democratica: siccome il partito extraparlamentare
è più vicino agli elettori e agli affiliati, esso è più idoneo a rappresentarne le esigenze che non il partito
parlamentare. Venne così alla ribalta il tema della rappresentanza in tutti i suoi aspetti problematici, e non
per nulla Ostrogorski definì poi i membri del parlamento come «semplici marionette sul palco parlamentare»
[1903].
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
La «tendenza a votare per i partiti più che per le persone incomincia a essere una caratteristica permanente della
politica inglese a partire dal 1868».
Lo sviluppo dell’associazionismo, la cosiddetta «associomania» che si diffuse in tutta Europa negli anni Sessanta
e Settanta del XIX secolo [Nord 2000, xvii; Hoffmann 2003a, 286], insieme con l’aumento dei tassi di alfabetizzazione,
istruzione e circolazione della stampa (vedi infra tab. 3.1), ebbe un effetto importante in Gran Bretagna, perché
riversò nella vita politica nuovi settori della società.
La reazione alla “machine”
I caucus, sosteneva Ostrogorski, degradano la politica: «il boss manovra i bisogni e gli appetiti, la credulità e la
vanità, come se giocasse a scacchi» e così vengono incoraggiate le «mediocrità» [1903; trad. it. 1991, 512-513]. Il
tradizionale sistema di rappresentanza individuale, dove sono prassi la razionalità e la deliberazione, rischia di essere
spazzato via dalle «masse indistinte» proiettate nella sfera politica dagli apparati di partito.
Secondo Ostrogorski, il partito che emerge dall’esperimento di Birmingham – sulla stessa linea dell’apparato
(machine) americano – non conosce limite nell’eccitare le masse e nel far prevalere le emozioni sulla
razionalità a proprio vantaggio, visto che per vincere le elezioni ora bisogna convincere molta più gente di
prima (essendo aumentato il numero degli elettori). In definitiva, Ostrogorski esprimeva, sulle stesse linee di
James Bryce e Abbott Lowell, quell’ansia nei confronti dell’ingresso delle masse nell’arena politica e il loro
inquadramento in organizzazioni partitiche rigidamente strutturate.
Di conseguenza, Bryce invocò primarie aperte – open air – come rimedio e, in buona sostanza, come arma antipartito
[Rosenblum 2008, 200]: una sorta di anticipazione di ciò che si sarebbe presentato in modo prepotente alla fine del
XX secolo.
“La psicologia delle folle” di Gustave Le Bon [1895] esprimeva bene quel sentimento.
Tornando al caso inglese, alla fine del XIX secolo i partiti non erano più confinati nell’empireo parlamentare. La
formazione «esterna» del Partito laburista ci offre la prova di questo passaggio.
Ma sarebbe stato il Labour a rompere la prassi, al punto da rivendicare apertamente il pieno controllo dei
«suoi» parlamentari. Questa impostazione, tuttavia, ebbe l’effetto (imprevisto) di ritardare l’entrata sulla scena
politica del Partito laburista in quanto l’opinione pubblica nel suo complesso aderì con molta gradualità al nuovo ruolo
del partito che il Labour voleva affermare nell’arena politica con la «riduzione» del singolo parlamentare a «uomo di
partito» [Beer 1969, 87].
La nascita del Partito laburista, come degli altri partiti socialisti europei, introdusse invece elementi inediti,
e dirompenti, nell’arena politica: questi partiti pretendevano, apertamente, e con successo, di rappresentare
interessi settoriali, non quelli generali difesi fino ad allora da tutti i partiti.
Francia
A parte le società segrete (dalla Massoneria, caratterizzata da un approccio socioculturale, alla Carboneria, più
orientata all’azione), i club borghesi dediti ad attività sociali mantennero una vita intensa e soprattutto en plein air
[Agulhon 1977].
Proprio per la loro radicale opposizione al regime dominante, le società segrete introdussero importanti
novità organizzative, che anticiparono le modalità dei futuri partiti politici: tra queste, l’affiliazione individuale
e ritualizzata, la struttura protomilitare e gerarchica, la rigida obbedienza a regole e direttive, un richiamo
nazionale che superava la dimensione locale. Quest’ultimo aspetto, in particolare, svolse una funzione cruciale
nel proiettare i club locali e i loro membri in una rete più ampia, nazionale o addirittura sovranazionale (come fu il
caso della Giovine Europa di Giuseppe Mazzini, la prima organizzazione politica transnazionale).
L’improvvisa liberalizzazione e democratizzazione del 1848 spalancò le porte all’attività politica favorendo la
trasformazione dei vari circoli in associazioni autenticamente politiche.
La ricorrente e persistente limitazione dei diritti politici rispecchia, quasi in senso pavloviano, la paura che qualsiasi
corps intermédiaire possa limitare la libertà dell’individuo.
La più netta sponsorizzazione dei partiti politici va attribuita a un importante intellettuale, Duvergier de
Hauranne. Dopo avere visitato gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, egli divenne assolutamente convinto che un
sistema democratico necessitasse di «partiti organizzati, perché i partiti sono costitutivi della democrazia
moderna».
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Jules Steeg introdusse durante il congresso del movimento, nel 1887, un’accezione moderna del termine «partito»
affermando che «un partito che non è organizzato non è un partito». L’epiteto «repubblica dei comitati», coniato
da Daniel Halévy per indicare il dominio (illecito) dei partiti sulla vita politica e la loro alienazione dalla volontà
popolare.
Germania
Il pensiero liberale restò sottosviluppato nella Germania del XIX secolo, preparando la strada a forme ben più severe
di conservatorismo e statalismo autoritario [Stürmer 1983].
I due partiti presenti in Germania a metà Ottocento, rappresentavano il prototipo della Honorationenpartei,
cioè di un circolo (partito) di notabili abituati a fare politica in maniera informale, in un ambiente ristretto: la
politica doveva essere – come di fatto era – confinata nell’arena di un’élite aristocratica e borghese.
I liberali, più che i conservatori, ebbero un ruolo importante nel favorire e incoraggiare le associazioni, dando
vita a quella che poi fu chiamata «associomania» (Vereinsmeierei) , vuoi per esprimere il loro desiderio
«borghese» di diventare parte piena della società, vuoi per la loro concezione illuminista dell’istruzione come
mezzo per elevare le classi «inferiori»; proprio in virtù di questa visione essi sostenevano la nascita e
l’attività di associazioni fra operai e (in minor misura) fra contadini.
La socialità era considerata un mezzo per «migliorare la società», mentre gli interessi individuali e settoriali erano
visti come negativi e «politicamente distruttivi». La società tedesca era ancora pervasa da una concezione
monistica dell’agire sociale e politico.
Con l’irrompere dei socialisti, «la politica uscì dal suo terreno predefinito»: scioperi, raduni di massa,
boicottaggi e manifestazioni «turbarono» drammaticamente il normale corso della vita.
Il Kulturkampf – così come le leggi antisocialiste per i socialisti – costituì una sorta di paradossale finestra di
opportunità per lo sviluppo di una rete organizzativa, non solo a livello partitico ma anche
nell’ambito sociale [Kalyvas 1996; contra Kreuzer 1998, 275].
Questa versione moderna, individualizzata, dei cahiers de doléances su abusi e frodi del processo elettorale creò
una specie di «cultura del reclamo» [Anderson 2000, 282].
Italia
L’Italia è caratterizzata da un processo contraddittorio: una formazione dei partiti tardiva unita a una
politicizzazione precoce, dovuta alla questione nazionale.
Un tale atteggiamento confuse i rispettivi ruoli di governo e opposizione e alimentò il «trasformismo»; una prassi che,
tra l’altro, scoraggiò l’emergere di organizzazioni partitiche ben definite in parlamento, oltre che all’esterno. La
mobilitazione politica all’esterno e dal basso fu debitrice della pluridecennale attività cospirativa e
rivoluzionaria mazziniana contro la monarchia e il conservatorismo, e a favore dell’unificazione nazionale e
della rivoluzione «morale». A Giuseppe Mazzini si deve infatti la prima organizzazione politica in Italia, la
semiclandestina Giovine Italia, fondata nel 1831. Nel 1853 Mazzini creò una formazione politica più aperta, il Partito
d’Azione; mentre allo stesso tempo fondava altre organizzazioni clandestine (la Falange sacra e l’Alleanza
repubblicana universale).
La difficoltà ad accedere alle istituzioni rappresentative non dipese solo dall’ideologia radicale antisistema della
componente repubblicana. Dal lato delle istituzioni, la fragilità della rule of law e l’uso arbitrario di mezzi coercitivi da
parte governativa per intralciare o proibire l’attività politica allontanarono le persone dall’attività politica e ritardarono
il consolidamento delle organizzazioni politiche. Come conseguenza, quando poi la politicizzazione si estese, essa
si espresse soprattutto con tendenze antisistemiche di vario tipo, incarnate da repubblicani, anarchici e socialisti
rivoluzionari (e, più tardi, fascisti).
La preminenza del localismo disincentivò l’organizzazione nazionale nel 1872, che c’erano «una mezza dozzina di
Destre, e una mezza dozzina di Sinistre, senza contare tutti i Centri».
Il Partito socialista italiano (Psi) e il Partito repubblicano italiano (Pri), che nacquero nel 1892 e nel 1895,
rispettivamente [Ridolfi 1989; Ciuffoletti 1992]. Entrambi avevano solo pochi membri in parlamento (riuniti nel gruppo
dell’Estrema) a causa della loro opposizione al regime, su base istituzionale per i repubblicani, su base sociale per i
socialisti.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Piuttosto, i cattolici svilupparono una rete sempre più estesa di associazioni benefiche, assistenziali, volontarie e
sindacali, ma dovettero aspettare il 1919 per avere un loro partito, il Partito popolare [Formigoni 2010; Diotallevi
1999].
Gli handicap politici – unità nazionale tardiva, rivolta popolare nel Sud (il «brigantaggio»), inaffidabilità dello stato di
diritto, intralcio e/o repressione dell’attività politica, manipolazione elettorale, «trasformismo» parlamentare, suffragio
limitatissimo fino al 1882, estraneazione dell’elettorato cattolico – furono rafforzati da carenze socioculturali:
l’alfabetizzazione era di gran lunga la più bassa d’Europa e la circolazione dei giornali, soggetta a censure di ogni
tipo prima dell’unificazione e sottoposta a controllo statale dopo, aveva, come tutto il materiale a stampa, una
diffusione elitaria. Infatti, l’associazionismo si sviluppava soprattutto in ambienti aristocratici e selettivi – un’eredità
delle accademie dell’ancien régime – e solo dopo l’unificazione questa caratteristica si attenuò.
Unità e potenza dello stato ebbero la meglio su pluralismo e politica partitica. La precoce e intensa
politicizzazione alimentata dal Risorgimento favorì i partiti antisistema anziché quelli prosistema.
SEGNALIBRO
2. La nascita dei partiti
Il riconoscimento della funzione centrale del partito in politica implica infatti l’accettazione di tutti i suoi potenziali
inconvenienti, come la divisività dell’ambito politico, la massificazione, l’impatto «irrazionale» sulle istituzioni e sulla
vita politica, la rappresentanza collettiva anziché individuale, e anche, per finire, dogmatismo e demagogia anziché
libertà d’espressione e discussione.
La sua estensione incrementò le possibilità di formazione e di sviluppo dei partiti sub specie di partiti di massa (ma
in realtà i partiti erano già presenti prima).
I primi partiti di massa europei: socialisti e cristiano-democratici
Paradossalmente, lo sviluppo organizzativo dei partiti socialisti fu agevolato dal loro attivismo in un
ambiente ostile. L’assenza di diritti politici, anziché limitarne lo sviluppo, spinse i partiti socialisti a formare
strutture articolate e compatte.
Un analogo modello di evoluzione fu seguito dagli altri partiti di massa – quelli confessionali – che sorsero
tanto nei paesi a predominio cattolico quanto in quelli religiosamente misti.
I partiti cattolici intrapresero la loro strada verso la formazione del partito partecipando alle elezioni nazionali in quanto
cattolici. Per esempio: il partito cattolico francese ebbe «origini interne». Infatti, i membri cattolici del parlamento
crearono il gruppo Action libérale nel 1901, che divenne un partito vero e proprio con il nome di Action libérale
populaire l’anno dopo.
L’estensione del voto e la formazione del partito furono strettamente correlati, nel senso che quando il
suffragio divenne universale, e la rappresentanza proporzionale fu estesa, i partiti liberali collassarono (e
dopo non fu creata alcuna organizzazione di rilievo).
Ma la loro strutturazione non resse l’impatto del nuovo elettorato nell’arena politica, né fu capace di andare oltre il
proprio aggregando altre componenti sociali [Gould 1999].
Alla fine, anche in questi paesi le élite più antiche ritennero necessario prendere parte ai processi elettorali. Ma i
partiti nati sotto i loro auspici rimasero poco più che apparenze esteriori.
Un quadro ipotetico delle condizioni di sviluppo dei partiti
In termini generali possiamo sfruttare la teoria della democratizzazione di Dahl (la poliarchia) affermando,
mutatis mutandis, che la liberalizzazione prima del suffragio di massa portò a formazioni partitiche tardive
ma garantite (Gran Bretagna), la liberalizzazione dopo il suffragio di massa a formazioni partitiche instabili,
precoci (Germania) o tardive (Francia), mentre la quasi simultaneità di liberalizzazione e suffragio di massa
portò a una rapida sequenza di nascita e consolidamento (Italia).
Inoltre i partiti, per essere accettati, necessitavano di uno Zeitgeist culturale favorevole.
Lo sviluppo culturale della società civile del XIX secolo [Kocka e Mitchell 1993] fu una precondizione dello sviluppo
dei partiti politici anche laddove l’ideologia dominante (come in Germania) o la prassi di governo (ancora in Germania
e in misura minore in Italia) giocavano contro.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Il risultato dell’Italia è molto distante dagli altri paesi in tutti gli indicatori: la sua arretratezza è netta sotto ogni aspetto.
Perciò, una società civile debole e la fascinazione culturale per lo statalismo tedesco e l’idealismo hegeliano, più che
per il liberalismo, rinchiusero la politica italiana fra le mura del parlamento (favorendo pratiche trasformistiche) e
ritardarono l’avvento (legale) dei partiti sul territorio.
Piuttosto, i partiti sul territorio sono il risultato di fenomeni socioculturali dove, pur in una liberalizzazione
limitata, alcuni imprenditori politici furono capaci di politicizzare le fratture sociali grazie alla preesistenza
di condizioni socioculturali favorevoli. Una liberalizzazione più aperta, poi, favorì decisamente lo sviluppo di
partiti sul territorio.
Come evidenziato più sopra, sulla falsariga di Kalyvas [1996] e Gould [1999], i partiti confessionali emersero come
reazione alla spinta laicizzante dell’élite liberale nell’ultimo quarto del XIX secolo. Si può sostenere, adottando una
diversa prospettiva, che le forze confessionali fossero stimolate dal processo di modernizzazione a intervenire per
proteggere il loro elettorato dai cambiamenti socioculturali, piuttosto che da quelli economici.
La politicizzazione della frattura di classe non seguì lo stesso passo. L’industrializzazione e la mobilitazione sociale
non andarono a braccetto con la formazione dei partiti socialisti.
Germania → La Germania, che stava al polo opposto all’Italia, data la precocità sia della sua industrializzazione sia
della formazione del Partito socialista, rappresenta il caso di un rapporto congruente fra questi due
eventi. Karl Marx ebbe ragione a rivolgere la sua attenzione al caso tedesco.
3. Dalla piena legittimazione all’iperesaltazione: il partito politico negli anni fra
le due guerre
Il riconoscimento del conflitto politico come qualcosa di inevitabile e positivo, e del ruolo centrale dei partiti
nella gestione di questo conflitto per il corretto funzionamento delle istituzioni, annulla ogni nostalgia per il
tradizionale statalismo. Oltre a queste considerazioni, Weber, in Parlamento e governo [1918], riflette anche
sulle caratteristiche dell’organizzazione e dei rapporti di potere interni al partito, proponendo una serie di
tipologie sulla base delle modalità notabiliare, burocratica e carismatica.
Hans Kelsen il giurista austriaco definisce senza equivoci i partiti come i pilastri del sistema politico. Kelsen si spinge
tanto in questa direzione da invocare il mandato imperativo, e cioè il diritto del partito a far dimettere, se necessario,
un proprio eletto in parlamento. Lo spostamento teoretico sul ruolo dei partiti politici espresso dai due
intellettuali tedeschi fu particolarmente importante perché ruppe il consenso sullo statalismo che dominava
da sempre la cultura politica tedesca.
Maurice Duverger nel suo classico I partiti politici [1951] descrive in maniera magistrale cosa fosse il partito
di massa: una struttura aperta, dove chiunque era il benvenuto grazie all’esistenza di una sede (la sezione),
aperta tutto il giorno che per erogare varie forme di assistenza; era il centro di una rete di associazioni
parallele al partito che gestivano bisogni e rappresentavano domande degli iscritti «dalla culla alla tomba»;
era un luogo di impegno e partecipazione, una struttura democratica con una catena bottom-up di delega ed
elezione per ogni carica del partito, e una struttura che operava in continuazione, grazie a un corpo di
funzionari dediti esclusivamente al funzionamento dell’organizzazione.
Il partito di massa esplica tutte queste funzioni[7] ma, sottolinea Duverger, svolge anche un compito molto
importante per tutto il sistema: si dedica all’istruzione politica, per poter coinvolgere sulla scena politica le
«masse amorfe».
L’avvento del partito totalitario
Duverger identifica due modelli differenti di questo nuovo tipo, la versione fascista e quella comunista. La
differenza più significativa sta nelle rispettive «unità di base»: esse erano basate su una struttura militare
per i partiti fascisti (la milizia) e su una struttura minimale e pronta all’azione, attiva nei luoghi di lavoro, per
quelli comunisti (la cellula).
In realtà, questi due modelli si addicono piuttosto alla fase della conquista del potere da parte dei fascisti e
dei comunisti.
Le strutture militari non erano più un’articolazione del partito: furono inserite nell’apparato statale. I regimi
mantennero le loro forze paramilitari per fiancheggiare le strutture repressive ordinarie dello stato, «secondo il
bisogno», ma non costituivano più i pilastri del partito.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
La teorizzazione leninista della funzione delle cellule era chiara: esse erano strutture clandestine, pronte per la
rivoluzione.
Questo passaggio richiama la considerazione di Duverger sull’«artificiosità» della cellula a confronto della
struttura più «naturale» della sezione.
Un sotterraneo filo di continuità?
A parte certi classici – Maurice Duverger, Sigmund Neumann e Juan Linz –, l’attenzione prestata alla versione
fascista del partito totalitario è minima[9]. Un’importante eccezione è rappresentata dalla rivista «Totalitarian
Movements and Political Religions», pubblicata dal 2000 al 2010.
Primo, i partiti fascisti toccarono livelli di reclutamento e di radicamento mai raggiunti da un partito politico in Europa
occidentale, prima e dopo la loro presenza.
Secondo, l’istituzione del sistema a partito unico implicava che tutto il potere derivasse «legittimamente» (cioè in
accordo con le regole e i principi del nuovo regime) dal partito, e che il partito avesse un potere assoluto nel sistema.
Terzo, l’esperienza totalitaria rivela certe tendenze sotterranee che circolano, inconsciamente, nei partiti politici delle
attuali società democratiche. La penetrazione totale della società e dello stato a opera del partito totalitario interbellico
rappresenta una sorta di anticipazione di ciò che il partito contemporaneo, in un contesto completamente diverso e
tramite mezzi completamente diversi, ha cercato di raggiungere.
L’ipotetica esistenza di un fil rouge che attraverserebbe i decenni dal periodo interbellico fino a oggi è stata sollecitata
da una mia lettura personale dei lavori di Richard Katz e Peter Mair [1994; 1995] sul «partito cartello» (cartel party).
In sintesi, il modello di partito cartello, che si profila alla fine del XX secolo, è caratterizzato dalla
compenetrazione tra partiti e stato e dalla conseguente acquisizione, senza precedenti, di risorse da parte
dei partiti. Ragionando sul filo del paradosso, il partito cartello sembrerebbe quindi avere una caratteristica
in comune con il partito totalitario: il suo statocentrismo, cioè un rapporto assertivo, vorace e di sfruttamento
nei confronti dello stato. Soprattutto, il partito contemporaneo ha abbandonato ogni pretesa di dominare la società;
anzi, si sta ritraendo da tale ambito. Tuttavia la massiccia e pervasiva acquisizione di risorse statali a opera dei partiti
– non di un singolo partito[11] – ha un antecedente nell’esperienza totalitaria, quando questo obiettivo veniva però
perseguito in una dimensione parossistica, con ogni strumento.
4. Il totalitarismo teorizzato e messo in pratica
Ci fu una paradossale inversione dei ruoli: l’elemento divisivo della società – per definizione, il partito
politico – divenne l’elemento dell’unità totale: passò dalla parzialità alla totalità. La ricerca incessante,
secolare di unità politica e armonia trovò una radicale, e per certi aspetti definitiva, conclusione negli anni
fra le due guerre grazie al partito unico, totalitario.
Solo nel 1933, per la prima volta, un ex comunista, Victor Serge, definì l’Urss uno stato totalitario.
Le origini del totalitarismo, di Hannah Arendt [1951], svolse un ruolo significativo nell’alimentare questa
interpretazione. L’edizione del 1958 includeva infatti un capitolo intitolato Ideologia e terrore, in cui i campi di
concentramento erano posti al centro dello stato totalitario. Di conseguenza, Arendt escludeva il fascismo italiano
dalla categoria di totalitarismo[13] [Pombeni 1994b, 441-442]. (Sulla falsariga di Emilio Gentile, il cui libro è infatti
intitolato La via italiana al totalitarismo [1995; 2008a].)
L’irruzione del partito totalitario nei sistemi politici fra le due guerre concluse il viaggio verso l’affermazione
del ruolo centrale e «legittimo» del partito politico.
Il Pcus, l’unico a prendere il potere con un’azione rivoluzionaria, distrusse tutte le precedenti strutture dello stato e si
impose come unico apparato statale: in questo senso fu il solo ad avere un tale rapporto con lo stato.
Il partito, non lo stato, forniva la legittimazione del potere. Questa situazione produsse un «doppio stato»
[Fraenkel 1941] dagli incerti confini in termini di legalità e legittimità.
Confusione e conflitto allignavano in quanto «la volontà autoritaria del Führer era espressa solo in modo irregolare,
non sistematico e indiretto» [ibidem, 284].
Come scrive Sigmund Neumann, «il partito nel momento in cui si appropria dell’apparato statale diventa
sovrano». Quindi il nuovo principe, davvero onnipotente, era il partito – un Behemoth piuttosto che un
Leviatano[14].
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Infatti, questo tipo di partito rappresentava interessi ed elettorati specifici – dunque, una parte – però pretendeva di
rappresentare anche la totalità del Volk politico. Così, per neutralizzare la fatale tensione fra partiti in conflitto,
ciascuno con la pretesa di essere partito totale, e per ricostruire l’unità politica, era necessario annientare il
pluralismo.
In verità, più che autorizzato, il partito – uno soltanto – è necessario per guidare lo stato.
Lo “stato totale” di Schmitt combinava due diversi ingredienti: da un lato, la sfiducia tradizionale e molto
radicata verso il multipartitismo e le perniciose divisioni sociopolitiche, e, dall’altro lato, la modalità nuova,
moderna, di rifondere l’unità politica sotto forma di una configurazione politica totale, onnicomprensiva,
attraverso il dominio del partito unico (in qualche modo anticipata dal celebrato saggio del 1930 di Ernst
Jünger La mobilitazione totale). Quindi, è autorizzato un partito soltanto.
Gli intellettuali fascisti[15] accettarono l’idea che un partito potesse rappresentare gli interessi generali, ma a una
condizione: doveva essere unico, perché solo un partito unico poteva esprimere pienamente e unitariamente la
volontà della nazione. Il pluralismo – definito «fazionalismo» – venne rifiutato in quanto espressione della
concezione liberale dello stato. La tradizione del monismo si ripresentava con rinnovato vigore.
Nel passato i partiti liberali avevano promosso soltanto interessi settoriali, mentre «il Partito [cioè il Pnf] non è una
fazione, non rappresenta un interesse specifico» [Gentile 1931, 100]. Gentile inoltre specificava che «il
liberalismo nega lo stato in nome dell’individuo, mentre il Fascismo riafferma il primato dello stato che
esprime la vera essenza dell’individuo».
{E’ interessante osservare come nella “intellighenzia” fascista ci siano dei richiami alla filosofia dei francesi
rivoluzionari rousseauiani – cioè nella torsione dei principi illuministi di libertà individuale – dove l’individuo
e la sua dimensione autonoma vengono annullati nel concetto dello Stato}
Per finire, Michels – il quale, socialista deluso, sposò il fascismo [vedi Beetham 1977] – affermava che «essere una
parte è solo l’inizio per un partito, mentre il suo fine ultimo è [conquistare] lo stato. Egli concludeva che «il Pnf ha
conseguito il fine totalitario, che è esattamente ciò a cui punta ogni partito» .
Insomma, lo stato diventava fascista perché tutte le sue strutture erano innervate – e controllate – dal partito.
Ma tutto questo non è ancora sufficiente affinché un partito diventi una parte totale. Ciò si realizza solo
quando «il Partito cessa di essere un partito […] e diventa la Nazione […] la quale coincide veramente con il
Partito». Il partito deve certo stemperarsi nello stato ma in realtà ha una missione ulteriore: l’educazione e
la mobilitazione delle masse. L’aspetto totalitario del Pnf sta precisamente nel suo sforzo di penetrare la
società ancor più dello stato.
Altri soggetti dimostrarono la loro resilienza fino a dar vita a un «doppio stato», con fedeltà, carriere pubbliche e linee
di controllo parallele. Ciò fu particolarmente vero in Italia, dove il fascismo dovette fare i conti con il potere di veto
impalpabile quanto inossidabile esercitato dalla monarchia e da quel formidabile concorrente per il controllo delle
mentalità che era la chiesa cattolica.
Soltanto chi era iscritto al partito aveva accesso all’impiego pubblico, o agli scatti di carriera, o a vantaggi e
benefici di varia natura.
La penetrazione del partito in tutta la sua forza è bene illustrata dalla diffusione dell’organizzazione per isolato,
ciascuno dei quali comprende 150 persone. Il partito tentò di inglobare la società intera «espandendo» l’integrazione
negativa tipica della Spd al tempo dell’impero [Roth 1963] in un’integrazione totale positiva [Neumann 1956c].
L’organizzazione del Pnf seguiva la tradizionale struttura del partito di massa. Le sezioni (chiamate «gruppi
rionali») rappresentavano il principale riferimento sul territorio ed erano presenti in quasi tutti i comuni.
Come osservava un giurista fascista dell’epoca, «soltanto l’iscrizione al partito garantisce i pieni diritti di cittadinanza»
(sic!) [Ranelletti 1939, 37-38].
5. L’eredità latente del partito totalitario
Il dominio del partito (totalitario) rappresenta un traguardo imprevisto e paradossale nella lunga strada verso
l’accettazione del partito: per la prima volta il partito è inequivocabilmente riconosciuto come il «dominus»
del sistema politico.
Quindi l’interpenetrazione dei partiti con lo stato, e il loro sfruttamento dello stato, attiva la spirale della
delegittimazione.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Come hanno sottolineato Philippe Schmitter [1974] e Antonio Costa Pinto [2014], il corporativismo attirò consensi
dall’intero spettro politico nel periodo interbellico.
Perciò l’attuale rapporto del partito cartello con lo stato va considerato una reminiscenza, un sentore, una lontana
scia dell’esperienza del partito totalitario.
Pur svanendo nel corso dei decenni, in realtà, alla fine del XX secolo la pretesa di controllo sociale è tornata, ma
invertendo i fattori, nel senso che tale pretesa viene ora rivolta allo stato anziché alla società.
Al culmine del potere il partito prese il posto della libertà.
Capitolo quarto — L’età dell’oro del partito e il suo declino
1. L’accoglienza dei partiti nel dopoguerra: un entusiasmo diffuso, con un’ombra
di fastidio
Gli anni postbellici rappresentarono quindi l’«età dell’oro» dei partiti, come scrissero Katz e Mair [1994, 2]. Ciò detto,
vanno distinti due differenti aspetti dell’età dell’oro: uno riguarda l’accoglienza dei partiti politici da parte dell’opinione
pubblica e l’altro la loro organizzazione.
Negli anni del secondo dopoguerra i partiti rappresentarono agli occhi dell’opinione pubblica l’occasione per
riaffermare (o conquistare) la democrazia. Il ritorno della democrazia, o la sua conquista, dopo la guerra fu
legato al multipartitismo: la presenza dei partiti (al plurale) rappresentò la fine del dominio autocratico e
dispotico del partito unico. [...] «La democrazia moderna è impensabile se non in termini di partiti politici» [1942,
1].
In alcuni paesi europei l’opinione pubblica accolse favorevolmente i partiti non solo perché essi
«coincidevano» con la democrazia stessa, ma perché avevano agito come forza politico-militare nella lotta
contro gli eserciti nazifascisti: si erano guadagnati stima e legittimità sul campo di battaglia. Francia e Italia
rappresentano l’esempio più lampante del potere – potere legittimo – guadagnato dai partiti.
Rispetto alla Francia, in Italia i partiti antifascisti del Comitato di liberazione nazionale (Cln) svolsero un ruolo
più diretto ed esclusivo. Furono i partiti politici a fornire una legittimazione di fatto al nuovo governo, non il
contrario. Questa svolta, oltre al ruolo giocato dalle milizie armate dei partiti nella guerra di liberazione del 1943-
1945, promosse i partiti italiani alla posizione, unica nell’Europa occidentale, di autentici domini del nuovo sistema
politico.
Infatti è stato sottolineato come la mobilitazione politica imposta dal fascismo fosse stata recuperata, con modalità
diverse, dai partiti democratici [Morlino 1998, 677].
In sostanza, anche se in misura diversa, la matrice totalitaria imposta a tutte le sfere della società e dello stato aveva
lasciato la sua impronta ambigua e ambivalente nel rapporto fra la massa della popolazione e la politica, e nel modo
di porsi del partito verso la società e lo stato.
Il desiderio di normalità legittimò, in una certa misura, l’ostilità nei confronti della mobilitazione politica appassionata
dell’immediato dopoguerra. I partiti italiani furono così accolti come i portatori e i legittimi dirigenti del nuovo sistema
democratico.
Il ritorno dei partiti
I paesi totalitari
I partiti italiani furono così accolti come i portatori e i legittimi dirigenti del nuovo sistema democratico.
Si trattava di una sorta di antipartitismo selettivo, alimentato da un sentimento molto peculiare di estraneità al sistema
politico e partitico [Ignazi 1989a].
Infatti la formazione dei partiti politici non poteva essere «spontanea», ma doveva seguire le linee imposte dalle forze
di occupazione. Nella zona americana le prescrizioni furono tanto meticolose e dettagliate da riguardare anche
l’«organizzazione interna dei partiti» [Rogers 1995, 34]: una prescrizione poi sostanzialmente adottata nel diritto
tedesco [Poguntke 1994].
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
La narrazione del paese come vittima dell’aggressione tedesca, benché palesemente falsa, fu promossa dall’élite
politica postbellica per cancellare le responsabilità austriaca nel coinvolgimento con il nazismo, ma anche
pienamente accolta dalle quattro potenze occupanti.
I paesi occupati
Fondamentalmente, dove l’occupazione fu dura e diretta, o guidata da un regime fantoccio, la mobilitazione
richiesta a supporto degli occupanti provocò un movimento di resistenza e alimentò, dapprima, passioni e
attività partigiane clandestine e, poi, l’identificazione con i partiti e il loro sostegno. Dove, invece,
l’occupazione fu meno oppressiva e la Resistenza rimase sottodimensionata, la politica partitica postbellica
ebbe meno difficoltà ad affermarsi.
I partiti potevano godere di rispetto e riconoscimento – e legittimità – nell’ambito del proprio elettorato di riferimento
(pillar); e quindi ritrovarono una presenza dominante e pervasiva nel sistema politico grazie ai rispettivi riferimenti
[Daalder 1987a; 1987b]. In tal modo, il ritorno dei partiti portò al ritorno alla normale vita politica.
Italia → Il ruolo marginale attribuito al Comitato per la libertà dai partiti tradizionali dopo la Liberazione riportò la
politica al punto di partenza, cioè agli anni precedenti dell’occupazione nazista, come non fosse successo nulla.
Scandinavia → Dunque il ritorno alla politica partitica nei due paesi scandinavi ebbe un differente significato: un
tranquillo recupero di una normalità appena scossa in Danimarca; una festosa riattivazione della democrazia in
Norvegia [Dahl 2006]. Ma in entrambe le nazioni i partiti politici riconquistarono un incontestato, fondamentale, ruolo
[Arter 2008].
Inghilterra → Nonostante la conflittualità tra Tory e Labour fosse rimasta, per necessità, in ombra sotto le bombe
tedesche, la continuità istituzionale e della vita politica, seppur sottotono, lasciò intatto il ruolo dei partiti. L’adesione
al Labour, in quel particolare momento, con tutte le sue proposte di welfare, implicava una nuova capacità dei cittadini
comuni, e soprattutto dei meno avvantaggiati, di essere pienamente integrati nel sistema: la classe operaia stava
cercando «voce nel processo decisionale degli anni del dopoguerra» [Conway 2004, 74].
Francia → Comunque, a prescindere dal ruolo e ettivamente svolto durante la guerra, i partiti dominarono la politica
francese postbellica. Lo stesso generale de Gaulle non riuscì a contenere il riuscito tentativo dei partiti di riconquistare
e gestire monopolisticamente il potere. Il crollo della Quarta Repubblica – la République des partis, come fu
etichettata – derivò anche dalla corrosione della legittimità dei partiti.
In quest’epoca i partiti si trovavano in una posizione ambivalente: per quanto fossero immersi in un profondo
conflitto interpartitico, anche a causa del laborioso processo di ratifica della costituzione, e sottoposti alla
critica implacabile dei gollisti riguardo alla loro invadenza, essi dominavano il processo politico; ma
rimanevano privi di una piena legittimazione[3].
Accettazione e mobilitazione
In una certa misura, il ruolo svolto dai partiti nel passaggio dal tempo di guerra alla democrazia ebbe il suo peso.
Con l’eccezione di Germania e Austria, la narrazione subito dispensata da ogni attore fu quella di una nazione che
recuperava la sua libertà grazie alla coraggiosa resistenza contro i suoi occupanti. E, con qualche sfumatura, la
politica destava più passione di prima – anche grazie alle donne – e le persone partecipavano in tanti modi, dalle
riunioni politiche agli scioperi, dalle campagne elettorali alle manifestazioni di massa: l’impegno era la disposizione
culturale dell’epoca.
I partiti comunisti in quel periodo ebbero un duplice impatto: spinsero a miglioramenti organizzativi i loro concorrenti,
soprattutto i partiti socialisti, e allo stesso tempo destarono preoccupazioni per la loro politicizzazione estrema della
scena pubblica. I partiti comunisti ottennero una risposta positiva nell’immediato dopoguerra perché erano stati la
componente più attiva della Resistenza. Il loro buon risultato elettorale era dovuto anche alla loro «arma»
organizzativa; la disciplina e l’impegno dei militanti e l’efficienza e l’articolazione della loro struttura attraevano e
spaventavano anche, a seconda del punto di vista. È in base a queste premesse che Duverger presentò la sua
tesi del «contagio della sinistra»: egli considerava il modello comunista basato sulla cellula come il più
idoneo a conquistare la vittoria alle elezioni. Nel lungo periodo, però, il contagio si verificò nella direzione
opposta, in quanto fu il partito socialista basato sulla sezione, e non quello comunista basato sulla cellula,
a diventare il modello vincente.
2. Il trionfo organizzativo del partito di massa e le sue contraddizioni
Il partito che ricevette un tale consenso generale fu, tuttavia, un particolare tipo di partito, il partito di massa.
Esistevano molti altri partiti, sotto forme diverse, alcuni dei quali addirittura precedenti alla formazione dei partiti
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
socialisti e confessionali. Però solo queste due famiglie partitiche (socialisti, confessionali più i conservatori
inglesi) raggiunsero una dimensione di massa e introdussero importanti innovazioni organizzative, di cui la
sezione territoriale costituisce il cuore.
L’adesione dei partiti moderato-borghesi (liberali) al modello del partito di massa si ebbe proprio quando le
premesse culturali, sociali e politiche di tale modello stavano venendo meno, lasciando spazio al «partito
pigliatutti» di Kirchheimer. Secondo lo studioso tedesco, l’«epoca in cui esistevano rigide divisioni di classe e
strutture denominazionali più differenziate» [ibidem; trad. it. 1971, 185], che aveva favorito il partito di massa, negli
anni Sessanta stava finendo.
Questo tipo di partito [di massa] fu acclamato come il partito per eccellenza, essendo stato il protagonista
di due cruciali congiunture storiche: gli anni Dieci-Venti e i Quaranta-Cinquanta. Il primo periodo
accompagnò l’ingresso delle «masse informi» sulla scena politica, e la conseguente conquista della piena
cittadinanza politica per milioni di persone in tutta Europa; il secondo periodo salutò il ritorno alla libertà e
al pluralismo.
Il partito di massa come il modello standard per ogni organizzazione politica: ogni partito doveva moltiplicare gli
iscritti, avere unità locali diffuse su tutto il territorio, impegnarsi in un continuo attivismo politico e nella più intensa
mobilitazione, eleggere rappresentanti controllabili e responsabili verso la leadership, operare in base al principio
bottom-up, curare la formazione e l’educazione politica, ecc.
La persistente idealizzazione di questo modello cozza tuttavia con la realtà delle società postindustriali
contemporanee: non è più isomorfico alla società attuale. Il partito di massa fu infatti «il figlio della
rivoluzione industriale», secondo l’acuta definizione di Hans Daalder.
Siamo entrati nell’era postindustriale, già preannunciata tra gli anni Sessanta e Settanta. Questa società presenta
lineamenti specifici: invece di grandi concentrazioni di salariati, si sono diffuse tante piccole unità di produzione;
invece di una forza lavoro presente in maniera massiccia nel settore industriale, è il settore terziario/dei servizi che
predomina; invece dell’omogeneità e della standardizzazione di compiti e funzioni sul posto di lavoro, prevalgono
differenziazione, frammentazione e specializzazione; invece delle grandiose ideologie onnicomprensive e degli
schieramenti politici infiammati dalla passione politica, espressione della fede assoluta dei true believers, navighiamo
in un’epoca di pluralizzazione e relativismo.
Il partito cartello – o, in altri termini, partito «statocentrico» – rappresenta il modello più recente, e quello più
largamente recepito dalla letteratura, dell’evoluzione dei partiti. Il partito cartello è, per certi aspetti, isomorfo
all’ambiente esterno post-anni Ottanta, cioè al contesto sociale e politico delle democrazie avanzate (post)industriali.
3. Il «terminus a quo»: il partito pigliatutti
Due ampi fenomeni sociali stavano erodendo alla base il partito di massa: il processo di secolarizzazione e le
trasformazioni socioeconomiche e tecnologiche.
La secolarizzazione
Stando all’interpretazione di Weber, la razionalità del mondo moderno determina una riduzione dell’influenza
della religione nella sfera pubblica. Di conseguenza, il processo di secolarizzazione mina la capacità dei partiti
confessionali di conservare il loro elettorato tradizionale. La combinazione tra secolarizzazione crescente e
disaffezione della componente più spirituale e coinvolta religiosamente verso i partiti cattolici alla lunga influì
negativamente su quei partiti: l’età dell’oro della democrazia cristiana tramontò alla fine degli anni Settanta. Quel
clima indebolì la fedeltà ai partiti confessionali, ma non eliminò l’importanza della religione per i votanti in generale.
La strategia di presentarsi come Volkspartei anziché come un partito puramente confessionale funzionò bene
all’inizio.
La controcultura degli anni Sessanta e specialmente la rivolta giovanile del 1968 riattizzarono il conflitto politico-
ideologico, ma gli effetti di quegli eventi sul partito (e sui partiti) si sarebbero visti più tardi.
Il cambiamento socioeconomico
Le trasformazioni socioeconomiche sono al centro dell’attenzione di Kirchheimer. La «società opulenta», del titolo
del fortunato libro dell’economista John Kenneth Galbraith (1958), non riguardava soltanto il sogno americano, ma
era diventata una realtà ben percepibile anche in Europa. Inoltre, e cosa più importante per la nostra analisi, le fiorenti
condizioni economiche cambiarono la composizione e la stratificazione sociale, nonché le condizioni di vita dei ceti
medio-bassi. La classe operaia raggiunse la sua massima espansione numerica grazie anche al trasferimento di
forza lavoro dal settore agricolo, mentre la borghesia passò dal settore industriale a quello dei servizi.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Insieme con l’espansione della classe operaia un altro fenomeno si manifestò in questo periodo:
l’«imborghesimento» dei lavoratori manuali grazie alle loro migliorate condizioni economiche.
In realtà, come Bartolini e Mair hanno dimostrato in maniera convincente, «per quanto riguarda la frattura di classe
[…] l’ipotesi del congelamento [delle scelte elettorali] è solidamente confermata» (corsivo nell’originale).
4. Adattamento e consenso: l’apogeo
Essi avrebbero dovuto attenuare sia il loro riferimento alla classe gardée sia la loro connotazione e il loro fervore
ideologico, e diventare più attenti e ricettivi verso gruppi e interessi differenti.
Kirchheimer, e molti studiosi dopo di lui, preferirono insistere sul primo aspetto: il catchallism implicava la
tendenziale convergenza dei principali partiti. Questo poteva portare alla collaborazione istituzionale e/o alla
convergenza ideologica. La convergenza fra attori politici un tempo radicalmente contrapposti portò
Kirchheimer ad anticipare il termine «partito cartello», più tardi adottato da Katz e Mair.
La «età del consenso» non operava solo in Gran Bretagna[8]. In gradi diversi, quasi tutti i paesi europei adottarono
quello stile politico. Le democrazie consociative (Belgio, Olanda, Austria e Svizzera) furono i recettori «naturali» di
quella impostazione. Più precisamente, in Danimarca «decisioni all’unanimità erano il risultato tipico del processo
legislativo […] e lo stile decisionale era simile allo stile consociativo». In Svezia, come sostiene Thomas Anton, lo
stile politico era deliberativo, ragionevole, aperto e consensuale: «il processo decisionale non appariva mai affrettato,
brusco, irrazionale o passionale»[9].
La Francia resistette a questo movimento di convergenza perché la «frattura istituzionale» della Quinta Repubblica
non intersecò gli schieramenti politici in profondità, tranne che per la breve «fase carismatica» (1958-1962) del ritorno
di de Gaulle. Ma, nello stesso tempo, la cooperazione fra il governo e l’opposizione comunista in parlamento, visto
l’alto numero di leggi passate con l’accordo tra i due schieramenti, suggerisce l’esistenza di un modello consensuale
opaco e sottotraccia.
In Italia, ogni tendenza esplicita alla convergenza fu impedita dalla presenza di potenti partiti antisistema a
sinistra (i comunisti) e a destra (i neofascisti): la radicalizzazione e la polarizzazione caratterizzano tanto la
cultura politica quanto il sistema partitico [Sartori 1976].
Seguendo Sartori [1976], è la sfera pubblica più di quella istituzionale a dover essere privilegiata per giudicare
atteggiamenti e comportamenti di un partito; facendo riferimento a questo approccio l’Italia rimane caratterizzata da
un «pluralismo polarizzato», cioè è un sistema in cui le opposizioni bilaterali sono molto distanti fra loro, con un ampio
divario fra di esse (distanza ideologica) e l’inasprimento della tensione politica attraverso un discorso divisivo e
delegittimante (radicalizzazione) [Ignazi 2015].
In questo modo, la collaborazione nell’arena parlamentare non influiva sul discorso «contro», conflittuale e
radicale, nella sfera pubblica: di conseguenza, la convergenza a livello di élite non riusciva a determinare un
sentimento di reciproco accordo e cooperazione a livello di massa.
5. I rapporti di potere intrapartitici
La storia ufficiale dei partiti non rivela alcuna iniziativa verso modalità differenti di funzionamento, né incentivi da
parte della leadership alla smobilitazione dei militanti e della stessa membership. Essenzialmente, il catchallism
lasciò intatto lo schema formale dell’organizzazione.
L’accesso alla televisione divenne prezioso sia per il partito nel suo complesso sia per la leadership del
partito. Il partito traeva profitto dal libero accesso alla televisione incrementando notevolmente il flusso
comunicativo con i cittadini senza alcun costo; la leadership del partito traeva profitto dall’accesso
privilegiato al nuovo mezzo guadagnando in statura personale agli occhi degli iscritti e, nello stesso tempo,
aumentando la propria distanza dagli organi collegiali del partito.
Soltanto la televisione, con i connotati intrinseci di personalizzazione e libertà d’azione che garantiva ai
dirigenti, ebbe una conseguenza duratura sulla vita interna del partito, perché privò gli iscritti del ruolo di
«trasmettitori di informazione», inducendoli poco alla volta al silenzio, all’irrilevanza e infine all’uscita. La
smobilitazione dei membri del partito rappresenta l’esito permanente del catchallism.
La maggiore autonomia e libertà d’azione della leadership alterò i rapporti interni al partito. Lo «scambio ineguale»
fra dirigenti e iscritti, dove questi ultimi riconoscevano l’indispensabilità dei capi per le loro presunte maggiori
conoscenze e capacità, consentiva ai capi a loro volta di avere mano libera, senza timore di conseguenze.
In effetti, il controllo del flusso dell’informazione è sempre stato un’importante «zona di incertezza».
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Kirchheimer fu lungimirante nell’evidenziare la nuova personalizzazione che la televisione avrebbe introdotto nella
politica partitica. Infatti, lo studioso tedesco intuiva che i dirigenti erano ormai orientati a cercare voti senza
preoccuparsi troppo se intaccavano alla radice quelle funzioni specifiche che il partito di massa esercitava,
come l’educazione e la formazione politica e la canalizzazione delle domande.
Il partito diventava così un’organizzazione vote-seeking e office-seeking, indifferente al problema
dell’intensità e della forza dell’identificazione dei membri con il partito: «La scelta dei candidati per una
legittimazione popolare come titolari di pubblici uffici appare la funzione più importante dell’attuale partito pigliatutt[i]».
Di conseguenza, il partito concentrò ogni suo sforzo nell’arena elettorale.
Soltanto più di recente la personalizzazione in politica ha dilagato a tal punto [Poguntke e Webb 2005] da abbattere
ogni vincolo partitico.
Una prosperità diffusa e la deideologizzazione avevano portato a un nuovo profilo di elettore, meno
interessato e meno coinvolto dalla politica. I partiti rispondevano a quei cambiamenti diventando pigliatutti.
Il partito pigliatutti incarna la disintegrazione dello standard organizzativo della società industriale ed è proiettato
verso la società postindustriale.
La Scuola di Francoforte avrebbe diffuso il concetto della riduzione dell’uomo a «una dimensione», cioè a quella di
consumatore nella società capitalista.
6. Adattamento e consenso: la reazione
I partiti erano criticati perché d’accordo su troppe questioni, perché adottavano le stesse posizioni, per la loro
convergenza di opinioni e politiche. I partiti finirono sotto tiro per la ragione opposta a quella che aveva
motivato sfiducia e disprezzo verso di essi per secoli: ora era il conflitto a essere invocato, non l’armonia.
Il paradigma del neocorporativismo predicava una convergenza degli interessi politici e sociali da cui
fossero escluse soltanto forze marginali o antisistema. Così il consensualismo, compresa la variante
consociativa, divenne lo standard dei paesi industrializzati avanzati.
Francia → Le istituzioni della Quinta Repubblica furono modellate precisamente per limitare il ruolo dei partiti nei
confronti del governo.
Capitolo quinto — L’immobilismo del partito in un’epoca di
cambiamento
Gli eventi del ’68 riaccesero l’impegno politico in tutta Europa e gli anni Settanta rappresentarono un’epoca di intenso
attivismo e di partecipazione politica non convenzionale.
Il ’68 alimentò un sentimento di distacco e di delusione nei confronti dei partiti, pur senza scatenare
estraneazione o apatia: in effetti accadde il contrario, visto che gli anni successivi furono contrassegnati da
un livello senza precedenti di mobilitazione politica. E questo non era mai successo in passato, perché il
sentimento antipartito era sempre andato a braccetto con la demotivazione politica.
1. Sterili sussulti di autocritica interna
La maggior parte dei partiti consolidati nei principali paesi europei si soffermarono sulla loro capacità, in quanto
partiti, di rispondere alle richieste provenienti da un ambiente socioeconomico e culturale in fase di cambiamento.
Germania → In definitiva, entrambi i partiti tedeschi, con tempi e drammatizzazioni differenti, intaccarono le loro
tradizioni ideologiche e organizzative introducendo alcune, anche profonde, innovazioni, avendo riconosciuto la
trasformazione in atto della società tedesca e la loro inadeguatezza a farvi fronte.
Italia → I partiti italiani rimasero bloccati nel loro schema organizzativo ispirato al modello del partito di massa, e non
trassero vantaggio dal loro embrionale esame autocritico per modificare il rapporto con la società civile.
Inghilterra → A fronte dell’effervescenza sociale che pervase la società britannica dalla metà degli anni Sessanta,
Tory e Labour restarono indifferenti e continuarono a comportarsi come sempre.
Francia → Solo il ’68 e le sue conseguenze spinsero dapprima la Sfio, e molto dopo i partiti della droite – e alla fine
anche il Pcf – a mettere in discussione il loro ruolo nella società e a modificare la loro struttura interna e il loro
funzionamento.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
La loro imperturbabilità fu agevolata da un generale consenso nella sfera intellettuale sulla legittimità del partito
politico. Erano pochissime le voci contro il partito in sé. Tutte le critiche erano rivolte piuttosto alla scarsa prestazione
dei partiti, non alla loro legittimità a operare in quel sistema di delega che sarebbe stato chiamato «governo dei
partiti».
La fine del consenso
Queste critiche, estremamente radicali e polarizzate in termini politici, non erano rivolte soltanto alle
politiche o ai profili ideologici dei partiti, ma anche alla loro organizzazione interna.
I partiti di sinistra furono l’obiettivo primario del movimento di protesta. Essi vennero accusati di
«imborghesimento» e di perdita dello spirito rivoluzionario. I liberali si aprirono a posizioni più progressiste.
Il conseguente «decadimento dei partiti [stimolò] valori antipartitici e antisistemici di quasi tutti i nuovi movimenti
politici, della Destra come della Sinistra» [1979, 32, 30].
2. Rigidità del partito a fronte della contrarietà circostante
Dal lato istituzionale, riguardo alle trasformazioni socioeconomiche, la pressione era per la stabilità e la
convergenza: il neocorporativismo e la gestione consensuale della maggior parte delle politiche
economiche, in cui erano coinvolti anche i partiti di opposizione, erano diventati una specie di camicia di
forza politico-istituzionale, che rafforzava la resilienza dei partiti a qualsiasi modificazione.
La presenza di tratti del partito cartello già nel partito piglia-tutti degli anni Settanta.
Dal lato socioattitudinale, i movimenti sociali continuavano a sfidare l’ordine politico con un nuovo repertorio di azioni
politiche e con proposte radicali, destinati, in una certa misura, a evolvere alla fine degli anni Settanta nel programma
della sinistra libertaria.
Questa divaricazione produsse un risultato imprevisto: un assetto para-istituzionale neocorporativo a fianco di un
conflitto partitico sempre più aspro. I partiti divergevano nell’arena politico-ideologica ma collaboravano in
quella istituzionale.
Negli anni Settanta andò ampliandosi la distanza dei partiti dal centro.
L’entropia del partito e la cartellizzazione anticipata
La polarizzazione del conflitto politico interpartitico e la diffusione di differenti modalità d’azione, combinate alle prassi
consociative, alla fine rafforzarono un atteggiamento difensivo e autoprotettivo dei partiti, che conduceva a un punto
morto.
La sfida ai partiti portata dal basso (i nuovi movimenti sociali) e dall’alto (gli interessi organizzati) era sotto controllo.
I Provos olandesi rappresentano un caso significativo in questo contesto in quanto costituiscono un prototipo
dell’espressione politica della controcultura giovanile [Kempton 2007][3].
I partiti non recepivano l’effervescenza sociale, mentre si trovavano a loro agio con le attività statocentriche indotte
dalla gestione di strutture paragovernative come le Sozialpartnerschaften, con conseguente spostamento dei partiti
verso lo stato e rafforzamento di prassi collusive.
3. La svolta degli anni Ottanta
Fiorì invece una rivoluzione a livello valoriale e attitudinale, la «rivoluzione silenziosa» individuata da Ronald
Inglehart.
I baby boomers insistevano invece su esigenze espressive e di realizzazione di sé, di curiosità intellettuale e
sensibilità estetica. Essi volevano partecipare alla sfera pubblica, esprimendo sentimenti e idee in maniera diretta ed
esplicita, rompendo regole e convenzioni a favore di una reale autenticità: le loro priorità erano postmateriali.
Piuttosto, i partiti verdi e della destra estremista/populista ebbero un effetto indiretto: essi raccolsero, e nello stesso
tempo alimentarono, l’insoddisfazione verso i partiti politici tradizionali e, per esteso, verso il partito in quanto tale.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Gli alfieri inefficaci del cambiamento: i partiti verdi
I partiti verdi diressero la loro offensiva verso i partiti tradizionali, e soprattutto quelli socialdemocratici. I partiti verdi
intendevano spazzare via tutte queste incrostazioni dall’organizzazione del partito. Essi volevano che:
a) chiunque potesse prendere parte al processo decisionale direttamente, senza mediazione alcuna;
b) il corpo burocratico interno interposto fra la base e la dirigenza fosse sostituito dal lavoro volontario
dei militanti;
c) tutte le cariche interne ed elettive fossero detenute solo per un periodo limitato, sostituendo la presa
soffocante della classe dirigente-burocratica con un servizio volontario temporaneo;
d) il/la leader fosse sostituito/a da una leadership collettiva;
e) la disuguaglianza di genere venisse eliminata a favore del perfetto equilibrio in ogni carica.
Tutti questi precetti, a prescindere dalla loro naïveté, scossero l’ambiente politico-partitico e obbligarono i partiti
quanto meno a confrontarsi e a prendere in considerazione tali sfide.
Il faro verde: i «Grünen»
I Grünen tedeschi costituiscono un riferimento privilegiato per esaminare l’originale di organizzazione interna comune
a quasi tutti partiti verdi.
Ai punti richiamati sopra se ne aggiunsero diversi altri, fra cui il riconoscimento dell’incompatibilità fra
cariche di partito ed elettive, la garanzia di massima autonomia locale e la «democrazia diretta di base»
(Basisdemokratie) in luogo della delega.
Questo modello organizzativo alternativo, e soprattutto la Basisdemokratie, sarebbe diventato lo standard
per tutti i partiti ambientalisti-libertari.
In altre parole, il partito si istituzionalizzò: perse l’aura movimentista delle origini e si adeguò, almeno in parte, alle
regole standard dei partiti tradizionali.
Fischer vinse quella battaglia e il «realismo» guadagnò terreno fra i verdi; un passaggio che influenzò anche le
filosofie organizzative degli altri partiti verdi.
L’implausibile alternativa nera: i partiti dell’estrema destra populista
Essi sono antipartito perché il loro codice genetico ideologico reca inscritto l’ideale di unità armoniosa e, di
conseguenza, l’orrore per le divisioni. Il pluralismo è estraneo alla visione populista e alla cultura politica
dell’estrema destra.
La critica rivolta ai partiti passa facilmente dall’ambito del confronto politico ad un assoluto disprezzo. I politici e i
partiti sono infatti un bersaglio ricorrente nel discorso dell’estrema destra populista.
Francia → Il prototipo di questa famiglia politica, il Front National (Fn) francese, usava bollare i quattro partiti
tradizionali francesi degli anni Ottanta come «la banda dei quattro» (riecheggiando la famosa cricca dei primi anni
della Cina post-Mao), per sottolineare la sostanziale convergenza di tutti i partiti mainstream, e l’estraneità del Fn al
sistema.
Austria → La logica della Proporz applicata nella società austriaca (una sorta di lottizzazione partitica di incarichi e
altri benefit praticata principalmente da socildemocratici e popolari).
L’ipotesi è che il successo dell’estrema destra populista sia stato alimentato da sentimenti antipartitici che
essa veicolava in maniera decisa e molto convincente.
Tuttavia, nonostante questi successi, il loro impatto sulle configurazioni intrapartitiche è stato minimo
(contrariamente alla loro influenza piuttosto forte sulle politiche anti-immigrazione e della sicurezza). Questo
è dovuto anzitutto al fatto che tali partiti non hanno mai delineato soluzioni organizzative originali; inoltre,
l’unico loro tratto caratteristico in quest’ambito, la leadership di tipo cesaristico, confliggeva con la generale
tendenza di maggiore democratizzazione interna.
Infine, va ancora sottolineato che le nuove famiglie partitiche contribuirono alla delegittimazione del partito
politico.
4. Il «terminus ad quem»: il partito cartello
I partiti adattavano – o, meglio, cercavano di adattare – i loro rapporti interni alle domande del nuovo ambiente
esterno, cioè la società postmoderna e postindustriale. Il punto è che l’adattamento all’ambiente esterno voleva
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
essere funzionale alla conservazione della posizione dei partiti nel sistema politico; tuttavia, un tale adattamento
risultava «disfunzionale» in termini di accettabilità e legittimazione.
I partiti in un ambiente «liquido»
Individualizzazione e personalizzazione
Tutte le caratteristiche sociali che Kirchheimer aveva previsto subirono un'accelerazione e si approfondirono.
La condizione postmoderna degli ultimi decenni induce al rifiuto di fedeltà stabili e precise: l’individuo è libero di
trovare il proprio ruolo nella società e nell’arena politica. Fedeltà ereditate e vincoli tradizionali sono messi in
discussione o persino rifiutati. Gli individui vivono in uno stato fluido dove identità e appartenenza sono flessibili,
mutevoli.
Ne consegue che «l’individualizzazione è diventata la struttura sociale della società moderna». Di
conseguenza, «i processi di individualizzazione stanno erodendo le condizioni della struttura sociale che
rendevano possibile l’azione politica collettiva».
Nessuna struttura collettiva e nessun movimento sociale ha sostituito quello che il postindustrialismo e il
postmodernismo hanno dissolto.
Lo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione di massa ha indubbiamente esaltato il ruolo dei leader politici, tanto che
certi network televisivi divennero essi stessi attori politici influenti (la catena Fox Tv in America e il gruppo Mediaset
in Italia sono i casi più eloquenti); infotainment e soft news hanno finito per modellare la comunicazione
politica.
Come hanno scritto Mazzoleni e Schultz, «il linguaggio dei politici viene sposato con quello della pubblicità, delle
relazioni pubbliche e degli affari commerciali». È il destino dell’«homo videns» di sartoriana memoria [Sartori 1997].
Questa «occupazione del video», e la conseguente maggiore esposizione al pubblico di massa, consente ai
leader di rafforzare la loro autonomia nei confronti degli organi esecutivi, delle élite intermedie (middle-level
elites) del partito e, naturalmente, della base.
Anche i politici locali hanno guadagnato carta bianca rispetto all’organizzazione locale del partito (favorendo così il
ritorno allo stile politico «notabiliare») e ai livelli superiori del partito (facendo quindi evolvere la struttura del partito
in senso stratarchico).
5. La doppia radice del partito cartello
La collusione interpartitica a fine secolo
I partiti si distanziarono sempre più dal centro dello spazio politico, alimentando così la polarizzazione. La
polarizzazione fu anzitutto innescata da uno spostamento a destra dei partiti moderati-conservatori, sollecitati da un
nuovo vento culturale proveniente d’oltre Atlantico, la tendenza neoconservatrice e
neoliberale.
Il neoliberismo minava la funzione mediatrice dei partiti, ma ciò che metteva all’angolo i partiti era anche la
rivoluzione silenziosa e il sorgere dei «cittadini critici», insieme con nuove forme di conflittualità politica.
Katz e Mair, nella maggior parte dei loro scritti, mettono in guardia sul rischio che la cartellizzazione solleciti
l’antipolitica: «“i partiti antipartito e antisistema” possono rappresentare il prossimo stadio nello sviluppo
dei partiti».
6. Una valutazione dell’attuale ricezione del partito
L’estensione e la forza dell’identificazione con il, e dell’attaccamento al, partito e il giudizio sulla sua correttezza,
efficacia, rappresentatività, moralità, democrazia interna, trasparenza ricevono valutazioni sempre più critiche. La
fiducia sta scomparendo. E con la perdita della fiducia, la legittimazione dei partiti ad operare nel nome e
nell’interesse dei cittadini viene meno: è ormai in discussione il ruolo stesso dei partiti come fiduciari e delegati.
L’identificazione con il partito
L’identificazione con il partito oggi può essere considerata semplicemente come rapporto affettivo fra
l’individuo e il partito. Il disallineamento non implica però necessariamente disaffezione per l’attivismo
politico. Questa ipotesi comunque è congruente con il sorgere del «cittadino critico» attivato dalla «mobilitazione
cognitiva».
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
La fiducia nei partiti e nei politici
Il deficit dei partiti in termini di fiducia non è «isolato»: non riguarda soltanto i partiti e i politici. Gli stessi sistemi
democratici sono sotto tensione.
Il problema e, nello stesso tempo, la soluzione della crisi sta proprio qui, nell’inevitabile indispensabilità dei partiti.
7. Il patto faustiano
I partiti sono caduti nella «trappola della legittimità»: l’acquisizione e l’accumulazione di più risorse e più potere sono
state pagate con il calo della fiducia e, alla fine, della legittimazione. Essi divennero come Leviatani malfermi: ricchi,
pervasivi e potenti, ma con i piedi di argilla della delegittimazione.
Capitolo sesto — Le risorse dei partiti all’alba del nuovo millennio
L’ultimo saggio di Peter Mair delinea una visione molto pessimistica sul futuro dei partiti. Il rapporto del
partito con le istituzioni nazionali e sovranazionali e con la società nel suo insieme è considerato da Mair
talmente allentato, frammentato e sbilanciato che il partito rischia di essere definitivamente accantonato
come opzione politica: la tecnocrazia, le autorità sovranazionali non controllabili, i nuovi media metterebbero
all’angolo i partiti, facendoli sembrare sempre più superflui. Questa cupa prospettiva riflette senza dubbio una
tendenza in atto.
La dinamica top-down, sia nel rapporto tra dirigenti e iscritti sia fra leadership centrale ed élite intermedie e organi
collegiali, ha forgiato l’immagine di un organismo autoreferenziale, insensibile alle esigenze e alla volontà dei cittadini
e degli iscritti, la funzione dei quali è ormai confinata all’applauso, a guisa di «capi-tifosi che incitano al sostegno
della squadra».
1. Un inventario delle risorse
Seguendo una sorta di «approccio economico», potremmo dire che i partiti dispongono di due tipi di risorse, legate
al capitale oppure al lavoro. Se adottiamo un’altra ottica, quella derivante dalla teoria degli incentivi, i partiti
dispongono di altri due tipi di risorse:
a) risorse simbolico-collettive, cioè la capacità dei partiti politici di attrarre, tenersi stretti e mobilitare
seguaci, tesserati, militanti e rappresentanti grazie alla spinta di incentivi generali, collettivi, e anche
emotivi;
b) risorse particolaristico-selettive, esemplificate da tutta una gamma di vantaggi e prebende distribuiti
a una platea di beneficiari che vanno dall’elettorato nel suo insieme fino a gruppi numericamente
molto limitati (addirittura fino al singolo individuo).
Mentre le risorse umane e finanziarie sono richieste e cercate dal partito per poter sopravvivere, le risorse collettive
e selettive sono offerte dal partito proprio per arrivare al primo tipo di risorse.
Una tendenza costante negli ultimi trent’anni: un declino della forza lavoro gratuita e volontaria, e delle risorse
simbolico-collettive, affiancato dall’incremento dei mezzi finanziari e delle risorse materiali-selettive.
2. Le risorse umane
La prima riguarda il rapporto fra agenzia (agency) e struttura. Il partito è stato concettualizzato come
un’organizzazione che riunisce persone desiderose di prendere parte al processo decisionale esprimendo
collettivamente le loro richieste nell’ambito della sfera pubblica.
Tuttavia, il partito, come qualsiasi altra organizzazione complessa, è guidato anche da alcuni, specifici «imperativi»
che trascendono la volontà individuale[1]. Lo scopo primario di ogni partito è, innanzitutto, la sopravvivenza
dell’organizzazione stessa: ogni azione svolta da un attore andrebbe vista attraverso la lente di tale scopo
primario.
I partiti sono, essenzialmente, luoghi di competizione e conflitto per il potere o, detta in altro modo, per il controllo su
«aree di incertezza» cruciali. Come Panebianco e più di recente Rye hanno sottolineato, il potere partitico ha molte
facce.
L’iscrizione al partito
Gli iscritti rappresentano la risorsa umana fondamentale di un partito politico. Sebbene il partito sia identificato –
da sempre – dal suo leader e dai messaggi che trasmette, soltanto la base (il partito sul territorio) conserva
la capacità di legittimazione. L’élite (nella direzione del partito e nelle cariche pubbliche) manca di questa
capacità (tranne che per la leadership carismatica): essa opera legittimamente in nome del partito.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Se i cittadini lasciano il partito, diventano spettatori e «rimangono a casa», i partiti perdono la loro anima: «il risultato
è l’inizio di una nuova forma di democrazia» si sostiene, con preoccupazione.
I partiti con una ristretta membership infatti deprimono fatalmente quella che Mair chiama «democrazia
popolare».
Al di là di questo ruolo simbolico – ancorché essenziale – la membership è stata utilizzata a lungo (oggi molto meno)
come una massa di manovra da parte della leadership.
La democrazia dell’audience può anche far presa, ma i partiti hanno ancora bisogno di esibire le loro truppe. In
effetti, alcuni partiti hanno compensato la penuria di iscritti spostando l’accento o sulla quota di militanti in
seno agli iscritti stessi, o su un ampio seguito elettorale a prescindere dalla bassa densità partitica, o sulla
qualità della leadership. La prima opzione è messa in pratica da partiti estremisti o di nuova costituzione,
legati a movimenti sociali molto attivi; la seconda da partiti moderati e conservatori; la terza, in senso
proprio, da partiti carismatici (in realtà rarissimi nella politica democratica) o, in senso lato, da tutti i partiti,
visto che ognuno confida in una leadership efficace.
La membership è quindi intrinsecamente legata al principio democratico. Ciò spiega la sua resilienza, almeno in via
di principio.
L’evoluzione della «membership»
Le figure 6.2a-6.2c, che raggruppano paesi per entità del rapporto fra iscritti ed elettori, indicano che più alto era il
punto di partenza, più precipitosa è stata la caduta. Invece, partiti che all’inizio hanno un modesto rapporto
iscritti/elettori mantengono più o meno la loro posizione. Si può inoltre osservare che la contrazione degli iscritti
sembrerebbe finita, come se dai partiti fossero stati drenati tutti i membri «superflui» ed essi avessero raggiunto una
sorta di stabilizzazione. A un livello basso, ma stabile. La caduta è confermata per quasi tutti i partiti, e per la maggior
parte di essi è stata marcata nel periodo fra gli anni Settanta e gli anni Novanta. In seguito si assiste a una sorta di
stabilizzazione o, in certi casi, a un declino più lieve a confronto con i periodi precedenti. Inoltre, i nuovi accordi
istituzionali riguardo alle regole elettorali, il potenziamento o depotenziamento del governo locale,
l’ammontare dei sussidi pubblici e così via possono avere anch’essi alterato la capacità, o la volontà, di
reclutamento dei partiti.
In effetti, una delle più frequenti ragioni date a giustificazione dell’iscrizione era proprio che la gente voleva mandare
via il governo.
Inghilterra → Il partito aveva offerto degli incentivi al coinvolgimento diretto degli iscritti introducendo il principio «un
membro, un voto» (One Member, One Vote, Omov) in tutte le votazioni interne e nei referendum indetti sulle
tematiche più salienti.
Italia → Nel partito di Berlusconi la membership fu considerata a lungo più un disturbo che una risorsa.
L’approssimazione dell’organizzazione interna e la totale «delega» di potere a Berlusconi toglievano qualsiasi
efficacia all’idea stessa di membership, e i congressi nazionali altro non erano che riti di celebrazione del leader.
Germania → In definitiva, il caso tedesco mette in evidenza proprio il fatto che le traiettorie delle cifre della
membership sono legate sia a tendenze sociali di lungo periodo – la fine delle fratture di classe e religiosa – sia a
eventi politici specifici e/o interni al partito che possono alterare, in una certa misura, l’andamento tendenzialmente
declinante del reclutamento.
La variazione nelle cifre relative alla membership nei maggiori partiti dei quattro paesi più grandi ha alcune
motivazioni ricorrenti che sono riassunte nella tabella 6.1[6]: l’entusiasmo per la prospettiva o il conseguimento di un
successo elettorale o la depressione a seguito di una sconfitta, l’entrata o l’uscita dal governo, l’avvento di una nuova
leadership e i mutamenti nelle regole interne a favore di una partecipazione più diretta alla gestione del partito.
Il quadro generale del logoramento della membership è in qualche misura controbilanciato dalla capacità
delle nuove formazioni di rigenerare l’impegno politico.
Queste nuove offerte politiche (digitali, movimentiste) dimostrano che esiste ancora un potenziale di
reclutamento partitico, sebbene per alcuni di questi partiti si debba parlare solo di «cyberiscritti». Tuttavia,
la confortante epoca delle adesioni di massa, sulla base della classe sociale e della religione, e della fedeltà
inossidabile è finita.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Funzione e concezione della «membership»
L’idea di un’adesione «leggera», con meno doveri, una quota di iscrizione più bassa e minore
coinvolgimento, riflette il sentire generale dell’impegno temporaneo e fluttuante: le fedeltà liquide sono in
sintonia con lo spirito dei tempi.
Il membro potenziale doveva interagire con una comunità, e questa interazione gli offriva tutti gli elementi di
socializzazione per identificarsi con il partito.
Avendo accantonato la dimensione diretta, personale e collettiva, della loro interazione con il pubblico, i partiti
appaiono organizzazioni autoreferenziali, società e lontane dai bisogni della gente.
Lo squilibrio tra l’offerta dei partiti e le richieste dei cittadini
Il loro «modello generale degli incentivi» ha riformulato la teoria tradizionale della scelta razionale con elementi
tratti dalla psicologia sociale. I due autori distinguono gli incentivi in sei categorie.
Le prime due riguardano gli incentivi collettivi (positivi o negativi): il membro crede negli obiettivi generali
del partito e ne è attratto, sia per sostenerli sia per combattere quelli avversari.
La terza categoria concerne l’ideologia del partito e le sue «finalità ultime»: il membro non è particolarmente
interessato alle politiche del partito, quanto alla visione generale che esso offre.
La quarta e la quinta categoria si riferiscono entrambe agli incentivi selettivi, rapportati agli scopi e agli
obiettivi individuali, ma con precise differenze. Infatti, mentre la quarta categoria non prevede alcun
vantaggio materiale, visto che il membro aderisce e partecipa per la soddisfazione individuale, personale,
insita nel fare politica, la quinta categoria è più centrata su vantaggi individuali come una carriera interna,
favori o l’opportunità di fare affari.
Infine, il sesto incentivo riguarda le «norme sociali»: ci si iscrive a un partito perché spinti dall’ambiente
circostante.
Il lato della domanda
Se il vantaggio diretto (una retribuzione) e quelli indiretti (onori, carriera extrapolitica, benefici materiali di
vario genere) sono il primum mobile della maggioranza degli iscritti, ciò significa che il partito recluterà
meno «credenti», cioè persone motivate da finalità ideologiche e collettive, e più «carrieristi» . Rispetto al
passato, i partiti sono frequentati da un maggior numero di persone che hanno un rapporto strumentale con il partito
stesso: esse vogliono «qualcosa» per risolvere i loro problemi individuali e materiali. La crescente presenza di
persone motivate alla carriera politica – e non dalla semplice motivazione di ricoprire «una carica come mezzo per
realizzare determinate politiche», come romanticamente sottolineava Anthony Downs – è conseguente alla logica
individualistica, orientata al mercato, dei tempi d’oggi. Sarebbe strano se soltanto i partiti politici fossero rimasti
immuni dalla predominante sensibilità culturale neoliberista. L’idea del successo individuale ha guadagnato
spazio rispetto ai fini collettivi. Dunque il partito politico è considerato, anche o soprattutto, un’opportunità
di realizzazione personale.
L’opportunità di una carriera politica era ammantata da considerazioni di carattere generale come l’impegno a
perseguire i fini collettivi del partito. Si deteneva una posizione dentro il partito o nelle assemblee elette in nome
delle finalità generali del partito.
Al contrario, quando gli interessi e le identità si frammentano e divergono, i partiti iniziano la loro discesa agli inferi.
Kirchheimer fu il primo a notare quella divisione, e il partito cartello di Katz e Mair ne cattura la configurazione attuale.
Il lato dell’offerta
I partiti offrono ciò di cui dispongono: denaro e potere. Negli ultimi decenni, a partire dagli anni Ottanta, i
partiti hanno acquisito una quantità di risorse materiali senza precedenti: hanno ricevuto sempre più denaro
dallo stato grazie ai finanziamenti pubblici, hanno tutte le redini di governo e hanno colonizzato ampi settori
degli apparati statali oltre che ambiti economici e sociali grazie a prassi clientelari e di patronage. In ogni
caso, c’è uno scollamento fra la domanda e l’offerta.
Tuttavia i partiti rimangono al centro del processo di delega e strutturazione del voto a prescindere dalla loro perdita
di attrattiva.
Più il partito punta sullo stato, meno riscuote fiducia e stima. Esso appare come un’«agenzia pubblica».
3. Le risorse finanziarie e il finanziamento pubblico
Il forte interesse per le modalità di finanziamento del partiti è emerso con lo sviluppo del partito di massa. Fino ad
allora – in tempi della Honorationenpartei – tutti i mezzi finanziari erano nelle mani di candidati e rappresentanti, che
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
gestivano autonomamente le risorse necessarie per essere eletti. In genere non avevano problemi a raccogliere
fondi, o dalle loro disponibilità private o da circuiti di notabili e di interessi costituiti. Il partito non svolgeva alcuna
funzione in tal senso.
Come osservava Kirchheimer, i partiti cominciarono a fruire di differenti fonti finanziarie in misura sempre maggiore
nell’era del partito pigliatutti.
I finanziamenti esterni possono provenire da interessi costituiti, ricchi donatori privati o associazioni di vario genere.
Tra queste ultime un ruolo particolare spetta ai sindacati.
Da una parte, i comunisti ricevevano fondi dall’Unione Sovietica sia direttamente sia indirettamente, controllando gli
scambi commerciali con il blocco sovietico attraverso imprese commerciali legate al partito. Dall’altra, alcuni partiti
moderati erano sostenuti dagli Stati Uniti: il caso della Dc italiana è il più rilevante, data l’importanza geopolitica
dell’Italia nel periodo della guerra fredda.
L’introduzione dei sussidi pubblici rappresenta un punto di svolta nelle finanze dei partiti, e nella loro stessa
vita. E le motivazioni addotte per giustificarla sono, schematicamente, di tre tipi:
a) liberare i partiti dall’influenza di interessi particolari;
b) contrastare la corruzione;
c) consolidare la democrazia.
Il finanziamento illegale ha investito l’Italia anche dopo l’approvazione della legge sul finanziamento pubblico nel
1974, e le malversazioni hanno raggiunto l’apice con lo scandalo di Tangentopoli nel 1992.
Negli ultimi decenni del XX secolo, mentre i contributi degli iscritti calavano e crescevano i costi di gestione di
un’organizzazione più complessa e articolata, e soprattutto delle campagne elettorali, i partiti si trovarono nell’urgente
necessità di aumentare i propri fondi. Si rivolsero così allo stato per cercare di compensare il deficit nei loro budget
[Hopkin 2004]. I sussidi pubblici, adottati da tutti i paesi europei (tranne la Svizzera e Malta), salvarono i partiti
da qualsiasi rischio di crisi finanziaria. In questo modo, però, i partiti divennero «dipendenti dallo stato».
Soltanto l’Italia mostra una drastica inversione dell’andamento positivo a seguito delle nuove
regolamentazioni introdotte nel 2012 e nel 2014 che prima hanno ridotto, e poi hanno abolito i finanziamenti
pubblici, fino ad allora generosissimi.
L’andamento generale suggerito da questi dati indica una quota crescente del finanziamento statale e una
contrazione delle quote e dei contributi degli iscritti. Soltanto l’arrivo della crisi economica ha bloccato l’incremento e
in certi casi ha invertito la tendenza. La maggior parte delle risorse finanziarie viene comunque tuttora dai sussidi
statali, mentre la percentuale dei contributi della membership è ovunque in calo e tende al minimo, con l’eccezione
della Germania e dell’Olanda. A parte queste eccezioni, la dipendenza dallo stato è pienamente confermata e il peso
del contributo degli iscritti è ormai limitato, se non irrilevante.
Il vero perdente di questa evoluzione è il partito sul territorio, che ha sofferto la maggior parte delle
restrizioni, nella misura in cui il finanziamento pubblico affluiva e veniva utilizzato soprattutto al centro.
L’organizzazione del partito oggi è molto più costosa che in passato perché non beneficia più del lavoro volontario
degli attivisti; un lavoro che non solo è meno disponibile ma addirittura, a volte, non viene nemmeno richiesto perché
considerato inefficace o inefficiente. L’evoluzione del partito in un’organizzazione «razional-efficiente» risale
alla fine del XX secolo e non conosce inversioni di tendenza.
Il punto è che il passaggio da un’organizzazione centrata sulle risorse umane a una centrata sulla gestione di risorse
finanziarie indebolisce la legittimazione del partito.
4. Le risorse di «patronage» e clientelismo
Patronage e clientelismo sono altri due strumenti con i quali i partiti controllano l’ambiente, drenano risorse, attirano
e ricompensano i sostenitori. Questo tipo di relazione con la società è vantaggioso per i partiti nel breve termine, ma
può evolvere in una «relazione pericolosa» a lungo andare, perché deprime anch’essa la stima nei partiti agli occhi
dell’opinione pubblica.
I partiti hanno continuato, o incrementato, le loro prassi di patronage e clientelismo. Questi due termini
identificano fenomeni differenti: il primo si riferisce alla nomina discrezionale a posizioni nella pubblica
amministrazione (sulla base della fedeltà al partito o verso un singolo politico); il secondo si riferisce alla
diretta assegnazione di risorse pubbliche in cambio di sostegno politico.
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Kopecký, Mair e Spirova sostengono che in tempi recenti i legami personali siano divenuti più rilevanti della fedeltà
al partito per ottenere posizioni politiche discrezionali, ma affermano anche che «sebbene le fedeltà personali
possano risultare più importanti delle fedeltà o identità partitiche nelle nomine, è proprio grazie al «patronage»
partitico che questi tipi di legami possono essere sviluppati come strutture fondanti del partito» .
Il passaggio verso l’utilizzo intensivo di risorse materiali, anziché simboliche, segue la logica dello spostamento dei
partiti dalla società allo stato [Kopecký, Mair e Spirova 2012, 11].
Inoltre, se il patronage ai livelli base può avere incontrato qualche resistenza, quello ai vertici è addirittura
aumentato.
Grecia → In Grecia il Movimento socialista panellenico (Pasok) introdusse il «clientelismo di massa» con una quantità
enorme di nomine negli anni Ottanta, scavalcando ogni procedura standard di reclutamento [Spourdalakis 1998;
Pappas 2009]; questo comportamento si intensificò quando Nuova democrazia (Nd) conquistò il potere a metà degli
anni Duemila [Pappas e Assimakopoulou 2012].
Inghilterra → Neppure la Gran Bretagna è rimasta immune dal patronage a causa all’estensione delle quangos –
acronimo per quasi-autonomous non-governmental organisations (organizzazioni non governative semiautonome) –
negli anni Ottanta. I governi conservatori hanno approfittato di questa possibilità [Skelcher 1998, 1-2] a tal punto che
le nomine sono state definite «decisamente partitiche» [Webb 2000, 260]
Controllando l’accesso alle risorse pubbliche direttamente attraverso nomine discrezionali nell’amministrazione
pubblica e nelle agenzie paragovernative (comprese le aziende pubbliche), o indirettamente (il che può essere
definito più propriamente come clientelismo) garantendo i vantaggi e i benefici che i clienti richiedono, poi i partiti
guidano il gioco.
Come previde Kirchheimer, i rapporti con il partito sono divenuti «occasionali e limitati nella sua portata».
La percezione nell’opinione pubblica dell’onestà dei politici e dei partiti è cambiata negativamente a causa del loro
coinvolgimento in queste prassi, indipendentemente da ogni effettivo illecito.
Inoltre, il cosiddetto «cittadino critico» irruppe nell’arena politica al di fuori e al di là dei partiti, sull’onda dei nuovi
movimenti sociali e delle organizzazioni di volontariato di vario genere. Quindi, il desiderio di partecipazione che
veniva dalla società prese altre strade. I partiti furono privati di queste energie: parafrasando Peter Mair, essi
vennero «svuotati» da questa dinamica.
Capitolo settimo — Il partito in agonia?
Il loro attacco, per quanto potesse forse richiamare la tradizionale, antica polemica antipartitica, se ne distaccava: in
precedenza, prima dell’ondata di democratizzazione e di liberalizzazione degli anni Venti del secolo scorso, i partiti
erano visti come un pericolo incombente di divisione: adesso, la reazione era contro la loro posizione al centro del
sistema.
1. Le riforme interne ai partiti
I partiti hanno riformato la loro organizzazione interna nel senso di una «maggiore inclusività e apertura». In effetti,
gli iscritti hanno aumentato il loro peso nella maggioranza dei partiti. Questo processo si è svolto in due modi:
con il coinvolgimento diretto nella selezione e nella nomina delle cariche e dei candidati, e – in misura minore
– nella definizione di alcune politiche di partito.
In realtà, l’aspetto positivo in termini di «maggiore democrazia interna» ha anche la sua controparte negativa
in termini di «minore rilevanza ed efficacia» di iscritti, militanti e quadri di medio livello.
In tale contesto le primarie di partito, nel senso di voto diretto dei membri per la scelta del personale politico,
rappresentano la novità più recente nel processo decisionale interno, a parte alcune divergenze di tempi,
forme e motivazioni, vi è una tendenza verso l’«apertura» e il coinvolgimento diretto degli iscritti.
Inghilterra → I laburisti, in particolare, fecero un passo verso una maggiore perequazione fra le loro diverse
componenti con le modifiche apportate nel 1993 per ridurre il potere – il potere di veto, soprattutto – dei sindacati
che minacciava il processo riformista. La regola dell’«un membro, un voto» (One Member, One Vote, Omov; vedi
cap. sesto) venne adottata per ciascuna delle tre componenti principali del partito (i membri delle sedi locali, i
parlamentari e le organizzazioni affiliate) per la scelta del leader, e venne garantita più voce in capitolo alle unità
locali e agli iscritti nella selezione dei candidati, anche se la parola finale rimaneva al comitato esecutivo nazionale.
Grazie alla riforma Collins che ha introdotto l’Omov+ (vedi anche cap. sesto), in base al quale gli iscritti sono affiancati
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
dai cosiddetti «iscritti registrati», depositari anch’essi del diritto di voto per il leader del partito, dietro versamento di
una quota minima di 3 sterline [Quinn 2016].
Germania → La Spd attivò anche il «dialogo fra cittadini», organizzando incontri in tutto il paese allo scopo di
sollecitare proposte dalla cittadinanza. Dei circa 40.000 suggerimenti, però, solo undici furono introdotti nel
programma elettorale del 2013 [Hornsteiner e Saalfeld 2014, 91-92].
Italia → I partiti italiani espressero un’apertura davvero limitata in confronto ai loro colleghi europei. Paradossalmente,
ma fino a un certo punto, sono i nuovi partiti emersi dallo spartiacque del 1994, come Forza Italia e la Lega Nord, a
essere i meno inclusivi. Invece i partiti di sinistra (Pd e Rifondazione comunista) hanno adottato fin dal 2005 un
metodo aperto e inclusivo (le primarie aperte) per scegliere il segretario del partito e il candidato alla carica di primo
ministro [Ignazi e Pizzimenti 2014]. L’inclusività per queste posizioni di vertice non viene adottata nella selezione dei
parlamentari. Anche se gli statuti di molti partiti attribuiscono la scelta dei candidati parlamentari alle circoscrizioni
locali, in realtà ciò non è mai successo [Bardi 2004; Bardi, Ignazi e Massari 2007].
Qual è l'effettivo significato del potenziamento del ruolo degli iscritti? In realtà, riguardo alla selezione della
leadership, Cross e Pilet tendono a ridurre l’importanza di queste innovazioni, sia in termini di numero di
casi investiti da questi cambiamenti, sia in merito alla maggiore democratizzazione.
I controeffetti del potenziamento degli iscritti
In entrambi i casi, un appello agli iscritti va considerato come una specie di arma: o per contrastare la
leadership – da parte di correnti interne – mostrandone la mancanza di consenso nel primo caso, oppure
per sollecitare una conferma plebiscitaria – da parte della stessa leadership – nel secondo.
La distanza fra membri e dirigenti, basata sulla percezione da parte dei militanti di base di una profonda
differenza nei loro rispettivi capitali politici, sociali e anche personali – come descritto nel quinto capitolo –
è stata «ridimensionata» dalla personalizzazione della politica. L’esposizione dei leader ai mass media li ha
resi più vicini ai cittadini e, a fortiori, ai membri del partito. La deferenza, la stima e il rispetto un tempo
riservati ai leader sono stati sostituiti da un sentimento di identificazione: il leader non è più distante,
inarrivabile, date le sue «qualità», ma assomiglia al cittadino-iscritto; è in risonanza con il pubblico. Il
risultato di questo nuovo rapporto risulta ambivalente: può rafforzare la posizione dei leader, profilandoli
come più vicini alla gente e quindi più attenti alle richieste dei cittadini, oppure può sminuirne l’immagine
(magari idealizzata) e quindi deprimerne l’expertise quali politici di professione, al punto da farli considerare
«superflui». Quest’ultimo sembra l’effetto oggi più diffuso.
La semplice – e forse semplicistica – idea che, per riguadagnare sostegno, sarebbe bastato attribuire diritti di voto
ai membri del partito non ha retto a una verifica empirica.
In accordo con le loro riflessioni, si sostiene qui che la delega agli iscritti rappresenti anche un espediente
intenzionale, voluto dalle dirigenze partitiche, per rafforzarsi grazie al richiamo plebiscitario. Appellarsi
direttamente ai membri (e, a fortiori, ai simpatizzanti) scavalca le strutture e le élite intermedie del partito. Di
conseguenza, queste ultime (tradizionalmente considerate la spina dorsale e la muscolatura del partito,
proprio per la loro funzione essenziale di trasmissione delle richieste dalla base) si trovano in difficoltà nel
riconquistare il loro ruolo.
In sostanza, il potenziamento dei membri comporta una perdita di potere dei livelli intermedi dell’organizzazione
partitica [Detterbeck 2012, 84; vedi anche Rahat 2009; Hazan e Rahat 2010; Ignazi e Pizzimenti 2014].
I leader traggono vantaggio dal vuoto creatosi nel partito a seguito dell’abbandono e dell’uscita di militanti e quadri:
senza più tanti vincoli e potenzialmente liberi battitori, essi usano il partito come una specie di «piattaforma», come
una «rampa di lancio» per le loro ambizioni e carriere.
L’ingenua spinta iperdemocratica verso il potenziamento dei membri e dei cittadini nel processo decisionale interno
ai partiti ha involontariamente fertilizzato il terreno per la crescita di piante ben diverse: leader e partiti che
legittimano la loro voce giocando sull’appello diretto al popolo e agli interessi «supremi» della nazione, con
una chiara visione olistica della politica.
Come scrivono Bardi, Bartolini e Treschel: «la mancanza di soddisfazione per la prestazione del partito si
riversa nell’insoddisfazione per la democrazia, nello sviluppo di una politica ancor più personalizzata e nella
nascita di nuove formazioni e nell’emergere di leader populisti e irresponsabili».
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
2. Alla ricerca della democrazia intrapartitica
In termini generali, i partiti sono «costretti» dall’ambiente esterno, in quanto democratico, a osservarne i fondamenti
democratici anche al proprio interno. In aggiunta, Susan Scarrow sostiene assai opportunamente che la
democrazia intrapartito può «contribuire alla stabilità e alla legittimità delle democrazie nelle quali i partiti
competono per il potere».
Italia → Quella italiana accennava ai partiti più di passaggio: l’articolo 49 stabilisce infatti che «Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
L’accento è sul diritto dei cittadini, più che sul ruolo dei partiti e l’espressione «metodo democratico» si riferisce alla
competizione esterna più che al funzionamento interno. Questo fu l’esito di un lungo dibattito teorico, durante la
stesura della carta costituzionale, in cui prevalsero i sostenitori del «distanziamento» dello stato dall’attività partitica:
il «complesso del tiranno» continuava a incombere [Bettinelli 1982; Gregorio 2013; Truffelli 2003]
Nell’interpretazione di van Biezen [2011], le costituzioni hanno previsto il ruolo dei partiti seguendo quattro fili
conduttori. Primo, le costituzioni definiscono i principi e i valori ai quali i partiti si devono attenere. Secondo, i partiti
sono concepiti come portatori di libertà negative e positive. Terzo, le costituzioni precisano il ruolo dei partiti
politici nel contesto democratico come strutture per la selezione di personale politico-parlamentare tramite
elezioni e per l’elaborazione di politiche pubbliche tramite i loro rappresentanti. Infine, il partito può essere
soggetto a un controllo di costituzionalità per le sue attività, nel senso che la sua stessa esistenza può essere messa
in questione allorché esso infranga le regole e i principi della costituzione. Questo potere di sanzione fino allo
scioglimento del partito costituisce un’arma a doppio taglio: utile per proteggere il sistema dall’assalto delle
forze antidemocratiche ma pericolosa per i suoi possibili abusi da parte dei governi.
Le norme introdotte assegnano ai partiti il ruolo di «agenzie semipubbliche», come scriveva Leon Epstein a proposito
dei partiti americani. La «sottomissione» dei partiti alle leggi dello stato, per quanto imposta dall’esterno per
poterli controllare, presenta un importante vantaggio: fornisce una specie di garanzia per l’esistenza dei
partiti stessi. L’intrusione della legge ha un effetto collaterale positivo.
I quattro cavalieri della democrazia interna
Perciò, il diritto di voto dei membri per scegliere leader e candidati direttamente (che qui definiamo
inclusione) non è una condizione sufficiente per la democrazia nel partito, contrariamente all’opinione diffusa: è
soltanto uno degli elementi che caratterizzano la democrazia interna.
Oltre all’inclusione, si dovrebbe tenere conto di tre elementi ancora:
a) il coinvolgimento nell’elaborazione delle politiche di partito, cioè l’attivazione di una qualche procedura
deliberativa interna;
b) la diffusione orizzontale e verticale del potere decisionale fra differenti livelli e attori intrapartito;
c) la garanzia di diritti di minoranza all’interno del partito, assicurando così il pluralismo.
Quindi inclusione, deliberazione, diffusione e pluralismo compongono la quadriglia dei cavalieri della
democrazia intrapartitica.
Deliberazione
Un elemento della quadriglia democratica riguarda il coinvolgimento degli attori e delle strutture del partito
nell’elaborazione politica, cioè l’attuazione di una dimensione deliberativa. Questa modalità decisionale aggira
qualsiasi ambito collettivo di discussione e deliberazione: essa implica l’atomizzazione dei rapporti interni. Una tale
individualizzazione del processo democratico è del tutto congruente con il paradigma culturale dominante neoliberale
in quanto garantisce l’accesso diretto e individuale al processo decisionale, ma allo stesso tempo isola i membri del
partito gli uni dagli altri.
L’accento posto sui diritti individuali degli iscritti e sul loro intervento diretto non lascia spazio alla deliberazione
[Muirhead 2006; van Biezen e Saward 2008; White e Ypi 2010]: il modello di rapporto non mediato fra leader e base,
applicato all’interno dei partiti, restringe lo spazio della discussione e impoverisce il dibattito.
Diffusione
Con questi due movimenti, l’élite centrale priva gli organi collettivi della loro funzione storica di luoghi di deliberazione
e decisione. In tal modo, la diffusione del potere e, a fortiori, l’ampliamento di arene di deliberazione sono
compromessi: e ciò impoverisce la democrazia interna [Detterbeck 2012; von dem Berge et al. 2013].
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Pluralismo
Perciò, il riconoscimento del dissenso organizzato sotto forma di correnti o fazioni interne e la garanzia di un’equa
rappresentanza negli organi di partito sono i requisiti necessari per certificare le caratteristiche democratiche di un
partito.
Dunque, all’incirca negli ultimi due decenni i partiti hanno intrapreso una serie di cambiamenti organizzativi che
possono essere così riassunti:
- la professionalizzazione della loro struttura interna con l’introduzione di – e/o lo stretto rapporto con – figure
professionali nello staff del partito e il conseguente incremento dei costi organizzativi diretti e indiretti;
- la concentrazione e la verticalizzazione del processo decisionale insieme con il depotenziamento degli organi
ai livelli locali e intermedi e dei loro componenti, nonché con il (fuorviante) empowerment dei membri del
partito;
- la personalizzazione della dirigenza;
- il rapporto non mediato fra leader e iscritti;
- la disponibilità senza precedenti di risorse finanziarie;
- lo sviluppo di posizioni clientelari e di patronage.
La retorica antipartito guadagna spazio proprio grazie alle due piaghe che infettano i partiti: lontananza e
privilegio.
3. Le alternative al partito
Referendum
Una delle espressioni di democrazia diretta più comunemente praticate è il referendum. Questo strumento va distinto
dal plebiscito.
Come molti sostengono, scavalcare i partiti politici e le istituzioni rappresentative comporta il rischio di eccessiva
semplificazione dei problemi, interpretazione diadica della realtà (sì o no) e delegittimazione delle istituzioni
rappresentative [Urbinati e Warren 2008]. Tuttavia, a fianco di questi inconvenienti sistemici, vanno considerati anche
alcuni effetti positivi: mobilitazione della cittadinanza, chiarezza e univocità delle scelte, possibilità di espressione per
gruppi non istituzionali [LeDuc 2015; Morel 2012].
I partiti tradizionali non vedono con favore le iniziative di democrazia diretta perché il risultato delle
consultazioni popolari talvolta contraddice in modo eclatante la linea del partito.
Revoca
Un altro modo per scavalcare i partiti politici consiste nel «rimuovere» i rappresentanti tramite la loro revoca. Questa
procedura è antica quanto le prime assemblee rappresentative, ma non ha mai trovato ampia applicazione. È a livello
locale che la revoca ottiene i maggiori successi. Infatti, i tre quarti dei recalls riguardano i rappresentanti delle
assemblee municipali o di contea o i membri dei consigli scolastici (eletti nelle liste di partito)[4]. «Tutto il potere al
popolo» può rivelarsi un’arma impropria a discapito del funzionamento delle istituzioni.
Giurie cittadine
La giuria civica, che ha qualche affinità con l’idea delle giurie popolari nei tribunali [Gastil 2010][5], rappresenta una
modalità peculiare di intervento diretto di un piccolo gruppo di cittadini. La giuria civica può funzionare ex ante, tramite
suggerimenti e proposte politiche, oppure ex post, attraverso il monitoraggio dell’attività dei funzionari eletti.
Il merito di questa forma di partecipazione, secondo Beetham [2012, 59], è che «offre una forma più pura di
rappresentanza e deliberazione, non
Democrazia deliberativa
La deliberazione «è la procedura con la quale gli individui valutano apertamente il merito degli argomenti in
discussione» [Fishkin 2009, 33]. Questo metodo di interazione si può esercitare in vari modi, ma sono tutti
accomunati da una stessa caratteristica: coinvolgere un campione di popolazione (una sorta di «minipopolo», come
lo definì Robert Dahl), in una discussione informata, con l’obiettivo di pervenire a una decisione ampiamente
condivisa. Questo microcosmo di una comunità più vasta, locale o nazionale, dopo essere stato informato da esperti
esterni e indipendenti, deve arrivare a una decisione su una specifica questione.
È stata anche suggerita la possibilità di una proficua integrazione dei meccanismi deliberativi dentro i partiti politici o
insieme a essi, affiancandone l’attività [Newton 2012].
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
lOMoARcPSD|3193521
Per concludere si potrebbe sostenere che, più che una vera e propria alternativa ai partiti, tutti gli strumenti
di democrazia diretta forniscono, in linea di principio, una compensazione del loro deficit di
rappresentatività. Nelle parole di Urbinati – che riecheggiano quelle di Rosanvallon – la diffusione della
democrazia diretta rispecchia il desiderio di controllare e monitorare istituzioni e leader; cioè, di esprimere
un potere negativo che rivendichi un esame e un giudizio diretto più che un potere decisionale positivo. [La
democrazia diretta] implica una verifica censoria da parte dei cittadini, l’aspirazione dei quali è la partecipazione
oculare, quindi la sorveglianza, più che l’autogoverno [2015, 478].
Così, tanto l’idea di una «democrazia oculare» [Green 2009], che controlli e sorvegli i rappresentanti come un
onnipresente Panopticon, quanto la «fede» che per qualsiasi problema la migliore soluzione non possa che emergere
da una deliberazione asettica, trovano i loro limiti nella carenza di responsabilità e accountability – e di «passione».
La politica partitica è intrinsecamente connessa a convinzioni differenti, conflittuali e appassionate.
Conclusioni
Le strategie adottate per compensare la demotivazione insistono sull’individualizzazione del processo decisionale, e
questo non fa che favorire la dei cittadini.
Inoltre, il partito è l’unico attore che esercita, monopolisticamente, la funzione di «strutturazione» del voto.
In realtà, uno scarso afflusso alle urne non equivale a un diffuso sentimento antipartitico. Le ragioni dell’astensione
sono molteplici e, al di là di alcune sacche di alienazione politica, riflettono un atteggiamento pragmatico verso la
politica: si va alle urne se si è motivati.
Anche se sono coinvolti nella campagna referendaria, essi non appaiono sulla scheda: rimangono nel backstage. In
questo senso il referendum costituisce un’alternativa alla politica partitica.
Oltre a queste considerazioni, la ragione principale dell’attuale predominio dei partiti risiede nella loro posizione
pivotale all’interno dello stato. Oggi i partiti sono «statocentrici».
In effetti, il mood sostanzialmente antipolitico inerente alla trionfante cultura politica neoliberale ha favorito il distacco
dalle tradizionali appartenenze politiche (dealignment) e la strisciante alienazione dalla politica di una parte della
cittadinanza.
Una volta erano i mediatori fra società e stato, come sostengono Katz e Mair nel loro fondamentale contributo sul
partito cartello.
I partiti tengono ancora le redini del potere grazie alla presa monopolistica su due aspetti cruciali: dal lato dell’input
la strutturazione del voto e dal lato dell’output la distribuzione/allocazione delle risorse pubbliche.
In questo senso ogni singolo partito – e, a fortiori, il cartello di partiti – assomiglia a un Leviatano malfermo: svuotato
al suo interno e drammaticamente carente di quella intangibile ma fondamentale caratteristica che è la legittimità. Il
venir meno della legittimazione dei partiti influisce inevitabilmente sulle istituzioni democratiche: «se fallisce il partito,
fallisce anche la democrazia». I partiti rimangono un «male necessario».
Scaricato da Mary Biondi (mari.biondi@outlook.it)
Potrebbero piacerti anche
- Cittadini senza politica. Politica senza cittadiniDa EverandCittadini senza politica. Politica senza cittadiniNessuna valutazione finora
- Riassunto - La Democrazia Degli Antichi e Dei Moderni - FinleyDocumento8 pagineRiassunto - La Democrazia Degli Antichi e Dei Moderni - FinleyMarco Colombo100% (1)
- Essere-con: filosofia delle forme relazionali. Scritti scelti 1999-2012Da EverandEssere-con: filosofia delle forme relazionali. Scritti scelti 1999-2012Nessuna valutazione finora
- 1 Capire La PoliticaDocumento13 pagine1 Capire La PoliticaMati BadoniNessuna valutazione finora
- Linee guida per l'attuazione dei diritti umaniDa EverandLinee guida per l'attuazione dei diritti umaniNessuna valutazione finora
- RIDOLA L'evoluzione Storico-Costituzionale Del Partito PoliticoDocumento19 pagineRIDOLA L'evoluzione Storico-Costituzionale Del Partito PoliticoruumrumNessuna valutazione finora
- Nondemocrazia. Il sistema in cui viviamo dipende solo da noiDa EverandNondemocrazia. Il sistema in cui viviamo dipende solo da noiNessuna valutazione finora
- Democrazia Diretta Bibliografia RagionataDocumento4 pagineDemocrazia Diretta Bibliografia RagionataDaniCarpiNessuna valutazione finora
- Costituzione, Stato e crisi - Eresie di libertà per un Paese di sudditiDa EverandCostituzione, Stato e crisi - Eresie di libertà per un Paese di sudditiNessuna valutazione finora
- Le Democrazie Antiche A Confronto (Storia Scuola)Documento107 pagineLe Democrazie Antiche A Confronto (Storia Scuola)Paolo ScelfoNessuna valutazione finora
- La Battaglia per la Costituente: Il contributo dei socialisti nell'elaborazione della Carta CostituzionaleDa EverandLa Battaglia per la Costituente: Il contributo dei socialisti nell'elaborazione della Carta CostituzionaleNessuna valutazione finora
- Contro Golia: Manifesto per la sovranità democraticaDa EverandContro Golia: Manifesto per la sovranità democraticaNessuna valutazione finora
- Il Pensiero Politico in PraticaDocumento26 pagineIl Pensiero Politico in PraticaAlessandro Murray BusnelliNessuna valutazione finora
- Democrazie Mafiose, Partitocrazia Mitologie Alcuni TestiDocumento7 pagineDemocrazie Mafiose, Partitocrazia Mitologie Alcuni TestiVerità e DemocraziaNessuna valutazione finora
- Franco Mercurio - Classi Dirigenti o Ceti Dominanti?Documento304 pagineFranco Mercurio - Classi Dirigenti o Ceti Dominanti?ElenoireshNessuna valutazione finora
- Storia Politica ContemporaneaDocumento17 pagineStoria Politica ContemporaneaSam StiflerNessuna valutazione finora
- Manuale Scienza Politica Capano PDFDocumento129 pagineManuale Scienza Politica Capano PDFZenaida Garay ReynaNessuna valutazione finora
- Edoardo Greblo Il Paradosso Del DemosDocumento15 pagineEdoardo Greblo Il Paradosso Del Demosvitofilos3Nessuna valutazione finora
- Mancini - Manuale Di Comunicazione PubblicaDocumento23 pagineMancini - Manuale Di Comunicazione PubblicaLarnè Marco100% (1)
- Marco Almagisti - Lessico Della Politica: Rappresentanza e PartecipazioneDocumento30 pagineMarco Almagisti - Lessico Della Politica: Rappresentanza e PartecipazioneGianmarco AltieriNessuna valutazione finora
- Teoria Delle Dottrine PoliticheDocumento46 pagineTeoria Delle Dottrine PoliticheTore ForteNessuna valutazione finora
- 1 Democrazia Rappresentativa e Parlamentarismo (Prof Ridola)Documento26 pagine1 Democrazia Rappresentativa e Parlamentarismo (Prof Ridola)Leonardo LombardiNessuna valutazione finora
- Diego Fusaro - La Filosofia Politica Di Giovanni GentileDocumento2 pagineDiego Fusaro - La Filosofia Politica Di Giovanni GentileTrifulmineNessuna valutazione finora
- Contributo Paolo CacciariDocumento17 pagineContributo Paolo CacciariMatteo BortolonNessuna valutazione finora
- Lucarelli PopulismoDocumento11 pagineLucarelli PopulismoSalvatore CascellaNessuna valutazione finora
- Per Il Partito Unitario Di Liberazione NazionaleDa EverandPer Il Partito Unitario Di Liberazione NazionaleNessuna valutazione finora
- Politica ContemporaneaDocumento27 paginePolitica Contemporaneamatydirectioner01Nessuna valutazione finora
- Il pensiero federalista nella storia del Sardismo: Enciclopedia del SardismoDa EverandIl pensiero federalista nella storia del Sardismo: Enciclopedia del SardismoNessuna valutazione finora
- Democraziaprocedura LagiDocumento40 pagineDemocraziaprocedura Lagilucacvl89Nessuna valutazione finora
- Platone TotalitarioDocumento3 paginePlatone TotalitariogingardelloNessuna valutazione finora
- Il Concetto Di Totalitarismo in Simone Weil e Hannah ArendtDocumento106 pagineIl Concetto Di Totalitarismo in Simone Weil e Hannah ArendtDeniseNessuna valutazione finora
- Stefano Rodotà Da "Democrazia Senza Partiti" Di OlivettiDocumento8 pagineStefano Rodotà Da "Democrazia Senza Partiti" Di OlivettiEdizioni di ComunitàNessuna valutazione finora
- Cedroni - Pari Opportunità e Rappresentanza PoliticaDocumento4 pagineCedroni - Pari Opportunità e Rappresentanza PoliticaAnonymous 28AYvphsTfNessuna valutazione finora
- Tesina Di Antropologia (CPT 8)Documento8 pagineTesina Di Antropologia (CPT 8)Luca SebastianelliNessuna valutazione finora
- Riassunto - Storia Delle Dottrine Politiche PDFDocumento157 pagineRiassunto - Storia Delle Dottrine Politiche PDFAlberto AmorusoNessuna valutazione finora
- Totalitarismo - Lezione 8Documento5 pagineTotalitarismo - Lezione 8Ivan GalliNessuna valutazione finora
- Democrazia o δημοκρατίαDocumento21 pagineDemocrazia o δημοκρατίαFRANCESCO BARONENessuna valutazione finora
- La ricerca della libertà: Libertà, democrazia e totalitarismo nell’epoca della Quarta rivoluzione industrialeDa EverandLa ricerca della libertà: Libertà, democrazia e totalitarismo nell’epoca della Quarta rivoluzione industrialeNessuna valutazione finora
- Oltre Pareto e le sue regole. Riflessioni sulla vera essenza del potere sociale e individuale.Da EverandOltre Pareto e le sue regole. Riflessioni sulla vera essenza del potere sociale e individuale.Nessuna valutazione finora
- Barbari PDFDocumento34 pagineBarbari PDFPablo TorreNessuna valutazione finora
- 4 Circuiti Della Politica ContemporaneaDocumento15 pagine4 Circuiti Della Politica ContemporaneaMati BadoniNessuna valutazione finora
- Democrazia e DemocratizzazioniDocumento181 pagineDemocrazia e DemocratizzazioniLorenzoNessuna valutazione finora
- Riassunto - Introduzione Alla Scienza Politica - Della PortaDocumento31 pagineRiassunto - Introduzione Alla Scienza Politica - Della Portaclaudiaronzoni85Nessuna valutazione finora
- DemocraziaDocumento14 pagineDemocraziaSabrina Amatulli100% (1)
- Populismi e Rappresentanza Democratica Alberto Lucarelli 2020Documento6 paginePopulismi e Rappresentanza Democratica Alberto Lucarelli 2020Giovanni Francesco PalmaNessuna valutazione finora
- Il LiberalismoDocumento3 pagineIl LiberalismoNANCYNessuna valutazione finora
- Tesina FrancescaDocumento11 pagineTesina FrancescaMary BiondiNessuna valutazione finora
- Eros in Platone e Le Sue Straordinarie Sfaccettature Nel SimposioDocumento54 pagineEros in Platone e Le Sue Straordinarie Sfaccettature Nel SimposioMary BiondiNessuna valutazione finora
- Corso SociolinguisticaDocumento178 pagineCorso SociolinguisticaMary BiondiNessuna valutazione finora
- Th. Mann, La Montagna MagicaDocumento7 pagineTh. Mann, La Montagna MagicaMary BiondiNessuna valutazione finora
- Pavese ProustDocumento10 paginePavese ProustMary BiondiNessuna valutazione finora
- M. Proust, Dalla Parte Di SwannDocumento15 pagineM. Proust, Dalla Parte Di SwannMary BiondiNessuna valutazione finora