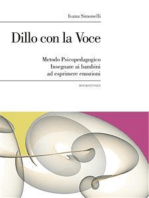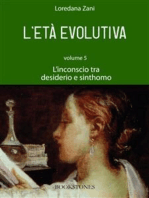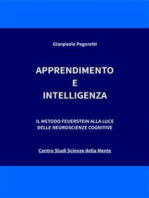Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Libro La Mentalizzazione Nel Ciclo Di Vita Interventi Con Bambini Genitorie Insegnanti
Caricato da
Elisa BerbigliaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunto Libro La Mentalizzazione Nel Ciclo Di Vita Interventi Con Bambini Genitorie Insegnanti
Caricato da
Elisa BerbigliaCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|2610606
Riassunto - libro "La mentalizzazione nel ciclo di vita.
Interventi con bambini, genitorie insegnanti"
Psicologia dello sviluppo (Università Cattolica del Sacro Cuore)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
LA MENTALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA
Introduzione
Mentalizzazione: concetto relativamente nuovo, ma in realtà estremamente vecchio; è una forma di
attività mentale immaginativa, cioè la percezione e l’interpretazione del comportamento umano in
termini di stati mentali intenzionali. E’ importante per la comprensione dello sviluppo psicologico e
per interventi di sostegno allo sviluppo. Radicata nel campo della ricerca sullo sviluppo, traendo
origini dalla psicoanalisi e dalla teoria dell’attaccamento, ha fornito idee sullo sviluppo del sé e
sull’abilità di entrare in relazione con gli altri, sul problema dell’attaccamento e il trauma che
influenzano le capacità di pensare alla propria mente.
Teoria della mente: paradigma della psicologia dello sviluppo. Non è da intendersi come la teoria
della mente di Piaget o dei comportamentisti, ma è la capacità che i bambini sviluppano di costruire
una teoria della mente propria e altrui, la psicologia ingenua (capacità dell’uomo di essere uno
psicologo ingenuo). La teoria della mente è quindi la capacità di attribuire a se e agli altri stati
mentali e di spiegare, prevedere, in base ad essi, il comportamento proprio e altrui. Ci
facciamo una teoria della mente per spiegare un comportamento (o prevederlo) per sapere cosa
aspettarsi dalle persone, se prevedo mi adatto in anticipo. Vale soprattutto per se stessi (es: forte
emozione, come gestirla), darsi una spiegazione e autoprevedere il comportamento.
Definizione delle parole: a) spiegare è diverso da comprendere=esplicare un pensiero è diverso
da interpretarlo; b) chiamarla teoria si avvicina alle scienze della natura, allora la chiamano
“mentalizzazione”, l’attività che ci permette di avere una funzione riflessiva sui nostri stati mentali
e altrui. Bruner preferisce definirla “comprensione soggettiva” perché gli stati mentali sono
soggettivi e il mio pensiero non è sempre oggettivamente vero. La comprensione della soggettività
ha implicazioni sull’egocentrismo, quello che è vero per uno può non essere vero per un altro dal
punto di vista dei vissuti (il mondo non è visto da tutti come lo vedo io). Questo ci fa capire che ci
sono teorie diverse sulla capacità di comprendere la mente degli altri e la propria ai fini esplicativo-
interpretativo-previsionale del comportamento.
Cos’è la mentalizzazione?
Quando mentalizziamo siamo impegnati in una forma di attività mentale immaginativa, che ci
consente di cogliere e interpretare il comportamento umano in termini di stati mentali, come
bisogni, desideri, emozioni, credente, obiettivi, intenzioni e motivazioni. La capacità di inferire e
rappresentarsi gli stati mentali altrui potrebbe essere unicamente umana.
Origini del concetto
Abbiamo sviluppato il nostro concetto di mentalizzazione all’interno di un vasto contesto di studi
empirici, in cui la sicurezza dell’attaccamento infantile con ciascun genitore risultava essere
fortemente predetta non solo dalla sicurezza dell’attaccamento dei genitori durante la gravidanza
(Fonagy, portatore della psicoanalisi e della teoria della mente), ma anche la capacità dei genitori di
pensare e capire, in termini di stati mentali, la loro relazione infantile con i propri genitori. Abbiamo
ipotizzato che ci fosse una sinergia vitale tra i processi di attaccamento e lo sviluppo delle abilità
del bambino di comprendere il comportamento interpersonale in termini mentalistici. Oltre con la
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
ricerca empirica, l’ispirazione per lo sviluppo del concetto di mentalizzazione è stata originata dal
lavoro psicoanalitico. Lo sviluppo ottimale della capacità di mentalizzare dipenda dall’interazione
con menti mature e sensibili.
La mentalizzazione coinvolge una componente autoriflessiva e interpersonale, è basata
sull’osservazione degli altri e sulla riflessione sui loro stati mentali; riguarda sia i sentimenti sia le
cognizioni. I sistemi neuronali alla base di queste componenti permettono al bambino di
rappresentarsi gli stati mentali causali, di distinguere la realtà interna da quella esterna, di inferire
gli stati mentali altrui a partire da sottili indizi comportamentali e contestuali.
Attaccamento e mentalizzazione
John Bowly, padre della teoria dell’attaccamento, aveva proposto che la funzione evolutiva di base
dell’istinto di attaccamento fosse quella di garantire che i bambini venissero protetti dai predatori. I
comportamenti di attaccamento del piccolo sono contraccambiati dai comportamenti di
attaccamento degli adulti che rinforzano il comportamento di attaccamento del bambino verso quel
particolare adulto. I comportamenti di attaccamento del bambino vengono attivati quando qualcosa
nel suo ambiente lo fa sentire insicuro. L’obiettivo del sistema di attaccamento è sperimentare
un’esperienza di sicurezza. L’attaccamento è il principale regolatore di esperienze emotive.
Nessuno nasce con la capacità di regolare le emozioni, quindi quando inizia a esserne sopraffatto
cercherà il caregiver nella speranza di essere consolato. Verso la fine del primo anno il
comportamento del bambino sembra essere basato su specifiche aspettative. Le sue esperienze
passate con le figure di attaccamento vengono aggregate nei sistemi rappresentazionali, che Bowlby
chiama modelli operativi interni (MOI).
Bowlby ipotizzò che i MOI si sé e degli altri fossero i prototipo per tutte le relazioni successive. I
meccanismi che fanno si che madri e padri con attaccamento sicuro sviluppino relazioni di
attaccamento sicuro con i figli sono difficili da identificare. L’attaccamento insicuro infantile e
disorganizzato è un fattore di rischio per lo sviluppo emotivo e sociale. Il maggior vantaggio
evolutivo dell’attaccamento nell’uomo è l’opportunità che viene data al bambino di sviluppare
l’intelligenza sociale.
Comprendere la relazione di attaccamento e la mentalizzazione
La genitorialità è la chiave di un attaccamento sicuro. La capacità della madre di pensare alla
mente del proprio figlio è chiamata in vari modi: mind-mindedness, capacità di insight e
funzione riflessiva. I genitori che mentalizzano potrebbero facilitare lo sviluppo della
mentalizzazione nei loro figli. La genitorialità mindful sviluppa sia l’attaccamento sicuro sua la
mentalizzazione.
L’esposizione a normali conversazioni familiari sembra essere un requisito indispensabile per la
mentalizzazione. La strada per comprendere le menti può essere costruita dalle conversazioni
nelle quali adulti e bambini parlano delle intenzioni implicite nei reciproci commenti e le
collegano alle reciproche azioni interpretate. Il lavoro di Mary Main aiuta a sviluppare schemi
esplicativi con i quali il comportamento di altre persone può essere compreso e predetto.
La giocosità è un’altra caratteristica dell’attaccamento sicuro e per la mentalizzazione, la
mancanza è evidente nei casi estremi. I bambini non vedenti hanno un gioco di finzione limitato
e lo capiscono poco; hanno un ritardo nelle prove di falsa credenza che superano solo
raggiungendo un’età verbale di undici anni, a differenza dei tipici cinque anni. Essi sono
depravati degli indizi su tali stati (es: le espressioni facciali, possono avere problemi di identità).
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
Il maltrattamento disorganizza il sistema di attaccamento. L’evidenza del ritardo
significativo nello sviluppo della comprensione delle emozioni nei bambini maltrattati è
consistente. Sono stati evidenziati nei bambini maltrattati anche deficit nella cognizione sociale
e un ritardo nella comprensione della ToM (theory of mind). Il maltrattamento può contribuire a
una parziale cecità mentale. Questo è più distruttivo se i maltrattamenti sono perpetrati da un
membro familiare, ma anche quando i genitori non si rendono conto che il bambino viene
maltrattato all’esterni, può invalidare le comunicazioni sui sentimenti. Da luogo a fenomeni
come la disorganizzazione dell’attaccamento, come l’atteggiamento manipolatorio nell’età
scolare. La manipolazione si verifica perché i bambini preferiscono esternalizzare una parte di
sé, inducendo il genitore a sperimentare gli stati mentali di rabbia o ansia che hanno
interiorizzato, ma che vivono come alieni. Si può percepire come unica soluzione
l’autolesionismo, spostare l’attacco interno della mente e del corpo all’esterno. Le esperienze
negative possono facilitare lo sviluppo della mentalizzazione tanto quanto quelle positive
connesse all’attaccamento sicuro.
Lo sviluppo del sé agente: l’acquisizione della cognizione sociale
A circa tre/quattro mesi la preferenza del bambino sembra cambiare. In questa fase il piccolo inizia
ad essere attratto da contingenze elevate ma imperfette, piuttosto che da quelle perfette.
L’esperienza ripetuta di queste risposte consente al neonato di cominciare a differenziare i suoi stati
mentali interni: questo processo è nominato biofeedback sociale. Una relazione appropriata e di
attaccamento sicuro contribuisce in maniera fondamentale alla nascita di precoci abilità di
mentalizzazione che permettono al bambino di scoprire o trovare il proprio sé psicologico nel
mondo sociale.
La capacità di comprendere e regolare le emozioni sviluppa due condizioni:
a) Una plausibile congruenza di rispecchiamento, per cui il genitore rispecchia lo stato mentale
del bambino
b) La marcatura del rispecchiamento, per mezzo del quale il caregiver è in grado di esprimere
un affetto, indicando contemporaneamente che non sta esprimendo il suo personale affetto
Se il rispecchiamento del caregiver è incongruente, la conseguenza rappresentazionale dello stato
interno del bambino non corrisponderà a uno stato costitutivo del sé e ciò potrebbe predisporre il
bambino a sviluppare una struttura di personalità narcisista.
Regolazione affettiva, controllo attentivo e mentalizzazione
Si ritiene che il bambino interiorizzi la propria esperienza di affetti ben regolati, costruendo le basi
di un legame di attaccamento sicuro e di un modello operativo interno. La regolazione affettiva è un
preludio alla mentalizzazione; una volta che compare la mentalizzazione, la natura della regolazione
affettiva si trasforma ulteriormente. Non solo la mentalizzazione consente la regolazione degli stati
affettivi, ma è usata per regolare il sé.
1. Durante la seconda metà del primo anno di vita, il bambino inizia a diventare capace di cogliere
le relazioni causali tra le azioni, i loro agenti e l’ambiente. A circa nove mesi, i bambini
cominciano a osservare le azioni nei termini di intenzioni sottostanti e a comprendere se stessi
come agenti teleologici, che possono scegliere tra diverse alternative il modo più efficiente per
raggiungere un obiettivo.
2. Durante il secondo anno, i bambini cominciano a capire che loro stessi e gli altri sono agenti
intenzionali, le cui azioni sono causate da stati mentali sottostanti, come i desideri e che le loro
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
azioni possono portare a cambiamenti sia nelle menti sia nei corpi. I bambini cominciano ad
acquisire un linguaggio sugli stati interni e la capacità di ragionare in maniera non egocentrica
sui sentimenti e desideri degli altri. Il bambino non è ancora in grado di rappresentarsi gli
stati mentali in modo indipendente dalla realtà fisica e non è stata ancora pienamente
raggiunta la distinzione tra interno ed esterno, apparenza e realtà.
3. Intorno ai tre-quattro anni il bambino comincia a cogliere che le azioni delle persone sono
causate dalle loro credenze. Verso i quattro anni le abilità di mentalizzazione compiano un salto
di qualità. Da questo momento il bambino può comprendere se stesso e gli altri come agenti
rappresentazionali. Egli sa che le persone non sempre provano ciò che in apparenza sembrano
provare e che le loro reazioni emotive a un evento sono influenzate dallo stato d’animo del
momento oppure da pregrese esperienze emotive vissute in eventi simili. La comprensione
delle emozioni è associata a un comportamento empatico e a relazioni più positive tra pari.
La nuova abilità del bambino di attribuire credenze errate a se stesso e agli altri arricchisce il
suo repertorio di interazione sociale: ora può fare trucchi, scherzi e inganni. Questo
cambiamento porta a termine il periodo in cui la mentalizzazione è stata acquisita attraverso la
mediazione di una mente adulta e apre a una fase di ricerca di miglioramento delle capacità di
comprendere se stessi e gli altri in termini di stati mentali attraverso legami con le persone che
condividono i propri interessi e inclinazioni.
4. Durante il sesto anno di vita vediamo ulteriori progressi, come la capacità del bambino di
mettere in relazione ricordi delle sue attività ed esperienze intenzionali all’interno di
un’organizzazione causale-temporale coerente che conduce alla costruzione del sé esteso nel
tempo. Quando queste abilità vengono acquisite, la necessità di utilizzare la violenza fisica
comincia a diminuire e aumenta l’aggressività relazionale.
La soggettività prima della mentalizzazione
Il bambino piccolo presuppone che quello che lui conosce sia conosciuto anche dagli altri e
viceversa. Il senso di unicità della propria prospettiva si sviluppa lentamente. I piccoli a circa tre
mesi, possiedono già un chiaro senso della loro integrità fisica, ma partiamo dal presupposto
che la conoscenza sia comune e che i nostri pensieri o sentimenti siano condivisi con gli altri. I
bambini ritengono che gli altri bambini conosceranno cose che essi stessi hanno appena imparato.
Una ragione per cui i bambini sono così inclini a esposizioni di rabbia e di frustrazione potrebbe
essere perché si aspettano che gli altri sappiano che cosa stanno pensando e provando.
La mentalizzazione nelle famiglie
Se da un lato si è sostenuto che la relazione precoce del bambino con i suoi caregiver è la culla della
mentalizzazione, dall’altro lato si è visto che non esiste un contesto che può portare a una perdita di
questa capacità tanto potente quanto quello delle interazioni familiari. È nella famiglia che i
rapporti tendono a essere più carichi e intensivi a livello emotivo: la famiglia è un contesto che
ha la potenzialità quotidiana di stimolare una perdita di mentalizzazione in uno o più membri della
famiglia. A volte possono verificarsi problemi specifici nella mentalizzazione.
Per esempio, in una separazione conflittuale tra genitori, uno dei due, di solito molto sensibile agli
stati emotivi del figlio, può avere grosse difficoltà a sintonizzarsi con i sentimenti e i pensieri del
bambino relativi alla perdita della coppia genitoriale, forse a causa del sentimento di odio che prova
nei confronti dell’altro genitore. Di conseguenza il genitore non è in grado di mentalizzare
quell’aspetto della vita di suo figlio. Oppure un genitore che è stato vittima di maltrattamenti fisici o
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
di abusi sessuali, di fronte al ricordo dei propri stati di impotenza, di rabbia o vergogna può perdere
temporaneamente la capacità di mentalizzare.
Una modalità non mentalizzante viene portata all’interno della famiglia da un genitore che può
essere temporaneamente assorto in importanti questioni concrete di vita (es: crisi lavorativa). Altro
problema familiare per la mentalizzazione può essere quando il bambino non rende inaccessibile il
proprio stato mentale. Possiamo individuare alcune condizioni che aumentano la frequenza di
interazioni familiari non mentalizzanti. Problemi di salute mentale di lunga data possono
compromettere la mentalizzazione nelle famiglie in vari modi. Quando un genitore soffre di
depressione maggiore, il bambino potrebbe adottare un comportamento iperattivo per stimolare il
genitore, non tanto per un’attitudine alla mentalizzazione, quando per creare, attraverso
comportamenti oppositivi, una connessione con lui, anche se solo per via disciplinare e di altre
azioni non mentalizzanti.
Un’altra prospettiva sistemica sul fallimento della mentalizzazione è l’esperienza dell’individuo di
fronte a menti non responsive. Quando siamo di fronte a familiari che non sanno rispondere alle
richieste di una mente indagatrice e curiosa, la persona si arrenderà, rafforzando così la disperazione
di tutte le persone coinvolte, con una conseguente mancanza di speranza ciclica. All’interno del
contesto familiare, la mentalizzazione genera ulteriore mentalizzazione, mentre la non
mentalizzazione può portare a un’ulteriore non mentalizzazione.
Un altro uso improprio della mentalizzazione è la coercizione dei pensieri del bambino. Il genitore
mina la capacità del bambino di pensare, umiliandolo nei suoi pensieri e sentimenti. Tali fenomeni
sono più nocivi in un contesto di abuso. L’abuso può indebolire la capacità del bambino di
mentalizzare.
Conclusione
La mentalizzazione potrebbe essere vista come uno dei diversi fattori che accomunano le
psicoterapie. Tutte le psicoterapie, qualunque sia il loro focus, condividono il potenziale di ricreare
una matrice relazionale di attaccamento, in cui la mentalizzazione può svilupparsi e fiorire. La
mentalizzazione è un costrutto evolutivo. Tutto ciò apre la possibilità di attuare un lavoro di
prevenzione durante l’infanzia. Siccome la mentalizzazione è un processo psicologico fondamentale
e ha a che fare con tutti i principali disturbi mentali, gli approcci centrati sulla mentalizzazione
possono avere il potenziale di migliorare il benessere delle persone che soffrono di diversi disturbi.
I problemi di mentalizzazione nei bambini e negli
adolescenti
Una tassonomia dei fallimenti nella mentalizzazione nei bambini e negli adolescenti
Possiamo dire che la mentalizzazione distorta si riferisce a un’interpretazione errata o a una lettura
distorta della mente. La pseudomentalizzazione riguarda quella lettura della mente che
assomiglia alla mentalizzazione, ma manca di alcune delle caratteristiche essenziali della vera e
propria mentalizzazione. Passeremo in rassegna i problemi di mentalizzazione nei bambini e negli
adolescenti.
L’assenza di mentalizzazione
Il termine mentalizzazione è spesso usato in modo intercambiabile con il concetto di teoria della
mente. L’ambito di studio della ToM è uno di quelli che in psicologia, negli ultimi trent’anni, hanno
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
visto la più rapida crescita di ricerche empiriche ed è al suo interno che è stata studiata l’ipotesi di
un’assenza di mentalizzazione sottostante ai disturbi dello spettro autistico. Gli autori hanno
concluso che i bambini autistici potrebbero non avere la capacità di costruire teorie sui
contenuti (credenze o false credenze) della mente altrui, un deficit che è stato definito, con il
termine cecità mentale.
L’ipomentalizzazione: non abbastanza di una buona cosa
I bambini autistici presentano una generale mancanza di interesse sociale, ridotti livelli di impegno
sociale e di scambi socio comunicativi, scarsi contatti oculari e ridotta attenzione visiva verso gli
stimoli sociali. Bambini di due anni affetti da autismo presentano ridotte capacità di imitazione,
gioco di finzione e rappresentazione simbolica di un oggetto condiviso. I bambini autistici
presentano meno spontaneamente il gioco di finzione, hanno difficoltà nella comprensione degli
stati mentali complessi, nel seguire la direzione dello sguardo, hanno una ridotta comprensione
dell’inganno e tendono a confondere ricordi delle proprie azoni. I bambini e gli adolescenti autistici
hanno una ridotta capacità di mentalizzare in tutte le fasi dello sviluppo.
Mentalizzare o non mentalizzare: l’iper e l’ipomentalizzazione nella schizofrenia
Il cluster dei sintomi negativi della schizofrenia a esordio precoce in adolescenza sembra presentare
una riduzione della mentalizzazione, simile a quella osservata nell’autismo. Anche nella
schizofrenia si è osservata una difficoltà nelle prove di riconoscimento delle espressioni a partire
dagli occhi e dal volto. Questi fallimenti nella mentalizzazione sembrano essere l’esito di inferenze
inesatte di stati mentali, associate a sintomi positivi della schizofrenia, piuttosto che di uno scarso
sviluppo o un’assenza di attribuzioni di stati mentali, tipici invece dell’altruismo.
Langdon ha spiegato l’ipermentalizzazione come originata dall’incapacità di assumere diverse
prospettive. Gli individui affetti da schizofrenia hanno difficoltà a leggere òa ,emte
(ipomentalizzazione) e di conseguenza proiettano i propri sospetto paranoici e pregiudizi sugli altri
(ipermentalizzazione).
L’ipermentalizzazione: troppo di una buona cosa
Né l’ipomentalizzazione né la sua completa assenza sono legate ai tratti borderline. Invece è
l’ipermentalizzazione (eccessiva interpretazione degli stati mentali) a essere fortemente associata
con le caratteristiche borderline negli adolescenti. I risultati confermano le evidenze cliniche e
teoriche relative al fatto che la mentalizzazione disfunzionale nelle persone con DBP è
maggiormente caratterizzata dall’utilizzo di strategie alternative inusuali (ipermentalizzazione) che
non dalla perdita di questa capacità (ipomentalizzazione o assenza di mentalizzazione).
Al contrario degli schizofrenici è improbabile che l’ipermentalizzazione derivi da
un’incapacità di riconoscere gli statu mentali in sé e negli altri. L’ipermentalizzazione nelle
persone con DBP non è il risultato della cecità mentale, questi individui tendono a scontrarsi con
l’integrazione e la differenziazione degli stati mentali, specialmente quando sono in condizioni di
elevata attività emotiva. L’aumento della risposta allo stress a sua volta influenza la capacità di
mentalizzazione. Uno studio ha dimostrato che le donne reagiscono allo stress con alti livelli di
cortisolo commettono più errori di mentalizzazione, dopo l’induzione di stress, evidenziando in tal
modo che la risposta allo stress modula la mentalizzazione
Una teoria della mente cattiva: la mentalizzazione distorta nei disturbi esternalizzanti
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
Un recente studio epidemiologico ha individuato una presenza nei più giovani del 19% di problemi
comportamentali esternalizzanti. Una delle caratteristiche distintive dei problemi esternalizzanti
sono le difficoltà interpersonali. I bambini con questi comportamenti tendono ad avere scarsi
rapporti con i coetanei e con i genitori. I bambini con problemi di condotta tendono ad avere deficit
in tutti gli aspetti dell’elaborazione delle informazioni sociali. È interessante la tendenza dei
bambini con problemi di condotta ad attribuire agli altri intenzioni ostili nelle situazioni ambigue.
Questi bambini rispondono in maniera aggressiva agli altri perché si aspettano di essere aggrediti. I
bambini con problemi di condotta hanno mostrato uno stile di mentalizzazione eccessivamente
positivo nell’interpretare i pensieri che gli altri fanno in relazione a loro.
In un altro studio abbiamo dimostrato la presenza di un deficit nella comprensione delle emozioni in
bambini di sette-undici anni con problemi di comportamenti esternalizzanti, utilizzando un compito
che richiede ai bambini di leggere le emozioni espresse nella regione oculare del viso.
La mentalizzazione, che è l’intenzionalità umana esercitata in contesti sociali, sta dunque alla
base del comportamento di fiducia. Dati i nostri problemi di mentalizzazione associati ai disturbi
esternalizzanti, non sorprende che i ragazzi con tali problemi abbiano mostrato anomalie nel
comportamento di fiducia.
La pseudomentalizzazione
Hanno evidenziato che i bulli, che in genere mettono in atto violente aggressioni indirette e
proattive, possiedono in realtà una capacità di mentalizzazione avanzata. Hanno ipotizzato che
questi bambini diventino abili lettori della mente in risposta ad ambienti ostili, caratterizzati da una
disciplina severa e incoerente. Questa tendenza a impegnarsi nella lettura della mente, che
assomiglia alla mentalizzazione ma manca di alcune delle sue caratteristiche essenziali, viene
definita pseudomentalizzazione. La pseudomentalizzazione implica l’utilizzo della mentalizzazione
per manipolare o controllare il comportamento, al contrario della mentalizzazione genuina, che
riflette una reale curiosità e un rispetto generale per le menti altrui.
Uno dei migliori esempi di pseudomentalizzazione è il caso della psicopatia. Gli adolescenti e gli
adulti psicopatici sono in grado di leggere la mente, ma questa lettura è a carico delle regioni
celebrali del pensiero, piuttosto che di quelle delle emozioni. L’empatia comporta una risposta
emotiva allo stato altrui, può essere vista come una conseguenza dell’assunzione di prospettiva.
L’empatia è perciò una risposta emotiva alla rappresentazione di uno stato interno altrui. Gli
psicopatici indossano una maschera di sanità mentale: sembrano mentalizzare, ma in verità stanno
pseudomentalizzando.
La mentalizzazione e i problemi internalizzanti
I bambini che soffrono di ansia sociale presentano un deficit di abilità sociale nei compiti che
richiedono di mentalizzare. Hanno rilevato che u bambini socialmente ansiosi, mentre sono capaci
di mettere in atto strategie di autopresentazione come i bambini non ansiosi, falliscono nel
modificare tali strategie in relazione alle persone che hanno davanti, evidenziando difficoltà nel
riconoscimento delle preferenze dei loro patti sociali. Questi studi mostrano come i bambini
ansiosi prestino una difficoltà nella comprensione e nella gestione efficace delle situazioni
sociali in cui sono presenti più stati mentali. Viene messa poi in luce l’ipervigilanza che essi
manifestano quando non possiedono una conoscenza delle menti altrui.
Conclusione
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
L’obiettivo è di analizzare i problemi di mentalizzazione nei bambini e negli adolescenti,
utilizzando una tassonomia che comprende diversi tipi di difficoltà di mentalizzazione:
l’assenza di mentalizzazione, l’ipomentalizzazione, l’ipermentalizzazione,la pseudomentalizzazione
e la mentalizzazione distorta. La letteratura dimostra l’assenza di mentalizzazione o
l’ipomentalizzazione in bambini con disturbi dello spettro autistico. Abbiamo visto come fallimenti
simili della mentalizzazione compaiano anche negli adolescenti o nei giovani adulti affetti da
schizofrebua, ma tale ipomentalizzazione precedeva un processo di attribuzione di intenzioni in
appropriate alle altre persone (ipermentalizzazione). Si è discusso di un nuovo studio che rileva
l’ipermentalizzazione negli adolescenti con disturbo di personalità. Si può anche rilevare sia
un’ipomentalizzazione sia una mentalizzazione distorta nei preadolescenti con problemi di
condotta, mentre la pseudomentalizzazione è presente in coloro che hanno comportamenti di
condotta più gravi, che presentano tratti psicopatici.
Un approccio evolutivo per le comunità di mentalizzazione
Esaminiamo ora il problema del bullismo e della violenza nelle scuole.
Il bambino problematico come sintomo di un sistema sociale patologico
Siamo in una città di medie dimensioni negli USA. Ci sono spesso atti di violenza, il clima è teso a
scuola: gli insegnanti riportano di sentirsi spaventati per la propria incolumità. Spesso sentono di
non possedere le abilità sociali e le conoscenze psicologiche necessarie per fronteggiare gli alunni.
Lo studente al centro della storia è Billy, un undicenne sovrappeso, che entra in aula urlando “Odio
il lunedì! La scuola è una perdita di tempo”. L’insegnante durante quest’ora faceva terminare i
compiti che non avevano svolto a casa. Billy fa capire all’insegnate che l’inglese è la materia che
odia. L’insegnante sa che l’intenzione di Billy è comportarsi male per causare un conflitto ed
evitare di fare qualsiasi lavoro. L’insegnante è molto frustrata per la situazione, che sembra
peggiorare. L’esplosione di Billy è il culmine del comportamento di molti giorni, in cui ha evitato di
fare il proprio lavoro in varie materie. L’insegnante pensa che queste azioni di disturbo quotidiane
siano permesse dalla madre, che minaccia costantemente la scuola. Ogni volta che l’insegnante
interviene per scoraggiare i comportamenti di Billy, il suo comportamento peggiora. Quando
l’insegnante lo manda dal dirigente scolastico, questo gli fa da babysitter per il tempo della lezione
e poi lo rimanda in aula. L’insegnante osserva che Billy ha una storia difficile alle spalle, difficoltà
con i coetanei fin dalla scuola primaria. I suoi tentativi di affiliarsi al gruppo più in vista non gli
hanno procurato l’attenzione di cui sembrava avere bisogno. I suoi problemi di relazione in classe e
con i pari dominavano la sua vita e avevano portato a una caduta significativa dei suoi voti
scolastici.
Commento del caso secondo la prospettiva della mentalizzazione
Dal punto di vista dell’insegnante Billy appare come un ragazzino capace di agire prepotenze verso
gli insegnanti e che, attraverso la manipolazione della madre, ottiene una protezione da parte del
sistema e una licenza illimitata a disturbare e maltrattare insegnanti e studenti. L’insegnante non
incolpa Billy e pensa che sia un agente razionale. L’agente razionale di Billy agirà per raggiungere i
propri obiettivi alla luce della sua credenza. Le credenze sono rappresentazioni della realtà. Non
esistono certezza rispetto alle credenze in relazione a esperienze particolari. La mentalizzazione è
inesatta. Il comportamento provocatorio di Billy, supportato dall’azione emotiva, da origine
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
all’ansia dell’insegnante in relazione alle sue responsabilità verso gli altri studenti. Ma le ansie
dell’insegnante compromettono la sua capacità di rappresentarsi gli stati mentali e vanno
oltre l’interazione di Billy. Il suo fallimento nel considerare le motivazioni alternative per il
comportamento di Billy può essere legato alla minaccia sperimentale in relazione alla madre di
Billy e a tutte le madri e i padri che manipolano in modo aggressivo gli insegnanti e rendono
impossibile pensare a convinzioni e desideri. Billy sperimenta il rimprovero come un attacco da
parte di un’altra mente ostile, che semplicemente convalida il suo bisogno di interrompere, far
rumore, disturbare, proteggere se stesso da ciò che è insopportabilmente doloroso. Considerare
Billy come un agente la cui razionalità è limitata dall’impoverita capacità di mentalizzare, ci aiuta a
rivalutare in maniera diversa il comportamento e la sua storia. Billy appare carente nella capacità di
sintonizzarsi con i pari, reagendo in modalità che essi trovano disturbanti.
Come possiamo aiutare Billy? Tentare di spiegare gli intricati modelli di comunicazione sarebbe
impraticabile. L’esperienza dimostra che ragazzi come Billy sono scarsamente responsivi a tali
tentativi. Per questo riteniamo che si dovrebbe anche nella scuola e nella classe, modificare il
comportamento della classe piuttosto che imporre delle conseguenze a Billy.
Commento del caso secondo la prospettiva delle dinamiche di potere nel sistema sociale
La ricerca ha dimostrato che negli episodi di aggressività la sottomissione incoraggia una risposta
grandiosa di controllo, attraverso l’identificazione proiettiva di parti ripudiate di se nel persecutore.
Quest’ultimo viene imprigionato nell’odio, che diminuisce la capacità di pensare e aumenta la
tendenza a stereotipare l’altro. Da tale prospettiva, il problema fondamentale di Billy è sistemico.
La forza o il potere del sistema, che mette Billy in un ruolo dominante, deriva dall’incapacità di
affrontare la dinamica di potere che lo sostiene. Nella posizione di vittima, l’insegnante è
sopraffatta e scoraggiata e va dal dirigente per chiedere aiuto. La lotta di potere nel sistema sociale
patologico peggiora,l perché il dirigente scolastico ha perso il suo potere divenendo il babysitter di
Billy, molto probabilmente veicolando a Billy il messaggio che sta tenendo sotto controllo il
dirigente, l’insegnante e l’intera scuola.
Tutte le persone nella vita di Billy hanno adottato i ruoli di bullo, vittima spettatore, la prospettiva
delle dinamiche di potere nel sistema sociale vede tutto questo come un processo dissociativo: il
bullo, dissocia la vittima dalla comunità scolastica. Ogni rimedio per questo stato di cose richiede
una concettualizzazione chiara del compito del gruppo, da una prospettiva che permetta
l’assunzione del capro espiatorio, responsabilizzi gli spettatori in un ruolo di aiuto e non enfatizzi
l’importanza dell’impegno terapeutico con la vittima o il persecutore. Il sintomo non è solo il
problema da risolvere, ma una soluzione o un adattamento che oscura il contesto sociale
disfunzonante.
Il progetto Paceful School: un sistema sociale mentalizzante
I sistemi sociali incompatibili con la violenza sono sistemi sociali mentalizzanti. Questo è dovuto
dal fatto che un individuo è in capace di esercitare aggressività interpersonale in un contesto nel
quale riesce a mentalizzare la propria vittima.
Nel 1922 iniziò una ricerca nelle scuole per verificare se era possibile creare un sistema sociale
mentalizzante con dinamiche di potere equilibrate. Comprendere come il sistema lavora consente ai
singoli (insegnanti e studenti) di creare modalità innovative per modellare il clima sociale nella
scuola. Le componenti di questa filosofia sono:
Diffusione di un clima positivo: incoraggia il cambiamento nel linguaggio e nel pensiero
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
Gestione del gruppo classe: supporta gli sforzi dell’insegnante rispetto alla disciplina attraverso
la focalizzazione dei problemi da correggere. Se un bambino offende la classe, la classe compila
una nota relativa alla lotta di potere. I bambini coinvolti poi vengono visti dal consulente
scolastico per ulteriore comprensione di quanto sta avvenendo. Così l’ambiente contribuisce al
pensiero all’interno del contesto di una relazione di un counselling psicologico che incoraggia la
mentalizzazione. L’obiettivo è incoraggiare il bambino a pensare dal punto di vista degli altri.
Tutoraggio tra pari e con l’adulto: tutoraggio è il tentativo di rispecchiare all’esterno il piano di
gestione della classe che avviene all’interno dell’aula. Guardare al tutoraggio da una prospettiva
mentalizzante richiede il punto di vista terzo, che consente all’analista di occuparsi del paziente
e di pensare a lui.
Il programma di educazione fisica del guerriero gentile: quest’approccio soddisfa i requisiti per
l’educazione fisica, impegnando una combinazione di giochi di ruolo, rilassamento e tecnica di
difesa tratte dalle arti marziali. L’approccio aiuta i bambini a proteggere se stessi e gli altri con
strategie fisiche e cognitive non aggressive.
Tempo per la riflessione: un gruppo sociale non ha il diritto alcun membro. La ferita narcisistica
messa in scena dal bullo o dalla vittima è un tentativo di riconquistare l’accesso a quel gruppo o
di essere accettato. L’obbiettivo di Peaceful School è che gli insegnanti diventino attivamente
coinvolti nel mentalizzare il bambino.
Conclusione
Nel presente capitolo abbiamo tentato di sintetizzare una prospettiva teorica e filosofica sulla
mentalizzazione e sulle dinamiche di potere.
Thougts in mind (TiM)
Lo sviluppo del progetto TiM
La mentalizzazione può essere definita come l’abilità di leggere i pensieri e i sentimenti
delle altre persone e di riflettere sui propri pensieri e sentimenti. Studi recenti indicano che
la mentalizzazione può essere supportata da programmi di educazione scolastica. Il progetto
danese Thougt in mind ha preso ispirazione da questi studi. TiM è stato creato come un
programma di gruppo per insegnanti, educatori e genitori, con l’obbiettivo di stimolare un
ambiente mentalizzante per bambini. Tale obbiettivo può essere raggiunto attraverso la
discussione, la narrazione di storie o di giochi.
I concetti base del TiM
L’aspetto cruciale di TiM è tradurre la teoria scientifica e le conoscenze sulla mentalizzazione in
conoscenze pratiche allo scopo di fornire un’ispirazione a professionisti e a genitori. Nel
materiale del TiM vi sono brevi storie che illustrano i concetti base. Non sono storie vere con
personaggi e azioni, ma piuttosto storie metanarrative, che creano cornici metaforiche per i
pensieri, i sentimenti e la mentalizzazione, nella quali chi ascolta può inserire i propri pensieri e
sentimenti.
Il cervello pensante e il sistema di allarme
Nel progetto TiM la neuropsicologia della mentalizzazione è spiegata attraverso la figura sotto.
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
lOMoARcPSD|2610606
Nel materiale TiM procediamo poi a
discutere come mente e cervello possano
essere allenati da sfide adeguate. Il
cervello pensante può imparare a
controllare il centro d’allarme affinché
quest’ultimo non venga attivato
involontariamente; questo significa che il
centro d’allarme è stabilizzato. Se la sfida
è troppo grande il centro d’allarme prende
il sopravvento e il cervello pensante viene
disattivato. Gli studi indicano che
quando il sistema d’allarme è acceso il
volume della memoria aumenta, mentre
il volume di memoria del cervello
pensante si abbassa. Può essere difficile
ricordare dettagli di quanto accaduto in
una situazione altamente emotiva.
Spiegare il centro d’allarme del cervello a
un bambino può essere utile e può stimolarlo a pensare a cosa potrebbe essere positivo fare quando
questo accade.
Conclusione
Abbiamo concluso che il programma TiM suscita un sufficiente interesse presso professionisti e
genitori. La mentalizzazione è uno dei fattori più importanti sottostanti alla salute mentale e al
comportamento. I risultati del progetto TiM indicano che è possibile sviluppare programmi di
gruppo utili nel rendere le idee mentalizzanti quanto più ampiamente disponibili tra coloro che
si occupano di bambini. Il progetto TiM è fra i primi studi sulla mentalizzazione su larga scala e
incoraggia i ricercatori a sviluppare ulteriori idee in questo campo.
Scaricato da Elisa Berbiglia (elisa.berbiglia@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Dillo con la Voce. Metodo Psicopedagogico. Insegnare ai bambini ad esprimere emozioniDa EverandDillo con la Voce. Metodo Psicopedagogico. Insegnare ai bambini ad esprimere emozioniNessuna valutazione finora
- L'età evolutiva. Volume 5. L'inconscio tra desiderio e sinthomoDa EverandL'età evolutiva. Volume 5. L'inconscio tra desiderio e sinthomoNessuna valutazione finora
- L'Educazione Razionale EmotivaDocumento4 pagineL'Educazione Razionale Emotivainmygrace5391Nessuna valutazione finora
- Autismo e PsicoanalisiDocumento7 pagineAutismo e PsicoanalisiAnnachiara PiffariNessuna valutazione finora
- Riassunto Psicologia Generale Da Manuale MulinoDocumento5 pagineRiassunto Psicologia Generale Da Manuale MulinoRakele Isaia0% (1)
- La Teoria Della MenteDocumento6 pagineLa Teoria Della MenteNicolò GhettiNessuna valutazione finora
- I PRINCIPALI STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE Di E ERIKSONDocumento15 pagineI PRINCIPALI STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE Di E ERIKSONDario BenattiNessuna valutazione finora
- Psicometria 2 - Psicologia - Lezioni CavalleroDocumento111 paginePsicometria 2 - Psicologia - Lezioni CavalleroEmanuele CasaleNessuna valutazione finora
- Lo Spettro Autistico Risposte SempliciDocumento46 pagineLo Spettro Autistico Risposte SempliciLatinoamericaysugente GrupoNessuna valutazione finora
- Emozioni e AdolescenzaDocumento322 pagineEmozioni e AdolescenzaAnonymous uWo9lMaNessuna valutazione finora
- Lezioni - Psico. ClinicaDocumento19 pagineLezioni - Psico. ClinicaAmbra BerettiNessuna valutazione finora
- Psicobiologia e Psicologia FisiologicaDocumento42 paginePsicobiologia e Psicologia FisiologicaErika SpadettoNessuna valutazione finora
- Ansia Da Separazione e Misura Dell'attaccamento Normale e PatologicoDocumento11 pagineAnsia Da Separazione e Misura Dell'attaccamento Normale e PatologicokaramrhamNessuna valutazione finora
- Craving - Alla Base Di Tutte Le DipendenzeDocumento1 paginaCraving - Alla Base Di Tutte Le Dipendenzeamalia6274Nessuna valutazione finora
- Piaget, Freud, Vigostkij e Altre TeorieDocumento10 paginePiaget, Freud, Vigostkij e Altre TeorieNico RicciNessuna valutazione finora
- Modelli Operativi InterniDocumento5 pagineModelli Operativi InterniNeuroscienze.net100% (1)
- Eziologia AutismoDocumento8 pagineEziologia AutismoNataliaNessuna valutazione finora
- LelliDocumento42 pagineLelliagilulfo123Nessuna valutazione finora
- Memoria Positiva - MammarellaDocumento4 pagineMemoria Positiva - MammarellaLaura GianniniNessuna valutazione finora
- Psicologia Dell'Handicap RiassuntiDocumento36 paginePsicologia Dell'Handicap RiassuntiRoberta RossiNessuna valutazione finora
- Neuroscienze CognitiveDocumento8 pagineNeuroscienze CognitiveLorenzo Maria CerviNessuna valutazione finora
- Il Disimpegno Morale Nella Teoria Social-CognitivaDocumento11 pagineIl Disimpegno Morale Nella Teoria Social-CognitivaPsycHomer100% (3)
- ComportamentismoDocumento4 pagineComportamentismocriNessuna valutazione finora
- 21.autismo DiagnosiDocumento22 pagine21.autismo DiagnosiPerla BelloneNessuna valutazione finora
- Riassunto Psicologia GeneraleDocumento54 pagineRiassunto Psicologia Generalefrancesca duranteNessuna valutazione finora
- Appunti Psicologia SocialeDocumento11 pagineAppunti Psicologia SocialelulujolieNessuna valutazione finora
- Psicologia Dello Sviluppo e Dell'educazioneDocumento52 paginePsicologia Dello Sviluppo e Dell'educazioneGiovanna GiordaniNessuna valutazione finora
- (PPS) Psicologia Dinamica - Prof. Ssa Adriana Lis (Nascita Psicanalisi)Documento27 pagine(PPS) Psicologia Dinamica - Prof. Ssa Adriana Lis (Nascita Psicanalisi)lulujolieNessuna valutazione finora
- Psicologia GeneraleDocumento27 paginePsicologia Generaleshiver85Nessuna valutazione finora
- Lo Sviluppo Cognitivo e Morale Secondo PiagetDocumento3 pagineLo Sviluppo Cognitivo e Morale Secondo PiagetPsycHomerNessuna valutazione finora
- 11 Gli Stadi Dello Sviluppo Cognitivo Secondo PiagetDocumento14 pagine11 Gli Stadi Dello Sviluppo Cognitivo Secondo PiagetSalvatoreMurgiaNessuna valutazione finora
- Emozioni Teorie ClassicheDocumento10 pagineEmozioni Teorie ClassichefultosoNessuna valutazione finora
- Lezione Mente CorpoDocumento21 pagineLezione Mente CorpoNunzio Luca BufardeciNessuna valutazione finora
- Tecniche Di Comunicazione InterpersonaleDocumento10 pagineTecniche Di Comunicazione InterpersonaleClaudia PasquiniNessuna valutazione finora
- La Teoria Dei Codici Affettivi Di Franco FornariDocumento25 pagineLa Teoria Dei Codici Affettivi Di Franco Fornarifilippo_mittino67% (6)
- D'odoricco Osservare-Per-Educare-RiassuntoDocumento10 pagineD'odoricco Osservare-Per-Educare-RiassuntoSilvia GrossoNessuna valutazione finora
- Teorie Di Base: GestaltDocumento46 pagineTeorie Di Base: GestaltstanismiragliaNessuna valutazione finora
- Il TemperamentoDocumento5 pagineIl TemperamentoChiara MarchesiNessuna valutazione finora
- Psicologia Dello Sviluppo - Camaioni, Di BlasioDocumento32 paginePsicologia Dello Sviluppo - Camaioni, Di Blasiobarbarella.901635100% (1)
- Psicologia Sociale Della Seconda Infanzia e Dell'adolescenzaDocumento18 paginePsicologia Sociale Della Seconda Infanzia e Dell'adolescenzaBenedetta BartoliniNessuna valutazione finora
- Educazione All'affettivitàDocumento4 pagineEducazione All'affettivitàSimona OdoreNessuna valutazione finora
- Riassunto Psicologia ClinicaDocumento33 pagineRiassunto Psicologia ClinicaVanna Amicizie Esaurite IsaiaNessuna valutazione finora
- Band UraDocumento7 pagineBand UrasimonaprioriNessuna valutazione finora
- AnamnesiDocumento53 pagineAnamnesilulujolieNessuna valutazione finora
- Introduzione Terapia Della GestaltDocumento2 pagineIntroduzione Terapia Della GestaltDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Militerni Psicologia Dello Sviluppo AppuntiDocumento37 pagineMiliterni Psicologia Dello Sviluppo AppuntiAda TodiscoNessuna valutazione finora
- Deficit Del Controllo Inibitorio Nel DOC e Nel GAP - Dal Forum Di ASSISI 2015Documento1 paginaDeficit Del Controllo Inibitorio Nel DOC e Nel GAP - Dal Forum Di ASSISI 2015State of Mind100% (1)
- Emozioni e Affetti - Cesarina Lobello 18.04.11Documento13 pagineEmozioni e Affetti - Cesarina Lobello 18.04.11studiogaribaldi100% (2)
- INSEGNARE A COMUNICARE FRASI ED EMOZIONI AL BAMBINO CON AUTISMO. Aspetti Educativi nei Bisogni SpecialiDa EverandINSEGNARE A COMUNICARE FRASI ED EMOZIONI AL BAMBINO CON AUTISMO. Aspetti Educativi nei Bisogni SpecialiNessuna valutazione finora
- Pragmatica - Di MeolaDocumento13 paginePragmatica - Di MeolaFedericaNessuna valutazione finora
- L EmpatiaDocumento32 pagineL EmpatiaLudovico Nocco0% (1)
- Linconscio Non Abita Piu QuiDocumento22 pagineLinconscio Non Abita Piu QuiAldo Insigne GambardellaNessuna valutazione finora
- Corso Di Psicologia Dello Sviluppo (Riassunto) - BombiDocumento73 pagineCorso Di Psicologia Dello Sviluppo (Riassunto) - Bombinoisdue88% (17)
- Riassunti Moderato Rovetto - Psicologo Verso La ProfessioneDocumento68 pagineRiassunti Moderato Rovetto - Psicologo Verso La Professioneanno666100% (3)
- Emozioni Affettivita ApprendimentoDocumento9 pagineEmozioni Affettivita ApprendimentoSara BacchiniNessuna valutazione finora
- ManualeDocumento298 pagineManualeElo EloNessuna valutazione finora
- Il Conflitto Socio Cognitivo RizzoDocumento6 pagineIl Conflitto Socio Cognitivo Rizzotomluigi0% (1)
- Dodici Dimensioni Per Orientare La Diagnosi Sistemica Matteo SelviniDocumento22 pagineDodici Dimensioni Per Orientare La Diagnosi Sistemica Matteo SelviniMarica SpitaliNessuna valutazione finora
- Apprendimento e Intelligenza: Il Metodo Feuerstein alla luce delle neuroscienze cognitiveDa EverandApprendimento e Intelligenza: Il Metodo Feuerstein alla luce delle neuroscienze cognitiveNessuna valutazione finora
- Programmi d'intervento precoce basati sulle evidenze scientifiche nei disturbi dello spettro autisticoDa EverandProgrammi d'intervento precoce basati sulle evidenze scientifiche nei disturbi dello spettro autisticoNessuna valutazione finora