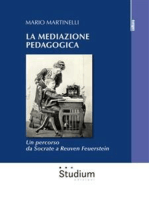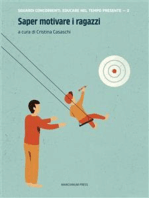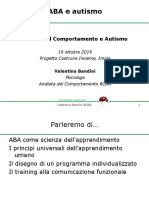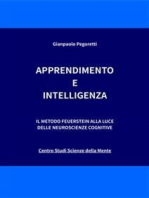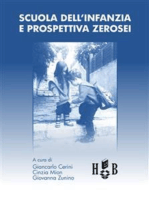Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Emozioni Affettivita Apprendimento
Caricato da
Sara BacchiniTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Emozioni Affettivita Apprendimento
Caricato da
Sara BacchiniCopyright:
Formati disponibili
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
Emozioni, affettivit e apprendimento
(Tratto e adattato da: Scataglini C., Cramerotti S. e Ianes D. Fare sostegno nelle scuole superiori, Trento, Erickson,
2008)
Un legame molto stretto, come abbiamo gi anticipato, anche quello che
intercorre tra processi di apprendimento e componenti affettivo-emotive
dellalunno.
Questo evidente fin dallinstaurarsi dei primi e importantissimi legami di
attaccamento tra il bambino e le sue figure di riferimento (Bowlby, 1982). Le
capacit di apprendimento e di adattamento sociale sono infatti molto legate
alla reattivit emozionale, e in alcuni casi ne sono quasi completamente
condizionate. Si pensi ad esempio a un alunno che non sa gestire ed esprimere
costruttivamente la frustrazione che deriva dallinsuccesso in un compito e
reagisce con livelli di collera e rabbia tali da compromettere e distruggere la
situazione di insegnamento/apprendimento.
Per molti anni questi aspetti di reciproca influenza sono stati troppo spesso
trascurati, ponendo maggiore attenzione pi agli aspetti di apprendimento
puro e ritenendo che la sfera propria delle emozioni e dellaffettivit e
quindi anche uneducazione alle emozioni e allaffettivit fosse prerogativa e
compito primario della famiglia, se non, in alcuni casi ancora pi estremi, un
aspetto unicamente evolutivo che seguiva un suo corso preciso al pari di altri
aspetti e sul quale, ben poco la scuola poteva ed era tenuta a fare.
Fortunatamente, in anni pi recenti, lattenzione del mondo scolastico per la
dimensione affettivo-emotiva dellalunno ha trovato ampio spazio e quindi, di
conseguenza, sono diventati oggetto di studio e interesse anche i forti legami
con i vari processi di apprendimento.
Gi a partire dagli anni Settanta, gli importanti contributi di Maslow e Rogers,
illustri rappresentanti dellapproccio umanistico alle problematiche educative e
riferimento di numerosi modelli didattici, enfatizzano e assegnano un posto di
grande rilievo alle relazioni socio-affettive allinterno della classe.
La gratificazione dei bisogni fondamentali teorizzata da Maslow appare ancora
oggi importante punto di riferimento anche per affrontare la questione della
motivazione. Per Maslow lessere umano e una totalit integrata che possiede
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
tendenze e bisogni essenzialmente che si traducono in motivazioni allagire,
ossia in mezzi per raggiungere un fine. La piena realizzazione delle proprie
potenzialit, che e il fine di ogni essere umano, si raggiunge proprio grazie al
soddisfacimento di tali esigenze che possono essere percettivamente
visualizzate attraverso una piramide; partendo dalla base della piramide
troviamo nellordine i bisogni fisiologici, i bisogni di sicurezza, i bisogni di
appartenenza, il bisogno di stima e infine, allapice della piramide, il bisogno di
autorealizzazione (Maslow, 1973). Rogers (1973) propone invece linteressante
concetto di libert di apprendimento, che caratterizza la sua pedagogia non
direttiva, nella quale linsegnante dovrebbe assumere unicamente il ruolo di
facilitatore dellapprendimento, con atteggiamenti di ascolto, attenzione per i
vari bisogni dellalunno, empatia, ecc.
Pi recentemente, in riferimento alla teoria delle intelligenze multiple di
Gardner (1993; 1999; 2005) ricordiamo che questo autore ha individuato, fra
le varie tipologie di intelligenza che caratterizzano lessere umano, una
Intelligenza interpersonale/relazionale (preferenza per il comprendere le
persone e le relazioni, mediare i conflitti) e una Intelligenza intrapersonale
(preferenza per il comprendere la propria esistenza per se e per gli altri
attraverso attivit su autostima/ identit, emozioni, sentimenti, motivazioni,
intenzioni, empatia, ecc.).
Nel 1996 Goleman, nella sua celebre opera Lintelligenza emotiva, scriveva:
Prevedo un giorno nel quale sar compito normale delleducazione quello
di inculcare comportamenti umani essenziali come lautoconsapevolezza,
lautocontrollo e lempatia, e anche larte di ascoltare, risolvere i conflitti
e di cooperare. (Goleman, 1996, p. 16)
Lautore quindi sottolinea non solo lesistenza di una vera e propria intelligenza
emotiva, ma anche la necessit da parte delle istituzioni educative di
promuovere dei veri e propri programmi di educazione emozionale volti a
sviluppare capacita come quelle di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli
altri, di motivare noi stessi e di gestire postivamente le emozioni, sia
interiormente sia nelle relazioni con gli altri.
Nel nostro Paese, un autorevole contributo in questa direzione, che affonda le
sue radici nella Terapia Razionale Emotiva di Ellis (1989, ed. orig. 1962),
2
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
quello proposto da Mario Di Pietro (1992; 1994; 1999) nei suoi percorsi di
educazione razionale emotiva, dove lobiettivo generale proprio la
consapevolezza dei propri stati emotivi e dei meccanismi che li influenzano, sia
in senso positivo che negativo.
Da qui derivano poi obiettivi pi specifici a breve termine quali il saper
fronteggiare con maggiore efficacia le difficolt che si incontrano
quotidianamente, favorire laccettazione di se stessi e degli altri (e quindi
anche dei punti di debolezza che caratterizzano ognuno di noi), aumentare la
tolleranza alla frustrazione, acquisire abilita di autoregolazione del proprio
comportamento. Infatti, le nostre emozioni derivano non tanto da ci che ci
accade, ma dal modo in cui valutiamo e interpretiamo ci che ci accade (dalla
rappresentazione cognitiva degli eventi), che in molti casi risulta disfunzionale,
dominata da pensieri irrazionali e dannosi. E quindi proprio agendo su queste
modalit che possiamo lavorare per riuscire a elaborare e controllare meglio, in
modo pi adattivo, i nostri vissuti emotivi.
Vermigli e colleghi hanno messo a punto il Test ACESS (Analisi degli indicatori
cognitivo-emozionali del successo scolastico, 2002) in cui vengono misurate
alcune aree ritenute fattori personali molto attivi rispetto allapprendimento di
competenze e al successo scolastico: la capacit di adattamento alle attivit
scolastiche (intesa come il risultato tra il giudizio di valore degli altri e
lautopercezione sulle proprie capacita scolastiche); lemotivit (che in et
adolescenziale pu essere condizionata da fattori fisiologici e relazionali);
lidentit corporea (ossia la percezione di quanto ci si sente accettati nel
proprio aspetto fisico); ladattamento sociale (ossia la consapevolezza di
quanto si e amati e accettati dagli altri); le relazioni familiari (intese come
punto di riferimento dal quale avere sostegno per affrontare esperienze).
Percorsi di educazione affettivo-emotiva di questo tipo sono quindi la base
indispensabile per creare terreno fertile per tutti gli altri tipi di
apprendimento e dovrebbero quindi essere attuati in modo trasversale a tutte
le discipline scolastiche in un clima di forte collaborazione, coinvolgimento,
coerenza e co-costruzione fra tutte le figure di riferimento educativo e,
naturalmente, sfruttando il pi possibile la risorsa compagni di classe.
Ricordiamoci inoltre che non ci sono limiti di tempo o di et per iniziare e
3
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
portare avanti percorsi di questo tipo (Tuffanelli, 2005), considerandoli
compito, peculiarit e priorit di ordini di scuola inferiori, ma anche a livello di
scuola secondaria di secondo grado possono anzi data lemergenza
evidenziata in questo settore dalla scuola di oggi, potremmo dire devono
essere attuati percorsi volti al riconoscimento e alla gestione del bagaglio
emozionale proprio e altrui.
Ci troviamo in completo accordo con Tuffanelli (2005) quando afferma:
Linsegnante che pensi facendo questo di sacrificare il programma, di
sottrarre risorse alleducazione cognitiva, si dovrebbe convincere che
non ce apprendimento che possa prescindere dalle emozioni. Educare le
emozioni significa anche investire sullapprendimento. Al contrario, o
forse e meglio dire ancor pi, di altre forme di apprendimento,
leducazione emotiva non tollera la fretta: e necessario rispettare il
calendario emozionale dello sviluppo dellalunno. (Tuffanelli, 2005, p.
53)
Il Box operativo che proponiamo qui sotto presenta alcuni elementi base di
formazione allaffettivit/emozioni. Si tratta di una proposta certamente
originale, che esce dai consueti schemi tradizionali attraverso i quali sono
impostati i percorsi di educazione affettivo-emotiva attualmente proposti nei
diversi contesti educativi.
Questa proposta si basa sullimmagine/metafora della molecola del cuore,
capace di raccogliere le diverse competenze affettive che nel vivere quotidiano
ogni alunno dovrebbe padroneggiare al fine di vivere il pi positivamente
possibile la propria affettivit. Si tratta quindi di uno schema concettuale che si
propone sia come strumento di osservazione che come strumento di
orientamento dellazione formativa: da un lato, esso, infatti, evidenzia capacita
e bisogni dellalunno nelle diverse competenze affettive indispensabili, dallaltro
raccoglie obiettivi formativi generali, ma irrinunciabili, e, cosi, orienta verso
possibili interventi che possano favorirne lo sviluppo, promuovendo allo stesso
tempo la formazione di quel terreno fertile per lapprendimento.
Lestrema flessibilit e adattabilit del modello, ne permette una sua corretta
ed efficace applicazione alla vasta gamma dei vari Bisogni Educativi Speciali
(Ianes e Demo, 2007).
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Materiale ad esclusivo uso in ambito formativo. Tutti i diritti riservati.
Erickson centro Studi S.p.A - Vietata la vendita e la distribuzione
Potrebbero piacerti anche
- Introduzione Alla Competenza EmotivaDocumento29 pagineIntroduzione Alla Competenza EmotivaHannah196100% (1)
- Lo Sviluppo Del BambinoDocumento32 pagineLo Sviluppo Del BambinoAnna GuarracinoNessuna valutazione finora
- Gli Screenings Scolastici: Descrizione generale delle condizioni funzionali degli alunniDa EverandGli Screenings Scolastici: Descrizione generale delle condizioni funzionali degli alunniNessuna valutazione finora
- Programmi d'intervento precoce basati sulle evidenze scientifiche nei disturbi dello spettro autisticoDa EverandProgrammi d'intervento precoce basati sulle evidenze scientifiche nei disturbi dello spettro autisticoNessuna valutazione finora
- Crescere emotivamente competenti: Proposte dalle scuole della Svizzera ItalianaDa EverandCrescere emotivamente competenti: Proposte dalle scuole della Svizzera ItalianaNessuna valutazione finora
- A scuola dopo la Covid-19: Non torniamo indietro, andiamo avanti! Riflessioni e idee per una scuola a misura di bambini e ragazziDa EverandA scuola dopo la Covid-19: Non torniamo indietro, andiamo avanti! Riflessioni e idee per una scuola a misura di bambini e ragazziNessuna valutazione finora
- INSEGNARE A COMUNICARE FRASI ED EMOZIONI AL BAMBINO CON AUTISMO. Aspetti Educativi nei Bisogni SpecialiDa EverandINSEGNARE A COMUNICARE FRASI ED EMOZIONI AL BAMBINO CON AUTISMO. Aspetti Educativi nei Bisogni SpecialiNessuna valutazione finora
- La mediazione pedagogica: Un percorso da Socrate a Reuven FeuersteinDa EverandLa mediazione pedagogica: Un percorso da Socrate a Reuven FeuersteinNessuna valutazione finora
- Le arti e il gioco nelle strategie educative dell’inclusione: Atti del ConvegnoDa EverandLe arti e il gioco nelle strategie educative dell’inclusione: Atti del ConvegnoNessuna valutazione finora
- Matematica e Dsa: emozioni e convinzioni.Da EverandMatematica e Dsa: emozioni e convinzioni.Valutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (2)
- La Didattica Delle Competenze - Primo Incontro PDFDocumento48 pagineLa Didattica Delle Competenze - Primo Incontro PDFMaddalena CapassoNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo e DellDocumento30 pagineFondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo e DellCarbone AntonioNessuna valutazione finora
- 7608 Alla Scoperta Delle Emozioni 2015Documento67 pagine7608 Alla Scoperta Delle Emozioni 2015susi sajon100% (1)
- Approfondimento Sul PAS Metodo FeuersteinDocumento7 pagineApprofondimento Sul PAS Metodo FeuersteinsviluppocognitivoNessuna valutazione finora
- 11 Gli Stadi Dello Sviluppo Cognitivo Secondo PiagetDocumento14 pagine11 Gli Stadi Dello Sviluppo Cognitivo Secondo PiagetSalvatoreMurgiaNessuna valutazione finora
- Didattica Per Competenze e Metodo Eas PDFDocumento9 pagineDidattica Per Competenze e Metodo Eas PDFRaffaela CesaroNessuna valutazione finora
- Emozioni e AdolescenzaDocumento322 pagineEmozioni e AdolescenzaAnonymous uWo9lMaNessuna valutazione finora
- I PRINCIPALI STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE Di E ERIKSONDocumento15 pagineI PRINCIPALI STADI DELLO SVILUPPO PSICOSOCIALE Di E ERIKSONDario BenattiNessuna valutazione finora
- Valutazione AutenticaDocumento5 pagineValutazione AutenticaGa_VNessuna valutazione finora
- PROGETTARE PERCORSI CURRICOLARI Di M. PiscitelliDocumento9 paginePROGETTARE PERCORSI CURRICOLARI Di M. PiscitelliDipartimento Lingua- Circolo Didattico di VinciNessuna valutazione finora
- Assertività PDFDocumento19 pagineAssertività PDFAnnaMaria PassaggioNessuna valutazione finora
- Militerni Psicologia Dello Sviluppo AppuntiDocumento37 pagineMiliterni Psicologia Dello Sviluppo AppuntiAda TodiscoNessuna valutazione finora
- 34 Comportamento ProblemaDocumento17 pagine34 Comportamento ProblemaLiborio ScavoneNessuna valutazione finora
- ADHD e Scuola: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-5/2021Da EverandADHD e Scuola: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-5/2021Nessuna valutazione finora
- Test Tfa Precedenti-53Documento10 pagineTest Tfa Precedenti-53Marianna MusumeciNessuna valutazione finora
- Emozioni e Affetti - Cesarina Lobello 18.04.11Documento13 pagineEmozioni e Affetti - Cesarina Lobello 18.04.11studiogaribaldi100% (2)
- 26-Creatività e Pensiero DivergenteDocumento5 pagine26-Creatività e Pensiero DivergentealessioanginiNessuna valutazione finora
- ABA Bandini IMOLA 2019Documento70 pagineABA Bandini IMOLA 2019davbast78Nessuna valutazione finora
- DISTURBI EMOTIVI A SCUOLA Da Capitolo 1 A 4Documento20 pagineDISTURBI EMOTIVI A SCUOLA Da Capitolo 1 A 4lagima100% (1)
- Educare Alla Scelta Volume PrimoDocumento54 pagineEducare Alla Scelta Volume PrimoGa_VNessuna valutazione finora
- Disturbi D' Ansia in Età EvolutivaDocumento21 pagineDisturbi D' Ansia in Età EvolutivaAlessandro BelliNessuna valutazione finora
- 4895 - 9788859008552 - x353 - L Abc Delle Mie Emozioni 4 7 Anni PDFDocumento16 pagine4895 - 9788859008552 - x353 - L Abc Delle Mie Emozioni 4 7 Anni PDFconsiglia grandeNessuna valutazione finora
- Soluzione Pratica Per L-IperrattivitàDocumento48 pagineSoluzione Pratica Per L-IperrattivitàDaniela ElenaNessuna valutazione finora
- Piaget, Freud, Vigostkij e Altre TeorieDocumento10 paginePiaget, Freud, Vigostkij e Altre TeorieNico RicciNessuna valutazione finora
- Disabilità e Integrazione A ScuolaDocumento4 pagineDisabilità e Integrazione A ScuolaIlaria D'AmicoNessuna valutazione finora
- Sviluppo Emotivo Ed Affettivo Libro CamaioniDocumento22 pagineSviluppo Emotivo Ed Affettivo Libro CamaionisaraNessuna valutazione finora
- Progettare Per CompetenzeDocumento7 pagineProgettare Per CompetenzeElena SchievanoNessuna valutazione finora
- Introduzione Terapia Della GestaltDocumento2 pagineIntroduzione Terapia Della GestaltDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Apprendimento e Intelligenza: Il Metodo Feuerstein alla luce delle neuroscienze cognitiveDa EverandApprendimento e Intelligenza: Il Metodo Feuerstein alla luce delle neuroscienze cognitiveNessuna valutazione finora
- L'Educazione Razionale EmotivaDocumento4 pagineL'Educazione Razionale Emotivainmygrace5391Nessuna valutazione finora
- 21.autismo DiagnosiDocumento22 pagine21.autismo DiagnosiPerla BelloneNessuna valutazione finora
- Riassunto Psicologia Dello SviluppoDocumento51 pagineRiassunto Psicologia Dello Sviluppocorso aggiornamentoNessuna valutazione finora
- Correttore - Test Di Competenze Su Creatività e Pensiero DivergenteDocumento9 pagineCorrettore - Test Di Competenze Su Creatività e Pensiero DivergenteVichi Siri100% (1)
- Rogers e Il Problema Dell'empatiaDocumento2 pagineRogers e Il Problema Dell'empatiaMassimiliano MorescoNessuna valutazione finora
- DamasioDocumento3 pagineDamasioStefania DonarelliNessuna valutazione finora
- Didattica Laboratoriale e Formazione Di Luisa ZeccaDocumento56 pagineDidattica Laboratoriale e Formazione Di Luisa ZeccaPietroNessuna valutazione finora
- Programmi Di Intervento in AutismoDocumento8 pagineProgrammi Di Intervento in Autismoshoppo shoppiniNessuna valutazione finora
- Luigi D'alonzo - La Differenziazione Didattica Per L'inclusione - RiassuntoDocumento20 pagineLuigi D'alonzo - La Differenziazione Didattica Per L'inclusione - RiassuntoCamilla TottiNessuna valutazione finora
- Riassunto NeurodidatticaDocumento46 pagineRiassunto NeurodidatticaAntonio BonansingaNessuna valutazione finora
- C.A.A. e IN-book: Racconti Personalizzati Per L'inclusioneDocumento34 pagineC.A.A. e IN-book: Racconti Personalizzati Per L'inclusioneGiovanniNessuna valutazione finora
- Problemi Di Comportamento e Relazione Di AiutoDocumento52 pagineProblemi Di Comportamento e Relazione Di AiutoLiborio ScavoneNessuna valutazione finora
- Comunicazione AssertivaDocumento19 pagineComunicazione AssertivaGaetano Scorsone100% (2)
- L'educatore ImperfettoDocumento51 pagineL'educatore ImperfettoPaola BoeriNessuna valutazione finora
- Il LinguaggioDocumento10 pagineIl LinguaggioGiada PieralliniNessuna valutazione finora
- Tesina Lab GiocoDocumento13 pagineTesina Lab Giocoanon_650021551Nessuna valutazione finora
- AUTISMO - Linee Guida SinpiaDocumento82 pagineAUTISMO - Linee Guida SinpiatifososscnapoliNessuna valutazione finora
- GIUSTI - Raccolta GiurisprudenzialeDocumento147 pagineGIUSTI - Raccolta GiurisprudenzialeAnnalisa GianfeliceNessuna valutazione finora
- Giorgio Agamben - L'Albero Del LinguaggioDocumento11 pagineGiorgio Agamben - L'Albero Del Linguaggiodavi pessoaNessuna valutazione finora
- Iacopone Da Todi - LaudeDocumento303 pagineIacopone Da Todi - Laudejack_risos4334Nessuna valutazione finora
- Problema Dei TravasiDocumento10 pagineProblema Dei Travasidebugger20Nessuna valutazione finora
- Le Correnti Del Tempo - Il Libro Delle LamineDocumento3 pagineLe Correnti Del Tempo - Il Libro Delle LamineMarco DraghiNessuna valutazione finora
- AAVV - Canoni Calvinisti Di DordrechtDocumento24 pagineAAVV - Canoni Calvinisti Di DordrechtPapeSatanAleppeNessuna valutazione finora