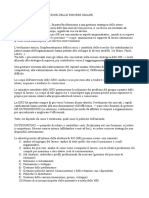Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Sole
Il Sole
Caricato da
Elena AcquadroTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Sole
Il Sole
Caricato da
Elena AcquadroCopyright:
Formati disponibili
IL SOLE
Linterno del sole contiene quasi tutta la massa della stella ed formato da:
-nucleo
-zona radiativa
-zona convettiva.
Il nucleo, che ha un raggio di circa 15000km la zona di produzione dellenergia, dove
lelio aumenta continuamente a spese dellidrogeno. Qui in funzione un vero e
proprio reattore nucleare a fusione, mantenuto stabile dalla forza di gravit. A quella
profondit, infatti, la pressione gravitazionale dellenorme involucro di materiali
sovrastanti in grado di contenere la violenza esplosiva delle reazioni termonucleari,
fatte innescare da temperature elevatissime, prossime ai 15 milioni di gradi kelvin.
Lenergia prodotta nel nucleo si trasmette verso lesterno attraverso la zona
radiativa (involucro gassoso). Gli atomi dei gas della zona radiativa assorbono ed
emettono energia, ma a causa della minore temperatura, non danno luogo a razioni
nucleari.
Nella zona convettiva il trasporto dellenergia avviene per convezione, cio
attraverso movimenti della materia innescati da differenze di temperatura.
La fotosfera linvolucro che irradia quasi tutta la luce solare e corrisponde, quindi,
alla superficie visibile del sole. Quella che vediamo, in realt, solo la parte sommitale
dellinvolucro di gas incandescente che costituisce lintera zona convettiva: la
trasparenza di tali gas infatti non totale e losservazione con i normali telescopi non
pu penetrare per pi di 400-500km. La temperatura media superficiale del sole di
5785 K e ad essa dovuto il colore giallo della stella. La superficie della fotosfera non
liscia, ma presenta una struttura a granuli brillanti, detta granulazione. Questi
granuli segnano laffiorare di gigantesche bolle di gas molto caldi e corrispondono alla
parte sommitale dei movimenti in atto nella sottostante zona convettiva. Inoltre, la
superficie brillante della fotosfera appare costellata, con una certa periodicit, da
macchie solari: piccole aree scure depresse rispetto alla superficie circostante, nelle
quali si distingue una zona centrale pi scura circondata da una fascia pi chiara. In
realt tali strutture appaiono scure solo per il contrasto con la litosfera. Losservazione
sistematica della superficie solare ha messo in evidenza che il numero di macchie non
costante, ma passa da valori minimi a valori massimi in modo ciclico ogni 11 anni.
Latmosfera solare divisa in due strati: la cromosfera e la corona.
La cromosfera un involucro trasparente di gas incandescenti che avvolge la
fotosfera. visibile per un breve tempo durante uneclissi totale di sole, quando la
luna nasconde completamente il disco della fotosfera. La cromosfera appare allora
come un sottile alone roseo, il cui bordo esterno sfrangiato in numerose punte
luminose dette spicole (diametro di 1000 km, altezza 15000km, velocit di
innalzamento 20/50 km/s): esse appaiono come un prolungamento verso lalto dei
moti turbolenti dei granuli della fotosfera. La cromosfera , in pratica, uno strato di
transizione a bassa temperatura tra la fotosfera e la corona.
La corona la parte pi esterna dellatmosfera solare ed formata da un involucro di
gas ionizzati sempre pi rarefatti. La sua luminosit cos bassa che la corona si pu
osservare direttamente solo durante uneclissi totale. Nella parte pi estrema della
corona le particelle ionizzate hanno velocit sufficienti per sfuggire allattrazione
gravitazionale del sole e si disperdono perci nello spazio come vento solare.
Lenergia irradiata dalla superficie legata solo alla temperature del sole chiamata
radiazione stazionaria.
Insieme al vento solare la radiazione stazionaria rappresenta la normale attivit solare.
Esistono per altri aspetti molto vistosi dellattivit della parte pi esterna del sole.
-la formazione e la scomparsa delle macchie solari a intervalli regolari di circa 11 anni
-le protuberanze: grandi nubi di idrogeno che si innalzano dalla cromosfera e
penetrano ampiamente nella corona. Sono molto pi calde della corona ma fredde
rispetto alla corona solare entro cui si spingono.
-i brillamenti (o flares): violentissime esplosioni di energia, veri e propri lampi di luce
intensissimi associati a potenti scariche elettriche. Nel corso di tali esplosioni la
temperatura pu raggiungere parecchi milioni di gradi e vengono liberate enormi
quantit di energia con unampia gamma di radiazioni, dai raggi X alle onde radio.
Oltre a radiazioni di carattere ondulatorio, i brillamenti possono lanciare getti di
materia gassosa incandescente fino a 10-20 000 km di altezza, ma soprattutto
emettono un intenso flusso di particelle atomiche (elettroni protoni) che lasciano il sole
verso lo spazio viaggiando ad alta velocit. Nel caso dei flares pi intensi, si osserva
anche lemissione di unultraradiazione (o radiazione cosmica), formata da particelle
ad altissima energia che si propagano a velocit prossima a quella della luce. Quando
un flare esplode presso il centro del disco solare (rispetto alla terra), nel giro di 26 ore
il flusso di particelle raggiunge il nostro pianeta. I velocissimi corpuscoli di origine
solare colpiscono con violenza le particelle ionizzate dellalta atmosfera soffiandole
verso la bassa atmosfera, dove danno origine alle aurore polari. Contemporaneamente
alle autore polari si verificano forti perturbazioni nel campo magnetico terrestre
chiamate tempeste magnetiche. Nel sole, quindi, si alternano periodi di attivit
normale a periodi di attivit pi intensa. Durante questi periodi alla radiazione
stazionaria si sommano:
-le radiazioni ondulatorie collegate soprattutto alla comparsa si macchie solari e
brillamenti
-i flussi di particelle atomiche, emesse soprattutto dai brillamenti
Tutti i fenomeni temporanei e periodici che caratterizzano lattivit dellatmosfera
solare risultano collegati in qualche modo ai cicli di 11 anni delle macchie solari, che a
loro volta sembrano condizionati da fluttuazioni del campo magnetico solare che
presente periodici e forti aumenti di intensit localizzati in numerose aree della
superficie.
Potrebbero piacerti anche
- Dialogo Della Natura e Di Un AnimaDocumento1 paginaDialogo Della Natura e Di Un AnimaElena AcquadroNessuna valutazione finora
- SimulazioneDocumento4 pagineSimulazioneapi-240178367Nessuna valutazione finora
- Il SoleDocumento4 pagineIl SoleantonioNessuna valutazione finora
- Tibaldi Il Sistema SolareDocumento38 pagineTibaldi Il Sistema SolareDaniele PulvirentiNessuna valutazione finora
- Il Sistema SolareDocumento8 pagineIl Sistema Solarenv7bmtvknrNessuna valutazione finora
- 4-Radiazione Solare PDFDocumento61 pagine4-Radiazione Solare PDFkonefavazzaNessuna valutazione finora
- Terra e Sistema SolareDocumento10 pagineTerra e Sistema SolareFla PessaNessuna valutazione finora
- Le StelleDocumento2 pagineLe StelleGelsomino GrilloNessuna valutazione finora
- Il Sistema SolareDocumento29 pagineIl Sistema SolareElle Erre EmmeNessuna valutazione finora
- La TerraDocumento6 pagineLa TerraMargit Vimercati SanseverinoNessuna valutazione finora
- Le AuroreDocumento2 pagineLe AuroreSara ToniniNessuna valutazione finora
- L Universo Intorno A NoiDocumento27 pagineL Universo Intorno A Noidayana acostaNessuna valutazione finora
- Lo Spettacolare Fenomeno Dell'Aurora PolareDocumento6 pagineLo Spettacolare Fenomeno Dell'Aurora PolareCozma Ionela CosminaNessuna valutazione finora
- Fisica Dei PianetiDocumento118 pagineFisica Dei Pianetiastrobo84100% (1)
- Il Clima e Il Bilancio Energetico Della TerraDocumento18 pagineIl Clima e Il Bilancio Energetico Della TerraPat Tab3Nessuna valutazione finora
- L Universo Capitolo 1Documento46 pagineL Universo Capitolo 1TheStarsOfYoutube TSOYTNessuna valutazione finora
- Geologia Muttoni Studocu - OKDocumento66 pagineGeologia Muttoni Studocu - OKdsofia2001Nessuna valutazione finora
- Modello Di Foglio Uso BolloDocumento4 pagineModello Di Foglio Uso BolloDomenico ZucaroNessuna valutazione finora
- Vita Di StellaDocumento80 pagineVita Di Stellaadriano germanoNessuna valutazione finora
- Sole DispensaDocumento22 pagineSole DispensaLuca CiaoNessuna valutazione finora
- GIOVEDocumento3 pagineGIOVEmarioNessuna valutazione finora
- Sistema Sol AreDocumento13 pagineSistema Sol AreMohammed RegraguiNessuna valutazione finora
- Programma ScienzeDocumento33 pagineProgramma ScienzeV.F.Nessuna valutazione finora
- 3 Media 12IL SISTEMA SOLARE ED I PIANETIDocumento14 pagine3 Media 12IL SISTEMA SOLARE ED I PIANETIcalonso134Nessuna valutazione finora
- L'UniversoDocumento6 pagineL'UniversoSara PerraNessuna valutazione finora
- L'universoDocumento5 pagineL'universogiulianinoemi52Nessuna valutazione finora
- Il Sistema SolareDocumento3 pagineIl Sistema SolareAlessandroNessuna valutazione finora
- Variabilità SolareDocumento2 pagineVariabilità SolareZoeyy RogersNessuna valutazione finora
- Campo Magnetico TerrestreDocumento3 pagineCampo Magnetico TerrestreNANCYNessuna valutazione finora
- UranoDocumento8 pagineUranoMartina CurtoNessuna valutazione finora
- Scardia Geografia ADocumento82 pagineScardia Geografia AAntonella PedronNessuna valutazione finora
- Powerpoint ScienzeDocumento20 paginePowerpoint ScienzeAngelo ZingaleNessuna valutazione finora
- StellaDocumento3 pagineStellaElisa CambòNessuna valutazione finora
- TERRADocumento6 pagineTERRALeonardo TovoNessuna valutazione finora
- Meccanica CelesteDocumento44 pagineMeccanica CelesteStefano TafaniNessuna valutazione finora
- L' Universo e Il Sistema SolareDocumento15 pagineL' Universo e Il Sistema SolareMELANIA FAZZINONessuna valutazione finora
- L'atmosferaDocumento7 pagineL'atmosferaNancyNessuna valutazione finora
- L'Universo e Il Sistema SolareDocumento31 pagineL'Universo e Il Sistema SolareCettina StancanelliNessuna valutazione finora
- UD2 Radiazione SolareDocumento57 pagineUD2 Radiazione SolareDensoRobotNessuna valutazione finora
- L'energia Della TerraDocumento7 pagineL'energia Della TerraMaria Chiara SciaccaNessuna valutazione finora
- GeografiaDocumento101 pagineGeografiasenorbronsonNessuna valutazione finora
- Capitolo 4 LunaDocumento9 pagineCapitolo 4 LunaPeppe ViscianoNessuna valutazione finora
- Presentazione Sul Sistema SolareDocumento29 paginePresentazione Sul Sistema SolareEdoardo MigliavaccaNessuna valutazione finora
- Evoluzione StellareDocumento5 pagineEvoluzione StellareBenedetta RussoNessuna valutazione finora
- Il Sistema SolareDocumento9 pagineIl Sistema SolareGiulia BalestraNessuna valutazione finora
- I FulminiDocumento38 pagineI FulminifukinagashiNessuna valutazione finora
- Cavazzuti Powerpoint 52059 c2Documento30 pagineCavazzuti Powerpoint 52059 c2DDM008Nessuna valutazione finora
- Formazione Dei FulminiDocumento2 pagineFormazione Dei FulminiMichele TaddeoNessuna valutazione finora
- Ciclo Vitale Del SoleDocumento2 pagineCiclo Vitale Del Soleluca raveraNessuna valutazione finora
- Le EclissiDocumento2 pagineLe EclissiLuca ToralboNessuna valutazione finora
- Power Point LunaDocumento13 paginePower Point LunaTiziano De BenedettiNessuna valutazione finora
- 03 Sistema SolareDocumento92 pagine03 Sistema Solaretomaoana011Nessuna valutazione finora
- PIANETIDocumento13 paginePIANETIgiovanniNessuna valutazione finora
- Descarcari Electrice in AtmosferaDocumento8 pagineDescarcari Electrice in AtmosferaDiana TureacNessuna valutazione finora
- Teorema Viriale-Struttura StelleDocumento25 pagineTeorema Viriale-Struttura StelleFederico Teodoro FigheraNessuna valutazione finora
- Terrae LunaDocumento24 pagineTerrae LunaParole DamoreNessuna valutazione finora
- UranoDocumento5 pagineUranomariachiaratandaNessuna valutazione finora
- AtmosferaDocumento9 pagineAtmosferaMariassunta MinonneNessuna valutazione finora
- Appunti Gestione Risorse UmaneDocumento10 pagineAppunti Gestione Risorse UmaneElena AcquadroNessuna valutazione finora
- Giovanni VergaDocumento2 pagineGiovanni VergaElena AcquadroNessuna valutazione finora
- Scienze I Fenomeni SismiciDocumento3 pagineScienze I Fenomeni SismiciElena AcquadroNessuna valutazione finora
- Riassunto Psicologia Dello SviluppoDocumento15 pagineRiassunto Psicologia Dello SviluppoElena Acquadro100% (1)
- Destra e Sinistra HegelianaDocumento1 paginaDestra e Sinistra HegelianaElena AcquadroNessuna valutazione finora
- Annales XV 57Documento1 paginaAnnales XV 57Elena AcquadroNessuna valutazione finora
- Tarea FisicaDocumento4 pagineTarea FisicaPzl AndyNessuna valutazione finora
- Esercizi Struttura Atomo Proprieta' Periodiche Legame Ionico PDFDocumento4 pagineEsercizi Struttura Atomo Proprieta' Periodiche Legame Ionico PDFverne571Nessuna valutazione finora
- Program MaDocumento1 paginaProgram MaBraccialetti RossiNessuna valutazione finora
- Rifasamento e Filtraggio Delle Armoniche Negli Impianti ElettriciDocumento62 pagineRifasamento e Filtraggio Delle Armoniche Negli Impianti ElettricisbonaffinoNessuna valutazione finora
- Lucidi RaggixDocumento62 pagineLucidi RaggixSalvatore IgnazziNessuna valutazione finora
- Il Modello Atomico Di Roberto MontiDocumento3 pagineIl Modello Atomico Di Roberto Montiask5230100% (1)
- TAVOLA SINOTTICA D.Lgs. 192/2005 - L. 90/2013 - D.Lgs. 28/2011 - D.M.26/6/2015Documento2 pagineTAVOLA SINOTTICA D.Lgs. 192/2005 - L. 90/2013 - D.Lgs. 28/2011 - D.M.26/6/2015Marco MuroniNessuna valutazione finora
- L'Energia NucleareDocumento6 pagineL'Energia Nucleareaverage-joeNessuna valutazione finora
- La UNI TS 11300 - Parti 1, 2, 3 e 4 - Determinazione Delle Prestazioni Energetiche Degli Edifici - Un Lungo CamminoDocumento52 pagineLa UNI TS 11300 - Parti 1, 2, 3 e 4 - Determinazione Delle Prestazioni Energetiche Degli Edifici - Un Lungo Camminopietro1953100% (1)
- Asta Corpo RigidoDocumento5 pagineAsta Corpo RigidofiorenzogaudenzioNessuna valutazione finora