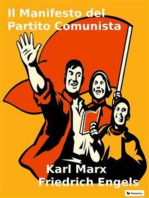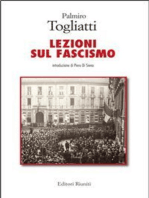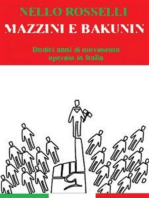Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
La Crisi Dello Stato Liberale Italiano
Caricato da
sofia0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2 visualizzazioni7 pagineTitolo originale
La crisi dello Stato liberale Italiano
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2 visualizzazioni7 pagineLa Crisi Dello Stato Liberale Italiano
Caricato da
sofiaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 7
La crisi dello Stato liberale Italiano.
I problemi economici e sociali della ricostruzione.
Dal confitto l'Italia era uscita vincitrice, ma stremata per lo sforzo compiuto e dominata da gravi
difficoltà economiche e da profondi contrasti sociali. Le casse dello Stato avevano infatti
accumulato elevatissimi debiti; la produzione agricola era diminuita per l'abbandono dei campi
durante la guerra. A loro volta le industrie pesanti, quali la siderurgica e la meccanica, erano
costrette a provvedere in tempi brevi a una riconversione produttiva, cioè il passaggio da
un'economia di guerra a un'economia di pace.
Il ristagno economico e la caduta generale del tenore di vita riducevano notevolmente il mercato
interno. La disoccupazione cresceva a ritmo incalzante. Lo sforzo di conversione era aggravato
dalla contemporanea crisi che travagliava le banche italiane, dimostratesi incapaci di porre in atto
un valido sostegno creditizio nei confronti dell'industria, a causa dei consistenti prestiti a lungo
termine già effettuati durante il periodo bellico e alla difficoltà del loro recupero. Ci fu il crollo di
importanti istituti bancari con immediati riflessi negativi su tutto il sistema industriale.
Di qui un inevitabile peggioramento delle già difficili condizioni di vita dei lavoratori; di qui
un'esasperazione dei conflitti sociali, che dette l'avvio a due anni tormentati nella storia politica
italiana, definiti biennio rosso, (1919-1920), in quanto caratterizzati da agitazioni operaie a sfondo
rivoluzionario, che culminarono nell'occupazione delle fabbriche.
Il dopoguerra era per di più travagliato da un profondo senso di frustrazione, alimentato da tutta una
serie di interrogativi sul reale significato dei sacrifici sopportati a fronte degli esigui risultati
ottenuti dal conflitto. Ebbe una forte presa su larga parte dell'opinione pubblica il mito della vittoria
mutilata, divenuto ben presto il cavallo di battaglia di nazionalisti prima e dei fascisti poi.
Ad appesantire la situazione contribuiva anche la smobilitazione dei circa 6 milioni di uomini
chiamati alle armi dall'inizio del conflitto e che ora si trovavano inaspettatamente senza
occupazione.
In questo difficile contesto si determinò un evento che avrebbe poi avuto molta influenza sulla vita
politica della penisola e sul suo sviluppo storico. Il pontefice Benedetto 15 permise la fondazione
del partito popolare italiano, divenuta una realtà a Roma il 18 gennaio 1919 per iniziativa di Don
Luigi Sturzo ed alcuni deputati a lui vicini. Don Luigi Sturzo era un sacerdote e uomo politico
italiano. Nonostante la sua inclinazione agli studi filosofici e teologici, fu forte la passione sociale e
politica. Fu attento osservatore del messaggio di Don Romolo Murri e cercò di applicarlo con
prudenza, pur senza partecipare alla vita della Democrazia Cristiana a livello nazionale. Fondò il
partito popolare italiano con coloro che aderirono al suo "appello a tutti gli uomini liberi e forti", al
fine di dare rappresentanza politica alle masse cattoliche, ancora prive di un proprio partito.
L'intenzione era quella di spezzare l'egemonia del partito socialista sulle masse popolari, soprattutto
contadine, contrapponendogli un partito cattolico moderato. Don Sturzo voleva creare un partito
democratico e aconfessionale, con un programma ricco di proposte progressiste. Tra i punti più
qualificanti del programma del nuovo partito vi era una radicale riforma agraria, che interessava i
ceti medi rurali. In base a essa il proprietario avrebbe cessato di essere il padrone per diventare al
pari dei contadini e dei salariati un socio dell'azienda agricola: in tal modo avrebbe riscosso un certo
interesse per il capitale offerto e, insieme agli altri soci, avrebbe diviso gli utili a fine anno.
Il programma prevedeva inoltre l'estensione del voto alle donne, una maggiore autonomia locale,
cioè maggior decentramento, in contrasto con il centralismo liberale e giolittiano; l'attenzione nei
confronti del problema operaio era invece molto limitata. Dal pensiero cattolico provenivano
l'ideale della tutela della famiglia e delle libere associazioni, le "comunità intermedie". Fu
Favorevole ad una legislazione sociale e riforma fiscale che tutelasse le classi sociali più deboli e
conferisse carattere di progressività alle imposte. In politica internazionale appoggiò il programma
di Wilson dei 14 punti e credette nella funzione pacificatrice della società delle nazioni.
La composizione sociale del partito popolare italiano era interclassista e la sua organizzazione
poteva contare sull'appoggio di banche, giornali, organizzazioni del movimento cattolico popolare,
cooperative e sindacati cattolici. Vi era una certa eterogeneità politica: intorno alla posizione di
Sturzo si formarono una destra conservatrice e una sinistra democratica e sociale. Il partito verrà
sciolto nel 26 quando il fascismo divenne regime a partito unico.
Nelle masse, in seguito alla delusione per la vittoria mutilata, andarono invece riaccendendosi i
rancori e le lotte fra i nazionalisti e gli ex interventisti di destra da una parte e vecchi neutralisti
dall'altra: i primi disposti a riprendere le armi per correggere le storture della conferenza di Parigi, i
secondi avversi ad ogni forma di violenza, considerata negativa, pericolosa, inopportuna.
Un'identica tendenza all'attivismo si poteva notare a livello sociale: gruppi sempre più numerosi di
persone davano infatti origine ad uno stato di agitazione permanente contro il carovita.
A tutto ciò si aggiungevano le difficoltà interne del maggior partito di massa, quello socialista, che
vedeva sempre più nettamente prevalere la corrente massimalista, avversa ad ogni collaborazione
con lo Stato borghese e pertanto in netto contrasto con i riformisti, che facevano capo a Filippo
turati. I seguaci del socialismo massimalista e del suo leader Giacinto Menotti Serrati, erano
convinti che fosse ormai prossimo anche in Italia l'avvento della rivoluzione proletaria di tipo
sovietico: compito del partito socialista era pertanto quello di preparare il proletariato alla lotta e
alla ribellione intensificando le agitazioni, considerate come una "ginnastica rivoluzionaria",
evitando ogni compromesso con il nemico di classe.
Questa impostazione appariva però ben lontana dal proporre un piano d'azione concreto e capace di
portare il partito aldilà della semplice diffusione di parole d'ordine vaghe e generiche. Proprio gli
esponenti riformisti non perdevano occasione per sottolineare che il partito, in attesa di una
rivoluzione che non si realizzava, tendeva ormai sempre più a rinunciare all'uso di strumenti in
grado di attuare alcuni fondamentali miglioramenti e di avviare una progressiva trasformazione
sociale e di convivenza democratica. Proprio mentre la polemica tra le due correnti del partito
socialista si faceva sempre più rovente, se ne veniva costituendo una terza, legata ad Amedeo
Bordiga e al giornale torinese "l'ordine nuovo" fondato nel 1919 da una vivace Elite intellettuale
che ebbe tra gli esponenti più rappresentativi Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti.
Gramsci fu un pensatore di grande originalità, che approfondì la conoscenza del pensiero di Lenin.
Entrò in contrasto con la direzione massimalista del partito socialista accusata di rivoluzionarismo
verbale e inconcludente, e si fece sostenitore di un progetto di rivoluzione italiana, fondata
sull'alleanza tra operai del nord, contadini del sud, intellettuali progressisti e sulla "democrazia
proletaria" incentrata sui consigli di fabbrica. Arrestato nel novembre del 1926, Gramsci fu
processato e condannato dal tribunale fascista a 20 anni di prigione. Scrisse i "quaderni dal
carcere", pubblicati a partire dal 1948. Morì in una clinica romana prima di essere tornato in libertà.
Gramsci si interrogò sulle condizioni necessarie per avviare una trasformazione della società in
senso socialista. Fattore decisivo e' il "gruppo sociale fondamentale": un gruppo sociale si afferma
come fondamentale quando diventa cosciente della sua condizione e coinvolge altri gruppi in questa
coscienza. Gramsci parlò di blocco storico cioè l'unificazione culturale e politica dei diversi gruppi
sociali intorno a quello fondamentale. Egli accentuò rispetto alla tradizionale dottrina di Max il
momento culturale e politico del divenire sociale rispetto al momento economico. All'interno della
sovrastruttura attribuì il primato alla società civile, al momento culturale e politico della
persuasione, subordinando alla società civile lo Stato inteso come apparato coercitivo, esercizio di
forza. Sostenne l'importanza di una riforma intellettuale e morale della società rispetto al momento
della conquista del potere politico. Da qui il problema degli intellettuali: essi dovevano attuare
l'unificazione culturale della società. Dal Rinascimento in poi gli intellettuali si erano staccati dal
popolo. Da questi intellettuali si differenzia l'intellettuale organico, cioè colui che si preoccupa dei
problemi delle masse, ne da' una interpretazione coerente che diventi mentalità di tutta la società.
Solo il proletariato può unificare culturalmente la società: è il partito stesso l'intellettuale organico
per eccellenza, è la realizzazione della volontà collettiva. Compito della filosofia e' elaborare la
concezione del mondo del gruppo egemone e favorirne la penetrazione all'interno della società. La
filosofia viene funzionalizzata alla prassi. Nel mondo sociale ciò che si prevede e' solo la lotta. I
singoli momenti di essa sono prevedibili, nella misura in cui si opera per realizzarli. La storia e'
attività pratica di gruppi sociali, in lotta per l'egemonia.
Ad ostacolare in Italia un costruttivo sviluppo della vita democratica contribuiva l'indisponibilità
dei partiti a trovare una base d'intesa: il partito liberale, infatti, male accettava il programma del
partito popolare, giudicato troppo avanzato; dal canto suo il partito socialista tendeva ad acuire il
proprio anticlericalismo e a rifiutare l'intesa con i popolari, accusati a loro volta di essere sensibili
solo al problema contadino.
L'emergere dell'attivismo fascista e la questione di fiume
Di tale stato di cose seppe abilmente approfittare l'ex socialista ed ex interventista Benito Mussolini,
il quale, rientrato dal fronte, si era messo a difendere dalle colonne del suo giornale "il Popolo
d'Italia" i risultati della guerra vittoriosa contro l'arrendevolezza e l'incomprensione della classe
dirigente. Dotato di una non comune capacità oratoria e per di più sicuro di poter contare su
finanziamenti internazionali, era riuscito a raccogliere intorno a sé alcuni simpatizzanti fra i
nazionalisti, gli ex combattenti e giovani della media borghesia, con l'appoggio dei quali il 23
marzo 1919 aveva fondato a Milano, in un vecchio stabile di piazza San sepolcro, i fasci di
combattimento. Il fascio simboleggiava la promessa del movimento: se l'Italia fosse riuscita a
diventare unita, eliminando i contrasti interni fomentati dei socialisti, sarebbe diventata una grande
potenza come la Roma antica. Il fascio dà impressione di unità e forza; è infatti un insieme di
elementi stretti e legati tra di loro. Il fascio littorio comprendente vari bastoni e una scure, era
portato sulla spalla da coloro che nell'antichità scortavano i magistrati romani.
Il programma del nuovo movimento, il cosiddetto programma di San Sepolcro, prevedeva, in
politica estera, la lotta contro tutti gli imperialismi nonché l'adesione alla società delle nazioni. In
politica interna chiedeva l'instaurazione della Repubblica con ampie autonomie regionali e
comunali, il suffragio universale esteso anche alle donne, l'abolizione del Senato quale espressione
della reazione aristocratico borghese in quanto di nomina regia, l'eliminazione dei titoli nobiliari,
della polizia politica e della coscrizione obbligatoria. Il programma prevedeva inoltre un ampio
piano di riforme economiche e sociali, che prevedevano il pagamento dei debiti dello Stato da parte
delle classi più abbienti, la lotta alle speculazioni borsistiche e bancarie, il censimento delle
ricchezze in vista di un'adeguata tassa sul patrimonio. Prevedeva inoltre la terra ai contadini, la
partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende, la concessione di industrie e servizi pubblici a
organizzazioni operaie, la riduzione dell'orario lavorativo alle otto ore giornaliere. Voleva inoltre il
sequestro di tutti beni delle congregazioni religiose.
Secondo alcuni storici questo programma costituiva l'essenza del fascismo antecedente al
compromesso effettuato con la classe dirigente italiana all'atto della presa del potere, (fascismo
movimento in contrapposizione a fascismo regime), e riassumeva in sè i valori dei ceti medio bassi,
ostili sia ai poteri plutocratici, basati cioè sulla ricchezza, sia ai socialisti che fomentavano i
contrasti di classe e che impedivano l'unità della nazione. Il programma di Sansepolcro raccoglieva
tuttavia un insieme di posizioni generiche e disparate, dal repubblicanesimo all'anticlericalismo, da
richieste progressiste a rivendicazioni di tipo reazionario. La linea politica dei fasci, appare ancora
decisamente spostata a sinistra, piena di rivendicazioni sociali, ma nello stesso tempo, il programma
insisteva sulla necessità di una politica estera intesa a valorizzare l'Italia nel mondo. Il movimento si
proponeva di fondere insieme socialismo, e quindi riforme sociali, e l'idea di nazione. Mussolini
tendeva a considerare i fasci di combattimento più come un movimento politico duttile ed elastico
che come un vero partito, fermo nella sua ideologia. "Noi fascisti, affermava allora, ci permettiamo
il lusso di essere aristocratici e democratici, conservatori e progressisti, a seconda delle circostanze
di tempo, di luogo e di ambiente. I fascisti non hanno dottrine prestabilite: la loro unica tattica e'
l'azione".
Era questa l'impressione che il fascismo delle origini suscitò in osservatori attenti: il fascismo non
aveva ancora rivelato il suo vero volto e pertanto difficilmente poteva essere giudicato. Tutti erano
certi dell'inconsistenza del fenomeno, che ritenevano destinato a rientrare ben presto nei limiti dello
Stato liberale o a sparire.
In questo difficile contesto venne a inserirsi la questione di Fiume. Insorta durante la conferenza di
Parigi e riguardante la sistemazione del confine italiano con il nuovo regno di Jugoslavia, tale
questione costituì un motivo di aspri dissidi e lunghe discussioni. I termini della contesa erano i
seguenti: se si intendeva tenere conto del criterio di nazionalità, l'Italia avrebbe dovuto tenere la
città di Fiume, i cui abitanti erano italiani, ma non la Dalmazia, dove la popolazione era quasi tutta
slava; se si voleva invece prendere in considerazione quanto era stato stabilito con il patto di
Londra, all'Italia sarebbe spettata la Dalmazia ma non Fiume, che in quel trattato non era neppure
menzionata. La posizione italiana era chiara: il patto di Londra andava rispettato quindi Dalmazia e
Istria dovevano passare all'Italia con l'aggiunta di Fiume, in quanto la maggioranza della sua
popolazione italiana aveva espresso pubblicamente la propria volontà di annessione al paese di
origine. Francia e Inghilterra non vedevano di buon occhio un aumento dell'influenza italiana
sull'Adriatico e neppure il presidente americano Wilson si mostrava disponibile alle richieste
italiane, deciso com'era a difendere il principio di nazionalità, in virtù del quale gli slavi dovevano
riunirsi in un unico Stato. Ecco perché da parte dei tre ex alleati vennero esercitate pressioni di ogni
genere sui rappresentanti italiani Orlando e Sonnino, al fine di indurli a non pretendere
l'applicazione letterale delle clausole del patto di Londra e a non insistere sull'annessione di Fiume.
A quel punto il presidente Orlando commise l'ingenuità di abbandonare sdegnosamente la
conferenza, con un gesto che ebbe un esito negativo, poiché gli alleati in sua assenza discussero la
questione delle colonie tedesche, senza tenere conto dell'Italia.
A causa di tali avvenimenti, nel giugno del 1919 il governo Orlando cadde e venne sostituito da un
altro ministero liberale, retto dall'economista Francesco Saverio Nitti che raggiunse con le potenze
vincitrici un accordo in base al quale Fiume sarebbe stata evacuata dalle truppe italiane, che fino
allora l'avevano presidiata, e affidata a reparti alleati in attesa di una definitiva soluzione del
problema.
Tale decisione esasperò gli ambienti nazionalisti al punto da indurre Gabriele D'Annunzio ad
organizzare la cosiddetta marcia di Ronchi. Egli nella notte tra l'11 e il 12 settembre 1919, alla testa
di un gruppo di volontari e di un consistente numero di ufficiali e soldati, partì da Ronchi, nel
Friuli-Venezia Giulia per occupare Fiume, dove instaurò un governo provvisorio sotto il nome di
reggenza del Carnaro ( nome del golfo omonimo) e proclamò l'annessione della città All'Italia. Di
fronte a tale situazione Nitti dette palese prova di debolezza in quanto non assunse una ferma
posizione né a favore né contro gli eventi di fiume, infatti sperava nella riapertura del tavolo delle
trattative con le potenze.
Le prime elezioni politiche del dopoguerra, nel novembre 1919, evidenziarono la crisi del
liberalismo e sancirono il successo dei socialisti e dei cattolici. Nel giugno 1920 Nitti si dimise e il
governo passò a Giolitti, più aperto alle rivendicazioni popolari.
Anche Giolitti però ben poco poté fare a causa soprattutto del carattere organico della crisi liberale,
manifestatasi nella sua fase più acuta proprio in quei difficili mesi, allorché sembrava che anche in
Italia ci fossero tutte le condizioni per una rivoluzione socialista come quella che un paio d'anni
prima si era affermata in Russia. Di qui una serie di scioperi a catena, di prolungate agitazioni di
massa, che miravano al rinnovo del contratto salariale, al fine di adeguare gli stipendi all'aumento
del costo della vita; gli industriali, dal canto loro, rifiutarono ogni concessione, trovandosi in
difficoltà sia per i problemi derivanti dalla riconversione delle strutture, sia per le pesanti tasse
imposte dal governo, sia infine per la resistenza opposta dalle banche alle loro richieste di prestiti.
Ne derivò uno stato di gravissima tensione, che segnò il periodo culminante del biennio rosso, 1919
-1920.
Di fronte alla decisione degli industriali di non concedere gli aumenti salariali, i lavoratori
metalmeccanici del Nord aderenti al sindacato Fiom, (federazione impiegati operai metallurgici),e
più in particolare quelli del triangolo industriale Torino-Milano-Genova, procedettero
all'occupazione di oltre 600 fabbriche, metallurgiche, delle ferrovie, dei trasporti, i portuali di
Genova e Savona. In molti stabilimenti l'attività lavorativa non venne interrotta e fu aumentata la
produzione, volendo dimostrare che la fabbrica funzionava anche con una gestione collettiva. Nello
stesso tempo si procedette ad una difesa delle strutture occupate contro una eventuale irruzione
delle forze dell'ordine. La situazione era divenuta pertanto molto grave e avrebbe potuto sfociare in
una guerra civile, se Giolitti non si fosse opposto alle richieste di tipo autoritario avanzate dagli
industriali. Egli dette ordine alla forza pubblica di non assalire le fabbriche, ma al tempo stesso di
non permettere l'uscita degli operai in armi dai luoghi di lavoro e di creare a scopo puramente
difensivo assembramenti di truppe nei punti strategici della città. A quel punto però Giolitti cercò di
risolvere la crisi attraverso un accordo perseguito tra il 12 e 20 settembre 1920 e raggiunto con la
collaborazione dei sindacati. Così, dopo ben 7 settimane di lotta, la vertenza poté considerarsi
conclusa con insoddisfazione di tutti. Gli industriali ritennero di avere subito una grave disfatta,
avendo dovuto non solo accettare il progetto di un controllo operaio sulle aziende, progetto di legge
che poi verrà accantonato, ma anche prendere atto dell'atteggiamento assunto dal governo,
considerato troppo favorevole allo spirito rivoluzionario delle masse. Infatti Giolitti obbligò gli
industriali a concedere dei miglioramenti salariali. Gli operai dal canto loro, condizionati dai
mancati rifornimenti di materie prime, abbandonati dai tecnici e dagli ingegneri e guidati con poca
chiarezza di obiettivi dalla direzione dei sindacati e del partito socialista, si erano trovati
nell'impossibilità di autogestire le fabbriche e avevano quindi dovuto rinunciare all'occupazione. A
uscire provato dall'intricata situazione fu anche Giolitti, che si trovò sommerso da una valanga di
accuse provenienti da ogni parte. A confortare il vecchio statista intervenne però la soluzione della
questione di Fiume. Egli infatti per mezzo del ministro degli esteri Carlo sforza, aveva preso già da
tempo contatti con la Jugoslavia. Il 12 novembre 1920, con la firma del trattato di Rapallo, Italia
ottenne la città di Zara, (oggi in Croazia), le isole di Cherso, Lussino, Lagosta e Pelagosa, mentre
Fiume venne dichiarata città libera, cioè non appartenente né alla sovranità italiana a quella
jugoslava; la restante parte della Dalmazia fu invece sottoposta alla Jugoslavia.
Di fronte a tale iniziativa diplomatica, D'Annunzio e i suoi seguaci dovettero lasciare la città, il 18
gennaio 1921.
In tutta questa vicenda Mussolini ebbe un atteggiamento ambiguo. Egli infatti, dopo aver dichiarato
nel 1919 che il vero governo risiedeva non a Roma bensì a fiume, nel 1920 riconobbe "l'inevitabile
logica di Rapallo". Che cosa era avvenuto di tanto rilevante da determinare un'imprevedibile
voltafaccia? Mussolini aveva fiutato il cattivo tempo e con realismo politico aveva evitato di
mettersi fuori dalla legalità. Infatti i conservatori non l'avrebbero mai seguito sulla via dell'impresa
fiumana, che avrebbe implicato tra l'altro una rottura delle alleanze e delle amicizie dell'Italia con le
potenze dell'intesa. La pista da battere rimaneva per Mussolini quella della lotta contro il socialismo
e le forze dei nuovi partiti di massa, che avevano messo in crisi il vecchio assetto economico e
sociale del paese. Solo ponendosi su tale via, egli avrebbe potuto trovare consensi e collegamenti
necessari alla sua ascesa politica. Con tutto ciò non va dimenticato che fu proprio Mussolini nel
1924, nella sua qualità di capo del governo, ad affrontare di nuovo la questione ed avviare la
soluzione con un accordo siglato a Roma, in base al quale veniva accettata l'annessione di Fiume
all'Italia, fatta eccezione per il sobborgo di Susak assegnato alla Jugoslavia e trasformato nel vero
porto della città.
Giorni ancora più travagliati e difficili erano comunque alle porte. I Liberali non esercitavano più
un ruolo di primo piano, proprio mentre il fascismo diventava di giorno in giorno sempre più
aggressivo nei confronti dei socialisti, intensificando gli atti di violenza ai danni delle sedi di
partito, delle cooperative e delle leghe operaie.
Nel frattempo all'interno del partito socialista Italiano il divario tra riformisti e massimalisti da una
parte e la corrente comunista dall'altra si accentuò al punto da rendere inconciliabili due diversi
modi di intendere il partito. Ne derivò una situazione di rottura, che finì per condurre il partito
socialista Italiano ad una scissione: nel corso del congresso socialista di Livorno, infatti, la
minoranza di estrema sinistra dette vita, il 21 gennaio 1921 al partito comunista, in origine partito
comunista d'Italia.
Intanto il governo assisteva pressoché indifferente al diffondersi della violenza fascista,
considerandola non pericolosa per la stabilità delle istituzioni. Per risanare il bilancio statale,Giolitti
pose mano ad alcune riforme importanti, tese ad aumentare la pressione fiscale sui ceti ricchi: il che
accentuò il malumore delle destre, rendendo sempre meno stabile la posizione del presidente del
consiglio il quale decise di ricorrere allo scioglimento anticipato delle camere e di indire nuove
elezioni nel maggio 1921. A tale scopo i giolittiani costituirono un'alleanza elettorale con
nazionalisti e fascisti, il blocco nazionale, sulla base del comune obiettivo di sconfiggere i partiti di
massa. I risultati usciti dalle urne non premiarono i liberali con l'auspicata maggioranza, ma
consacrarono invece l'ascesa del fascismo al parlamento con ben 35 deputati eletti: tra essi lo stesso
Mussolini, il quale nel corso di un congresso tenuto a Roma dal 7 all'11 novembre 1921 riusciva a
far votare un ordine del giorno per la trasformazione del movimento in partito nazionale fascista. La
metamorfosi era ormai completata: sorto come realtà ambigua, ma comunque aperta a sollecitazioni
e tematiche socialiste, il fascismo si era ormai schierato su posizioni di difesa a oltranza degli
interessi borghesi e della proprietà privata, di opposizione violenta nei confronti di tutti coloro che
avevano tentato di far progredire il movimento dei lavoratori nelle campagne e nelle città. Le
ragioni del crescente successo del nuovo partito vanno ricercate nel comportamento dei ceti medi,
ma soprattutto della piccola borghesia che, non protetta dalle organizzazioni sindacali come lo era il
proletariato e del tutto indifesa nei confronti dello strapotere economico della grande borghesia,
tendeva a rivendicare un proprio spazio vitale. Nel generale turbamento dello stato, i fascisti
finirono però per trovare il sostegno anche della grande borghesia agraria e industriale, convinta di
poter strumentalizzare il movimento in senso antisocialista e quindi di poterlo facilmente liquidare.
D'altra parte, la grande borghesia e i ceti medi erano tenuti insieme soprattutto dall'impressione
suscitata dagli avvenimenti del settembre 1920: l'occupazione delle fabbriche era apparsa loro come
un attentato alla proprietà privata, come un chiaro segno di sovvertimento dell'ordine costituito,
come un nuovo passo verso la conquista del potere da parte della classe operaia.
L'Elemento decisivo per un radicale mutamento della situazione politica erano state le elezioni del
maggio del 1921, che avevano sancito l'ascesa del fascismo e determinato la caduta del governo
Giolitti, accusato dalle destre di troppa remissività nei confronti dei rossi e di ostilità nei riguardi
delle classi più elevate, sulle quali egli aveva fatto ricadere una maggiore pressione fiscale. Una
volta ottenuta nelle elezioni del maggio del 1921 una patente di rispettabilità con l'ingresso in
parlamento e verificatosi la caduta del governo Giolitti, Mussolini, dette via libera alle squadre
d'azione. Il movimento fascista intrapreso la strada della violenza. Finanziato, armato rifornito di
mezzi dai grandi proprietari terrieri, il fascismo si organizzò in squadre d'azione che avevano
l'obiettivo di smantellare l'organizzazione politica e sindacale di matrice socialista e cattolica.
Furono bruciati tipografie di giornali e sedi di riunione. I membri di queste bande armate vestivano
la camicia nera, indossata durante la guerra dai reparti d'assalto del nostro esercito, avevano come
distintivo il fascio littorio ed erano muniti di corti bastoni ferrati, i manganelli, simbolo di una
violenza che avrebbe assicurato loro la giustizia diretta. Loro preciso compito era quello di assalire
e disperdere con la forza le associazioni socialiste e cattoliche e di mettere a tacere gli esponenti
politici dei partiti di sinistra. I membri delle squadre d'azione erano appartenenti ai ceti medi
piccolo borghesi ed erano giovani o adolescenti. Di fronte a tale tendenza a farsi giustizia da sé e a
creare un regime di terrore con la tecnica delle spedizioni punitive e delle manganellate, il nuovo
governo Bonomi pensò di poter riservare ai fascisti una larga tolleranza, lasciando libero corso degli
eventi, nella certezza di poterli frenare al momento opportuno. Questa volta però commetteva un
grosso errore, non rendendosi conto che le forze fasciste non erano destinate a rientrare nella
legalità: esse trovavano valido sostegno economico non soltanto presso l'alta borghesia, ma anche
presso gli esponenti della classe politica liberale, nonché presso gli organi dello Stato come
prefetture e questure e dell'esercito, ma soprattutto presso quei settori della piccola e media
borghesia che più temevano l'eversione rossa.Le forze dell'ordine non intervennero per difendere le
vittime degli squadristi, anzi i fascisti erano preziosi alleati che riportavano la pace sociale e
rimettevano le masse al loro posto.
Potrebbero piacerti anche
- Neri come la morte: Lo squadrismo italiano dalle origini al regimeDa EverandNeri come la morte: Lo squadrismo italiano dalle origini al regimeNessuna valutazione finora
- FascismoDocumento7 pagineFascismoSilvia FerrariNessuna valutazione finora
- Rapporti tra Stato e Chiesa. La revisione del 1984Da EverandRapporti tra Stato e Chiesa. La revisione del 1984Nessuna valutazione finora
- Perché non si stava meglio quando si stava peggioDa EverandPerché non si stava meglio quando si stava peggioNessuna valutazione finora
- Che torni la Democrazia Cristiana. Il trionfo del popolo è il sapereDa EverandChe torni la Democrazia Cristiana. Il trionfo del popolo è il sapereNessuna valutazione finora
- I Fasci Di CombattimentoDocumento5 pagineI Fasci Di CombattimentoFrancesca BrescianiNessuna valutazione finora
- Ultima LezioneDocumento2 pagineUltima LezioneGiulia SantanielloNessuna valutazione finora
- Fascismo STORIA CONT.Documento9 pagineFascismo STORIA CONT.901243Nessuna valutazione finora
- I giorni della violenza e dell’attesa.: Brescia cattolica e il dramma di Aldo Moro.Da EverandI giorni della violenza e dell’attesa.: Brescia cattolica e il dramma di Aldo Moro.Nessuna valutazione finora
- Storia Della Repubblica Italiana Dalla Liberazione Ad OggiDocumento39 pagineStoria Della Repubblica Italiana Dalla Liberazione Ad OggiSam StiflerNessuna valutazione finora
- FascismoDocumento23 pagineFascismoMaria Elena ApollonioNessuna valutazione finora
- L'evoluzione dell'immagine della donna nell'Italia degli anni CinquantaDa EverandL'evoluzione dell'immagine della donna nell'Italia degli anni CinquantaNessuna valutazione finora
- Italia Nel Secondo Dopo GuerraDocumento3 pagineItalia Nel Secondo Dopo GuerracescaNessuna valutazione finora
- Avvento Del FascismoDocumento2 pagineAvvento Del FascismoGaia RiccardiNessuna valutazione finora
- Gli anni di piomboDocumento3 pagineGli anni di piombohyfrhvqttnNessuna valutazione finora
- Pericolosi sovversivi: Storia del Centro Socialista Interno (1934-1944)Da EverandPericolosi sovversivi: Storia del Centro Socialista Interno (1934-1944)Nessuna valutazione finora
- Giulio Pastore (1902-1969): Rappresentanza sociale e democrazia politicaDa EverandGiulio Pastore (1902-1969): Rappresentanza sociale e democrazia politicaNessuna valutazione finora
- L'Italia GiolittianaDocumento5 pagineL'Italia GiolittianaNicoleta DvornicNessuna valutazione finora
- Radici ideologiche ed esiti socioculturali del '68Da EverandRadici ideologiche ed esiti socioculturali del '68Nessuna valutazione finora
- Età GiolittianaDocumento2 pagineEtà GiolittianaNoemi GaidanoNessuna valutazione finora
- Capitolo 31Documento7 pagineCapitolo 31Sofia RussoNessuna valutazione finora
- Lupo, Il Mito Della Societa CivileDocumento27 pagineLupo, Il Mito Della Societa CivileAntonio Maria PuscedduNessuna valutazione finora
- Il FascismoDocumento4 pagineIl FascismoLeonardo TovoNessuna valutazione finora
- Il Dopoguerra in ItaliaDocumento2 pagineIl Dopoguerra in ItaliaDaniele PisciottaniNessuna valutazione finora
- Il Primo Dopoguerra in ItaliaDocumento5 pagineIl Primo Dopoguerra in ItaliaFlorin DumitruNessuna valutazione finora
- Volpe - Genesi Del Fascismo (1935)Documento29 pagineVolpe - Genesi Del Fascismo (1935)Augusto TrifulmineNessuna valutazione finora
- Il Secondo DopoguerraDocumento5 pagineIl Secondo DopoguerraIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- Il Sessantotto ItalianoDocumento3 pagineIl Sessantotto ItalianoMarco BiscosiNessuna valutazione finora
- NUOVO STATO SOCIALE - Dai Comuni all'EuropaDa EverandNUOVO STATO SOCIALE - Dai Comuni all'EuropaNessuna valutazione finora
- Senza Tregua: STORIA DEI COMITATI COMUNISTI PER IL POTERE OPERAIO (1975-1976)Da EverandSenza Tregua: STORIA DEI COMITATI COMUNISTI PER IL POTERE OPERAIO (1975-1976)Nessuna valutazione finora
- Crestani AugustoDocumento88 pagineCrestani AugustoAlessandro FulgioneNessuna valutazione finora
- Storia Dei Partiti e Dei Movimenti PoliticiDocumento32 pagineStoria Dei Partiti e Dei Movimenti PoliticiArianna AdsNessuna valutazione finora
- (04-2011) 07 - Il Caso Italiano, Dallo Stato Liberale Al FascismoDocumento5 pagine(04-2011) 07 - Il Caso Italiano, Dallo Stato Liberale Al FascismoDiego DeplanoNessuna valutazione finora
- Societa Di Mas e Giolitti ClubDocumento8 pagineSocieta Di Mas e Giolitti ClubluisatgnNessuna valutazione finora
- MAZZINI-Prof CoviniDocumento2 pagineMAZZINI-Prof CoviniConcettaNessuna valutazione finora
- P. Togliatti Corso Sugli Avversari. Le L PDFDocumento34 pagineP. Togliatti Corso Sugli Avversari. Le L PDFFabio GarciaNessuna valutazione finora
- La Missione impossibile: Il PSU e la lotta al fascismoDa EverandLa Missione impossibile: Il PSU e la lotta al fascismoNessuna valutazione finora
- Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in ItaliaDa EverandMazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in ItaliaNessuna valutazione finora
- Lettera sulla base etica nella Costituzione ItalianaDa EverandLettera sulla base etica nella Costituzione ItalianaNessuna valutazione finora
- Tesina FascismoDocumento7 pagineTesina Fascismoman88gioNessuna valutazione finora
- Docsity Emilio Gentile Fascismo Storia e Interpretazione 4Documento23 pagineDocsity Emilio Gentile Fascismo Storia e Interpretazione 4Ivan MasciNessuna valutazione finora
- Europa socialista: L'europeismo genetico nel socialismo italiano e il suo contributo al processo di integrazione europeaDa EverandEuropa socialista: L'europeismo genetico nel socialismo italiano e il suo contributo al processo di integrazione europeaNessuna valutazione finora
- Conseguenze Politiche Della Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento4 pagineConseguenze Politiche Della Seconda Rivoluzione IndustrialeLuca ToralboNessuna valutazione finora
- TOSCADocumento10 pagineTOSCAsofiaNessuna valutazione finora
- AnAmericanInParis TimpaniDocumento6 pagineAnAmericanInParis TimpanisofiaNessuna valutazione finora
- Il Nuovo Pozzoli Solfeggi Parlati e Cantati 1 PDFDocumento69 pagineIl Nuovo Pozzoli Solfeggi Parlati e Cantati 1 PDFViviana Carolina Guzman Moreno100% (2)
- Prim HitlDocumento4 paginePrim HitlsofiaNessuna valutazione finora
- Le Grandezze FisicheDocumento5 pagineLe Grandezze FisichesofiaNessuna valutazione finora
- Scuola SicilianaDocumento21 pagineScuola SicilianasofiaNessuna valutazione finora
- MRGTDocumento8 pagineMRGTsofiaNessuna valutazione finora
- MRGTDocumento8 pagineMRGTsofiaNessuna valutazione finora
- Glass ReichDocumento2 pagineGlass ReichsofiaNessuna valutazione finora
- Glass ReichDocumento2 pagineGlass ReichsofiaNessuna valutazione finora
- Scheda Oggetti MaxDocumento2 pagineScheda Oggetti MaxsofiaNessuna valutazione finora
- SegantiniDocumento3 pagineSegantinisofiaNessuna valutazione finora
- Umanesimo e RinascimentoDocumento5 pagineUmanesimo e Rinascimentosofia100% (1)
- Le Due CoreeDocumento6 pagineLe Due CoreesofiaNessuna valutazione finora
- Rassegna Stampa Sfoglia I Giornali Rassegna Stampa Del 9 Novemre 2019Documento58 pagineRassegna Stampa Sfoglia I Giornali Rassegna Stampa Del 9 Novemre 2019Marcello MigliosiNessuna valutazione finora
- MarxDocumento6 pagineMarxMarco StefanelliNessuna valutazione finora
- Appunti - Dopo Hegel, Feuerbach, MarxDocumento5 pagineAppunti - Dopo Hegel, Feuerbach, MarxAndrea GiubellinoNessuna valutazione finora
- Costanzo Preve - Destra e Sinistra. La Natura Inservibile Di Due Categorie Tradizionali (PDF 1998, CRT)Documento62 pagineCostanzo Preve - Destra e Sinistra. La Natura Inservibile Di Due Categorie Tradizionali (PDF 1998, CRT)Orazio FlaccoNessuna valutazione finora
- Il Percorso Ideologico e Politico Di PascoliDocumento4 pagineIl Percorso Ideologico e Politico Di PascoliJungle JuLiaNessuna valutazione finora
- Rivoluzione Russa - Appunti PDFDocumento9 pagineRivoluzione Russa - Appunti PDFALESSIO SCAFURONessuna valutazione finora
- Carlo Di Mascio - NOTE SU 'HEGEL. STATO E DIRITTO' DI EVGENY PASHUKANISDocumento31 pagineCarlo Di Mascio - NOTE SU 'HEGEL. STATO E DIRITTO' DI EVGENY PASHUKANISgolo scholzNessuna valutazione finora
- Poggio, Pier Paolo (Coord.) - L'Altronovecento, Vol. II. Il Sistema e I Movimenti (Europa 1945 - 1989) (2011) - Ed. Jaca Book, 2011Documento820 paginePoggio, Pier Paolo (Coord.) - L'Altronovecento, Vol. II. Il Sistema e I Movimenti (Europa 1945 - 1989) (2011) - Ed. Jaca Book, 2011Carlos Álava100% (1)
- De Felice, Renzo. - Il Fascismo. Le Interpretazioni (1970)Documento735 pagineDe Felice, Renzo. - Il Fascismo. Le Interpretazioni (1970)Paulo Neto Paulo Neto100% (1)
- Anarchismo. Rivista Bimestrale - 3 PDFDocumento70 pagineAnarchismo. Rivista Bimestrale - 3 PDFΝίκος ΚανέναςNessuna valutazione finora
- Simboli AnarchiciDocumento2 pagineSimboli Anarchicienzo de simoneNessuna valutazione finora
- Camatte - Della RivoluzioneDocumento9 pagineCamatte - Della RivoluzioneRosario CarannaNessuna valutazione finora