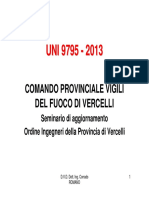Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Uni 9494-2 - 2012
Caricato da
Carlos GirelaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Uni 9494-2 - 2012
Caricato da
Carlos GirelaCopyright:
Formati disponibili
N O RMA Sistemi per il controllo di fumo e calore UNI 9494-2
I T AL IA NA Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di
Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)
GIUGNO 2012
Smoke and heat control systems
Part 2: Design and installation for powered smoke and heat exhaust ventilators
(PSHEVS)
La norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei
Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso
d’incendio.
La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e
Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi
superficie minima di 600 m2. La norma contiene prospetti e
procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di
rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.
Il dimensionamento dell’impianto secondo la presente norma non
si applica ai seguenti casi:
- ambienti a rischio di esplosione;
- corridoi;
- corridoi con scale.
TESTO ITALIANO
La presente norma, unitamente alla UNI 9494-1:2012, sostituisce
la UNI 9494:2007.
ICS 13.220.20; 23.120
UNI © UNI
Ente Nazionale Italiano Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento
di Unificazione può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza
Via Sannio, 2 il consenso scritto dell’UNI.
20137 Milano, Italia www.uni.com
UNI 9494-2:2012 Pagina I
PREMESSA
La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della
Commissione Tecnica UNI
Protezione attiva contro gli incendi
La Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha dato la sua
approvazione il 9 aprile 2012.
La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell’UNI ed è
entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 7 giugno 2012.
Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti
interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato
dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione di questa norma, di poter fornire sug-
gerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell’arte
in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano di
Unificazione, che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione della norma stessa.
Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o
di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l’esistenza di norme UNI corrispondenti alle
norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina II
INDICE
INTRODUZIONE 1
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1
2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2
3 TERMINI E DEFINIZIONI 2
4 SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI 4
5 GENERALITÀ 5
5.1 Principi di funzionamento degli impianti SEFFC ...................................................................... 5
5.2 Schema degli impianti SEFFC ........................................................................................................... 5
figura 1 Illustrazione schematica di un impianto SEFFC ................................................................................. 6
6 PROGETTAZIONE 7
6.1 Generalità .................................................................................................................................................... 7
6.2 Principi ............................................................................................................................................................ 7
figura 2 Schema di suddivisione in compartimenti e grandezze di riferimento per il calcolo .............. 8
6.3 Altezza del locale ...................................................................................................................................... 8
figura 3 Individuazione dell’altezza del locale nel caso di edifici con copertura a shed ....................... 9
6.4 Altezza dello strato libero da fumo - Altezza delle barriere al fumo .............................. 9
6.5 Superficie del compartimento a soffitto ......................................................................................... 9
6.6 Calcolo della portata di aspirazione e della temperatura dei fumi estratti ................. 9
prospetto 1 Calcolo del gruppo di dimensionamento di un impianto SEFFC ............................................... 10
prospetto 2 Portata volumetrica di aspirazione in m3/h per ogni compartimento a soffitto ...................... 11
prospetto 3 Temperatura media dei fumi TF,media (°C) ......................................................................................... 11
prospetto 4 Temperatura locale dei fumi TF,locale (°C) per la determinazione della classe
di temperatura dei componenti dell’impianto SEFFC .................................................................... 12
6.7 Afflusso/Alimentazione dell'aria esterna.................................................................................... 12
6.8 Ambienti di piccole dimensioni ....................................................................................................... 12
6.9 Prescrizioni sui componenti e per la progettazione............................................................. 12
prospetto 5 Classi minime di temperatura per i componenti dell'impianto SEFFC ..................................... 13
figura 4 Definizione delle grandezze rilevanti per la determinazione del numero minimo di
punti di estrazione necessari ................................................................................................................. 15
figura 5 Nomogramma ............................................................................................................................................. 16
prospetto 6 Fattore di correzione cz per diverse aperture di mandata aria ................................................... 17
prospetto 7 Densità corrispondenti alle diverse temperature medie dei fumi TF,media ............................. 18
7 INSTALLAZIONE, COMPONENTI E SISTEMA 23
7.1 Generalità................................................................................................................................................... 23
7.2 Installazione ventilatori........................................................................................................................ 24
7.3 Installazione condotte .......................................................................................................................... 24
7.4 Installazione delle prese d’aria ....................................................................................................... 24
7.5 Installazione delle barriere al fumo .............................................................................................. 24
7.6 Installazione dei comandi .................................................................................................................. 24
7.7 Installazione delle linee e dei quadri ........................................................................................... 24
8 DOCUMENTAZIONE (MANUALE) DELL’IMPIANTO 25
APPENDICE A CALCOLO DELLA PORTATA VOLUMETRICA NEL CASO DI RILASCIO
(normativa) TERMICO DI 600 kW/m2 26
A.1 Generalità................................................................................................................................................... 26
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina III
prospetto A.1 Portata volumetrica di aspirazione (m3/h) per ogni compartimento a soffitto (dato un
rilascio termico di 600 kW/m2) .............................................................................................................. 26
prospetto A.2 Temperatura media del fumo TF (°C) dato un rilascio termico di 600 kW/m2 ...................... 26
prospetto A.3 Temperatura locale del fumo TF,locale (°C) per la determinazione della classe di temperatura
degli elementi di un impianto SEFFC dato un rilascio termico di 600 kW/m2 ....................... 27
prospetto A.4 Densità corrispondenti alle diverse temperature medie dei fumi TF,media ............................. 27
APPENDICE B PRINCIPI DI DIMENSIONAMENTO 28
(informativa)
B.1 Modello di calcolo ................................................................................................................................. 28
prospetto B.1 Ipotesi di calcolo per un rilascio termico di 300 kW/m2 ................................................................ 28
B.2 Ambienti protetti con SEFFC e con altri impianti antincendio ....................................... 28
APPENDICE C SPINTA DI GALLEGGIAMENTO 30
(informativa)
C.1 Generalità .................................................................................................................................................. 30
figura C.1 Differenziale di pressione in funzione della temperatura dello strato dei fumi e della
quota h all’interno di questo (T0 = 20 °C) .......................................................................................... 30
C.2 Nota sulle caratteristiche dei ventilatori .................................................................................... 31
figura C.2 Portata di massa elaborata dal ventilatore e portata volumetrica in funzione della
temperatura ................................................................................................................................................. 31
APPENDICE D SCHEMI E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SEFFC 32
(informativa)
D.1 Generalità .................................................................................................................................................. 32
D.2 Classificazione ........................................................................................................................................ 32
figura D.1 Esempio SEFFC-DSNS con aspirazione diretta per un unico compartimento a soffitto,
per singolo compartimento antincendio ad immissione aria esterna naturale ...................... 33
figura D.2 Esempio SEFFC-MSNS con aspirazione canalizzata per un unico compartimento a
soffitto, per singolo compartimento antincendio ad immissione aria esterna naturale ................... 33
figura D.3 Esempio SEFFC-CSNS con aspirazione centralizzata per tre diversi compartimenti a
soffitto, per singolo compartimento antincendio ad immissione aria esterna naturale ................... 34
figura D.4 Esempio di due SEFFC per compatimenti antincendio singoli (SEFFC-CSNS quello al
piano superiore e SEFFC-DSNS quello al piano inferiore) applicati ad un unico edificio .............. 34
figura D.5 Esempio SEFFC-CMNS per compartimenti antincendio multipli di un unico edificio ........ 35
figura D.6 Esempio SEFFC-CMFS con immissione forzata dell'aria esterna per compartimenti
antincendio multipli ................................................................................................................................... 35
figura D.7 Edifici monopiano con galleria interna coperta (mall) (priva di scale, scale mobili o altre
strutture verticali di esodo) predisposta per l'evacuazione del fumo ....................................... 36
figura D.8 Edifici multipiano con galleria interna coperta (mall) priva di scale, scale mobili o altre
strutture verticali di esodo) predisposta per l’evacuazione del fumo ....................................... 37
figura D.9 Edifici con balconi non destinati a vie di esodo ............................................................................... 37
APPENDICE E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 38
(normativa)
E.1 Generalità .................................................................................................................................................. 38
E.2 Fase preliminare .................................................................................................................................... 38
E.3 Fase successiva (progetto definitivo e/o esecutivo) .......................................................... 39
APPENDICE F LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO DI
(informativa) DIMENSIONAMENTO 40
F.1 Generalità .................................................................................................................................................. 40
F.2 Criteri di scelta per la determinazione del tempo di intervento .................................... 40
prospetto F.1 Valori medi dei tempi di intervento dei VVFF ................................................................................... 41
F.3 Classificazione ai fini della determinazione della velocità di propagazione
dell’incendio ............................................................................................................................................. 42
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina IV
prospetto F.2 Gruppi di pericolo e corrispondenti velocità di propagazione dell’incendio ........................... 42
F.4 Indicazioni circa la determinazione del rilascio termico .................................................... 42
APPENDICE G INTEGRAZIONE DI UN SEFFC IN IMPIANTI HVAC 43
(informativa)
G.1 Generalità .................................................................................................................................................. 43
G.2 Raccomandazioni .................................................................................................................................. 43
prospetto G.1 Esempio di matrice di funzionamento ................................................................................................. 44
BIBLIOGRAFIA 45
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina V
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina VI
INTRODUZIONE
In caso di incendio i sistemi per l’evacuazione di fumo e calore creano e mantengono uno
strato libero da fumo al di sopra del pavimento mediante la rimozione del fumo stesso.
Essi servono inoltre a evacuare contemporaneamente i gas caldi rilasciati da un incendio
durante le fasi di sviluppo.
L’utilizzo di tali sistemi per creare zone libere da fumo al di sotto di uno strato di fumo in
sospensione è ormai ampiamente diffuso. È solidamente dimostrato il loro valore
nell’agevolare l’evacuazione delle persone da edifici e da altri fabbricati, nel ridurre i danni
e le perdite finanziarie provocati dall’incendio prevenendo danni da fumo, facilitando
l’accesso all'edificio per la lotta contro l’incendio grazie al miglioramento della visibilità, nel
ridurre le temperature delle strutture portanti e del tetto e nel ritardare il diffondersi laterale
degli effluenti gassosi.
Per ottenere tali vantaggi è essenziale che i sistemi per l’evacuazione di fumo e calore
siano completamente funzionanti ed affidabili ogniqualvolta devono essere azionati nel
periodo in cui rimangono installati.
Un sistema di evacuazione di fumo e calore (cui si fa riferimento nella presente norma
come SEFC) è un impianto di sicurezza destinato a svolgere un ruolo positivo in una
situazione d’emergenza dovuta a un incendio.
I Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore aiutano a:
- mantenere le vie di esodo e gli accessi liberi da fumo;
- agevolare le operazioni di lotta contro l’incendio creando uno strato libero da fumo;
- ritardare e/o prevenire il “flash over” e quindi lo sviluppo generalizzato dell’incendio;
- limitare i danni agli impianti e alle merci;
- ridurre gli effetti termici sulle strutture;
- ridurre i danni provocati dai gas di combustione e dalle sostanze tossiche e/o
corrosive originate dalla combustione.
La norma, relativa ai sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, è parte di una serie
relativa ai sistemi di controllo di fumo e calore che consiste delle seguenti parti:
- parte 1: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore;
- parte 2: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore;
- parte 3: controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore;
- parte 4: metodi ingegneristici per la progettazione dei sistemi di evacuazione fumo e
calore.
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di
Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d’incendio.
La presente norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore
(SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m2.
La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine
di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.
Il dimensionamento dell’impianto secondo la presente norma non si applica ai seguenti
casi:
- ambienti a rischio di esplosione;
- corridoi;
- corridoi con scale.
La presente norma può essere tenuta in considerazione anche in tutte le altre condizioni
di installazione dei SEFFC; in ogni caso, al di fuori del campo di applicazione, si può
ricorrere ai metodi dell’approccio ingegneristico.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 1
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente parte della norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni
contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati
del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive
modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte
nella presente parte della norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non
datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli
aggiornamenti).
UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme di
incendio - Progettazione, installazione ed esercizio
UNI EN 54 (serie) Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
UNI EN 1364-2 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Soffitti
UNI EN 12101-1 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Specifiche per le
barriere al fumo
UNI EN 12101-3 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli
evacuatori forzati di fumo e calore
UNI EN 12101-7 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 7: Condotte per il
controllo dei fumi
UNI EN 12101-8 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 8: Serrande per il
controllo dei fumi
UNI EN 12101-10 Sistemi per il controllo del fumo e del calore – Parte 10:
Apparecchiature di alimentazione
UNI EN 13501-1 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle
prove di reazione al fuoco
UNI EN 13501-3 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione - Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle
prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati
in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al
fuoco
UNI EN 15423 Ventilazione degli edifici - Misure antincendio per i sistemi di
distribuzione dell'aria negli edifici
prEN 12101-9:2011 Smoke and heat control systems - Part 9: Control panels
CEI 20-45 Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non
propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione
nominale U0/U di 0,6/1 kV
CEI 20-105 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza
alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi
fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio
CEI EN 50200 Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non
protetti per l’uso in circuiti di emergenza
3 TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni seguenti.
3.1 altezza del locale: Distanza tra il livello più alto del pavimento e la media delle altezze del
punto più alto e del punto più basso del tetto.
3.2 ambiente da proteggere: Locale o parte di locale, di un edificio, oggetto di evacuazione di
fumo e gas caldi, che è equipaggiato da un SEFC (o sotto sistema di un SEFC) e che è
attivato da un solo dispositivo o da un gruppo di dispositivi correlati con l’ambiente. Un
ambiente contiene almeno un compartimento a soffitto.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 2
3.3 apparecchiatura di alimentazione: Sorgente e/o accumulo di potenza necessari per
garantire il funzionamento del sistema.
3.4 barriera al fumo: Dispositivo per convogliare, contenere e/o prevenire la migrazione del
fumo e degli effluenti prodotti dall’incendio.
Nota Le barriere al fumo possono anche essere indicate come cortine di contenimento fumo.
3.5 colonna di fumo: Flusso di gas combusti che sale dal focolaio e alimenta lo strato di fumo
(plume).
3.6 compartimento a soffitto (serbatoio di fumo): Volume all’interno di un ambiente limitato o
chiuso dal soffitto e dalle barriere al fumo o da elementi strutturali per trattenere il fumo
che stratifica in caso di incendio.
3.7 compartimento (compartimento antincendio): Parte della costruzione organizzata per
rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi
costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la
capacità di compartimentazione.
3.8 condotta di controllo del fumo: Condotta utilizzata in un sistema per controllare il
movimento e/o il contenimento del fumo e del calore.
3.9 condotta di controllo del fumo per singoli compartimenti: Condotta di controllo del fumo,
costituita da più di una sezione, destinata all’uso per singoli compartimenti e progettata
per convogliare fumo e gas caldi lontano dall’origine dell’incendio.
3.10 condotta di controllo del fumo per compartimenti multipli: Condotta di controllo del fumo,
costituita da più di una sezione e avente caratteristiche di resistenza al fuoco, destinata
all’uso per molteplici compartimenti e progettata per convogliare fumo e gas caldi lontano
dall’origine dell’incendio.
3.11 durata convenzionale di sviluppo dell'incendio: Tempo che si assume intercorra tra lo
scoppio dell'incendio e l'inizio delle operazioni di estinzione, assunto per il
dimensionamento del sistema.
3.12 gruppo di dimensionamento: Grandezza ausiliaria per il dimensionamento di un sistema
di evacuazione di fumo e calore (SEFC).
3.13 installatore di SEFC: Persona fisica o giuridica che, avendone le competenze, è
responsabile di realizzare, secondo la regola dell’arte, la posa in opera di tutti i
componenti, i collegamenti necessari e la verifica di primo funzionamento del SEFC
(esclusi gli impianti di interfaccia per esempio impianti di rivelazione incendio), in
conformità ad un progetto.
Nota L’installatore di sistema SEFC può affidare l’esecuzione di parti del SEFC a diversi soggetti, specialisti,
ognuno di soltanto una o più parti del SEFC; che nel linguaggio comune possono anche essere chiamati
“installatori”.
3.14 posizione antincendio: Stato del sistema dopo la rivelazione d’incendio generato
manualmente o automaticamente.
3.15 progetto: Insieme dei documenti che vengono predisposti per la realizzazione di un SEFC.
3.16 serranda di controllo del fumo: Dispositivo, attivato automaticamente o manualmente,
che può essere aperto o chiuso nella sua posizione operativa di controllo del flusso di
fumo e gas caldi verso, da o all’interno di, una condotta.
3.17 serranda di controllo del fumo per singolo compartimento: Serranda di controllo del fumo
destinata all’impiego in compartimenti singoli. Può essere associata ad un sistema di
condotte di controllo del fumo per singolo compartimento e può essere installata su parete
esterna o a soffitto.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 3
3.18 serranda di controllo del fumo per compartimenti multipli: Serranda di controllo del fumo
con caratteristiche di resistenza al fuoco destinata all’impiego per molteplici
compartimenti. Può essere associata ad un sistema di condotte di controllo del fumo per
più compartimenti e può essere installata in corrispondenza della suddivisione tra
differenti compartimenti antincendio.
3.19 sistema di evacuazione di fumo e calore (SEFC): Componenti selezionati per lavorare
congiuntamente al fine di evacuare fumo e calore in modo da creare uno strato in
sospensione di gas caldi al di sopra di aria più fredda e più pulita.
3.20 sistema di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC): Sistema di evacuazione di fumo
e calore in cui l’evacuazione è provocata dallo spostamento di gas attraverso l’utilizzo di
uno o più ventilatori motorizzati.
3.21 stato di anomalia: Stato rilevato dal sistema di controllo che indica che un componente
non è nella sua condizione normale. Lo stato richiede l’intervento del responsabile interno
ed un eventuale operazione di manutenzione.
3.22 stato di guasto: Stato rilevato durante le operazioni di sorveglianza o controllo che
richiede un operazione di manutenzione.
3.23 stato di veglia: Condizione di attesa normale del sistema che precede il passaggio ad una
delle altre tre condizioni, stato di anomalia, stato di guasto, posizione antincendio.
3.24 strato di aria libera da fumo: Zona compresa fra il livello del pavimento e il limite inferiore
dello strato di fumo in cui la concentrazione del fumo è minima e le condizioni sono tali da
permettere il movimento agevole di persone.
3.25 strato di fumo: Volume a soffitto in cui stratificano fumi e gas caldi prodotti dall’incendio.
3.26 tasso di emissione di calore (rilascio termico): Quantità di calore, espressa in kW/m2, per
unità di tempo e di superficie.
3.27 velocità di propagazione: Velocità di avanzamento del fuoco all'interno della zona
interessata dall'incendio.
3.28 ventilatore per SEFFC: Apparecchio specificatamente progettato per convogliare fumo e
gas caldi all’esterno di un edificio in caso di incendio.
4 SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI
Ai fini della presente norma si applicano i simboli e le abbreviazioni seguenti.
As superficie del compartimento a soffitto, in metri quadrati;
y altezza dello strato di aria libera da fumo, in metri;
h altezza del locale da proteggere, in metri;
hb altezza della barriera al fumo, in metri;
Af superficie del focolaio, in metri quadrati;
z altezza dello strato di fumo (h - y), in metri;
TF, media temperatura media dei fumi (°C);
TF, locale temperatura locale dei fumi (°C);
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 4
5 GENERALITÀ
5.1 Principi di funzionamento degli impianti SEFFC
I SEFFC permettono di mantenere a pavimento uno strato di aria libera da fumo al di
sopra del quale galleggia lo strato di fumo e gas caldi che vengono convogliati all'esterno
attraverso l’utilizzo di uno o più ventilatori motorizzati.
Anche se esiste un effetto congiunto tra azione del ventilatore e spinta di galleggiamento,
l'utilizzo di un sistema meccanico permette l’evacuazione dei fumi dal compartimento a
soffitto interessato dall’incendio in modo indipendente dalla spinta generata dalla
differenza di densità dell'aria tra la base e la sommità dell'ambiente stesso.
5.2 Schema degli impianti SEFFC
I SEFFC sono costituiti per lo meno da un ventilatore e da dispositivi per l’immissione
dell’aria esterna attivati automaticamente o manualmente.
I SEFFC, oltre ad essere composti da uno o più ventilatori, possono prevedere l'impiego
di opportune canalizzazioni, serrande di controllo del fumo, griglie di ripresa e mandata
dell'aria ed altri accessori descritti nel seguito.
La figura 1 rappresenta un esempio di un impianto SEFFC e dei suoi componenti. Gli
esempi non sono esaustivi; altri possibili schemi di impianto sono rappresentati
nell’appendice D.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 5
figura 1 Illustrazione schematica di un impianto SEFFC
Legenda
1 Compartimento antincendio
2 Compartimento a soffitto
3 Apertura per l’afflusso di aria esterna
4 Barriera al fumo o elemento strutturale
5 Ventilatore per SEFC
6 Serranda per il controllo del fumo per singolo compartimento
7 Condotta per l'evacuazione dei fumi per compartimento singolo
8 Condotta per l'evacuazione dei fumi per compartimenti multipli
9 Serranda per il controllo del fumo per compartimenti multipli montata a parete o a pavimento
10 Serranda per il controllo del fumo per compartimenti multipli montata sulla superficie del
condotto
11 Sistema di controllo/alimentazione elettrica
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 6
6 PROGETTAZIONE
6.1 Generalità
La progettazione di un SEFFC deve essere basata sul processo di analisi e valutazione
del rischio incendio per l’attività in esame e di tutte le condizioni e fattori che possono
influenzare il sistema stesso.
Tutte le informazioni che identificano l’attività da cui il progettista ricava i parametri di
calcolo devono essere ricavate da documenti appropriati o comunicate da persone che ne
sono responsabili.
Nella considerazione che la protezione incendio debba essere vista nel suo complesso, si deve
tenere conto delle possibili interazioni tra il SEFFC e le altre misure di protezione previste.
Nella progettazione si deve tener conto altresì dei vincoli strutturali dell’edificio servito e
delle interferenze con gli impianti dell’edificio che potrebbero influenzare la prestazione
del SEFFC.
Il SEFFC deve essere in grado di essere attivato e garantire l’evacuazione del fumo e del
calore anche in condizioni climatiche avverse.
La documentazione progettuale deve essere redatta in conformità con l’appendice E.
6.2 Principi
Il dimensionamento dei SEFFC dipende dal tempo convenzionale di sviluppo
dell'incendio e dalla velocità media di propagazione del fuoco (che determinano il gruppo
di dimensionamento) oltre che dal rilascio termico e dall’altezza dello strato libero da fumo
che si desidera raggiungere nel locale (vedere figura 2).
Tramite questi parametri è possibile calcolare la portata volumetrica da aspirare in
ciascun compartimento al soffitto e la temperatura dei fumi prevista.
In base a questi valori ed alla tipologia dell'edificio è possibile selezionare i componenti
del SEFFC e procedere con la progettazione dell'intero impianto.
Per il dimensionamento si suppone:
- accensione tempestiva dell’impianto di estrazione del fumo, in seguito alla
rivelazione della presenza di incendio tramite sensori di rivelazione di fumo oppure
in seguito all’intervento del personale di sorveglianza presente in loco;
- per gli usi consueti, si assume un tempo convenzionale previsto di sviluppo
dell’incendio fino all’inizio delle operazioni di estinzione di 10 min;
- corretto dimensionamento delle superfici attraverso le quali avviene l’afflusso
dell’aria di ricambio. In particolare, il sistema di alimentazione dell’aria di ricambio
deve avere dimensioni sufficientemente grandi tali da evitare la turbolenza del fumo
ed essere distribuito in modo uniforme in prossimità del pavimento. Si suppone
inoltre che il sistema di alimentazione dell’aria di ricambio entri in funzione al
momento dell’accensione dell’impianto SEFFC;
- una suddivisione dei locali di grandi dimensioni in compartimenti antifumo tramite
cortine antifumo;
- un rilascio termico del materiale coinvolto dall'incendio uguale o inferiore a
300 kW/m2 o 600 kW/m2;
- condizioni di incendio non generalizzato;
- temperature dei fumi inferiori alle condizioni di flash over.
Qualora si faccia riferimento ad altre ipotesi per il dimensionamento si ricade al di fuori del
campo di applicazione della presente norma.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 7
figura 2 Schema di suddivisione in compartimenti e grandezze di riferimento per il calcolo
Legenda
1 Strato libero da fumo
2 Colonna di fumo
3 Strato di fumo
y Altezza dello strato di aria libera da fumo in metri
h Altezza del locale da proteggere in metri
hb Altezza della barriera al fumo in metri
z Altezza dello strato di fumo (h - y) in metri
Aae Superficie geometrica dell'apertura per l'afflusso di aria esterna
Qout Portata di aria espulsa in m3/h
Qin Portata di aria immessa nel caso di immissione forzata in m3/h
NOTA 1 m3/h = 3 600 m3/s.
Inserire un muro tra secondo e terzo compartimento a soffitto; in altre parole individuare un
compartimento antincendio.
6.3 Altezza del locale
L’altezza h del locale è l’altezza libera interna, nel caso di copertura orizzontale e l’altezza
media nel caso di copertura inclinata.
Nel caso di tetti a shed l’altezza del locale da considerare corrisponde all’altezza media
misurata dal pavimento (vedere figura 3).
Negli ambienti con pavimenti con pendenze di rilievo, per esempio locali di pubblico
spettacolo, gradinate con posti a sedere a quote diverse, ecc., il punto zero per la misura
della altezza (h) è quello dell’ingresso d’aria a quota più alta.
Soltanto i soffitti autoportanti e controsoffitti che possiedono una resistenza al fuoco
indipendentemente da ogni elemento costruttivo soprastante possono essere considerati
soffitti.
Questi devono essere sottoposti a prova secondo la UNI EN 1364-2 con condizione di
esposizione al fuoco da sotto.
La loro applicazione deve avvenire nel rispetto del campo di applicazione del rapporto di
prova della UNI EN 1364-2 (tempo di resistenza al fuoco).
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 8
figura 3 Individuazione dell’altezza del locale nel caso di edifici con copertura a shed
Legenda
h Altezza del locale da proteggere in metri
6.4 Altezza dello strato libero da fumo - Altezza delle barriere al fumo
Si definisce l’altezza dello strato libero dal fumo y come la distanza fra il pavimento e la
superficie inferiore dello strato di fumo. Lo strato libero da fumo serve per:
- far fuoriuscire le persone in completa sicurezza;
- permettere alla squadra di intervento di mettere in salvo persone, animali e oggetti;
- rendere possibile un’efficace estinzione dell’incendio;
- attenuare i danni dovuti all’incendio conseguenti al calore e al fumo generati.
L’altezza minima dello strato di aria libera da fumo deve essere pari a 2,5 m.
Quando l’altezza dello strato di aria libera da fumo y d 4 m le barriere al fumo devono
scendere al di sotto allo strato di fumo per almeno 0,5 m. Di conseguenza, l’altezza
minima da terra delle barriere al fumo è di 2 m.
Quando lo strato di aria libera da fumo y > 4 m, l’altezza delle barriere al fumo deve essere
almeno pari all’altezza dello strato di fumo z. In ogni caso, le barriere al fumo devono
scendere per almeno 1,0 m dalla quota h come definita al punto 6.3.
Nota Se il SEFFC ha lo scopo di proteggere materiali, merci o manufatti sensibili al fumo, il limite inferiore dello
strato di fumo dovrebbe essere mantenuto distante almeno 0,5 m dagli stessi.
6.5 Superficie del compartimento a soffitto
Il dimensionamento degli impianti SEFFC ai sensi della presente norma presuppone che
i locali da proteggere abbiano una superficie d1 600 m2 o che questi vengano suddivisi
tramite barriere al fumo conformi al punto 6.4 in compartimenti a soffitto con una
superficie massima As di 1 600 m2.
La distanza massima tra due cortine antifumo oppure tra una barriera al fumo e la parete
adiacente deve essere <60 m. Non sono consentiti altri tipi di suddivisione (per esempio,
elementi strutturali chiusi) oppure cortine con altezza inferiore a quella indicata.
Nota I compartimenti a soffitto sono delimitati sui 4 lati da barriere al fumo o da elementi strutturali idonei.
6.6 Calcolo della portata di aspirazione e della temperatura dei fumi estratti
Il calcolo della portata di aspirazione necessaria a raggiungere gli obiettivi di sicurezza
desiderati (altezza libera da fumo) è eseguito in funzione della potenza dell’incendio
associata al gruppo di dimensionamento.
6.6.1 Durata convenzionale di sviluppo dell’incendio
La durata convenzionale di sviluppo dell’incendio (t ) si compone di due parti:
- t1 tempo d’allarme;
- t2 tempo d’intervento.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 9
6.6.2 Tempo di allarme
Il tempo di allarme (t1) tra lo scoppio dell’incendio ed il momento dell’allarme si assume
pari a:
- t1 = 0 min in presenza di un sistema automatico di rivelazione incendio che aziona
automaticamente il SEFFC o con allarme trasmesso ad un locale presidiato h 24 con
personale in grado di intervenire adeguatamente;
- t1 = 5 min nel caso di edificio con presenza di persone h 24;
- t1 = 10 min in tutti gli altri casi.
Nota Nel caso in cui l’ubicazione e/o l’utilizzo dell’edificio non permette di essere sicuri che un incendio possa
essere individuato in massimo 10 min, si consiglia l’installazione di un sistema di rivelazione.
6.6.3 Tempo di intervento
Il tempo di intervento (t2) tra l’allarme e l’inizio delle operazioni di estinzione si assume
pari a:
- t2 = 5 min nel caso di presenza h 24 di squadra di soccorso interno;
- nel caso di squadra di soccorso esterna t2 = 10, 15, 20 min o maggiore, da definire in
funzione delle condizioni locali e comunque non minore di 10 min.
Nota La valutazione delle condizioni di intervento dipende da fattori locali come per esempio distanza, traffico,
condizioni climatiche, percorribilità strade, ecc. (vedere appendice F).
6.6.4 Gruppo di dimensionamento
Il gruppo di dimensionamento dell’impianto, corrispondente alla superficie dell’incendio
descritta nell’appendice B, si ricava dal prospetto 1 in funzione della durata convenzionale
di sviluppo dell’incendio e della velocità di propagazione attesa (vedere appendice F).
In generale, il gruppo di dimensionamento 3 è da considerarsi come riferimento. Si
consideri il prospetto 1: si tratta, per esempio, del valore che risulta dall’incrocio tra la riga
2 (che rappresenta un tempo convenzionale di sviluppo dell’incendio di 10 min) e la
colonna 3 (che rappresenta una velocità media di propagazione dell’incendio).
L’utilizzo dei valori della colonna “bassa” del prospetto 1 è possibile soltanto per velocità
particolarmente basse; l’utilizzo dei valori della colonna “alta" del prospetto 1 è
necessario quando il tipo di materiale e/o la sua sistemazione e/o quantità determinano
condizioni favorevoli allo sviluppo dell’incendio. Nell’appendice F sono riportate
indicazioni per agevolare la valutazione della velocità di propagazione.
Il gruppo di dimensionamento definito secondo il prospetto 1 può essere ridotto di una unità
in presenza di un impianto di estinzione automatico (per esempio impianti sprinkler, impianti
a schiuma). Viceversa, se nel compartimento sono immagazzinati materiali con altezza
maggiore di 1,5 m, il gruppo di dimensionamento deve essere aumentato di una unità.
Se a seguito delle ipotesi circa la durata convenzionale dell’incendio e circa la velocità di
propagazione del fuoco ci si trova all’interno del gruppo di dimensionamento 5, l’altezza
delle merci non deve essere maggiore di 1,5 m.
prospetto 1 Calcolo del gruppo di dimensionamento di un impianto SEFFC
Colonna 1 2 3 4
Riga Tempo convenzionale di Velocità di propagazione dell’incendio
sviluppo dell’incendio (min)
Bassa Media Alta
1 d5 1 2 3
2 d10 2 3 4
3 d15 3 4 5
4 d20 4 5 -
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 10
6.6.5 Portata volumetrica di aspirazione e temperature medie dei fumi
Per ogni compartimento a soffitto, deve essere determinata, sulla base del prospetto 2, la
portata volumetrica che l’impianto SEFFC deve evacuare. I principi posti alla base del
calcolo per i valori presenti nei prospetti sono spiegati nell’appendice B.
I valori che seguono sono compatibili con un rilascio termico di 300 kW/m2. Laddove si
ipotizzasse un rilascio termico maggiore, fino a valori di 600 kW/m2, è possibile consultare
i prospetti presenti in appendice A.
prospetto 2 Portata volumetrica di aspirazione in m3/h per ogni compartimento a soffitto
Riga Altezza dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1 2,5 29 000 46 000 75 000 128 000 223 0001)
2 3 34 000 55 000 88 000 145 000 248 000
3 4 43 000 72 000 115 000 184 000 303 000
4 5 50 000 85 000 143 000 229 000 366 000
5 6 59 000 96 000 165 000 276 000 436 000
6 7 73 000 105 000 183 000 311 000 512 000
7 8 88 000 121 000 197 000 342 000 580 000
8 9 105 000 143 000 206 000 368 000 633 000
9 10 123 000 166 000 231 000 387 000 681 000
1) In questa condizione è lecito supporre condizioni di incendio generalizzato (flash-over) che rendono il sistema
SEFFC inefficace nella creazione di uno strato libero da fumo per proteggere le persone presenti nel locale. È quindi
necessario modificare il progetto per ottenere un Gruppo di Dimensionamento minore.
prospetto 3 Temperatura media dei fumi TF,media (°C)
Riga Altezza dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1 2,5 160 210 290 400 560
2 3 130 170 230 310 430
3 4 100 120 150 210 290
4 5 80 100 120 160 210
5 6 70 90 100 120 170
6 7 60 80 90 110 140
7 8 50 70 90 100 120
8 9 50 60 80 90 110
9 10 40 60 70 90 100
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 11
prospetto 4 Temperatura locale dei fumi TF,locale (°C) per la determinazione della classe di temperatura dei
componenti dell’impianto SEFFC
Riga Altezza dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1 2,5 196 268 371 516 7221)
2 3 156 209 287 397 554
3 4 121 148 193 265 367
4 5 103 122 148 196 268
5 6 90 108 127 155 209
6 7 74 99 114 135 170
7 8 64 87 106 122 146
8 9 56 75 101 113 133
9 10 50 67 91 107 123
1) In questa condizione è lecito supporre condizioni di incendio generalizzato (flash-over) che rendono il sistema
SEFFC inefficace nella creazione di uno strato libero da fumo per proteggere le persone presenti nel locale. È quindi
necessario modificare il progetto per ottenere un Gruppo di Dimensionamento minore.
6.7 Afflusso/Alimentazione dell'aria esterna
L’aria esterna di ricambio deve affluire nel locale ad altezza del pavimento in modo
naturale, tramite apposite aperture, o in modo forzato tramite ventilatori di immissione.
L’attivazione dell’immissione deve essere contestuale all’attivazione dell’impianto SEFFC
e può avvenire automaticamente, tramite intervento del personale di emergenza, oppure
tramite dispositivi speciali.
6.8 Ambienti di piccole dimensioni
In relazione all’entità delle portate in estrazione e alla velocità massima di immissione
dell’aria, i prospetti di dimensionamento riportati nella presente norma hanno
un’applicazione gestibile, dal punto di vista della realizzazione dell’impianto SEFFC, per
superfici dell’attività o del compartimento comprese tra 600 m2 e 1 600 m2, con un
minimo, utilizzato nella determinazione dei suddetti prospetti, di 600 m2.
Ciò non esclude la possibilità di installare impianti SEFFC anche per superfici minori di
600 m2 o maggiori di 1 600 m2 laddove ne sia riscontrata l’effettiva necessità, per le
superfici inferiori, o l’impossibilità di maggiori suddivisioni per le superfici maggiori, ma la
progettazione e il dimensionamento, in questi casi, devono essere oggetto di specifici
approfondimenti e analisi di fattibilità.
In particolare, per superfici minori di 600 m2, ulteriori considerazioni relative alle
disponibilità di uscite di sicurezza, alla protezione e alla lunghezza delle vie di esodo, alla
presenza di impianti di rivelazione fumi, ecc., possono permettere di rideterminare
caratteristiche e prestazioni dell’impianto stesso, sulla base, comunque, di una specifica
progettazione applicando ugualmente i principi della norma.
6.9 Prescrizioni sui componenti e per la progettazione
6.9.1 Generalità
I componenti di un impianto SEFFC sono:
- ventilatore per SEFFC;
- punti o aperture di estrazione fumo e calore;
- aperture per l'afflusso dell'aria esterna;
- condotte di controllo del fumo;
- serrande di controllo del fumo;
- barriere al fumo;
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 12
- condotte per l'immissione dell'aria esterna;
- serrande di controllo dell'immissione dell'aria esterna;
- ventilatori di immissione dell'aria esterna;
- impianto di alimentazione elettrica;
- sistemi di controllo;
- supporti.
Per ciascuno di essi devono essere definite la disposizione, le prestazioni e le
caratteristiche, ecc.
I componenti devono essere dimensionati per resistere alle sollecitazioni a cui saranno
sottoposti durante il loro funzionamento in caso d’incendio. Le loro dimensioni devono
soddisfare i requisiti prestazionali dell’impianto. I componenti devono essere scelti sulla
base delle loro prestazioni misurate in conformità alle norme pertinenti di riferimento.
La scelta ed il posizionamento dei componenti devono essere altresì effettuati nel rispetto
dei regolamenti vigenti, delle condizioni al contorno (per esempio, caratteristiche
costruttive dell’edificio, ecc.).
Nota I componenti che fanno parte della costruzione e sono inseriti nell’edificio possono essere soggetti anche ad
altre normative.
6.9.2 Classe di temperatura dei componenti dell’impianto SEFFC
Alcuni dei componenti dell’impianto SEFFC, per poter operare alle condizioni indicate nel
prospetto 4, devono soddisfare le classi minime di temperatura riassunte nel prospetto 5.
prospetto 5 Classi minime di temperatura per i componenti dell'impianto SEFFC
Componenti Temperatura locale dei fumi TF, locale (°C) Norme di riferimento
d200 °C d300 °C d400 °C d600 °C
Ventilatori per SEFFC F200 F300 F400 F600 UNI EN 12101-3
Condotte di controllo del fumo E300 30 S E300 30 S E600 30 S E600 30 S
(singolo compartimento)
UNI EN 12101-7
Condotte di controllo del fumo
EI xxx S
(compartimenti multipli)
Serrande di controllo del fumo E300 30 S E300 30 S E600 30 S E600 30 S
(singolo compartimento)
UNI EN 12101-8
Serrande di controllo del fumo
EI xxx S
(compartimenti multipli)
Barriere al fumo D 30 UNI EN 12101-1
Cavi di segnale CEI 20-105
Cavi di potenza UNI EN 13501-1
UNI EN 13501-3
Per i prodotti con classe EI xxx S, il termine "xxx" indica la durate di resistenza al fuoco (da
15 min a 240 min) del compartimento antincendio nel quale il prodotto è installato.
Per le "condotte di immissione dell'aria esterna" valgono gli stessi requisiti delle "condotte
di controllo del fumo" siano esse per singolo compartimento o per compartimento
multiplo.
Per le "serrande di controllo dell'immissione dell'aria esterna" valgono gli stessi requisiti
delle "serrande di controllo del fumo" siano esse per singolo compartimento o per
compartimento multiplo.
Per tutti gli altri prodotti le eventuali indicazioni sono riportate nei punti seguenti.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 13
6.9.3 Ventilatori per SEFFC
Oltre alla classificazione indicata nel prospetto 5, i "ventilatori per SEFFC" devono
soddisfare i requisiti circa:
- le prestazioni aerauliche (portata e prevalenza);
- le modalità di installazione generiche (all'esterno o all'interno dell'edificio, in
posizione; orizzontale e/o verticale, eventuale collegamento a condotta, metodo di
fissaggio a canale, tetto o parete, ecc.);
- le prestazioni specifiche (carico di neve, installazione all'esterno o all'interno di un
compartimento a soffitto, funzionamento in doppia funzione o utilizzo
esclusivamente d'emergenza, ecc.).
I valori di portata volumetrica dei ventilatori devono essere uguali o maggiori a quelli
indicati nel prospetto 2. Non è necessaria alcuna correzione della portata in base alle
diverse densità/temperature dei fumi in quanto le portate indicate al prospetto 2 tengono
già conto della densità dei fumi estratti in base alla rispettiva temperatura.
Per i SEFFC con aspirazione centralizzata il ventilatore deve garantire la maggiore tra le
portate necessarie per ciascun compartimento a soffitto e potrà aspirare in ogni altro
compartimento una portata maggiore di quella richiesta purché non comprometta
l’evacuazione corretta del fumo.
Per le applicazioni all'esterno dell'edificio deve essere assicurata la compatibilità elettrica e
meccanica del ventilatore (agenti atmosferici, temperature, ecc.) per l'installazione prevista.
Per le applicazioni all'interno di un compartimento a soffitto, qualora il ventilatore sia
collegato ad una "condotta di controllo del fumo per compartimenti multipli", il ventilatore
stesso deve essere coibentato esternamente per avere resistenza al fuoco EI xxx S pari
a quella della condotta stessa.
Per tutte le altre applicazioni le specifiche sulla temperatura superficiale esterna del
ventilatore assicurano adeguate condizioni si sicurezza senza alcun ulteriore isolamento
del ventilatore stesso.
6.9.4 Punti di estrazione del fumo e calore
Nel caso di impianti SEFFC ad aspirazione diretta il ventilatore SEFFC (o comunque gli
accessori di fissaggio/installazione previsti dal costruttore) includono una apertura di
estrazione fumo e calore già adatta all'impiego.
Per gli altri impianti SEFFC i punti di estrazione fumo e calore possono essere costituiti da:
1) semplici aperture realizzate sulle condotte di controllo del fumo per singolo
compartimento;
2) griglie o diffusori (a scopo estetico o funzionale) installate sulle condotte di controllo
del fumo per singolo compartimento;
3) serrande di controllo del fumo (per singolo compartimento o compartimenti multipli)
installate sulla superficie delle condotte di controllo del fumo.
Nel caso di impiego di griglie o diffusori, il materiale utilizzato ed il sistema di
fissaggio/installazione deve garantire la resistenza alle temperature medie dei fumi
previste (prospetto 3) per evitare che il distacco di alcuni componenti comprometta il
funzionamento della singola apertura di aspirazione o dell'intero SEFFC. In particolare
modo è da porre particolare attenzione alla presenza di eventuali componenti in materiale
non metallico (PVC, nylon, ecc.).
Nel caso che le aperture di aspirazione fumo e calore siano costituite da serrande di
controllo del fumo, i rispettivi requisiti di classe di temperatura devono essere almeno
uguali a quelli del condotto di controllo del fumo sul quale sono installate.
In tutti i sistemi SEFFC (siano essi ad aspirazione diretta, canalizzata o centralizzata), per
ciascun compartimento a soffitto deve essere verificata l'equazione:
N
· ·
V TOT = ¦ Vi (1)
i=1
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 14
dove:
·
V TOT è la portata volumetrica totale di aspirazione dal compartimento a soffitto,
ricavata dal prospetto 2;
·
Vi è la portata volumetrica per l'i-esimo punto di aspirazione;
N è il numero delle aperture di aspirazione.
In ogni punto di aspirazione tuttavia la portata volumetrica aspirata non deve essere
·
maggiore del valore di V i,max che viene determinato in base ai seguenti fattori, utilizzando
il nomogramma di figura 5:
- 'dS, misura (in metri) dello strato di fumo al di sotto del punto più basso dell'apertura
di aspirazione (vedere figura 4);
- TF,media, temperatura media dei fumi (ricavata dal prospetto 3).
figura 4 Definizione delle grandezze rilevanti per la determinazione del numero minimo di punti di estrazione
necessari
Legenda
y Altezza dello strato libero da fumi, in metri
'ds Distanza tra l’imbocco del condotto di estrazione e la superficie inferiore dello strato di fumo,
in metri
Smin Distanza minima tra due punti di estrazione, in metri
·
Vi Portata volumetrica estratta dall’i-esimo punto di estrazione (m3/h)
h Altezza del locale da proteggere, in metri
TF,media Temperatura media dei fumi (°C)
·
Noti valori di 'dS e TF, media dalla figura 5 è possibile ricavare il valore V i,max relativo alla
“portata volumetrica massima teorica per ogni punto di aspirazione”.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 15
figura 5 Nomogramma
La distanza minima Smin tra due punti di aspirazione vicini è invece determinata dalla formula
·
S min t 0,015 u V i (2)
dove:
·
Vi è la reale portata di fumo aspirata dall'i-esimo punto di aspirazione e che deve
·
sempre essere uguale o minore del valore V i,max .
6.9.5 Punti di afflusso dell'aria esterna
6.9.5.1 Generalità
Per i sistemi SEFFC questi elementi dell'impianto possono essere costituiti da:
1) aperture installate su una o più pareti del compartimento antincendio e che
confinano con l'ambiente esterno;
2) aperture installate su canali destinati all'afflusso dell'aria esterna tramite un apposito
ventilatore.
In ogni caso, le aperture per l’afflusso dell’aria esterna dovranno essere collocate
all’interno dello strato libero da fumo.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 16
6.9.5.2 Aperture per sistemi ad immissione aria naturale
In questa tipologia di impianti SEFFC le aperture per l'afflusso dell'aria esterna possono
essere costituite da:
- serrande automatizzate o altri dispositivi simili;
- porte o finestre.
Al fine da evitare turbolenze che rischierebbero di interferire con la stratificazione dei gas
caldi, lo spigolo superiore di ciascuna apertura deve avere una distanza di almeno 1 m dal
limite inferiore dello strato di fumo (con gli elementi descritti in prospetto 6 e larghi al
massimo 1,25 m è possibile ridurre questa distanza a 0,50 m). In questi casi la velocità
massima di immissione non può superare i 2 m/s.
Laddove non venga rispettato il vincolo riguardante la distanza tra spigolo superiore delle
aperture e limite inferiore dello strato di fumo la velocità massima di immissione deve
essere ridotta a 1 m/s.
La minima superficie efficacie AEF per le aperture di afflusso dell’aria esterna (in m2) si
calcola dividendo la portata aspirata dal compartimento a soffitto (vedere prospetto 2) -
calcolata in m3/s - per la velocità massima ammissibile per l'ingresso dell’aria di ricambio.
Nel caso di compartimento antincendio composto da più serbatoi di fumo è necessaria e
sufficiente un'unica serie di aperture per l'intero compartimento e dimensionate per la
maggiore delle portate aspirate dagli stessi compartimento a soffitto.
Per calcolare la superficie efficace AEF a partire dalla superficie geometrica AAE delle
aperture di afflusso dell’aria si ricorre alla formula:
AEF = cZ u AAE (3)
dove il termine cz, chiamato fattore di correzione, è ricavato dal prospetto 6.
prospetto 6 Fattore di correzione cz per diverse aperture di mandata aria
Tipo di apertura Angolo di aperturaa) Fattore di correzione cz
Porte o cancelli --- 0,65
90° 0,65
t60° 0,5
Finestra ad apertura normale o vasistas
t45° 0,4
t30° 0,3
a) È ammessa una tolleranza di ±5°.
Per le aperture costituite da serrande automatizzate o dispositivi simili, il valore di
superficie efficace AEF deve essere desunto dai cataloghi del produttore; in mancanza
viene ricavato utilizzando un fattore di correzione cz = 0,5.
Se l’aria esterna non viene immessa in senso orizzontale (come per esempio in caso di
bocchette/serrande ad alette inclinate) la distanza tra le aperture ed il limite inferiore dello
strato di fumo deve essere di almeno 1,5 m.
Tutte le aperture per l'afflusso dell'aria esterna devono:
- essere chiaramente indicate come tali all’esterno e all’interno dell'edificio tramite
apposite targhette;
- aprirsi automaticamente per intervento del sistema di controllo dell'impianto SEFFC.
Le aperture per l'afflusso dell'aria esterna devono essere posizionate facendo attenzione
alla distanza che le separa dal punto in cui il fumo viene espulso (sia esso un ventilatore per
SEFFC o un canale di espulsione) per prevenire il suo rientro nel compartimento stesso.
Questa condizione viene garantita se:
- l'espulsione del fumo è collocata ad almeno 2,5 m al di sopra dello spigolo superiore
di ciascuna apertura per l'afflusso dell’aria esterna;
- la distanza orizzontale tra espulsione del fumo e aspirazione dell’aria esterna è di
almeno 8 m.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 17
6.9.5.3 Aperture per sistemi ad immissione aria forzata
Nel caso di sistemi ad immissione aria forzata, le aperture possono essere costituite da:
- semplici aperture realizzate sulle condotte di immissione dell'aria esterna;
- griglie o diffusori (a scopo estetico o funzionale) installate sulle medesime condotte;
- serrande per il controllo dell'immissione dell'aria esterna (per singolo compartimento
o compartimenti multipli) installate sulla superficie delle condotte predisposte.
Lo spigolo superiore di ciascuna apertura deve avere una distanza di almeno 1 m dal
limite inferiore dello strato di fumo.
Se l’aria esterna non viene immessa in senso orizzontale (come per esempio in caso di
bocchette/serrande ad alette inclinate) la distanza tra le aperture ed il limite inferiore dello
strato di fumo deve essere di almeno 1,5 m.
La minima superficie per le aperture di afflusso dell’aria esterna (in metri quadrati) si
calcola dividendo la portata aspirata dal compartimento a soffitto (vedere prospetto 2) -
calcolata in m3/s - per la velocità massima ammissibile per l'ingresso dell’aria di ricambio.
Con l'immissione forzata, essendo indotta da un ventilatore che garantisce la portata
desiderata, non sono necessari fattori correttivi per il calcolo delle superfici.
Nel caso di immissione forzata va evitata la pressurizzazione dei locali oggetto di
evacuazione di fumo e calore; a tal fine è necessario correggere la portata di mandata in
funzione della densità dei fumi estratti in modo da avere il bilanciamento in massa delle
portate fluenti.
Con riferimento alle temperature presentate nel prospetto 3, il prospetto 7 riporta le
corrispondenti densità:
prospetto 7 Densità corrispondenti alle diverse temperature medie dei fumi TF,media
Riga Spessore dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1 2,5 0,81 0,73 0,63 0,52 0,42
2 3 0,88 0,80 0,70 0,61 0,50
3 4 0,95 0,90 0,83 0,73 0,63
4 5 1,00 0,95 0,90 0,81 0,73
5 6 1,03 0,97 0,95 0,90 0,80
6 7 1,06 1,00 0,97 0,92 0,85
7 8 1,09 1,03 0,97 0,95 0,90
8 9 1,09 1,06 1,00 0,97 0,92
9 10 1,13 1,06 1,03 0,97 0,95
La portata di mandata deve essere calcolata tenendo conto del termine (data l’ipotesi di
testerna = 20 °C):
U
-------------------- (4)
U t = 20 °C
dove U è la densità ricavata dal prospetto 7 in funzione delle ipotesi circa altezza libera da
fumi e gruppo di dimensionamento e Ut = 20 °C è la densità dell’aria valutata a 20 °C
(= 1,2041 kg/m3).
Nel caso di compartimento antincendio composto da più serbatoi di fumo è sufficiente
un'unica serie di aperture per l'intero compartimento e dimensionate per la maggiore delle
portate aspirate dagli stessi compartimenti a soffitto.
Per le caratteristiche delle eventuali serrande per il controllo dell'immissione dell'aria
esterna si rimanda all'apposito punto.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 18
Il posizionamento del punto di aspirazione dell'aria esterna da parte del sistema forzato
deve avvenire facendo attenzione alla distanza che lo separa dal punto in cui il fumo viene
espulso (sia esso un ventilatore per SEFFC o un canale di espulsione) per prevenire il suo
rientro nel compartimento stesso.
Questa condizione viene garantita se:
- l'espulsione del fumo è collocata ad almeno 2,5 m al di sopra del punto di
aspirazione dell'aria esterna;
- la distanza orizzontale tra espulsione del fumo e aspirazione dell’aria esterna è di
almeno 8 m.
6.9.6 Condotte di controllo del fumo
Questi componenti dell'impianto permettono di collegare ad un unico ventilatore per
SEFFC una o più aperture di estrazione fumo e calore, e si dividono tra:
- condotte di controllo del fumo per singolo compartimento;
- condotte di controllo del fumo per compartimenti multipli.
Le condotte di fumo per compartimenti multipli devono essere utilizzate quando, in uno
qualsiasi degli scenari d'incendio previsti, l'aria del canale è in comunicazione diretta con
un compartimento antincendio diverso da quello in cui il canale è installato.
Qualora le condotte attraversino ulteriori compartimenti non serviti dal SEFC, le loro
caratteristiche devono comunque essere quelle per compartimenti multipli e comunque
congrue con quelle del compartimento attraversato.
Per tutti gli altri casi in cui le condotte possono essere attraversate esclusivamente dal
fumo aspirato dallo stesso compartimento antincendio (anche se proveniente da un
compartimento a soffitto diverso dal proprio) sono previste condotte di controllo del fumo
per singolo compartimento.
Ne consegue che per i sistemi SEFFC destinati ad un unico compartimento antincendio
l'intera canalizzazione in esame sarà realizzata con condotte di controllo del fumo per
singolo compartimento.
Per i sistemi SEFFC destinati a più compartimenti antincendio solamente i tratti di
canalizzazione in comunicazione diretta con compartimenti diversi dal proprio devono
essere realizzati con condotte per compartimenti multipli, mentre i restanti tratti saranno
realizzati con condotte per singolo compartimento. In questo scenario l'impiego di serrande
di controllo del fumo per compartimenti multipli (descritte nel punto dedicato) può escludere
la comunicazione diretta di una condotta con un compartimento antincendio diverso dal
proprio, permettendo l'impiego di condotte per singolo compartimento.
Le condotte di controllo del fumo devono avere sezione sufficiente affinché la velocità dei fumi
al suo interno non sia maggiore del valore di 15 m/s in qualsiasi scenario d'incendio previsto.
Le condotte di controllo del fumo previste devono essere classificate secondo la
UNI EN 12101-7 anche per poter assicurare le proprie prestazioni sia alla maggiore
pressione prevista dal progetto nel punto in cui sono installate, sia nella posizione
verticale/orizzontale richiesta.
Gli accessori utilizzati per il fissaggio e la sigillatura delle condotte devono assicurarne il
corretto funzionamento in caso di intervento del sistema SEFFC.
6.9.7 Serrande di controllo del fumo
Questi componenti dell'impianto, collegati al sistema di controllo, hanno lo scopo di permettere
l'estrazione del fumo esclusivamente dal compartimento a soffitto interessato dall'incendio.
La loro posizione aperta o chiusa è definita dal sistema di controllo per assicurare il
passaggio o meno del fumo a seconda dello scenario d'incendio occorso.
Utilizzate esclusivamente in sistemi SEFFC ad aspirazione centralizzata, la loro
applicazione può prevedere due principali tipi di installazione, ovvero:
- a canale, cioè nel punto di giunzione tra due tratti successivi di condotte di controllo
del fumo;
- sulla superficie di un canale per il controllo del fumo.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 19
Le serrande utilizzate devono essere classificate secondo la UNI EN 12101-8 in
particolare circa la loro posizione (verticale od orizzontale) e alla installazione (su
condotta o su parete).
Questi componenti possono esser di due diverse tipologie:
- serrande di controllo del fumo per compartimenti multipli;
- serrande di controllo del fumo per singolo compartimento.
Le serrande di controllo del fumo per compartimenti multipli sono da utilizzarsi:
- quando installate sulla superficie di una condotta di controllo del fumo per
compartimenti multipli;
- quando installate a canale dove almeno uno dei due tratti di canale uniti dalla
serranda stessa è una condotta di controllo del fumo per compartimenti multipli.
In tutti gli altri casi sono da utilizzarsi serrande di controllo del fumo per singolo compartimento.
Tutte le serrande devono essere collegate al sistema di controllo in modo da poter
cambiare il loro stato aperto/chiuso in funzione dello scenario d'incendio occorso.
Se il sistema SEFFC non è attivato automaticamente da un sistema di rivelazione incendi,
tutte le serrande di controllo del fumo devono essere classificate "MA" ovvero per
intervento manuale (secondo la UNI EN 12101-8).
In tutti gli altri casi le serrande possono essere in alternativa classificate "AA" (per sistemi
ad attivazione automatica).
Le serrande utilizzate devono essere classificate secondo UNI EN 12101-8 anche per
poter assicurare il loro funzionamento fino alla maggiore pressione prevista dal progetto
nel punto in cui sono installate.
6.9.8 Barriere al fumo
Le barriere al fumo sono elementi che delimitano il perimetro del compartimento a soffitto
aventi dimensioni e caratteristiche conformi ai punti 6.3 e 6.4.
Nel caso debbano essere installate delle barriere al fumo, in complemento agli elementi
strutturali esistenti per racchiudere il compartimento a soffitto, queste devono essere
conformi alla UNI EN 12101-1.
Le barriere al fumo possono essere di due tipologie:
- fisse (o di tipo SSB);
- mobili (o di tipo ASB1, ASB2, ASB3 e ASB4).
Per quelle mobili, che possono essere di tipo flessibile o rigide, è sempre necessario il
collegamento al sistema di controllo dell'impianto SEFFC.
Il sistema di rilascio del meccanismo può essere indifferentemente del tipo "fail safe"
(come per le barriere tipo ASB1 e ASB3) o ad attivazione motorizzata (come per le
barriere tipo ASB2 e ASB4).
Gli elementi strutturali dell'edificio che garantiscono la separazione a soffitto dei diversi
serbatoi di fumo possono essere considerati come barriere al fumo fisse (SSB).
Tutti gli elementi perimetrali del compartimento a soffitto devono avere lo stesso livello
minimo di prestazione per la resistenza al calore e la permeabilità ai fumi e gas caldi delle
barriere aggiunte.
Il compartimento al fumo deve essere realizzato per limitare al minimo il fumo che può
invadere i compartimenti circostanti e inquinare lo strato libero da fumo come definito nel
punto 6.5.
Si ritiene che questo obiettivo è raggiunto se, in caso d’incendio, la somma di tutti gli spazi
liberi presenti sul perimetro del compartimento a soffitto fino al livello minimo delle
barriere al fumo non è maggiore dello 0.5% della loro superficie complessiva.
Le barriere al fumo devono inoltre soddisfare le condizioni indicate al punto 7.5.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 20
6.9.9 Condotte per l'immissione dell'aria esterna
Le condotte per l'immissione dell'aria esterna devono rispettare tutti i medesimi criteri
indicati nel punto 6.9.6 per le condotte di controllo fumo e calore.
6.9.10 Serrande per il controllo dell'immissione dell'aria esterna
Le serrande per il controllo dell'immissione dell'aria esterna devono rispettare tutti i
medesimi criteri indicati nel punto 7.7 per le serrande di controllo fumo e calore.
6.9.11 Ventilatori di immissione dell'aria esterna
Questi componenti possono essere installati all'esterno o all'interno.
Se installato all’interno ma nello strato di fumo, deve avere caratteristiche conformi alla
UNI EN 12101-3; se invece è installato nella zona prevista libera da fumo deve essere
protetto dai danni diretti provocati dall’incendio.
Qualora sia collegato ad una condotta per l'immissione dell'aria esterna per
compartimenti multipli, il ventilatore stesso deve essere protetto esternamente per avere
resistenza al fuoco pari a quella della condotta stessa (vedere prospetto 5).
Per i sistemi SEFFC con immissione dell'aria esterna centralizzata per più serbatoi di fumo,
il ventilatore deve essere dimensionato per la maggiore tra le portate volumetriche richieste
in ciascuna zona asservita. In questo caso il ventilatore deve tuttavia immettere la portata
volumetrica di aria richiesta dal compartimento a soffitto interessato dall'incendio ed
equivalente a quella estratta dallo stesso mediante il ventilatore per SEFFC.
Per le applicazioni all'esterno dell'edificio deve essere assicurata la compatibilità elettrica
e meccanica del ventilatore (agenti atmosferici, temperature, ecc.) per l'installazione
prevista.
6.9.12 Azionamento
6.9.12.1 Quadro di comando e controllo
Il quadro di comando e controllo deve essere in grado di realizzare e segnalare il ciclo di
attivazione del SEFFC e, in particolare, di tutti gli elementi attivi dello stesso quali:
- ventilatore per SEFFC;
- aperture per l'afflusso dell'aria esterna;
- serrande di controllo del fumo;
- barriere al fumo;
- serrande di controllo dell'immissione dell'aria esterna;
- ventilatori di immissione dell'aria esterna;
Il quadro di comando e controllo deve consentire, durante le operazioni di sorveglianza,
controllo e manutenzione, di eseguire, manualmente e/o in automatico in maniera anche
programmabile, tutte le operazioni necessarie per verificare i parametri di funzionamento
previsti dal progetto.
Grazie a tale sistema potranno essere segnalati eventuali stati di anomalia o di guasto di
uno o più componenti del sistema.
Le modalità di comando previste hanno lo scopo anche di evitare la ridondanza dei
componenti.
Il quadro di comando e controllo deve essere conforme al prEN 12101-9:2011.
Il SEFFC si può considerare attivo ed efficiente quando dopo un opportuno comando
successivo all’insorgere di un incendio, tutti i componenti attivi passano dallo stato di
veglia alla posizione antincendio.
I componenti interessati a questo cambiamento di stato sono soltanto quelli relativi ad uno
stesso compartimento a soffitto in cui si sviluppa l’incendio.
L’attivazione del SEFFC deve avvenire mediante segnale proveniente da sistema di
rilevazione incendio e/o da comando remoto manuale.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 21
In caso di presenza di più ventilatori per SEFFC per uno stesso compartimento a soffitto
è possibile differire tra loro l'accensione per ridurre il picco di assorbimento elettrico a cui
è sottoposto l'impianto di alimentazione elettrica. In ogni caso il tempo massimo trascorso
tra l'accensione del primo e dell'ultimo ventilatore per SEFFC dello stesso compartimento
a soffitto non deve essere maggiore di 2 min.
L’attivazione deve azionare le opportune segnalazioni visive ed acustiche locali e remote.
Il sistema deve essere collegato anche ai componenti del sistema HVAC (come estrattori,
ventilatori, lame d'aria, ventilconvettori, ecc.) che controllano la normale ventilazione nel
compartimento antincendio interessato.
Non è esclusa la possibilità che il sistema di comando e controllo del SEFFC possa
comandare e controllare il funzionamento di dispositivi di protezione passiva (serrande e
porte tagliafuoco) o attiva (sistemi sprinkler o affini) dell'incendio. In tal caso il sistema
deve essere conforme anche alle rispettive norme e disposizioni.
Se presente un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendi conforme alla
UNI 9795, il sistema di comando e controllo del SEFFC deve essere ad esso collegato
ricevendo la segnalazione di incendio in ogni specifico compartimento a soffitto.
Se non è presente alcun sistema di rivelazione d'incendio il sistema deve essere collegato
a punti d'allarme manuali, a dispositivi sonori e luminosi di allarme conformi alle norme
pertinenti della serie UNI EN 54.
In quest'ultimo caso ogni compartimento a soffitto deve contenere almeno un punto
d'allarme manuale, un dispositivo sonoro di allarme ed un dispositivo luminoso di allarme,
posizionati in modo chiaro e facilmente raggiungibile dal personale interno.
Nel caso sia presente un sistema automatico di comando e controllo del SEFFC esso è
composto da:
- una unità centrale anche modulare;
- una interfaccia di gestione;
- eventuali moduli di campo;
- eventuali cavi di trasmissione dati di collegamento tra l'unità centrale e i moduli di campo.
L'unità centrale del sistema, oltre a dover essere posizionata in luogo sicuro e protetto
dall'incendio, deve permettere la programmazione e modifica della configurazione di ogni
singolo componente dell'impianto SEFFC in funzione di ciascuna tipologia di scenario
d'incendio previsto.
Tale programmazione può essere effettuata tramite un dispositivo esterno o tramite
l'interfaccia di gestione.
Tale interfaccia (display, quadro elettrico o equivalente) deve inoltre permettere di
monitorare, attivare/disattivare o testare il corretto funzionamento di ciascun componente
dell'impianto SEFFC. Essa deve essere posizionata in luogo sicuro e protetto
dall'incendio e accessibile facilmente dalle squadre di intervento in caso d'incendio per
permettere, se necessario, di attivare/disattivare o forzare il sistema SEFFC.
I moduli di campo permettono di comandare e monitorare lo stato degli altri componenti
attivi del sistema SEFFC (ventilatori, serrande di controllo fumo e calore, barriere al fumo,
ASBx, aperture per l'afflusso dell'aria, ecc.). In alcuni casi i moduli di campo possono
essere già inclusi all'interno del componente attivo. Il funzionamento di ciascun modulo di
campo e dei cavi che lo collegano al componente del sistema SEFFC da controllare, deve
essere garantito per il tempo di funzionamento del sistema. Qualora necessario tali
elementi devono essere protetti dal fumo e calore da contenitori in materiale isolante
appropriato.
La topologia di collegamento tra moduli di campo e l'unità centrale deve essere composta
da uno o più anelli chiusi che partono e ritornano all'unità centrale stessa collegando tutti
i moduli di campo.
In caso di interruzione elettrica anche parziale in un punto qualsiasi dell'anello, o nel caso
si verifichi un cortocircuito tra due o più conduttori del cavo multipolare utilizzato per
l'anello, tutti moduli di campo devono rimanere sempre e comunque collegati all'unità
centrale del sistema permettendo il corretto funzionamento dell'intero sistema SEFFC.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 22
Negli edifici dotati di sistema di supervisione dell'impianto HVAC o di sistema BMS è
consigliato il collegamento al sistema di controllo del SEFFC per poter eseguire e
verificare il corretto funzionamento del sistema tramite le prove periodiche previste dal
progetto.
6.9.12.2 Impianto di alimentazione elettrica
L’impianto di alimentazione elettrica del SEFFC deve essere dedicato esclusivamente ad
esso; deve essere progettato e realizzato in modo da garantire l’alimentazione elettrica ai
componenti attivi del sistema SEFFC (ventilatori, serrande di controllo fumo e calore,
barriere al fumo ASBx, aperture per l'afflusso dell'aria, ecc.) anche se l’alimentazione
all’edificio servito viene interrotta per motivi di sicurezza o in caso di avaria di altri impianti
ad esso collegati.
Dove è consentito dal gestore della rete elettrica, l’alimentazione per il quadro di comando
e controllo delle apparecchiature deve essere presa a monte dell’interruttore generale
dell’alimentazione ai fabbricati e dove ciò non è permesso mediante il collegamento
dall’interruttore generale.
Ogni interruttore installato sulle linee di alimentazione dedicate alle apparecchiature
elettriche deve essere etichettato come segue:
ALIMENTAZIONE DEL MOTORE DEL …….
NON APRIRE IN CASO DI INCENDIO
Le lettere sull’etichetta devono essere alte almeno 10 mm e devono essere bianche su
sfondo rosso. Gli interruttori devono essere protetti contro eventuali manomissioni.
L’alimentazione deve essere sempre assicurata anche con dispositivi non ad uso
esclusivo dimensionati tenendo conto degli eventuali picchi di assorbimento dei ventilatori
o degli altri componenti dell'impianto per un tempo compatibile con la classe dell’edifico e
comunque derivante dalla valutazione del rischio.
Le alimentazioni devono essere conformi alla UNI EN 12101-10.
6.9.12.3 Cavi di alimentazione elettrica
Poiché deve essere garantito il funzionamento anche in caso di incendio, i cavi da
utilizzare devono essere di tipo “resistenti al fuoco”, rispondenti alla CEI 20-45, con una
tensione di funzionamento 0,6/1 kV e una durata garantita in servizio in caso di incendio
di 120 min.
6.9.12.4 Cavi di segnale e trasmissione dati
I cavi di trasmissione dati servono al collegamento tra l'unità centrale ed i moduli di campo
e devono avere una resistenza al fuoco determinata secondo la CEI EN 50200 per il
tempo di almeno 30 min ed essere conformi alla norma CEI 20-105.
7 INSTALLAZIONE, COMPONENTI E SISTEMA
7.1 Generalità
Tutti i componenti costituenti un sistema di evacuazione forzata fumo e calore (SEFFC)
devono essere installati in conformità a:
- istruzioni del produttore;
- progetto esecutivo dettagliato (DEP).
L’installazione dei componenti deve essere effettuata nel rispetto dei regolamenti locali,
delle condizioni di installazione (caratteristiche costruttive dell’edificio) e in maniera tale
da garantire le condizioni di sicurezza.
I componenti devono essere posizionati in modo tale da poter eseguire in maniera
agevole e in sicurezza tutte le operazioni di controllo, manutenzione e riparazione,
necessarie per mantenerli in efficienza.
A tale scopo devono essere previsti sportelli o pannelli di accesso, golfari o appoggi.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 23
Adeguati spazi di manovra devono essere lasciati disponibili per tutte le componenti
mobili degli SEFFC; tali spazi devono essere mantenuti liberi da ostruzioni quali parti
mobili o fisse della costruzione.
Per quanto applicabile si rimanda alla UNI EN 15423.
7.2 Installazione ventilatori
Per quanto applicabile si rimanda alla UNI EN 15423.
7.3 Installazione condotte
Per quanto applicabile si rimanda alla UNI EN 15423.
7.4 Installazione delle prese d’aria
L’installatore realizza le prese d’aria secondo quanto indicato dal progetto costruendo
quelle dedicate e individuando quelle esistenti. Su entrambe le tipologie devono essere
applicati appositi cartelli segnaletici.
Ogni presa d’aria deve essere marcata con targhetta che specifica:
- l’indicazione “APERTURA PER L’AFFLUSSO D’ARIA DEL SEFFC”;
- lo spazio libero richiesto attorno per il corretto funzionamento.
Devono essere evitati all’interno e all’esterno delle prese per l’afflusso di aria fresca
ostacoli fissi che ne pregiudicano l’efficienza.
7.5 Installazione delle barriere al fumo
Una barriera al fumo può essere una parte della struttura, può essere una barriera fissa o
una barriera mobile o una combinazione di queste.
I fissaggi devono resistere alle sollecitazioni dovute al fuoco. Non sono ammessi i fissaggi
con parti in plastica. I fissaggi devono garantire presa anche su zone tese delle strutture.
La parte superiore delle barriere deve essere a tenuta e non presentare fessure. Sono
consentite fessure tra parti della barriera e tra la barriera e le strutture laterali;
complessivamente la superficie non deve comunque superare il valore indicato nel progetto.
Nella superficie totale deve essere tenuta in conto la possibile deflessione della barriera.
L’aumento della temperatura non deve creare nuove fessure o allargare le fessure
esistenti della barriera.
Nel caso di impiego delle barriere al fumo su balconate degli atri devono chiudere
completamente l’affaccio ed essere installate con guide laterali. È consigliata
l’installazione di barriere con classificazione DH (30, 60, 120 min) in modo da poter
resistere al fuoco per il tempo proprio della classe dell’ambiente.
7.6 Installazione dei comandi
Se le zone sono più di una, schemi con la posizione dei meccanismi di apertura e le zone
cui sono collegati devono essere posti nei pressi del pannello di comando.
Gli elementi di comando devono essere installati in luoghi sicuri e facilmente accessibili in
caso d’incendio.
Tutti i dispositivi di comando devono essere contrassegnati adeguatamente.
7.7 Installazione delle linee e dei quadri
Tutti i cavi devono essere protetti contro il fuoco e i danni meccanici e, se possibile,
passare all’esterno delle zone protette dall’impianto o attraverso quelle parti dell’edificio
dove il pericolo di incendio è trascurabile e che sono separate da qualsiasi significativo
pericolo di incendio mediante pareti, tramezzi o pavimenti con una resistenza al fuoco non
minore di 60 min. I cavi devono essere di singola tratta senza giunzioni.
Il quadro elettrico principale deve essere situato in un compartimento antincendio
utilizzato esclusivamente per l’alimentazione elettrica.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 24
8 DOCUMENTAZIONE (MANUALE) DELL’IMPIANTO
Al fine della realizzazione del SEFFC deve essere approntata una documentazione
comprendente le informazioni che permettono di controllare e successivamente gestire
l’impianto, in modo da garantirne il mantenimento della conformità e l’efficienza. Questo
manuale comprende i documenti di progetto aggiornati per renderli conformi a quanto
realizzato. Deve essere inoltre predisposta la documentazione seguente:
- rapporto di verifica di primo funzionamento;
- documentazione componenti conformi alle norme e le specifiche di riferimento;
- schede tecniche,
- manuale installazione, uso e manutenzione;
- manuale di uso e manutenzione con istruzioni di funzionamento, controlli periodici e
manutenzione del SEFFC.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 25
APPENDICE A CALCOLO DELLA PORTATA VOLUMETRICA NEL CASO DI RILASCIO TERMICO DI
(normativa) 600 kW/m2
A.1 Generalità
I prospetti A.1 e A.2 possono essere applicati al posto dei prospetti 2, 3 e 4 se,
nell’eventualità di un incendio, il rilascio termico non è maggiore di 600 kW/m2.
prospetto A.1 Portata volumetrica di aspirazione (m3/h) per ogni compartimento a soffitto (dato un rilascio termico
di 600 kW/m2)
Riga Spessore dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1 2,5 38 000 64 000 112 000 -1) -1)
2 3 44 000 73 000 124 000 -1) -1)
3 4 58 000 92 000 152 000 257 000 448 000
4 5 71 000 115 000 183 000 301 000 511 000
5 6 84 000 136 000 218 000 351 000 581 000
6 7 93 000 155 000 256 000 404 000 657 000
7 8 109 000 175 000 286 000 462 000 738 000
8 9 127 000 194 000 316 000 522 000 825 000
9 10 149 000 210 000 345 000 570 000 916 000
1) In questa condizione è lecito supporre condizioni di incendio generalizzato ( flash-over ) che rendono il sistema
SEFFC inefficace nella creazione di uno strato libero da fumo per proteggere le persone presenti nel locale. È quindi
necessario modificare il progetto per ottenere un Gruppo di Dimensionamento minore.
prospetto A.2 Temperatura media del fumo TF (°C) dato un rilascio termico di 600 kW/m2
Riga Spessore dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1 2,5 291 403 561 - -
2 3 226 311 432 - -
3 4 154 209 288 398 555
4 5 120 155 212 291 403
5 6 101 126 166 226 311
6 7 91 109 136 184 251
7 8 79 97 119 154 209
8 9 69 87 107 132 179
9 10 61 81 98 120 155
1) In questa condizione è lecito supporre condizioni di incendio generalizzato ( flash-over ) che rendono il sistema
SEFFC inefficace nella creazione di uno strato libero da fumo per proteggere le persone presenti nel locale. È quindi
necessario modificare il progetto per ottenere un Gruppo di Dimensionamento minore.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 26
prospetto A.3 Temperatura locale del fumo TF,locale (°C) per la determinazione della classe di temperatura degli
elementi di un impianto SEFFC dato un rilascio termico di 600 kW/m 2
Riga Spessore dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1)
1 2,5 510 713 - - -
1)
2 3 371 516 722 - -
1)
3 4 287 397 554 775 -
4 5 193 265 367 510 7131)
5 6 150 196 268 371 516
6 7 125 157 209 287 397
7 8 112 135 170 232 320
8 9 96 119 149 193 265
9 10 83 107 133 166 226
1) In questa condizione è lecito supporre condizioni di incendio generalizzato ( flash-over ) che rendono il sistema
SEFFC inefficace nella creazione di uno strato libero da fumo per proteggere le persone presenti nel locale. È quindi
necessario modificare il progetto per ottenere un Gruppo di Dimensionamento minore.
prospetto A.4 Densità corrispondenti alle diverse temperature medie dei fumi TF,media
Riga Spessore dello strato Gruppo di dimensionamento
libero da fumo (m)
1 2 3 4 5
1 2,5 0,63 0,52 0,42 - -
2 3 0,71 0,60 0,50 - -
3 4 0,83 0,73 0,63 0,53 0,43
4 5 0,90 0,82 0,73 0,63 0,52
5 6 0,94 0,88 0,80 0,71 0,60
6 7 0,97 0,92 0,86 0,77 0,67
7 8 1,00 0,95 0,90 0,83 0,73
8 9 1,03 0,98 0,93 0,87 0,78
9 10 1,06 1,00 0,95 0,90 0,82
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 27
APPENDICE B PRINCIPI DI DIMENSIONAMENTO
(informativa)
B.1 Modello di calcolo
Il calcolo della portata volumetrica di estrazione è stato condotto prendendo in
considerazione diversi scenari di incendio, con diversi gruppi di dimensionamento, sulla
base di un modello a zone semplificato.
L’ambiente considerato è stato semplificato come costituito da due macrovolumi. Uno
superiore (compartimento a soffitto) contenente i prodotti della combustione; il secondo,
più basso, rappresentante invece l’aria a condizioni ambiente. Si è ipotizzato quindi la
presenza ad una determinata altezza dal pavimento di un’interfaccia con una variazione a
gradino, per esempio, della temperatura in corrispondenza ad essa. All’interno di
ciascuno dei due volumi descritti, il tipo di schematizzazione assunta presuppone
l’uniformità nello spazio di grandezze di interesse quali, per esempio, la temperatura.
La determinazione delle portate d’aria è il risultato del bilancio dei flussi di massa e di
energia entranti e uscenti dallo strato contenente i prodotti della combustione. Il calcolo è
stato eseguito in regime stazionario, trascurando quindi il transitorio di accensione, ma
prendendo in considerazione determinate superfici dell’incendio. Nel calcolo si è tenuto
inoltre conto della trasmissione del calore agli elementi strutturali lambiti dallo strato di
fumo e della frazione scambiata per irraggiamento dalle fiamme.
Il calcolo delle portate volumetriche degli impianti SEFFC è stato effettuato in modo tale
che questi garantiscano lo stesso livello di sicurezza degli impianti SENFC. I rilasci termici
considerati nel dimensionamento sono stati due: 300 kW/m2 e 600 kW/m2. Le ipotesi di
calcolo, con riferimento ad un rilascio termico di 300 kW/m2, per ciascun gruppo di
dimensionamento, sono riassunte dal prospetto seguente:
prospetto B.1 Ipotesi di calcolo per un rilascio termico di 300 kW/m2
Parametro Gruppo di dimensionamento
1 2 3 4 5
Superficie dell’incendio m2 5 10 20 40 80
Lato m 2,236 3,162 4,472 6,325 8,944
Diametro m 2,523 3,568 5,046 7,136 10,093
Perimetro m 7,927 11,210 15,853 22,420 31,707
Rilascio termico kW 1 500 3 000 6 000 12 000 24 000
Parte convettiva kW 1 200 2 400 4 800 9 600 19 200
Si fa notare come a ciascun gruppo di dimensionamento corrisponda una determinata
area dell’incendio. Ciò significa che, a seguito delle ipotesi fatte circa la velocità di
propagazione dell’incendio e della durata convenzionale dell’incendio, essendo questi i
parametri da cui dipende la scelta del gruppo di dimensionamento, si è implicitamente
supposto di riuscire a confinare all’area indicata la propagazione delle fiamme. Se tale
contenimento non è possibile, l’impianto SEFFC non è in grado di mantenere l’altezza
libera da fumi voluta.
B.2 Ambienti protetti con SEFFC e con altri impianti antincendio
Se si deve evitare che in caso di incendio un locale sia completamente invaso dal fumo
(per esempio per garantire la fuga o il salvataggio delle persone, per salvare beni materiali
e per permettere al personale addestrato di intervenire per iniziare le opere di
spegnimento) il mantenimento di uno strato libero da fumo è possibile solo in presenza un
impianto di estrazione fumo; un impianto antincendio non è in grado da solo di assicurare
tali condizioni.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 28
Quando si impiegano congiuntamente un impianto di estrazione del fumo e un sistema di
estinzione del fuoco, occorre combinare i due sistemi in modo tale da salvaguardare la
massima sicurezza e da scongiurare eventuali interferenze negative.
Ai fini del dimensionamento di un impianto SEFFC (flusso volumetrico, resistenza alle
temperature dei componenti, ecc.), le condizioni di progetto dovrebbero corrispondere a
quelle che si verificano nell’istante in cui sono attivati gli sprinkler se esistenti. L’attivazione
dell’impianto sprinkler riduce il rilascio termico, la temperatura dei fumi e la quantità di
fumo presente e questo giustifica la scelta di gruppi di dimensionamento inferiori. Per
questo motivo, nel caso di presenza di impianto sprinkler, senza fornire particolari
spiegazioni, è consentita la scelta del gruppo di dimensionamento immediatamente
inferiore del prospetto 1.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 29
APPENDICE C SPINTA DI GALLEGGIAMENTO
(informativa)
C.1 Generalità
La differenza di densità tra uno strato di gas caldo e il fluido circostante risulta in una
differenza di pressione. Se si ipotizza che temperatura ambiente e temperatura dello
strato libero da fumi siano uguali e se si suppone che l’interfaccia tra strato libero da fumi
e strato dei fumi corrisponda al piano neutro, tale differenza di pressione può essere
espressa dalla formula:
'P = (U0 - U)gh (C.1)
Se si ipotizza il comportamento ideale e si assume che le variazioni della pressione siano
trascurabili rispetto al valore atmosferico ritenendo cioè le trasformazioni isobare, la
densità ad una data temperatura è legata a questa dalla relazione:
U0 T0
U = -----------
- (C.2)
T
Sostituendo tale relazione all’interno dell’espressione precedente, è possibile ricavare la
differenza di pressione in funzione della temperatura ambiente (T0) e della temperatura
dello strato di gas caldi (Tf) secondo la formula:
T
'P = U0 gh § 1 – -----0- · (C.3)
© Tf ¹
Nella formula riportata il termine h indica la differenza di quota (m) tra l’interfaccia dello
strato di gas caldi e una generica posizione all’interno dello strato di fumo.
figura C.1 Differenziale di pressione in funzione della temperatura dello strato dei fumi e della quota h
all’interno di questo (T0 = 20 °C)
Legenda
1m
2m
3m
4m
5m
1 Temperatura dei fumi (°C)
2 Differenziale di pressione 'p (Pa)
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 30
La spinta di galleggiamento determinata dallo spessore dello strato di fumo aiuta il
ventilatore di estrazione del fumo. Inoltre, grazie alla spinta di galleggiamento, in caso di
avaria di un ventilatore, se questo non è bloccato o frenato, si crea comunque una
corrente di estrazione del fumo che fuoriesce naturalmente.
C.2 Nota sulle caratteristiche dei ventilatori
La portata di massa di un ventilatore è definita nella formula:
·
m· = V u U (C.4)
dove:
m· è la portata di massa (kg/s);
·
V è la portata volumetrica (m3/s);
U è la massa volumica (kg/m3).
Segue che all’aumentare della temperatura dei fumi elaborati, diminuisce la
corrispondente portata di massa.
Dato il legame tra temperatura e densità, è preferibile posizionare i ventilatori SEFFC
verso l’uscita dei condotti di estrazione del fumo. Le dispersioni di calore all’interno
dell’impianto SEFFC, funzioni della velocità della corrente e dalle proprietà di isolamento
termico dei condotti, provocano una riduzione della temperatura. La portata di massa del
fumo che viene estratta aumenta all’aumentare della densità a causa dell’abbassamento
delle temperature, anche a parità di portata volumetrica elaborata dal ventilatore.
figura C.2 Portata di massa elaborata dal ventilatore e portata volumetrica in funzione della temperatura
Legenda
Portata volumetrica
Portata in massa
1 Temperatura dei fumi (°C)
2 % della portata
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 31
APPENDICE D SCHEMI E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI SEFFC
(informativa)
D.1 Generalità
L'elevata casistica dei possibili scenari d'incendio in un edificio richiede soluzioni in grado
di configurare tutti i componenti dell'impianto in modo opportuno. Negli schemi seguenti
sono illustrati gli schemi per le principali applicazioni SEFFC con l’indicazione dei vari
componenti. Si fa presente come negli schemi proposti non siano richiamati i componenti
relativi a controllo, comando e alimentazioni.
Le varie tipologie di SEFFC possono essere classificate sulla base delle seguenti
caratteristiche:
1) tipologia di aspirazione/evacuazione fumo e calore (sistemi con aspirazione diretta
nell’ambiente, canalizzata per singolo compartimento a soffitto o centralizzata per
più serbatoi di fumo);
2) interazione con compartimentazione antincendio (sistemi atti a estrarre il fumo e
calore da un singolo compartimento antincendio o da compartimenti multipli);
3) tipologia di immissione aria esterna (sistemi con afflusso naturale o forzato);
4) natura dell'impianto SEFFC (solo estrazione fumi o doppia funzione).
Per questo motivo, ogni SEFFC può essere descritto da una sigla di 4 lettere così definita:
D.2 Classificazione
D.2.1 Generalità
Nelle figure seguenti sono indicati i diversi esempi di classificazione.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 32
Legenda figure da D.1 a D.6
1 Ventilatore per SEFFC
2 Apertura per l’afflusso di aria esterna
3 Compartimento antincendio
4 Compartimento a soffitto
5 Apertura di estrazione fumo e calore
6 Condotta per l’estrazione di fumo
7 Barriera al fumo o elemento strutturale
8 Serranda di controllo del fumo per singolo compartimento montata a canale
9 Serranda di controllo del fumo per singolo compartimento montata sulla superficie del canale
10 Serranda di controllo del fumo per compartimenti multipli montata a canale o su parete
11 Condotta di controllo del fumo per compartimenti multipli
12 Serranda di controllo del fumo per compartimenti multipli montata sulla superficie del canale
13 Serranda di controllo dell'immissione aria esterna per compartimenti multipli montata a
canale o su parete
14 Serranda di controllo dell'immissione aria esterna per compartimenti multipli montata sulla
superficie del canale
15 Ventilatore di immissione aria esterna
16 Condotta per l'immissione dell'aria esterna per compartimenti multipli
D.2.2 Classificazione sulla base della tipologia di aspirazione
figura D.1 Esempio SEFFC-DSNS con aspirazione diretta per un unico compartimento a soffitto, per singolo
compartimento antincendio ad immissione aria esterna naturale
figura D.2 Esempio SEFFC-MSNS con aspirazione canalizzata per un unico compartimento a soffitto, per
singolo compartimento antincendio ad immissione aria esterna naturale
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 33
figura D.3 Esempio SEFFC-CSNS con aspirazione centralizzata per tre diversi compartimenti a soffitto, per
singolo compartimento antincendio ad immissione aria esterna naturale
D.2.3 Classificazione sulla base dell’interazione con compartimentazione antincendio
figura D.4 Esempio di due SEFFC per compatimenti antincendio singoli (SEFFC-CSNS quello al piano
superiore e SEFFC-DSNS quello al piano inferiore) applicati ad un unico edificio
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 34
figura D.5 Esempio SEFFC-CMNS per compartimenti antincendio multipli di un unico edificio
D.2.4 Classificazione sulla base della tipologia di immissione aria esterna
La caratterizzazione di un impianto SEFFC può essere operata anche in base alla
tipologia di immissione dell’aria esterna di ricambio.
Si consideri la figura D.5; la rappresentazione dell’impianto configura un SEFFC con
immissione naturale dell’aria esterna. Laddove l’immissione di aria esterna fosse
meccanica, la corrispondente rappresentazione dell’impianto sarebbe quella proposta
nella figura D.6.
figura D.6 Esempio SEFFC-CMFS con immissione forzata dell'aria esterna per compartimenti antincendio
multipli
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 35
D.2.5 Impianti a doppia funzione
Gli impianti a doppia funzione consentono il doppio utilizzo delle installazioni: sia per la
ventilazione e climatizzazione degli ambienti in cui sono presenti sia, in caso di necessità,
per l’evacuazione del fumo e del calore.
La “doppia funzione” può essere ottenuta con l’applicazione degli schemi precedenti (per
esempio, al caso dei torrini d’estrazione impiegabili anche per la ventilazione estiva).
È evidente, però, che data la variabilità delle tipologie impiantistiche riscontrabili nei
sistemi finalizzati alla ventilazione e/o alla climatizzazione degli ambienti non è facile
schematizzare tali applicazioni.
Evidentemente tali applicazioni devono derivare da una studiata combinazione delle
prestazioni dei vari componenti.
D.2.6 Casi particolari
Esistono impianti di evacuazione forzata di fumo e calore che, per la particolare natura
dell'edificio, non possono essere categorizzati tra quelli sopra esposti. In questi casi
particolari è possibile ricorrere ai metodi dell’approccio ingegneristico. Nelle figure
seguenti sono riportati alcuni esempi.
figura D.7 Edifici monopiano con galleria interna coperta (mall) (priva di scale, scale mobili o altre strutture
verticali di esodo) predisposta per l'evacuazione del fumo
Legenda
y Altezza libera
1 Galleria interna coperta
2 Negozio (sede dell’incendio)
3 Negozio
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 36
figura D.8 Edifici multipiano con galleria interna coperta (mall) priva di scale, scale mobili o altre strutture
verticali di esodo) predisposta per l’evacuazione del fumo
Legenda
1 Volume di aria calda a soffitto
2 Stratificazione del fumo
figura D.9 Edifici con balconi non destinati a vie di esodo
Legenda
1 Scarico del fumo
2 Ingresso dell’aria esterna
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 37
APPENDICE E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
(normativa)
E.1 Generalità
Nella redazione del progetto, si deve tener conto di tutte le condizioni che possono
influenzare il SEFFC.
Il progetto si suddivide in due fasi:
- una fase preliminare che permette di individuare tutti gli elementi che identificano il
progetto e le caratteristiche e i dati che permettono di giungere ad un progetto
preliminare e/o di massima;
- una fase esecutiva che deve confermare o adeguare le ipotesi del progetto
preliminare per sviluppare un progetto definitivo e/o esecutivo del SEFFC.
Tutte le informazioni che identificano l’attività e da cui il progettista ricava i parametri di
calcolo devono essere desunte da documenti pertinenti o comunicate da persone che ne
sono responsabili.
Tutti i disegni e i documenti informativi devono riportare le seguenti indicazioni:
a) il nome dell’utente e del proprietario, laddove conosciuto;
b) l’indirizzo e l’ubicazione di ogni fabbricato;
c) la destinazione d’uso di ogni singolo edificio;
d) il nome dell’esecutore del progetto;
e) il nome della persona responsabile del controllo del progetto, che non deve essere
l’esecutore del progetto;
f) la data ed il numero di emissione.
E.2 Fase preliminare
Devono essere forniti almeno i seguenti elaborati:
a) una relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti
comprensiva, dello schema a blocchi. La relazione deve includere tutti gli elementi
necessari per il corretto dimensionamento del sistema;
Nota Le informazioni devono essere coerenti con l’analisi del rischio dell’attività.
b) un insieme di tavole grafiche del(i) fabbricato(i) che illustri:
1) il(i) tipo(i) di installazione e il gruppo di dimensionamento,
2) l’estensione del sistema con l’indicazione della compartimentazione a soffitto,
3) la destinazione delle aree da proteggere,
4) almeno una sezione trasversale (tipica) dell’intera altezza dell’edificio con
l’indicazione dell’altezza della zona libera da fumo e delle barrire al fumo;
c) la dichiarazione che il progetto preliminare e/o di massima, si basa sulla conformità
del SEFFC alla presente norma, oppure che fornisca le informazioni di ogni
scostamento dai requisiti della stessa e le relative motivazioni, sulla base delle
informazioni disponibili.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 38
E.3 Fase successiva (progetto definitivo e/o esecutivo)
Devono essere forniti almeno i seguenti elaborati:
a) scheda riassuntiva del progetto che indichi:
1) il nome del progetto e del progettista,
2) elenco dei disegni e dei documenti con titoli, numero e indice di revisione, data di
emissione,
3) un elenco dei componenti inclusi nel sistema con le relative specifiche,
4) la dichiarazione che il progetto del SEFFC è stato progettato e deve essere
installato in conformità alla presente norma, oppure che fornisca le informazioni
di ogni scostamento dai requisiti della stessa e le relative motivazioni, sulla base
delle informazioni disponibili;
b) relazione tecnico descrittiva dettagliata per ogni locale da proteggere che indichi:
1) consistenza degli impianti e suddivisione in compartimenti a soffitto,
2) normativa di riferimento,
3) relazione di calcolo e dimensionamento dei componenti con dati di progetto e
risultati dei calcoli,
4) criteri di scelta dei componenti (ventilatori, barriere al fumo, ingressi d’aria,
alimentazioni, ecc.),
5) dimensionamento delle linee,
6) elenco componenti (tipologia, specifiche di riferimento e prestazioni);
c) schema funzionale a blocchi con la rappresentazione delle zone (compartimenti a
soffitto), e la logica di funzionamento.
Per impianti particolarmente complessi, questa può essere espressa tramite una
matrice di funzionamento che riporti:
- l’elenco completo di tutti i componenti dell’impianto e il loro stato in funzione
della localizzazione dell’incendio,
- sulle ascisse (ovvero sulla prima riga) l'elenco di tutti gli scenari d'incendio
ipotizzabili e pari ad almeno il numero di serbatoi di fumo presenti, oltre allo
scenario di assenza di allarme,
- sulle altre celle del prospetto lo stato di funzionamento (aperto/chiuso,
acceso/spento, portata volumetrica o velocità del ventilatore, ecc.) previsto per
ogni elemento in ordinata in funzione della situazione/scenario in essere;
d) disegni di layout del SEFFC con le seguenti informazioni:
1) orientamento della planimetria,
2) tipi e posizione dei ventilatori,
3) tipi e posizione barriere al fumo,
4) tipi e posizione ingressi d’aria,
5) tipi e posizione organi di controllo, comando e alimentazioni,
6) linee di collegamento,
7) interfacce con altri impianti,
8) sezioni rilevanti,
9) legenda dei simboli utilizzati.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 39
APPENDICE F LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO DI DIMENSIONAMENTO
(informativa)
F.1 Generalità
La presente appendice fornisce indicazioni orientative per la scelta dei tempi di intervento
e delle velocità di propagazione che devono essere successivamente verificate con
un’analisi secondo la specificità dei casi in esame.
F.2 Criteri di scelta per la determinazione del tempo di intervento
Il tempo di intervento delle squadre di soccorso esterno (VVF) deve essere definito
preferibilmente dopo avere verificato direttamente con il distaccamento della zona in cui è
ubicata la costruzione.
A titolo indicativo viene fornito il prospetto F.1 che fornisce dei valori che sono le medie dei
tempi di intervento nelle varie province. Questi valori non possono essere assunti
direttamente come tempi di intervento ma danno soltanto una valutazione qualitativa delle
difficoltà con cui i VVF riescono ad intervenire a secondo delle zone.
I valori indicati sono espressi in minuti e sono calcolati sulla media dei "tempi medi di
arrivo" degli anni 2008, 2009 e 2010, arrotondata per eccesso al minuto primo, ed i cui
valori sono stati ricavati dall' "Annuario statistico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"
edizione 2010.
Il progettista può altresì utilizzare valori basati su dati statistici più recenti pubblicati in via
ufficiale dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o concordare con il comando locale dei
VVF il valore più corretto.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 40
prospetto F.1 Valori medi dei tempi di intervento dei VVFF
Provincia t Provincia t Provincia t
AGRIGENTO 12 GORIZIA 9 POTENZA 21
ALESSANDRIA 9 GROSSETO 13 PRATO 17
ANCONA 12 IMPERIA 8 RAGUSA 11
AREZZO 14 ISERNIA 13 RAVENNA 9
ASCOLI PICENO 15 LA SPEZIA 12 REGGIO CALABRIA 19
ASTI 11 L'AQUILA 12 REGGIO EMILIA 9
AVELLINO 12 LATINA 13 RIETI 18
BARI 12 LECCE 14 RIMINI 14
BELLUNO 11 LECCO 15 ROMA 19
BENEVENTO 12 LIVORNO 14 ROVIGO 13
BERGAMO 17 LODI 18 SALERNO 14
BIELLA 14 LUCCA 12 SASSARI 11
BOLOGNA 13 MACERATA 12 SAVONA 11
BRESCIA 15 MANTOVA 12 SIENA 15
BRINDISI 16 MASSA CARRARA 12 SIRACUSA 10
CAGLIARI 12 MATERA 13 SONDRIO 13
CALTANISSETTA 8 MESSINA 13 TARANTO 18
CAMPOBASSO 15 MILANO 14 TERAMO 12
CASERTA 14 MODENA 15 TERNI 10
CATANIA 9 NAPOLI 10 TORINO 13
CATANZARO 16 NOVARA 14 TRAPANI 11
CHIETI 15 NUORO 12 TREVISO 18
COMO 14 ORISTANO 18 TRIESTE 6
COSENZA 15 PADOVA 13 UDINE 12
CREMONA 11 PALERMO 14 VARESE 13
CROTONE 13 PARMA 14 VENEZIA 14
CUNEO 11 PAVIA 14 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 12
ENNA 15 PERUGIA 15 VERCELLI 14
FERRARA 13 PESARO 13 VERONA 17
FIRENZE 19 PESCARA 15 VIBO VALENTIA 12
FOGGIA 12 PIACENZA 18 VICENZA 15
FORLI 15 PISA 13 VITERBO 19
FROSINONE 16 PISTOIA 16
GENOVA 11 PORDENONE 11
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 41
F.3 Classificazione ai fini della determinazione della velocità di propagazione
dell’incendio
La classificazione ai fini della determinazione della velocità di propagazione è ricavata
sulla base della classificazione dei pericoli tipici, della metodologia per la catalogazione
delle merci immagazzinate e delle categorie di deposito in funzione dei prodotti indicati
nelle appendici A, B, C della UNI EN 12845.
La velocità di propagazione dell’incendio dipende dal tipo di materiale e dalla sua
configurazione e disposizione.
In mancanza di dati specifici è possibile fare una valutazione di massima della velocità di
propagazione riferendosi alla classificazione dei pericoli tipici indicate nella UNI EN 12845.
prospetto F.2 Gruppi di pericolo e corrispondenti velocità di propagazione dell’incendio
Velocità di propagazione Gruppo di pericolo
dell’incendio secondo UNI EN 12845
Bassa LH; OH1
Media OH2, OH3; OH4
Alta HHP, HHS
Il prospetto F.2 si riferisce soltanto al tipo di attività e non contiene nessun riferimento al
tipo di stoccaggio che richiede una particolare attenzione in quanto una disposizione
verticale delle merci può aumentare la velocità di propagazione.
Nel caso di stoccaggio di grande altezza è inoltre molto probabile che ci siano degli
sprinkler sia in alto che ad altezza intermedia.
Nella scelta della velocità di propagazione si raccomanda di porre attenzione alla
disposizione del materiale che può sia accelerare l’incendio, favorendo la ventilazione
della combustione, sia rallentare la propagazione dell’incendio nel caso in cui i prodotti
siano disposti in modo sparso e distanziato.
F.4 Indicazioni circa la determinazione del rilascio termico
Anche se sono state effettuate alcune ricerche sul rilascio termico di un certo numero di
materiali, queste non sono rappresentative di un generico incendio. Un incendio reale
coinvolge una grande quantità di materiali combustibili. Pertanto, non è applicabile un
valore riferito ad un materiale specifico, ma è necessario essere in grado di valutare il
rilascio termico per l’attività in questione in termini di condizioni più gravose ai fini della
tutela di persone e beni.
A tal fine si può fare riferimento al CEN/TR 12101-5 oppure al prospetto E.5
dell’Eurocodice UNI EN 1991-1-2:2004.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 42
APPENDICE G INTEGRAZIONE DI UN SEFFC IN IMPIANTI HVAC
(informativa)
Nota La presente appendice ha carattere informativo nei confronti del corpo della norma; nel caso sia utilizzata se
ne raccomanda la sua applicazione integrale.
G.1 Generalità
In alcuni casi è possibile valutare l’utilizzo di una o più parti di impianti di climatizzazione
in un SEFFC.
È bene precisare che l’esistenza di un sistema di climatizzazione che prevede un ricambio
dell’aria ambiente non può sostituire un SEFFC senza opportune sostanziali modifiche.
La presente appendice informativa ha lo scopo di proporre delle linee guida che
riassumono i punti fondamentali delle verifiche sia funzionali, sia di idoneità del tipo di
costruzione e di prodotti utilizzati.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vengono elencati degli impianti che possono
essere presenti negli ambienti da proteggere:
- Impianti di ventilazione per l’igiene (in pressione o depressione o combinati).
- Impianti di riscaldamento ad aria.
- Impianti di climatizzazione.
Sono possibili diverse integrazioni:
- sistema di immissione utilizzato sia per HVAC che per SEFFC;
- sistema di estrazione utilizzato per HVAC e SEFFC;
- combinazione dei sistemi di immissione ed estrazione.
G.2 Raccomandazioni
G.2.1 Progettazione
La possibilità di integrazione di SEFFC e sistema HVAC deve essere valutata in fase di
dimensionamento e progettazione verificando:
- Portate dei sistemi (funzionamento antincendio, funzionamento HVAC).
- Dimensioni e posizione sistemi di mandata e/o aspirazione di aria e fumo.
- Sistema di controllo e comando e logica di attivazione e funzionamento.
Il progetto deve individuare, giustificandone l’idoneità ai sensi della presente norma, le
eventuali bocchette di immissione e/o di aspirazione.
Le soluzioni tecniche adottate devono essere totalmente conformi alla presente norma
garantendo lo stesso livello di efficienza e affidabilità.
Un opportuno schema funzionale deve indicare lo stato dei componenti in funzione dello
stato dell’impianto (stato di veglia, posizione antincendio) e dei relativi compartimenti a
soffitto.
In questo caso lo stato di veglia può coincidere con il funzionamento corrente del sistema
HVAC.
Il passaggio dallo stato di veglia alla posizione antincendio deve essere possibile in ogni
momento garantendo la priorità al comando relativo (manuale e/o automatico).
Si riporta nel prospetto G.1 una matrice di funzionamento che riassume queste
informazioni.
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 43
prospetto G.1 Esempio di matrice di funzionamento
Elementi di campo No allarme Incendio Incendio Incendio Incendio Incendio Incendio Incendio Incendio
zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 zona 7 zona 8
Mandata UTA 1 Auto Off Off Off Off On On On On
Ripresa UTA 1 Auto Off Off Off Off On On On On
Recuperatore rotativo UTA 1 Auto Off Off Off Off On On On On
Mandata UTA 2 Auto On On On On Off Off Off Off
Ripresa UTA 2 Auto On On On On Off Off Off Off
Ventilatore SEFFC 1 Off On On On On Off Off Off Off
Serranda controllo fumo zona 1 Chiusa Aperta Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa
Serranda controllo fumo zona 2 Chiusa Chiusa Aperta Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa
Serranda controllo fumo zona 3 Chiusa Chiusa Chiusa Aperta Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa
Serranda controllo fumo zona 4 Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Aperta Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa
Barriere mobili al fumo zona 1, 2, 3 e 4 Alzate Abbassate Abbassate Abbassate Abbassate Alzate Alzate Alzate Alzate
Porte/finestre aria esterna zona 1, 2, 3 e 4 Auto Aperte Aperte Aperte Aperte Auto Auto Auto Auto
Aperture aria esterna zona 1, 2, 3 e 4 Chiuse Aperte Aperte Aperte Aperte Chiuse Chiuse Chiuse Chiuse
3
Ventilatore SEFFC 2 - portata 35 000 m /h Off Off Off Off Off On On Off Off
3
Ventilatore SEFFC 2 - portata 55 000 m /h Off Off Off Off Off Off Off On On
Serranda controllo fumo zona 5 Auto Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Aperta Chiusa Chiusa Chiusa
Serranda controllo fumo zona 6 Auto Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Aperta Chiusa Chiusa
Serranda controllo fumo zona 7 Auto Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Aperta Chiusa
Serranda controllo fumo zona 8 Auto Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Chiusa Aperta
Barriere mobili al fumo zona 5, 6, 7 e 8 Alzate Alzate Alzate Alzate Alzate Abbassate Abbassate Abbassate Abbassate
Porte/finestre aria esterna zona 5, 6, 7 e 8 Auto Auto Auto Auto Auto Aperte Aperte Aperte Aperte
Aperture aria esterna zona 5, 6, 7 e 8 Chiuse Chiuse Chiuse Chiuse Chiuse Aperte Aperte Aperte Aperte
G.2.2 Prescrizioni sui componenti
Tutti i componenti e le parti dell‘impianto HVAC, già conformi alle pertinenti norme, che
partecipano anche all’evacuazione di fumo e calore o che possono essere in contatto con
fumi e gas caldi, devono essere conformi alle relative norme di prodotto, rispondendo ai
requisiti specifici della presente norma.
G.2.2.1 UTA a doppia funzione
Nel caso che l'unità di trattamento dell'aria (UTA) dell'impianto HVAC debba garantire in
caso d'incendio anche l'estrazione del fumo e/o l'immissione dell'aria esterna, i ventilatori
che lo compongono devono soddisfare i requisiti del punto 6.9.3 per i ventilatori per
SEFFC e del punto 6.9.11 per i ventilatori di immissione dell'aria esterna.
Come indicato nella UNI EN 15423, i componenti interni dell'UTA che ostacolano
l'evacuazione del fumo (come scambiatori, filtri, silenziatori, recuperatori di calore,
separatori di gocce, umidificatori, ecc.) devono essere escludibili tramite serrande.
Queste ultime ed ogni ulteriore componente dell'UTA attraversato dal fumo deve avere
classificazione equivalente a quella della condotta di controllo fumo e calore a cui è
collegata l'UTA stessa.
G.2.2.2 Serrande di controllo del fumo
Le serrande di controllo del fumo utilizzate in sistemi a doppia funzione nel quale il loro
stato di apertura/chiusura in assenza di incendio può essere determinato anche dal
sistema HVAC, devono essere classificate almeno in classe "C10 000".
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 44
BIBLIOGRAFIA
UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler -
Progettazione, installazione e manutenzione
UNI EN 1991-1-2:2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni in generale
- Azioni sulle strutture esposte al fuoco
DIN 182325-5(2011) Smoke and heat control installations - Part 5: Powered smoke
exhaust systems; requirements, design
CEN/TR 12101-4 Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS
systems for smoke and heat ventilation
CEN/TR 12101-5 Smoke and heat control systems - Part 5: Guidelines on functional
recommendations and calculation methods for smoke and heat
exhaust ventilation systems
UNI 9494-2:2012 © UNI Pagina 45
UNI
Ente Nazionale Italiano Riproduzione vietata - Legge 22 aprile 1941 Nº 633 e successivi aggiornamenti.
di Unificazione
Via Sannio, 2
20137 Milano, Italia
Potrebbero piacerti anche
- Uni 11224 2011Documento30 pagineUni 11224 2011Anonymous 7QpTAoNessuna valutazione finora
- ANTINCENDIO-ITA-UNI en 54-2 Rivelazione e Segnalazione Antincendio-CentraleDocumento50 pagineANTINCENDIO-ITA-UNI en 54-2 Rivelazione e Segnalazione Antincendio-CentraleCkaal74100% (1)
- Uni-En-671!2!2012 Idranti A MuroDocumento38 pagineUni-En-671!2!2012 Idranti A Murogooofle100% (1)
- ManualeFPC EN1090 1esempioDocumento36 pagineManualeFPC EN1090 1esempioAlessandro Celuzza100% (5)
- UNI en 179 Maniglioni AntipanicoDocumento38 pagineUNI en 179 Maniglioni AntipanicoFrancesco SpinaNessuna valutazione finora
- Cei 64-4 PDFDocumento22 pagineCei 64-4 PDFKamel SatourNessuna valutazione finora
- Uni 7131Documento26 pagineUni 7131gcusiNessuna valutazione finora
- UNI11224 - 2019 Impianti Di Rivelazione FumoDocumento46 pagineUNI11224 - 2019 Impianti Di Rivelazione FumoNicola CrocenziNessuna valutazione finora
- Uni1114305 2005 EitDocumento11 pagineUni1114305 2005 EitkoolhNessuna valutazione finora
- Norma UniDocumento25 pagineNorma UniNadia BasileNessuna valutazione finora
- Linee Guida LNDDocumento72 pagineLinee Guida LNDCervo AmatoriNessuna valutazione finora
- Uni en 354Documento14 pagineUni en 354angeloNessuna valutazione finora
- Uni en 1838 Illuminazione Di EmergenzaDocumento18 pagineUni en 1838 Illuminazione Di EmergenzagdnberNessuna valutazione finora
- UNI10348Documento15 pagineUNI10348Dario Spartaco BaldiNessuna valutazione finora
- Uni en 12845 2009 PDFDocumento152 pagineUni en 12845 2009 PDFluigicorvaglia100% (1)
- Uni en 14731Documento16 pagineUni en 14731GabrieleNessuna valutazione finora
- Norme CEIDocumento61 pagineNorme CEILittleNemo70Nessuna valutazione finora
- Uni en 12259 1 07 2002Documento62 pagineUni en 12259 1 07 2002sinisa.nikolicNessuna valutazione finora
- Linee Guida Manutenzione Impianti AnticendioDocumento97 pagineLinee Guida Manutenzione Impianti AnticendioDavide TesconiNessuna valutazione finora
- Manutenzione Manichette AntincendioDocumento2 pagineManutenzione Manichette Antincendiojasper_kikeNessuna valutazione finora
- Uni en Iso 9346 Trasferimento Di MassaDocumento15 pagineUni en Iso 9346 Trasferimento Di MassaGiuseppe CantelmiNessuna valutazione finora
- Dott - Ing.c.romano Uni 9795-2013Documento63 pagineDott - Ing.c.romano Uni 9795-2013Wissem ElliliNessuna valutazione finora
- DPR 151 2011 PDFDocumento138 pagineDPR 151 2011 PDFAntonioNessuna valutazione finora
- Norme UNIDocumento4 pagineNorme UNIVIBANessuna valutazione finora
- UNI 12237 - 2004 - CompressedDocumento14 pagineUNI 12237 - 2004 - CompressedMaseNessuna valutazione finora
- Principi Per Il Bilanciamento Degli Impianti IdroniciDocumento11 paginePrincipi Per Il Bilanciamento Degli Impianti IdroniciDorianaNessuna valutazione finora
- UNI 11224 2007 IT Antincendio PDFDocumento22 pagineUNI 11224 2007 IT Antincendio PDFAlessandro VeroneseNessuna valutazione finora
- Uni 11292:locali Destinati Ad Ospitare Gruppi Di Pompaggio Per Impianti AntincendioDocumento19 pagineUni 11292:locali Destinati Ad Ospitare Gruppi Di Pompaggio Per Impianti AntincendioArmond KurtiNessuna valutazione finora
- Modello Inail Impianto Elettrico Di Cantiere - 084756 PDFDocumento2 pagineModello Inail Impianto Elettrico Di Cantiere - 084756 PDFgoverna68Nessuna valutazione finora
- Evacuazione Fumi CaloreDocumento24 pagineEvacuazione Fumi CaloreIngLuigiDiFrancescoNessuna valutazione finora
- En 12464Documento42 pagineEn 12464pietro_sNessuna valutazione finora
- Intro Impianti PDFDocumento41 pagineIntro Impianti PDFantonio8850Nessuna valutazione finora
- Calcoli UNI TR 11175Documento55 pagineCalcoli UNI TR 11175Nicola TomasiNessuna valutazione finora
- Ntro e 7240-19 CompletaDocumento61 pagineNtro e 7240-19 CompletaVanessa RibottoNessuna valutazione finora
- UNI EN ISO 6946 - Resistenza Termica e Trasmittanza Termica - Metodo Di CalcoloiDocumento30 pagineUNI EN ISO 6946 - Resistenza Termica e Trasmittanza Termica - Metodo Di CalcoloiMauroNessuna valutazione finora
- PALESTRE - Linee Guida 2010Documento17 paginePALESTRE - Linee Guida 2010Ellicleo100% (1)
- Uni 9795 GuidaDocumento7 pagineUni 9795 Guidamatteo2009Nessuna valutazione finora
- Cei 27-1Documento30 pagineCei 27-1poodpoNessuna valutazione finora
- Sistemi Di Scarico Acque Nere - UNI 12056-1Documento20 pagineSistemi Di Scarico Acque Nere - UNI 12056-1Carlo Rico GardiniNessuna valutazione finora
- 01 Scarico IntroDocumento51 pagine01 Scarico IntroaNessuna valutazione finora
- Eurocodice 3-1-10 - ITDocumento20 pagineEurocodice 3-1-10 - ITAgliozzoNessuna valutazione finora
- Segnaletica Di SicurezzaDocumento35 pagineSegnaletica Di Sicurezzaporto d'armiNessuna valutazione finora
- Cei en 61770Documento50 pagineCei en 61770seve75100% (1)
- Uni 10845Documento24 pagineUni 10845ttiinneell8932Nessuna valutazione finora
- Manuale e Guide Tecniche VorticeDocumento26 pagineManuale e Guide Tecniche VorticeMister_jNessuna valutazione finora
- Norma UNI CIG 7129-1-2-3-4 (2008 - 10) - Impianti A Gas Per Uso Domestico e Similari Alimentati Da Rete Di Distribuzione - Progettazione e InstallazioneDocumento164 pagineNorma UNI CIG 7129-1-2-3-4 (2008 - 10) - Impianti A Gas Per Uso Domestico e Similari Alimentati Da Rete Di Distribuzione - Progettazione e Installazionepfc63Nessuna valutazione finora
- UNI EN 12464-1 Illuminazione Luoghi Di LavoroDocumento29 pagineUNI EN 12464-1 Illuminazione Luoghi Di LavoroStefano SquadraniNessuna valutazione finora
- Uni 10779 - La Nuova Edizione Della Norma Per Le Reti IdrantiDocumento3 pagineUni 10779 - La Nuova Edizione Della Norma Per Le Reti IdrantipzeoooNessuna valutazione finora
- 10 04 Lanzoni TermografiaDocumento8 pagine10 04 Lanzoni TermografiaDavide LanzoniNessuna valutazione finora
- Uni en 15316-2-1 - 2008Documento42 pagineUni en 15316-2-1 - 2008Stefano SquadraniNessuna valutazione finora
- Brochure Gruppo Rossi Parete VentilataDocumento22 pagineBrochure Gruppo Rossi Parete VentilatananineiNessuna valutazione finora
- Verifica IdraulicaDocumento24 pagineVerifica IdraulicaGicuţă Şi Geta ZvîncăNessuna valutazione finora
- Arduino | Passo dopo passo: Il manuale pratico per principiantiDa EverandArduino | Passo dopo passo: Il manuale pratico per principiantiNessuna valutazione finora
- Progettazione e Installazione: Design and InstallationDocumento14 pagineProgettazione e Installazione: Design and InstallationGiulia srlNessuna valutazione finora
- Uni9165 Condotte Gas Fino A 5 Bar ProgDocumento28 pagineUni9165 Condotte Gas Fino A 5 Bar Progluca di pasqualeNessuna valutazione finora
- Progettazione e Installazione: Design and InstallationDocumento58 pagineProgettazione e Installazione: Design and InstallationGiulia srlNessuna valutazione finora
- Uni10832-99 Serbatoi GPLDocumento22 pagineUni10832-99 Serbatoi GPLluca di pasqualeNessuna valutazione finora
- Impianti A Gas Per L'ospitalità Professionale Di Comunità e SimilareDocumento24 pagineImpianti A Gas Per L'ospitalità Professionale Di Comunità e SimilareGiulia srlNessuna valutazione finora
- UNI EN ISO 13786 - 2001 - Caratteristiche Termiche DinamicheDocumento24 pagineUNI EN ISO 13786 - 2001 - Caratteristiche Termiche DinamicheGiuseppeNessuna valutazione finora
- Progettazione e Installazione: Design and InstallationDocumento64 pagineProgettazione e Installazione: Design and InstallationGiulia srlNessuna valutazione finora
- 00ZP-D41-7306 RevDocumento28 pagine00ZP-D41-7306 RevUsman ArifNessuna valutazione finora
- Capannoni in Acciaio in Caso Di IncendioDocumento29 pagineCapannoni in Acciaio in Caso Di IncendioPinoScribdNessuna valutazione finora
- Reazione Al FuocoDocumento151 pagineReazione Al FuocoStefano Pagano100% (1)
- 04 - Cap.1 RTVDocumento46 pagine04 - Cap.1 RTVMaria Chiara CimminoNessuna valutazione finora
- 5.lezione PPV 001 Chiusure VerticaliDocumento24 pagine5.lezione PPV 001 Chiusure VerticaliVi ViNessuna valutazione finora
- 1 - Analisi Strutturali Straus7 Capannoni Acciaio Progettazione Antincendio Crosti MarinoDocumento9 pagine1 - Analisi Strutturali Straus7 Capannoni Acciaio Progettazione Antincendio Crosti MarinoAlessandroAleottiNessuna valutazione finora
- Manuale Promat 2017 - EdilportaleDocumento292 pagineManuale Promat 2017 - EdilportaleVittorioNessuna valutazione finora
- Resistenza Al Fuoco Buono PDFDocumento209 pagineResistenza Al Fuoco Buono PDFagostNessuna valutazione finora
- Calcolo R Fuoco Quaderni Progettazione Strutturale 02Documento18 pagineCalcolo R Fuoco Quaderni Progettazione Strutturale 02roldoguidoNessuna valutazione finora
- Eurocodice 3 - Parte 1.2 (UNI ENV 1993-1-2) Progettazione Delle Strutture in Acciaio - Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioDocumento62 pagineEurocodice 3 - Parte 1.2 (UNI ENV 1993-1-2) Progettazione Delle Strutture in Acciaio - Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioRoberto_Enriqu_1386Nessuna valutazione finora
- Manuale EN 13381 - 1695 - PDFDocumento53 pagineManuale EN 13381 - 1695 - PDFTAMMA HOUSSAM ELDDINNessuna valutazione finora
- Certificazioni e Dichiarazioni Di Prevenzioni Incendi Seminario Del 15 02 2013 PDFDocumento40 pagineCertificazioni e Dichiarazioni Di Prevenzioni Incendi Seminario Del 15 02 2013 PDFEdoardoNessuna valutazione finora
- NormogrammaDocumento8 pagineNormogrammaEManueleNessuna valutazione finora
- DM 1998 05 04Documento23 pagineDM 1998 05 04frabono1Nessuna valutazione finora
- Catalogo Amotherm LowDocumento29 pagineCatalogo Amotherm Lowalfy60Nessuna valutazione finora
- Antincendio DM 2007Documento48 pagineAntincendio DM 2007Francesco Vichi100% (1)
- Igniver Intonaco AntincendioDocumento6 pagineIgniver Intonaco Antincendioseve75Nessuna valutazione finora
- LaResistenzaAlFuocoDegliElementiStrutturali PDFDocumento201 pagineLaResistenzaAlFuocoDegliElementiStrutturali PDFPippo FrancoNessuna valutazione finora
- Elenco Doc SCIA VVFDocumento5 pagineElenco Doc SCIA VVFSimoneNessuna valutazione finora
- Manuale Protezione Passiva Dal Fuoco 2022Documento177 pagineManuale Protezione Passiva Dal Fuoco 2022occhidisaleNessuna valutazione finora
- Eurocodice 2 - Uni Env 1992-1-2 Progettazione Delle Strutture Di Calcestruzzo Parte 1-2 Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioDocumento78 pagineEurocodice 2 - Uni Env 1992-1-2 Progettazione Delle Strutture Di Calcestruzzo Parte 1-2 Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioRoberto_Enriqu_1386Nessuna valutazione finora
- ParetiDivisorie RIGIPSDocumento58 pagineParetiDivisorie RIGIPSDaniel Tesfaye MamoNessuna valutazione finora
- (7812) Scheda Tecnica Soffiti D11Documento24 pagine(7812) Scheda Tecnica Soffiti D11lucioctsicil100% (1)
- 1a Linee Guida Prestazioni Ingegneria Antincendio Aprike 2014 Ver 1Documento19 pagine1a Linee Guida Prestazioni Ingegneria Antincendio Aprike 2014 Ver 1bandito6411Nessuna valutazione finora
- Autorimesse-Testo Coordinato.v4Documento17 pagineAutorimesse-Testo Coordinato.v4NicolaNessuna valutazione finora
- 2007 FerraroDocumento362 pagine2007 Ferrarovincenzo_12613735Nessuna valutazione finora
- 09 - F-303 - Promaspray P300 - En13381-5Documento37 pagine09 - F-303 - Promaspray P300 - En13381-5Max PlanckNessuna valutazione finora
- Promat Base PDFDocumento144 paginePromat Base PDFclorofilloNessuna valutazione finora
- (7758) Protezione PassivaDocumento48 pagine(7758) Protezione PassivaANDYNessuna valutazione finora
- Resistenza Al Fuoco REI Dei Materiali Da Costruzione PDFDocumento20 pagineResistenza Al Fuoco REI Dei Materiali Da Costruzione PDFBasilio DanziNessuna valutazione finora