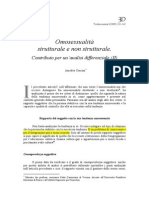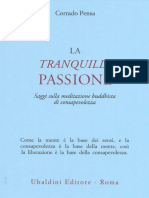Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Rigon - Fragilità Familiari e Discernimento Vocazionale
Caricato da
Jorge Pedro TresymedioCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Rigon - Fragilità Familiari e Discernimento Vocazionale
Caricato da
Jorge Pedro TresymedioCopyright:
Formati disponibili
1
Una formazione adeguata
Responsabilit della formazione nellaccompagnamento di giovani provenienti da famiglie in
difficolt. Quale ambiente, quali percorsi e quali attenzioni per una formazione veramente
personalizzata?
Sr.Samuela RIGON SSM
In: Fragilit familiari e discernimento vocazionale, Vocazioni, Anno XXVII (5) sett.-ott.2010, 48-60
Lesperienza familiare costituisce un evento fondante nella vita di ogni individuo e nella
strutturazione della sua personalit. La crisi profonda che listituzione famiglia sta attraversando
nella nostra epoca si riflette inevitabilmente nello sviluppo e nella formazione dellindividuo ed
influenza in diversi modi lo sviluppo della sua identit umana e cristiana.
Giovani uomini e donne che aderiscono alla chiamata di Dio nel cammino di
consacrazione, nelle sue diverse forme, sono figli della loro cultura con le ricchezze e le povert
che la caratterizzano. Cristo lo stesso ieri, oggi e sempre, ma come formatori vocazionali siamo
interpellati dai cambiamenti sociali e culturali affinch possiamo meglio rispondere al nostro
compito di accompagnare altri nel cammino di ricerca, incontro e adesione a Dio. Come cristiani
siamo sostenuti dalla certezza e dalla fiducia nellopera fedele di Dio: Lui, nel Suo amore
materno e paterno, che fa crescere; ma siamo anche consapevoli, come educatori, della necessit
di una mediazione1 ecclesiale e formativa capace di accompagnare e favorire questo processo di
crescita e maturazione.
Nellavvicinare un giovane, un buon educatore deve saper mantenere lo sguardo su due
polarit: la realt concreta del giovane, con le sue risorse e le sue fatiche, il suo presente e la sua
storia da una parte; il suo orizzonte futuro, i suoi desideri, gli ideali, cio chi chiamato a
diventare dallaltra. Dio infatti raggiunge sempre il suo popolo, l dove esso concretamente e
storicamente si trova, per condurlo alla Terra promessa. Accompagnare un giovane significa porsi
accanto a lui o lei, in qualit di fratello e sorella maggiori nella fede, affinch possa emergere e
poi trovare forma una (o la) domanda cruciale che, nelle parole di S.Francesco, suona cos: Chi
sei tu, dolcissimo Iddio e chi sono io?.
Queste brevi considerazioni iniziali permettono di focalizzare lattenzione sullobiettivo
della presente riflessione, cio sulla responsabilit della formazione nellaccompagnamento di
Direttive sulla formazione negli istituti religiosi 30, Vita Consecrata 66.
giovani provenienti da famiglie in difficolt2 e sullimportanza di sviluppare dei percorsi adeguati
e personalizzati.
Ce lha con me: lo stile relazionale di sr.Federica
Sr.Federica ha 32 anni, da poco ha fatto la professione perpetua ed inserita in una
comunit di suore impegnate nellattivit della diocesi. Tra la responsabile della comunit e
sr.Federica si sviluppato un rapporto faticoso e conflittuale, che si riflette sul contesto
comunitario e che sembra non trovare soluzione nonostante i tentativi della superiora di rendere
il clima pi sereno. Ella persona piuttosto mite e sensibile alle esigenze di chi vive con lei, ma da
sr.Federica le ritorna continuamente il messaggio di non avere attenzioni per lei. Sr.Federica una
persona molto generosa e animata da buoni desideri, ma ha avuto delle difficolt relazionali in
ogni comunit dove ha vissuto. Certamente imparare a vivere relazioni libere e mature,
significative e orientate al dono di s, la sfida che ogni persona chiamata a vivere e centro di
ogni cammino cristiano. Tuttavia nel percorso di Federica si evidenziano delle costanti nel modo
di vivere le relazioni: la giovane suora si affeziona ad una persona della comunit, in modo
particolare ad una figura di autorit, sembra nascere una buona relazione, ma poco alla volta
laffetto diventa gelosia, controllo, ricerca ossessiva di attenzioni per sfociare successivamente nel
sospetto e nella convinzione che questa sorella non ha riguardo per lei e che non nutre per lei
nessuna attenzione, anzi la tratta con sgarbo. Questa modalit crea malumore e un clima faticoso
nella comunit, anche perch Federica si sente molto in ansia per quanto vive e cerca unaltra
sorella o una persona esterna alla comunit alla quale comunicare il suo vissuto e le sue
convinzioni su quanto sta avvenendo.
Tale modalit relazionale si era presentata fin dalla prima esperienza comunitaria, al
tempo della verifica vocazionale; la suora che laccompagnava sentiva la fatica di questa
relazione, ma era anche convinta che, con il passare del tempo e con le nuove esperienze,
Federica avrebbe avuto modo di crescere e maturare; anche nel postulato e noviziato emersero
difficolt simili, la giovane aveva talvolta delle reazioni impulsive verbali, anche drammatiche.
Largomento fu spesso affrontato con franchezza dalla formatrice e regolarmente, dopo qualche
capriccio e resistenza, la giovane sembrava riconoscere le sue difficolt e prometteva
sinceramente di impegnarsi a sviluppare delle modalit diverse. Con il passare del tempo la
giovane mostrava una certa capacit di gestione relazionale, nel senso che sapeva controllare
reazioni forti di gelosia o di aggressivit. Cos sr. Federica emette i voti perpetui e ben presto le
vecchie difficolt si ripresentano.
Come definire una famiglia in difficolt? Non entro nel merito di questo approfondimento che obiettivo di altri contributi in
questo stesso numero della rivista.
Ampliando lo sguardo per comprendere la situazione di Federica, possiamo vedere come lo
stile relazionale caratterizzato dalla sospettosit e dalla difficolt a fidarsi fosse un tratto
caratteristico della sua personalit manifestato fin dalladolescenza. Attualmente sembra che nella
vita comunitaria religiosa Federica non riesca a gestire in modo adatto n il sospetto n la gelosia,
da qui il bisogno di controllare gli altri e, a seguire, le reazioni aggressive. I tratti di personalit di
un soggetto chiaramente non nascono dal nulla, ma sono il frutto dellinterazione tra le
caratteristiche naturali proprie di ogni persona e il contesto educativo e culturale, prima tra tutti
quello familiare. Federica, terzogenita, ha vissuto allet di cinque anni il trauma del divorzio dei
genitori, decisione a cui la mamma e il pap giungono in seguito ad una relazione da sempre
difficile; lui persona molto rigida, uomo geloso e attento al riconoscimento sociale, lei donna
molto emotiva, pi giovane del marito, piuttosto ansiosa e succube di lui. Dopo la nascita di
Federica il clima familiare si era inasprito ed era caratterizzato dalle continue accuse di gelosia e
sospetto tra i coniugi; inoltre la bimba passava lunghi periodi dalla nonna perch la mamma
soffriva di crisi dansia. Federica viveva ci come un rifiuto, anche perch le sorelle maggiori
stavano in casa. Poi arriva il divorzio e le figlie vanno a vivere con la mamma che dopo un certo
tempo si coinvolge in una nuova relazione affettiva.
Lontano dallavere una visione deterministica della vita e lontano da un approccio
riduttivo che pretenda di spiegare le complesse e misteriose vicende della vita attraverso le
categorie causa-effetto, chiaro che il vissuto infantile e familiare di Federica ha un forte impatto
nello sviluppo della sua personalit e della sua modalit relazionale.
Quale considerazioni per il nostro discorso? Gi Freud (il cui riferimento non significa
adesione acritica alla sua teoria e, ancor meno alla sottostante antropologia) affermava che la
maturit di un individuo si manifesta nella capacit di amare e lavorare. In altri termini: la
maturit umana consiste nella capacit di vivere sufficientemente in pace con se stessi e con gli
altri, e nellassumersi la responsabilit delle proprie scelte lavorative ed esistenziali. Si tratta di
condizioni umane3 necessarie per assumersi limpegno di una risposta vocazionale, come indicato
nei documenti magisteriali 4 . Comprendiamo come la capacit umana di stabilire relazioni di
fiducia, significative, di reciprocit colora inevitabilmente la vita di fede che, nella sua essenza
relazione personale ed affettiva con la Persona di Ges. Laccompagnamento vocazionale non pu
evitare un confronto responsabile e adeguato con questi aspetti della storia personale e familiare
del/la giovane in discernimento vocazionale o in formazione.
Talvolta ci illudiamo che il tempo basti: non raro sentire discorsi del tipo con il tempo
crescer, imparer, ma si impara dalla vita e dallesperienza se si capaci di imparare. Nel
G VITTIGNI, La personalit borderline secondo il modello strutturale di Otto Kernberg, in: Tredimensioni, Anno VII (1) 2010, 6073.
4
Pastores Dabo Vobis 43, Vita Consecrata 65, Vita Fraterna in Comunit 35-37.
rispetto dei criteri stabiliti dalla Chiesa e secondo le indicazioni di ogni istituzione religiosa, si
rende necessario non solo valutare la presenza di certi presupposti umani, la cui maturazione
resa pi faticosa dalla fragile situazione della famiglia oggi, ma anche individuare dei percorsi
adeguati lungo i quali i/le giovani possano rielaborare, nei limiti del possibile, situazioni
complesse della loro storia e sviluppare capacit pi adatte a fronteggiare le difficolt.
La necessit di una basilare capacit relazionale, che si esprime nel poter vedere laltro con
realismo e nella sua fondamentale interezza 5 collegata ad una percezione sufficientemente
stabile e integrata di se stessi, cio alla capacit di tollerare in se stessi aspetti ambivalenti, ombre
e luci, risorse e limiti. Quando manca unimmagine sufficientemente realistica di se stessi, il
soggetto fa molta fatica (o non riesce) a sviluppare una percezione realistica dellaltro, ma anche
a maturare un ideale stabile, coerente che lo impegni per il futuro e, di conseguenza, anche una
scelta vocazionale. La stessa immagine e percezione di Dio quindi, rischia di essere frantumata,
non integrata, fluttuando alternativamente dalla percezione di un Dio-solo-buono a quella di
un Dio-solo-cattivo: se per ogni cristiano impegnativo vivere ed accogliere gli estremi della
fede, cio la Morte e la Risurrezione, possiamo comprendere come possa essere difficile conciliare
tali opposti per la persona che non ha maturato una stabile immagine di s e dellaltro.
Una scelta vocazionale libera
Alessio un seminarista di 30 anni prossimo al diaconato. Si presenta come una persona
generalmente mite, sa stare nel gruppo, ma tende ad evitare relazioni coinvolgenti o vicine. La
decisione vocazionale maturata in seguito ad una forte esperienza di fede e conversione vissuta
cinque anni prima. Sta vivendo attualmente un momento di fatica e di crisi perch sperimenta
una forte attrazione verso una giovane donna e sa di aver gradualmente posto le condizioni
affinch questa attrazione fosse ricambiata. Alessio si rende conto di vivere in una situazione
ambigua, da una parte questa esperienza lo mette di fronte ad una possibile e diversa scelta di vita
nella quale si sente maggiormente realizzato come uomo. Daltra parte sente di aver preso un
impegno serio con il Signore e non vuole abbandonare; nel confronto con il direttore spirituale
emerge anche la consapevolezza che, lasciare il seminario significherebbe far vedere agli altri, in
particolare al padre, la sua incapacit di essere costante o fedele in un cammino intrapreso.
Anche nel caso di Alessio il contesto della storia familiare pu offrire una pista
dinterpretazione significativa. Il giovane figlio unico di una coppia che ha portato avanti la
propria relazione in una alternanza di tradimenti e infedelt reciproci e rapporti estemporanei.
5
Kernberg parla di relazioni oggettuali totali e parziali: nel primo caso il soggetto ha maturato una fondamentale capacit di
relazionarsi realisticamente allaltro nella sua interezza, piuttosto che idealizzare o assolutizzare alcuni aspetti e negarne altri,
fluttuando tra percezioni affettivamente opposte, come avviene nel secondo caso.
Solo negli ultimi anni, quando Alessio gi stava in seminario, la relazione tra i genitori si
ricomposta in una unione pi serena. Alessio cresciuto in questo clima familiare, ha sofferto la
modalit dei genitori senza prendere posizioni nei confronti delluno o dellaltro. Il padre, che
aveva fama di dongiovanni, esprimeva spesso al figlio il suo dubbio e la sua perplessit nei suoi
confronti in quanto non lo vedeva lanciarsi in avventure con le ragazze e non raccontava
prodezze sessuali; cos il padre gli diceva spesso non che forse tu non sei un vero uomo?.
Alcuni aspetti importanti emergono nel cammino di Alessio che meglio aiutano a
comprendere lambiguit che sente dentro di s: da una parte il giovane uomo vuole prendere
posizione di fronte al padre mostrando di non esser come lui, cio incapace di fedelt; daltra
parte sente forte la dipendenza da lui e il bisogno di dimostrargli che uomo, cio maschio,
secondo i criteri del padre, ossia affascinare e attrarre le donne in relazioni pi o meno
strumentali. Risucchiato da queste dinamiche, Alessio rimane chiuso in una lotta psichica (cio
tra aspetti conflittuali del suo io) che fa fatica a trasformarsi in lotta spirituale, cio tra la persona
e il suo Dio6. Il rischio quindi, di perdere di vista lobiettivo, cio la ricerca della volont di Dio.
Rielaborando questi vissuti in un percorso di adeguato accompagnamento e interpretandoli in
verit alla luce della fede, Alessio potrebbe maturare una decisione vocazionale pi consapevole e
rispondere a Dio con maggior libert impegnandosi in un dono sincero di se stesso.
Non poche famiglie oggi sono segnate da legami instabili, relazioni fragili e non durature.
Non raro che i figli crescano con un solo genitore, in seguito a divorzio o separazione, oppure
che i fratelli abbiano la stessa mamma (generalmente) e padri diversi. Spesso il tessuto familiare
non in grado di trasmettere modelli esistenziali di fedelt e la relazione affettiva coniugale
sembra sostenuta pi dal va bene finch dura il sentimento che dallimpegno responsabile e dal
finalismo dellamore.
Queste fragilit familiari, tipiche del mondo moderno, si accostano a
situazioni faticose (purtroppo) non nuove, come presenza di alcoolismo o forme varie di violenza
domestica. Inoltre importante sottolineare come spesso oggi, a differenza di quanto accadeva nel
passato, la maturazione della vocazione non avviene nel grembo della famiglia che, attraverso il
suo vissuto e la sua testimonianza trasmetteva il senso della fede e una visione cristiana della vita.
Nella vita di tanti giovani spesso assente anche lesperienza della vita e dellimpegno ecclesiali,
nelle sue dimensioni di preghiera, comunione e servizio, che favoriscono uno sviluppo graduale
della vocazione battesimale e che fanno emergere una domanda vocazionale specifica. Aumenta il
numero di uomini e donne che entrano in vocazione in seguito ad una forte esperienza di fede e
conversione che ha segnato la loro vita.
Tutti questi aspetti ci interpellano a elaborare percorsi formativi adeguati capaci di
incontrare le reali esigenze di quanti accolgono il dono della chiamata divina e di favorire un
contesto di effettiva libert decisionale.
6
Vita Consecrata 70.
Alcune possibili sfide
La nostra umanit il terreno che accoglie il seme della chiamata divina, la vocazione
sempre un dono della grazia divina e mai un diritto o una conquista delluomo. Nel rispetto
dellinafferrabilit dellagire di Dio e del mistero che avvolge ogni singola vocazione, come
educatori e formatori non possiamo esimerci dalla responsabilit di cercare nella persona che si
pone alla sequela di Ges quei presupposti umani (e di favorirne lo sviluppo)7 che costituiscono il
terreno, pi o meno capace, di accogliere il seme della chiamata.
Sullo sfondo delle storie prima brevemente riportate vorrei evidenziare alcune attenzioni
formative da sviluppare nellaccompagnamento di giovani provenienti da famiglie in difficolt. Si
tratta di criteri e attenzioni importanti in ogni accompagnamento vocazionale, ma essi diventano
cruciali in quelle situazioni in cui le fragilit familiari possono aver interferito oppure ostacolato
lo sviluppo di alcune attitudini umane fondamentali.
A) Una percezione sufficientemente stabile ed integrata di s8
compito di ogni persona recuperare e credere alla positivit di se stessi imparando a
guardarsi dalla prospettiva di Dio: persone fatte a Sua immagine e somiglianza e
contemporaneamente deboli e segnate dalla fragilit e dal limite. Credere alla positivit di se stessi
non unidea, si tratta piuttosto di un impegno, un percorso, un cammino spesso faticoso perch
ci chiede di mettere le mani nelle inevitabili ferite che ognuno di noi porta nel proprio cuore e
nella propria storia personale e familiare, siano esse subite o il risultato dei nostri errori. Ognuno
di noi ha imparato a rapportarsi con se stesso dentro il tessuto delle relazioni che ha vissuto fin
dallinizio della propria vita e lungo questa storia ha sviluppato un senso pi o meno positivo
della propria identit. Talvolta abbiamo imparato che gli altri ci amano a condizione che e tutto
questo costituisce uneredit che non abbiamo cercato, ma semplicemente ricevuto Recuperare
la propria amabilit un compito che interpella nel proprio presente rinnovando ogni giorno la
fiducia in se stessi e lapprezzamento per lamore ricevuto. Significa diventare consapevoli ed
emotivamente convinti che in ognuno di noi non tutto forte e non tutto debole, che possiamo
accogliere le nostre personali ombre senza negarle e senza temere che esse offuschino le luci e gli
aspetti positivi, e tutto questo nella consapevolezza che la stima di s rimane unarea un po
vulnerabile per tutta la vita. Dalla consapevolezza sentita di essere stati amati gratuitamente
(senza il dovere di conquistare laffetto) scaturisce la gratuit dellamore: Cristo d alla persona
due fondamentali certezze: di essere stata infinitamente amata e di poter amare senza limiti. Nulla
7
8
Pastores Dabo Vobis 43.
S.RIGON, Vivere la gratuit nelle relazioni in: Consacrazione e Servizio, Anno LIX (5) 2010, 49-54.
come la croce di Cristo pu dare in modo pieno e definitivo queste certezze e la libert che ne
deriva9.
Credere alla propria positivit un fatto concreto che si manifesta nella capacit esistenziale
di accettare quello che siamo, di stare sufficientemente a proprio agio con se stessi pur tra gli alti
e bassi della vita e nella tensione di un possibile miglioramento e della crescita nella nostra
identit di figli di Dio.
Amare il prossimo come se stessi un cammino che segue un percorso obbligato: il
riconoscimento e laccettazione di s come esseri fragili e peccatori, ma redenti e raggiunti
dallamore personale e gratuito di Dio. Esso pu pertanto risultare arduo a coloro che non
abbiano raggiunto un sufficiente livello di integrazione psichica che consenta di tenere insieme i
pezzi e di contenere gli opposti.
B) Una fondamentale capacit di relazione e di fiducia
Si tratta di un compito che ci impegna fin dai primissimi tempi della nostra esistenza10 e che
rimane aperto per tutto larco della nostra vita. Pedagogicamente questo molto importante
perch significa che nei limiti del possibile, alcune antiche vulnerabilit nellambito della capacit
di fidarsi e di consegnarsi, possono essere lenite nel corso della vita. Diventa cruciale a questo
riguardo il modo in cui leducatore sa porsi accanto al giovane ferito nella capacit di fiducia:
compito delleducatore imparare a cogliere il vero bisogno dellaltro e rispondervi offrendo una
relazione che, di volta in volta, sa proporsi come sostegno, consolazione, presenza oppure come
provocazione, sfida, assenza11.
Nel vivere le relazioni spesso facciamo lesperienza della delusione: laltra persona non come
lho conosciuta fino a questo momento e rivela aspetti di s che non avevo visto o che non mi
piacciono. Oppure, come avviene pi frequentemente, ella solo diversa da come me laspettavo e
la desideravo.
Talvolta idealizziamo lamico/a, il coniuge, la consorella, il confratello e sullaltra persona
proiettiamo le nostre attese e aspettative. In questo modo nellaltro vediamo ci che ci piace o che
vorremmo vedere e assolutizziamo alcuni suoi aspetti gradevoli mentre altri nemmeno li notiamo.
Allo stesso modo ognuno di noi disattende o delude aspettative e attese che gli altri nutrono nei
nostri confronti. In alcuni casi lidealizzazione dellaltro cos forte che rischiamo di non avere di
lei/lui una percezione realistica. Sappiamo che non facile accogliere e vivere la delusione; si
tratta tuttavia di un passaggio importante che apre la strada ad una visione pi oggettiva della
realt altrui e ad un rapporto pi realistico. Questa fase richiede la capacit di integrare aspetti
positivi e negativi dellaltro e soprattutto, i sentimenti ambivalenti di affetto/rabbia che posso
9
Vita Fraterna in Comunit 22
E.ERIKSON, I cicli della vita. Continuit e mutamenti, Armando Editore, Roma, 2003, pp.73ss.
11
F.IMODA, Sviluppo umano, psicologia e mistero, PIEMME, Casale Monferrato, 1993, cap.IX.
10
provare nei suoi confronti. Una persona capace di integrare i diversi aspetti dellaltro nella
misura in cui sa custodire nel cuore, cio psicologicamente capace di mantenere viva dentro di
s limmagine positiva dellaltro, di dare continuit al sentimento della sua benevolenza anche
quando lo percepisce come frustrante o minaccioso.
La capacit di fidarsi fondamentale per la vita fraterna e apostolica, per impegnarsi in un
cammino formativo di apertura e collaborazione, ma essenziale anche per la relazione con Dio
affinch Egli possa essere creduto come presente e amante anche quando il soggetto non Lo
sente o fa esperienza del Suo silenzio Non si tratta forse di quella capacit sottesa alle parole di
Ges quando ci esorta a rimanere nel Suo amore (cfr. Gv 15)?
Bisogna inoltre imparare a vivere relazioni nella reciprocit, cio relazioni in cui si capaci di
entrare e di uscire, di dare e di ricevere. Questo tipo di relazione che possiamo anche definire
relazione dintimit, richiede un adeguato equilibrio tra due aspetti, lautonomia e la dipendenza.
Lautonomia, quale capacit di stare in piedi sulle proprie gambe permette di riconoscersi nella
propria individualit personale, come soggetto capace di pensare, amare, decidere e agire. La
capacit di dipendere, che nasce dallumile consapevolezza di non bastare a se stessi e di aver
bisogno dellaltro, intesa come capacit di lasciarsi coinvolgere e raggiungere dallaltro e
costituisce la base per poter accogliere laffetto degli altri; essa inoltre, rende possibile un senso di
appartenenza (alla famiglia, alla comunit religiosa, al gruppo). Autonomia e dipendenza
chiedono un dinamico equilibrio nella persona; se lautonomia troppo forte diventa facilmente
autosufficienza o paura dellaltro ed impedisce di entrare nella relazione, mentre quando il
bisogno di dipendere eccessivo allora la persona fa fatica ad uscire dalla relazione rischiando di
rimanerne invischiata.
C) La capacit di decentrarsi e uscire da s
Un terzo aspetto, intimamente unito agli altri due, dato dalla capacit di decentrarsi, cio
dalla capacit di uscire da s. Antropologicamente infatti, c vita quando c un movimento di
uscita:: se il bimbo non esce dal grembo materno muore, se il figlio non esce dalla sua famiglia di
origine non d vita alla propria famiglia. Si tratta di unuscita fisica ed anche simbolica o
psicologica perch luscita dal grembo materno accompagnata dal taglio del cordone ombelicale
un dato fisico, ma c anche un necessario e successivo taglio psicologico del legame. Allo stesso
modo luscita di casa del giovane che fa le sue scelte deve essere accompagnata da un reale
distacco e da una sana autonomia su tanti fronti perch si compia unuscita effettiva.
Come persone umane siamo fatte per la comunione, cio per uscire da noi stessi e incontrare
laltro e questa dimensione di alterit prende forme diverse nel corso dellesistenza. Lalterit
data dallaltro come singolo soggetto umano, ma anche dalla famiglia o legami parentali, dal
gruppo o dalla societ, dalla cultura e dallambiente, dai diversi orizzonti di valori, da Dio stesso.
In altri termini si cresce nella misura in cui si esce da se stessi, nella misura in cui si smette di fare
di se stessi e delle proprie esigenze e desideri il centro del mondo: la realizzazione di s si attua
raggiungendo degli obiettivi, dedicandosi a qualcosa o meglio a qualcuno. In termini evangelici:
la persona si realizza servendo, donando la propria vita, facendo dono sincero e totale di s come
Ges ha fatto. Se una persona concentrata su se stessa nel senso che impegna gran parte delle
sue energie per mantenere psichicamente uniti aspetti del proprio io, cio se non ha raggiunto
unadeguata coesione e una sufficiente integrazione del proprio io, (anche quando possibile) sar
molto arduo prendersi cura di altri, assumersi responsabilit per altre persone, farsi carico con un
adeguato margine di libert (affettiva ed effettiva) dellimpegno che una vocazione comporta.
Non si tratta in tal caso di poca buona volont da parte del giovane, n di quello spazio
intermedio in cui, in un contesto di essenziale normalit psicologica giocano conflittualit
subconscie che possono facilmente interferire con la scelta consapevole dei valori cristiani e
vocazionali. Mi riferisco ad una libert umana talmente ridotta che rende molto difficile al
giovane saper gioire delle piccole e sane cose della vita e che potrebbe compromettere
significativamente la capacit di una scelta vocazionale, sapendo che non vi possono essere
vocazioni, se non libere; se esse non sono cio offerte spontanee di s, coscienti, generose,
totali12.
Nella consapevolezza che siamo, s, collaboratori di Dio, ma che Lui che fa crescere (1 Cor
3,6.9),
importante
che
percorsi
di
discernimento
formazione
vocazionale,
laccompagnamento spirituale, le esperienze di servizio e di solidariet, di comunione e di vita
fraterna, mettano in risalto e promuovano nel/la giovane le condizioni fondamentali per entrare
in un impegno vocazionale: i segni di una relazione viva con Dio, una basilare chiarezza nella
proclamazione dei valori del Vangelo ed un minimo di realismo nel viverli, una sufficiente
integrit psichica e il desiderio e la capacit di crescere, di lasciarsi plasmare da Dio anche
attraverso le tante mediazioni che accompagnano il cammino formativo vocazionale.
12
Pastores Dabo Vobis 36.
Potrebbero piacerti anche
- Gender, omosessualità, genitorialità: Domande a uno psicologo cristianoDa EverandGender, omosessualità, genitorialità: Domande a uno psicologo cristianoNessuna valutazione finora
- Pedagogia CatechisticaDocumento24 paginePedagogia Catechisticaparsifal11Nessuna valutazione finora
- Chiesa e salute mentale: Cultura del provvisorio, scarti e nuovi poveri: il disagio psichico al tempo della tecnoliquiditàDa EverandChiesa e salute mentale: Cultura del provvisorio, scarti e nuovi poveri: il disagio psichico al tempo della tecnoliquiditàNessuna valutazione finora
- Vita Di S. Ignazio Di Loyola - Ribadeneira PietroDocumento233 pagineVita Di S. Ignazio Di Loyola - Ribadeneira Pietrogiordana214Nessuna valutazione finora
- Giovanna Casagrande Intorno A Chiara. Il PDFDocumento22 pagineGiovanna Casagrande Intorno A Chiara. Il PDFMa. Jesús Centeno PadillaNessuna valutazione finora
- Aiuto A Fraterno, T PDFDocumento204 pagineAiuto A Fraterno, T PDFJian TG SapienzaNessuna valutazione finora
- C - Sussidi I Tappa Tiberiade GenitoriDocumento60 pagineC - Sussidi I Tappa Tiberiade Genitoriapi-421393782Nessuna valutazione finora
- Breve Storia BenedettinaDocumento26 pagineBreve Storia BenedettinaGiacomo CantiNessuna valutazione finora
- Nota Pastorale Diocesi Di TivoliDocumento20 pagineNota Pastorale Diocesi Di Tivoliapi-421393782Nessuna valutazione finora
- Cencini La Vita Al Ritmo Della Parola - Estratto A5 - PDFDocumento14 pagineCencini La Vita Al Ritmo Della Parola - Estratto A5 - PDFBenNessuna valutazione finora
- Cencini OmossessualitàDocumento9 pagineCencini OmossessualitàJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Allamano, Cosi Vi VoglioDocumento320 pagineAllamano, Cosi Vi Vogliomayagreen2010Nessuna valutazione finora
- Moggio Udinese. Parrocchia AbbazialeDocumento216 pagineMoggio Udinese. Parrocchia AbbazialeBiodini WoujaNessuna valutazione finora
- Esenzione Cistercense e Formazione Del Privilegium Commune. Osservazioni A Partire Dai Cenobi Dell'italia Settentrionale - Guido Cariboni-CariboniDocumento43 pagineEsenzione Cistercense e Formazione Del Privilegium Commune. Osservazioni A Partire Dai Cenobi Dell'italia Settentrionale - Guido Cariboni-CariboniGerardo LarghiNessuna valutazione finora
- Servo Dei Poveri: P. Cesare M. Barzaghi, BarnabitaDocumento22 pagineServo Dei Poveri: P. Cesare M. Barzaghi, BarnabitaBarnabite Publications100% (1)
- Conflittualità Esteriore CenciniDocumento9 pagineConflittualità Esteriore CenciniClaudio RajolaNessuna valutazione finora
- B - Sussidi Prima Evangelizzazione RagazziDocumento13 pagineB - Sussidi Prima Evangelizzazione Ragazziapi-421393782Nessuna valutazione finora
- SAGGIO Misericordia e Pastorale Familiare in AL PDFDocumento17 pagineSAGGIO Misericordia e Pastorale Familiare in AL PDFSahayadas FernandoNessuna valutazione finora
- Norme Liturgiche - DecretoDocumento7 pagineNorme Liturgiche - Decretomaria1grazia1mazzaNessuna valutazione finora
- Fr. CITTI Philologia DelendaDocumento21 pagineFr. CITTI Philologia DelendaGIOVANNI NICCOLINessuna valutazione finora
- Collectanea Franciscana: Annus 92 2 0 2 2Documento95 pagineCollectanea Franciscana: Annus 92 2 0 2 2Petar UškovićNessuna valutazione finora
- Padre Règinald Grègoire e Gli Studi Agiografici - Rivista Di Storia Della Chiesa, Febbraio 2023Documento11 paginePadre Règinald Grègoire e Gli Studi Agiografici - Rivista Di Storia Della Chiesa, Febbraio 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Temi Del BaccellieratoDocumento181 pagineTemi Del BaccellieratoStrokers sTkNessuna valutazione finora
- Liber Annuus - Volume 61, 2011 PDFDocumento728 pagineLiber Annuus - Volume 61, 2011 PDFmanticoramiranda100% (1)
- Bibliografia Inculturazione Liturgica - 2016-2017Documento11 pagineBibliografia Inculturazione Liturgica - 2016-2017jesuscolado2Nessuna valutazione finora
- Itinerari Catecumenali ITADocumento97 pagineItinerari Catecumenali ITAXiomara MencosNessuna valutazione finora
- Sussidio Francescano Per La Giustizia, La Pace e Salvaguardia Del CreatoDocumento226 pagineSussidio Francescano Per La Giustizia, La Pace e Salvaguardia Del CreatoGreen Faith100% (1)
- Ettore Romagnoli - Cenni Storico-Artistici Di Siena e Suoi Suburbii (1852)Documento130 pagineEttore Romagnoli - Cenni Storico-Artistici Di Siena e Suoi Suburbii (1852)Il Tesoro di SienaNessuna valutazione finora
- Laicato Dal Concilio Vaticano II Ad OggiDocumento26 pagineLaicato Dal Concilio Vaticano II Ad OggiMagda CruzNessuna valutazione finora
- Calendario Di SantiDocumento9 pagineCalendario Di SantiMatteo GiudiceNessuna valutazione finora
- Clement, Olivier Il Fine Dell'Uomo È Dio, Il Fine Di Dio È L'uomoDocumento5 pagineClement, Olivier Il Fine Dell'Uomo È Dio, Il Fine Di Dio È L'uomoMaria Mercedes GuaitaNessuna valutazione finora
- Julius Evola - Terzo Sesso e DemocraziaDocumento3 pagineJulius Evola - Terzo Sesso e DemocraziaMary DechampsNessuna valutazione finora
- Assunzione Di Maria - Padri Della ChiesaDocumento50 pagineAssunzione Di Maria - Padri Della ChiesaAngelo PansaNessuna valutazione finora
- Pietro Da BernardoneDocumento50 paginePietro Da Bernardoneedvin_guerraNessuna valutazione finora
- Evoluzione Della Vita ReligiosaDocumento21 pagineEvoluzione Della Vita ReligiosaEldi Pereira SilvaNessuna valutazione finora
- Teologia Affettiva (Charles André Bernard)Documento445 pagineTeologia Affettiva (Charles André Bernard)Fantozzi UgoNessuna valutazione finora
- Buone Prassi Di Prevenzione e Tutela Dei Minori in ParrocchiaDocumento31 pagineBuone Prassi Di Prevenzione e Tutela Dei Minori in ParrocchiaCerco il Tuo voltoNessuna valutazione finora
- Storia Santita PDFDocumento18 pagineStoria Santita PDFCsapai CristianaNessuna valutazione finora
- Szabó Péter - I Libri Liturgici Orientali e La Sede Apostolica Sviluppo Della Prassi e Stato AttualeDocumento18 pagineSzabó Péter - I Libri Liturgici Orientali e La Sede Apostolica Sviluppo Della Prassi e Stato AttualeBogdan PalcăuNessuna valutazione finora
- F - Sussidi II Tappa Cafarnao Ragazzi PDFDocumento46 pagineF - Sussidi II Tappa Cafarnao Ragazzi PDFapi-421393782Nessuna valutazione finora
- Il Senso Della CaritativaDocumento17 pagineIl Senso Della CaritativaderfreihafenNessuna valutazione finora
- Bibliografia Espiritualidad SacerdotalDocumento39 pagineBibliografia Espiritualidad Sacerdotaljnk1203100% (1)
- L'Ordine Francescano Tra Futuro e NostalgieDocumento11 pagineL'Ordine Francescano Tra Futuro e Nostalgiecarlo serriNessuna valutazione finora
- Madre Marianna Nasi. Sfumature Di SantitàDocumento177 pagineMadre Marianna Nasi. Sfumature Di SantitàCottolengo_onlineNessuna valutazione finora
- Carisma e MinisteriDocumento17 pagineCarisma e MinisteriMaria Mercedes GuaitaNessuna valutazione finora
- Esperienze Religiose Nel MedioevoDocumento42 pagineEsperienze Religiose Nel MedioevoSabrina AlencastroNessuna valutazione finora
- La Dottrina Del Sacerdozio Comune Come Emerge Dalleucologia Maggiore Del Messale Romano Promulgato Da Paolo VIDocumento61 pagineLa Dottrina Del Sacerdozio Comune Come Emerge Dalleucologia Maggiore Del Messale Romano Promulgato Da Paolo VIapi-287271863Nessuna valutazione finora
- La Celebrazione Vigiliare Ambrosiana: Tradizioni, Significati, ModalitàDocumento8 pagineLa Celebrazione Vigiliare Ambrosiana: Tradizioni, Significati, ModalitàTomDokNessuna valutazione finora
- La Cattedrale Nella Italia Storia Della Chiesa Archeologia 1986 PDFDocumento86 pagineLa Cattedrale Nella Italia Storia Della Chiesa Archeologia 1986 PDFErnestoNessuna valutazione finora
- AssiduaDocumento105 pagineAssiduaValerio ZeballoNessuna valutazione finora
- Catalogo Fondazione Lorenzo Valla 2020 (IT)Documento117 pagineCatalogo Fondazione Lorenzo Valla 2020 (IT)Giuseppe GaribaldiNessuna valutazione finora
- Andrea Grillo - El Cuarto Sacramento y Su Relacion Con La IcDocumento16 pagineAndrea Grillo - El Cuarto Sacramento y Su Relacion Con La IcWalter PerelloNessuna valutazione finora
- Metodologia Teologica PraticaDocumento46 pagineMetodologia Teologica PraticaPaolo BianchiNessuna valutazione finora
- Corso - Psicologia Nei Processi VocazionaliDocumento57 pagineCorso - Psicologia Nei Processi VocazionaliRafa FanNessuna valutazione finora
- Rav101 - Rae117 - 201109 PDFDocumento52 pagineRav101 - Rae117 - 201109 PDFFedericoPGalloNessuna valutazione finora
- Ha Bruciato Le Tappe: Vita Breve Di Serafino GhidiniDocumento35 pagineHa Bruciato Le Tappe: Vita Breve Di Serafino GhidiniBarnabite PublicationsNessuna valutazione finora
- Tesi - Donna Nella Bibbia PDFDocumento82 pagineTesi - Donna Nella Bibbia PDFGabriel JacksonNessuna valutazione finora
- Cencini - La Verginità Per Il Regno IDocumento13 pagineCencini - La Verginità Per Il Regno IJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Metodo in Teologia - LonerganDocumento3 pagineMetodo in Teologia - LonerganJorge Pedro Tresymedio100% (1)
- Forte - Il Mistero Dell'Inconscio - L'Uomo Tra Fede - e - PsicologiaDocumento2 pagineForte - Il Mistero Dell'Inconscio - L'Uomo Tra Fede - e - PsicologiaJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Crea: Patologia e Speranza Nella Vita ConsacrataDocumento117 pagineCrea: Patologia e Speranza Nella Vita ConsacrataJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Cencini Omossessualità IDocumento9 pagineCencini Omossessualità IJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Cencini - La Verginità Per Il Regno IDocumento13 pagineCencini - La Verginità Per Il Regno IJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Cencini OmossessualitàDocumento9 pagineCencini OmossessualitàJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Galimberti Storia Della PsicologiaDocumento73 pagineGalimberti Storia Della PsicologiaJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- La Nascita Del Dio ViventeDocumento7 pagineLa Nascita Del Dio ViventeJorge Pedro TresymedioNessuna valutazione finora
- Mondo Primario e Mondo Secondario: Sovrapposizioni e Separazioni Il Saggio Sulle Fiabe Di J.R.R. Tolkien E...Documento22 pagineMondo Primario e Mondo Secondario: Sovrapposizioni e Separazioni Il Saggio Sulle Fiabe Di J.R.R. Tolkien E...AlbertoQuagliaroliNessuna valutazione finora
- Cristal 3Documento16 pagineCristal 3Vale46 RossiNessuna valutazione finora
- Corrado Pensa - La Tranquilla Passione. Saggi Sulla Meditazione Buddhista Di ConsapevolezzaDocumento290 pagineCorrado Pensa - La Tranquilla Passione. Saggi Sulla Meditazione Buddhista Di ConsapevolezzaAmedeo MerlonghiNessuna valutazione finora
- Tucci, Teoria e Pratica Del MandalaDocumento134 pagineTucci, Teoria e Pratica Del MandalaGiorgio ViaggioNessuna valutazione finora
- Pianeti Retrogradi Nel Proprio TN e Il KarmaDocumento17 paginePianeti Retrogradi Nel Proprio TN e Il KarmaShanabellaNessuna valutazione finora
- Equi BioDocumento6 pagineEqui Bioamnotaname4522Nessuna valutazione finora
- William Buhlman - Come Uscire Fuori Dal Corpo PDFDocumento234 pagineWilliam Buhlman - Come Uscire Fuori Dal Corpo PDFGiuseppe Fadda86% (7)
- 3 La Magia Nel RinascimentoDocumento2 pagine3 La Magia Nel RinascimentoGloria MendiolaNessuna valutazione finora
- Lo Svilupo Della Direzione Spirituale Dopo Il CVIIDocumento2 pagineLo Svilupo Della Direzione Spirituale Dopo Il CVIIMarcos RosadoNessuna valutazione finora
- Pulizia e Il Bilanciamento Dei ChakraDocumento21 paginePulizia e Il Bilanciamento Dei ChakraNina Ariel100% (1)
- S. Teresa Di G. B. - Novena Della FedeDocumento32 pagineS. Teresa Di G. B. - Novena Della FedePioggia_di_roseNessuna valutazione finora
- AngeliDocumento15 pagineAngeliChiara Elisabetta ScarfòNessuna valutazione finora
- BertiauxokultimookokokDocumento83 pagineBertiauxokultimookokokNera Luce Black Diamond100% (1)
- Abhinavagupta Tantrasara, Essenza Dei Tantra Boringhieri 1960 Mistica Dell'india PDFDocumento346 pagineAbhinavagupta Tantrasara, Essenza Dei Tantra Boringhieri 1960 Mistica Dell'india PDFamjr1001Nessuna valutazione finora