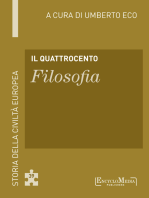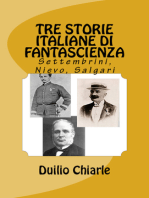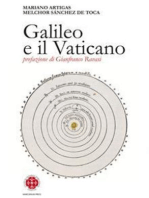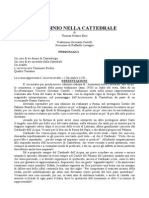Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Courcelle e Conosci Te Stesso
Courcelle e Conosci Te Stesso
Caricato da
Kaiser Von PollonsCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Courcelle e Conosci Te Stesso
Courcelle e Conosci Te Stesso
Caricato da
Kaiser Von PollonsCopyright:
Formati disponibili
Prof. Angelo Marchesi, www.dialexis.
it
Conosci te stesso, il precetto delfico attraverso i secoli
In questo testo si analizza quanto uno studioso di grande levatura come Pierre
Courcelle ha presentato e radunato criticamente su quanto stato scritto in riferimento
al famoso motto delfico: Conosci te stesso, lungo i secoli che si sono succeduti
dallepoca di Platone allet medievale di san Bernardo.
La preziosit di questa fatica filologica e documentaria non pu sfuggire nemmeno a
chi abbia anche solo una conoscenza generica dellantichit classica greca e dei
successivi periodi della patristica greca e latina e dei primi secoli dellet medievale.
Davvero imponente e rilevante la documentazione storica e teoretica che Pierre
Courcelle, grande studioso dellantichit classica e cristiana (1912-1980), ha radunato in
un volume di ben 678 pagine sul famoso effato delloracolo di Delfo: Conosci te
stesso, ora fruibile anche nelledizione italiana: Conosci te stesso, da Socrate a s.
Bernardo (Milano, Vita e Pensiero, 2001), con una Presentazione di Giovanni Reale
(pp, 7-10).
Per sobbarcarsi ad un simile compito occorre avere alle spalle una conoscenza
sterminata della letteratura pagana greca e latina e una altrettanto profonda conoscenza
della sua eredit negli scrittori, greci e latini, dellepoca cristiana (patristica e del primo
medioevo). Courcelle aveva, in questo senso, tutte le carte in regola e ci ha lasciato un
monumentale studio sulla fortuna e sulla storia complessa di questo famoso detto:
Conosci te stesso (Gnothi sauton Nosce te ipsum) giunto fino a noi, attraverso secoli
di riflessione e di commenti di filosofi, di teologi e di letterati di diversa provenienza.
G. Reale, nella sua Presentazione, rileva che: Lesortazione conosci te stesso
ha assunto una posizione di esortazione morale di carattere strettamente filosofico
soprattutto con Socrate il cui messaggio ruota per intero intorno a questo perno
teoretico e, nellambito della cultura occidentale, ha poi avuto una
Wirkungsgeschichte, ossia una storia di effetti di straordinaria portata () come
dimostra questo libro di Courcelle, che ormai si imposto come un punto di riferimento
obbligato per chiunque sia interessato al problema della storia della conoscenza
delluomo: soprattutto, direi, in questi tempi, in cui si assiste ad una frastornante e
dispersiva riflessione antropologica che rischia di vanificare la concezione stessa della
persona umana e della sua dignit spirituale.
Ancora Reale fa presente che gli studiosi sono oggi sostanzialmente daccordo
nel rilevare che Apollo, con il suo oracolo delfico, invitava luomo (dellantichit, ma
anche quello dei nostri giorni!) a riconoscere la propria limitatezza e finitezza, e
quindi esortava a mettersi in rapporto col dio, appunto sulla base di questa precisa
consapevolezza, ricordando a chi entrava nel tempio: uomo, ricordati che sei un
mortale e che, come tale, tu ti avvicini al dio immortale.
Il messaggio delloracolo delfico sar poi ripreso dai poeti come Pindaro e i
tragici greci, ricorda Reale, ma sar portato a livello filosofico da Socrate (non a caso
anche lindagine di Courcelle va da Socrate a s. Bernardo), invitando ogni uomo a
rendersi conto che la sua natura specifica consiste nella propria psych e che, quindi, il
suo compito supremo la cura dellanima (Presentazione, cit. p. 7).
Con i successivi pensatori, il motto delfico verr ripreso e, gi con Platone,
approfondito, ad esempio nellAlcibiade maggiore (132 C, ss.), ponendo in rilievo che
luomo si conosce solo ponendosi faccia a faccia con il divino che nella sua anima,
misurandosi con esso e mettendosi in rapporto con lui.
Nella scia di Platone e dei neoplatonici, Plutarco ricordava che, accanto al motto
Conosci te stesso, sulla facciata del tempio, era appesa una grande E, che
pg. 1
Prof. Angelo Marchesi, www.dialexis.it
indicherebbe Ei, cio: Tu sei, come riconoscimento, da parte delluomo, che solo il
dio veramente, mentre alluomo mortale non compete lessere.
Nei secoli successivi si manifesteranno pertanto due linee: quella socratica che
sottolinea la finitezza delluomo e quella platonica e neoplatonica che sottolinea il
rapporto che esiste tra lo spirito delluomo e la realt del divino con cui luomo in
contatto.
Soprattutto in s. Agostino emerger come basilare lidea biblica dellanima umana come
immagine di Dio e proprio su di essa si incentrer la nota tesi della necessit di
rientrare in se stessi, per attingere la verit e trovare Dio (cfr. Presentazione, p. 9).
Occorre notare che, nelledizione italiana, il grosso volume unico riunisce i tre
delledizione originale francese (1974-75) e si articola in due parti. Nella prima lAutore
traccia una meticolosa e documentata Storia del precetto delfico (pp. 15-243), da
Socrate a Platone, a Cicerone, a Filone e Plutarco; da Plotino a Origene, ai Padri
Cappadoci, sino ad Ambrogio e ad Agostino, per passare poi da Proclo allo PseudoDionigi sino a Scoto Eriugena, ai Vittorini e a s. Bernardo; nella seconda parte vengono
invece analizzate le Prospettive platoniche e cristiane sulla miseria e grandezza
delluomo (pp. 245-590), mettendo a tema la miseria umana, lanima legata al corpo,
ladescamento del male, lo spirito umano che avverte di trovarsi in una regione di
dissomiglianza (in regione dissimilitudinis) rispetto alla via ed al possesso della Verit,
con laspirazione a tornare alla originaria parentela delluomo con Dio, passando anche
qui dalle tematiche del pensiero platonico, neoplatonico e poi patristico-cristiano sino
alla prima scolastica del sec. XII.
*
Impossibile qui richiamare la complessit e la mole delle citazioni greche e
latine che accompagnano i diciotto capitoli e documentano lo svolgimento della
conoscenza di s come condizione essenziale per capire chi luomo e il suo rapporto
con lAssoluto.
Ci accontentiamo di seguire le Conclusioni (pp. 591-610) che lo stesso Courcelle ha
cura di presentare al termine della sua pluriennale ricerca. In quelle pagine (che passano
in rassegna le riflessioni ben quindici secoli!) si succedono gli accenni ai vari pensatori,
pagani e cristiani, che hanno concentrato la loro attenzione sul famoso precetto
Conosci te stesso, a cominciare dal passo platonico del Fedro (229E 230A), che
Courcelle giustamente presenta come esergo nella pagina iniziale, in cui scritto: io
non sono ancora in grado, secondo liscrizione di Delfi, di Conoscere me stesso
(gnnai emautn) e perci mi sembra ridicolo, non conoscendo ancora questo, indagare
su cose che mi sono estranee. Perci dando addio a tali cose e mantenendo fede a ci
che si crede di esse, vado esaminando non tali cose, ma me stesso, per vedere se non si
dia il caso che io sia una qualche bestia pervasa di brame (), o se invece io sia un
essere vivente pi mansueto e pi semplice, partecipe per natura (physei metchon) di
una sorte divina (theias moiras) e senza fumosa arroganza. Daltronde Platone aveva
gi asserito, nellApologia di Socrate, che : una vita non indagata profondamente
non vivibile (degna) per un uomo, anche se luomo deve essere consapevole della sua
condizione mortale.
Per questi motivi, in seguito, viene accentuata una portata etica di questo precetto
delfico, invitando luomo a prendere coscienza della sua limitatezza e della sua finitezza
e debolezza morale, accanto ad una lettura gnostica che accentua la nostra situazione di
esseri decaduti.
Per Plotino si deve accentuare unascesi religiosa affinch luomo riconosca la presenza
di Dio in se stesso, mentre, per Origene, il cristiano ha consapevolezza (anche mediante
pg. 2
Prof. Angelo Marchesi, www.dialexis.it
la suggestione di un versetto del Cantico dei cantici, I, 8) di essere stato creato ad
immagine di Dio, almeno nella sua parte spirituale.
In Occidente poi Macrobio, come gli Gnostici e i Neoplatonici, intender il Conosci te
stesso come reminiscenza della nostra nobile origine, cos come, per s. Ambrogio,
vescovo di Milano, lanima deve saper evadere dal corpo e sar in grado di conoscersi
solo vivendo secondo la sua natura, riconoscendo la sua attitudine razionale che fonda
la sua somiglianza con la divinit, sottomettendo la nostra condotta alla ragione (Cfr.
Conclusioni, pp. 591-92).
Sar poi soprattutto s. Agostino, sulle suggestioni di Porfirio, a stabilire che
luomo deve restituirsi a se stesso, allontanandosi dai sensi e dalle opinioni molteplici,
mediante lintrospezione (Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat
veritas etc.), contrapponendo, nella scia del Fedro platonico, lindagine interiore alla
ricerca della physis esteriore, quella che, secondo Lucrezio, avrebbe spinto Epicuro sino
ai moenia mundi. Courcelle scrive che, per Agostino, il precetto delfico ingiunge di
eliminare le croste terrose, incollate allanima dalle immagini degli oggetti sensibili,
per giungere ad una conoscenza esplicita di s mediante la cogitatio. Questa riflessione
interiore gli riveler limmagine trina dellanima (mens, notitia et amor),
specchio della Trinit delle Persone divine (Conclusioni, p. 593 e c. VIII, pp. 110-46).
Nel solco della riflessione agostiniana continuer poi il pensiero dei secoli successivi,
con Gregorio Magno, con Scoto Eriugena, con s. Anselmo, che insiste sulla presenza
immediata, intuitiva, dellanima a se stessa, con i Cistercensi, i Vittorini: Ugo di s.
Vittore affermer che conoscere se stessi costituisce la porta di tutte le conoscenze,
mentre per Riccardo di s. Vittore luomo deve passare dalla conoscenza di s per poi
elevarsi a Dio.
Analogamente diranno Guglielmo di Saint-Thierry e Bernardo di Chiaravalle che, pur
rilevando la miseria della condizione umana a causa del peccato, indicano la possibilit
per luomo, essere animato dallo spirito, di convertirsi e tornare a Dio. questo nel solco
del celebre asserto agostiniano: Noverim me, noverim Te, nei suoi memorabili
Soliloquia.
Courcelle rileva poi che il precetto delfico era ben presente anche ai pensatori
della scolastica medievale cos come sar ben noto ai mistici impregnati di
neoplatonismo come Meister Eckhart, Tauler, Suso e, in Italia, Caterina da Siena,
Petrarca, Marsilio Ficino e poi altri pensatori come Montaigne, o i mistici, spagnoli e
francesi, del XV secolo (cfr. Conclusioni, pp. 595-598).
Anche B. Pascal si riferir al precetto delfico, ma con tono polemico insister perch
luomo conosca la sua superbia e capisca che luomo oltrepassa infinitamente luomo,
ascoltando dal vero maestro la sua vera condizione che gli piace ignorare e ancora: che
luomo grande nella misura in cui si riconosce miserabile, mentre un albero non si
riconosce miserabile (Cfr. Conclusioni, pp. 599-600).
Courcelle, dopo aver fugacemente accennato a certi pensatori contemporanei come
Nietzsche, Anatole France, Jacques Monod, G. Gusdorf, contrari o pessimisti in
relazione alla validit del precetto delfico, conclude la sua vasta rassegna rilevando che
gli antichi e i medievali cercavano con il Nosce te ipsum di costruire unantropologia,
intesa poi come sintesi del precetto delfico e della sapienza cristiana, mentre certi
pensatori contemporanei, per differenti ragioni, vi rinunciano ab initio, cos come altri,
tra i pi grandi, continuano a cercare se stessi (), nella speranza di riuscire a
percepire il mistero della condizione umana(cfr. p.602). A questo proposito egli fa i
nomi di J. Green, Fr. Mauriac, A. Soljenitsyn (con Larcipelago Gulag), certo pi vicini
ad un umanesimo plenario, come stato proposto, tra la fine del secolo XX e gli inizi
pg. 3
Prof. Angelo Marchesi, www.dialexis.it
del secolo XXI, da Paolo VI e da Giovanni Paolo II nei loro messaggi indirizzati a tutti
gli uomini di buona volont. 1
Il presente articolo stato pubblicato su Terza pagina de LOsservatore Romano il 18 ott. 2006.
pg. 4
Potrebbero piacerti anche
- Giovanni Paolo II - UOMO E DONNA LO CREO' - Catechesi Sull'Amore UmanoDocumento259 pagineGiovanni Paolo II - UOMO E DONNA LO CREO' - Catechesi Sull'Amore UmanoGabriele Galleri100% (4)
- Venanzio Fortunato - OpereDocumento344 pagineVenanzio Fortunato - OpereGabriele Galleri50% (2)
- ODO CASEL - Il Mistero Dell'ecclesiaDocumento250 pagineODO CASEL - Il Mistero Dell'ecclesiaGabriele Galleri100% (4)
- Ludovico Ariosto - La CassariaDocumento55 pagineLudovico Ariosto - La CassariaIvano LoffredoNessuna valutazione finora
- Lettieri LezioniDocumento54 pagineLettieri LezioniGiuseppe QuattrominiNessuna valutazione finora
- Giorgio Colli, Alessandro Fersen - La Dimensione Perduta (Integrale)Documento9 pagineGiorgio Colli, Alessandro Fersen - La Dimensione Perduta (Integrale)dolan36Nessuna valutazione finora
- Teologia Dogmatica - Schmaus - Sintesi Primo Volume - ParzialeDocumento30 pagineTeologia Dogmatica - Schmaus - Sintesi Primo Volume - ParzialeGabriele GalleriNessuna valutazione finora
- Gioiosi Cantiamo - Luigi PicchiDocumento240 pagineGioiosi Cantiamo - Luigi PicchiGabriele Galleri100% (2)
- Eugenio MontaleDocumento6 pagineEugenio MontalecamilladaddarioNessuna valutazione finora
- Il Nostro Bisogno Di ConsolazioneDocumento3 pagineIl Nostro Bisogno Di ConsolazioneLucia NigroNessuna valutazione finora
- Gasparro - Gli Oracoli CaldaiciDocumento26 pagineGasparro - Gli Oracoli CaldaiciLeleScieriNessuna valutazione finora
- Napolitanognothi SeautonDocumento17 pagineNapolitanognothi SeautonCarlo AnaclerioNessuna valutazione finora
- Dodds, Pagani e Cristiani in Un Epoca D'angoscia.Documento2 pagineDodds, Pagani e Cristiani in Un Epoca D'angoscia.matei ionescoNessuna valutazione finora
- Gigante, Biografia e Dossografia in Diogene LaerzioDocumento72 pagineGigante, Biografia e Dossografia in Diogene LaerzioalverlinNessuna valutazione finora
- 16-Filosofi e ReligioneDocumento111 pagine16-Filosofi e Religioneparsifal11Nessuna valutazione finora
- Il Quattrocento - Filosofia (39): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 39Da EverandIl Quattrocento - Filosofia (39): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 39Nessuna valutazione finora
- Calveno Tauro e L'interpretazione Didascalica Della Cosmogenesi Del Timeo - Franco Ferrari PDFDocumento14 pagineCalveno Tauro e L'interpretazione Didascalica Della Cosmogenesi Del Timeo - Franco Ferrari PDFjusrmyrNessuna valutazione finora
- Apollonio Di TianaDocumento7 pagineApollonio Di TianaclapaeriNessuna valutazione finora
- Vita Di SocrateDocumento43 pagineVita Di SocratePaolo CartaNessuna valutazione finora
- Il Cinismo Come Domanda Nel Pensiero Di Michel FoucaultDocumento79 pagineIl Cinismo Come Domanda Nel Pensiero Di Michel Foucaultrebellin100% (1)
- Cavallo - La Trasmissione Dei Moderni Tra Antichità Tarda e Medioevo BizantinoDocumento17 pagineCavallo - La Trasmissione Dei Moderni Tra Antichità Tarda e Medioevo BizantinoSettemontiErma1Nessuna valutazione finora
- Upanisad DellacasaDocumento542 pagineUpanisad DellacasasarafergNessuna valutazione finora
- Augusto Del Noce e Rene DescartesDocumento34 pagineAugusto Del Noce e Rene DescartesCarlos Daniel LasaNessuna valutazione finora
- Plotino e ÇankaraDocumento16 paginePlotino e ÇankaraMaria PalmaNessuna valutazione finora
- Radici giudaico-cristiane d'Europa: un falso storicoDa EverandRadici giudaico-cristiane d'Europa: un falso storicoNessuna valutazione finora
- Chiaradonna Filosofia Tardoantica - Osservazioni Preliminari-LibreDocumento13 pagineChiaradonna Filosofia Tardoantica - Osservazioni Preliminari-LibreGiancarloBellinaNessuna valutazione finora
- Walter Burkert - Storia Delle Religioni - I GreciDocumento56 pagineWalter Burkert - Storia Delle Religioni - I GreciStefano UllianaNessuna valutazione finora
- Fadda, Tradizioni Manoscritte e Critica Del Testo Nel Medioevo (Riassunto)Documento75 pagineFadda, Tradizioni Manoscritte e Critica Del Testo Nel Medioevo (Riassunto)Hannah Laxis-TamNessuna valutazione finora
- PATROLOGIA Gli ApologistiDocumento4 paginePATROLOGIA Gli ApologistibrunomorabitoNessuna valutazione finora
- 1014 ZollaDocumento31 pagine1014 Zollaontarios7Nessuna valutazione finora
- Il Teatro Di Simone WeilDocumento68 pagineIl Teatro Di Simone Weilina_neckel1186Nessuna valutazione finora
- La quadratura del nulla. Nicola Cusano e la generazione del significatoDa EverandLa quadratura del nulla. Nicola Cusano e la generazione del significatoNessuna valutazione finora
- Vita Di SocrateDocumento43 pagineVita Di SocrateRocco ViggianoNessuna valutazione finora
- Narrant 3Documento35 pagineNarrant 3crespomanoloNessuna valutazione finora
- SociologiaDocumento197 pagineSociologiaPaolo SottileNessuna valutazione finora
- De Consolatione Philosophiae - Severino BoezioDocumento2 pagineDe Consolatione Philosophiae - Severino BoezioCaterina Autuori100% (1)
- Saffo Frammenti Tradotti Da Salvatore Quasimodo e Scheda Biografica Di Fedrico CondelloDocumento22 pagineSaffo Frammenti Tradotti Da Salvatore Quasimodo e Scheda Biografica Di Fedrico CondelloSergioLuizMarinhoNessuna valutazione finora
- Eckhart Dal Silenzio Alla ParolaDocumento8 pagineEckhart Dal Silenzio Alla ParolaKatejon Aguilar HernándezNessuna valutazione finora
- Tre storie italiane di fantascienza: Settembrini, Nievo, SalgariDa EverandTre storie italiane di fantascienza: Settembrini, Nievo, SalgariValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Pitagora Armonia .Documento4 paginePitagora Armonia .Oscar FilippeschiNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento158 pagineUntitledMatheusNessuna valutazione finora
- Walter Friedrich Gustav Hermann Otto - Spirito Classico e Mondo CristianoDocumento128 pagineWalter Friedrich Gustav Hermann Otto - Spirito Classico e Mondo CristianoPietro GiocoliNessuna valutazione finora
- La Via Dellimmortalita Percorsi PlatonicDocumento106 pagineLa Via Dellimmortalita Percorsi PlatonicLivio SimNessuna valutazione finora
- Clemente Di Alessandria - Protreptico Ai GreciDocumento52 pagineClemente Di Alessandria - Protreptico Ai GreciPapeSatanAleppeNessuna valutazione finora
- Mito e Poesia Nel PROMETEO INCATENATO Di EschiloDocumento9 pagineMito e Poesia Nel PROMETEO INCATENATO Di EschiloDavo Lo SchiavoNessuna valutazione finora
- Introduzione Al Pensiero Complesso Di Pa RecognizedDocumento36 pagineIntroduzione Al Pensiero Complesso Di Pa RecognizedJuanEstebanNessuna valutazione finora
- Masnovo - Ancora Alberto Magno e L'averroismo Latino PDFDocumento10 pagineMasnovo - Ancora Alberto Magno e L'averroismo Latino PDFAlberti Magni Studiosus100% (1)
- Sant'Agostino - Lo Spirito e La Lettera (ITA)Documento78 pagineSant'Agostino - Lo Spirito e La Lettera (ITA)PapeSatanAleppe100% (1)
- F. CIOTTI, Web SemanticoDocumento34 pagineF. CIOTTI, Web SemanticoMassimo IntelviNessuna valutazione finora
- Paganesimo e Cristianesimo Tra III e IV Secolo-SecondaDocumento6 paginePaganesimo e Cristianesimo Tra III e IV Secolo-SecondairelorisNessuna valutazione finora
- DISF Libro SapienzaDocumento6 pagineDISF Libro Sapienzailuafaaf100% (1)
- Plinio Boezio e La Teoria Pitagorica Dell'Armonia Delle SfereDocumento15 paginePlinio Boezio e La Teoria Pitagorica Dell'Armonia Delle SfereVopym78Nessuna valutazione finora
- L'arte Della Persuasione - PpsDocumento66 pagineL'arte Della Persuasione - PpslanaNessuna valutazione finora
- Davide Monaco - Cusano e La Tolleranza ReligiosaDocumento15 pagineDavide Monaco - Cusano e La Tolleranza ReligiosaEugen CiurtinNessuna valutazione finora
- Fowler PlatoneDocumento135 pagineFowler PlatoneSandro Themel100% (2)
- Cooper e L'ultimo Dei Mohicani ScannaviniDocumento13 pagineCooper e L'ultimo Dei Mohicani ScannaviniIrene ArchiniNessuna valutazione finora
- Nietzsche-La Morte Di Dio-CommentoDocumento8 pagineNietzsche-La Morte Di Dio-CommentoMarino RamaNessuna valutazione finora
- Da Zoroastro Ai CatariDocumento45 pagineDa Zoroastro Ai CataridonpedrodetoledoNessuna valutazione finora
- Mario Negri-Erika Notti - Leonardo Magini - Omero Il Cielo e Il Mare - Intro - Chap. 1Documento51 pagineMario Negri-Erika Notti - Leonardo Magini - Omero Il Cielo e Il Mare - Intro - Chap. 1Luciano DuòNessuna valutazione finora
- Baroncini, F.-La Libertà in DostoevskijDocumento13 pagineBaroncini, F.-La Libertà in DostoevskijDaniel Augusto García PorrasNessuna valutazione finora
- S. Camillotti 2014 - Cartoline D'africa. Le Colonie Italiane Nella Rappresentazione LetterariaDocumento177 pagineS. Camillotti 2014 - Cartoline D'africa. Le Colonie Italiane Nella Rappresentazione LetterariaPaolo BiagiNessuna valutazione finora
- Vinci - Heidegger.dal Gnosticismo Alla Gnosis GrecaDocumento34 pagineVinci - Heidegger.dal Gnosticismo Alla Gnosis GrecaJarekNessuna valutazione finora
- Machiavelli Dialogo Intorno Alla Nostra PDFDocumento15 pagineMachiavelli Dialogo Intorno Alla Nostra PDFsebatorres7Nessuna valutazione finora
- Vittorio Macchioro - Orfismo e Paolinismo (1982, Edizioni Bastogi)Documento311 pagineVittorio Macchioro - Orfismo e Paolinismo (1982, Edizioni Bastogi)BogdanNessuna valutazione finora
- In Difesa Di Origene-Aspetto Storico Della Seconda Controversia OrigenistaDocumento22 pagineIn Difesa Di Origene-Aspetto Storico Della Seconda Controversia Origenistalothar82Nessuna valutazione finora
- I Sette SacramentiDocumento5 pagineI Sette SacramentiGabriele GalleriNessuna valutazione finora
- Canti Per La ParrocchiaDocumento101 pagineCanti Per La ParrocchiaGabriele Galleri100% (1)
- Hugo Rahner - Mater EcclesiaDocumento78 pagineHugo Rahner - Mater EcclesiaGabriele Galleri100% (1)
- Liber HymnariusDocumento320 pagineLiber HymnariusGabriele Galleri100% (9)
- I Canti Della Fede - RepertorioDocumento211 pagineI Canti Della Fede - RepertorioGabriele Galleri100% (1)
- Cantoeprego PDFDocumento30 pagineCantoeprego PDFGabriele Galleri100% (1)
- Don Gabriele Amorth Il Caso Annaliese MichelDocumento8 pagineDon Gabriele Amorth Il Caso Annaliese MichelRoberto Buffagni100% (2)
- La Magi Adelle ParoleDocumento53 pagineLa Magi Adelle ParoleDiana MiglianoNessuna valutazione finora
- La Civiltà Delle Buone ManiereDocumento10 pagineLa Civiltà Delle Buone ManieredodecarioNessuna valutazione finora
- IngressorosacroceDocumento3 pagineIngressorosacroceAlfredo Di BlasiNessuna valutazione finora
- Quaresimale - Roberto CaraccioloDocumento96 pagineQuaresimale - Roberto Caraccioloblueyes247Nessuna valutazione finora
- Canti Con AccordiDocumento75 pagineCanti Con AccordipicosuerteNessuna valutazione finora
- La Pecora NeraDocumento3 pagineLa Pecora NeraAlita Lopez100% (1)
- Seneca - de Tranquillitate Animi - Testo A FronteDocumento39 pagineSeneca - de Tranquillitate Animi - Testo A Fronteado's100% (1)
- Preghiere OssessioniDocumento8 paginePreghiere OssessioniSanto DianoNessuna valutazione finora
- San SilvanoDocumento86 pagineSan SilvanoEleonora SassuNessuna valutazione finora
- FUNZIONADocumento4 pagineFUNZIONARenzo PicolatoNessuna valutazione finora
- AccordiDocumento6 pagineAccordiIsacco OttoliniNessuna valutazione finora
- Stoicismo Scetticismo CinismoDocumento10 pagineStoicismo Scetticismo CinismoDandy75Nessuna valutazione finora
- Errico Malatesta - Anarchia e ViolenzaDocumento2 pagineErrico Malatesta - Anarchia e Violenzaenzo de simoneNessuna valutazione finora
- Il Sacramento Della RiconciliazioneDocumento37 pagineIl Sacramento Della RiconciliazioneVICTORNessuna valutazione finora
- Sintesi NietzscheDocumento4 pagineSintesi NietzscheSilviu ChiriacNessuna valutazione finora
- La Voce Del Padre - Settembre 2012Documento4 pagineLa Voce Del Padre - Settembre 2012Barnabite PublicationsNessuna valutazione finora
- Una Storia Della Magia PDFDocumento0 pagineUna Storia Della Magia PDFvfallikNessuna valutazione finora
- Canti Per La LiturgiaDocumento65 pagineCanti Per La LiturgiaPaolo LongaNessuna valutazione finora
- Non Cessare Di Scolpire La Tua Propria Statua InterioreDocumento2 pagineNon Cessare Di Scolpire La Tua Propria Statua InteriorePAOLO ZORUTTINessuna valutazione finora
- Eliot - Assassinio Nella CattedraleDocumento48 pagineEliot - Assassinio Nella CattedraleDariusSteinerNessuna valutazione finora
- 05a - Klaus Hemmerle-Commenti e Testi Su Amore Al Prossimo 1Documento4 pagine05a - Klaus Hemmerle-Commenti e Testi Su Amore Al Prossimo 1AloZamNessuna valutazione finora
- Eugenio MontaleDocumento10 pagineEugenio MontaleSarah GiordanoNessuna valutazione finora