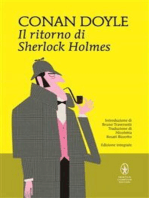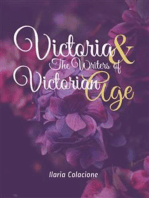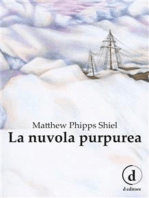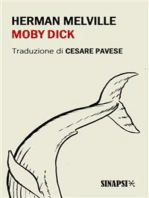Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Talkien
Caricato da
MarioPùccini0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni1 paginaCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni1 paginaTalkien
Caricato da
MarioPùcciniCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 1
Tra il 1954 ed il 1955 usciva la trilogia di J.R.R.
Tolkien, The Lord of the Rings: il maggior
studioso di letteratura anglosassone e medievale aveva scritto a sua volta un'epopea secondo le
regole del genere cavalleresco, diventando il servitore appassionato delle forze stesse che aveva
sentito pulsare nei versi di uomini morti da più d'un millennio. Macpherson nel '700 aveva
immaginato un bardo scozzese vestendosi dei suoi ruvidi gaelici panni, ma la sua era una frode, un
fingersi antico, agitato da selvatiche furie e malinconie. Altri avevano giocato con l'antico
parodiandolo, Mark Twain e J.B. Cabe si erano rassicurati sulla loro eccellenza di uomini evoluti e
coscienti a cospetto delle leggende e dei cicli cavallereschi dei loro compassionevoli avi. Tolkien
con costoro non ha niente da spartire, e nemmeno compone una favola romantica, magari
riatteggiata come gioco surreale, tanto da mostrare di stare alle regole di buona creanza
dell'avanguardia che tanto intimidiscono i timidi. Tolkien commise una lunga infrazione alle regole,
specie a quelle che presiedono all'ancora (per poco?) vigente studio accademico delle letterature
antiche. Esse vogliono che il filologo o lo storico del gusto partecipi per la parte riservata al suo
ufficio all'opera di schedatura universale, nel quadro d'una Burocrazia come Essere che si svela a se
stesso. Guai a far rivivere l'antico (uccidendo il moderno). In The Lord of the Rings Tolkien
viceversa riparla, in una lingua che ha la semplicità dell'anglosassone o del medioinglese, di
paesaggi che pare d'aver già amato leggendo Beowulf o Sir Gawain o La Mort d'Arthur, di creature
campate tra il mondo sublunare ed il terzo cielo, di essenze incarnate in forze fantastiche, di
archetipi divenuti figure.
Potrebbero piacerti anche
- Letteratura Inglese RiassuntoDocumento97 pagineLetteratura Inglese RiassuntoДжупи Мадам МимNessuna valutazione finora
- Teatro Nel SeicentoDocumento10 pagineTeatro Nel SeicentomatteosetturaNessuna valutazione finora
- Tesi Su TolkienDocumento157 pagineTesi Su TolkienrobertoNessuna valutazione finora
- Bertinetti - RiassuntoDocumento19 pagineBertinetti - Riassuntovanninabliff100% (7)
- Il Genere FantasyDocumento9 pagineIl Genere FantasyLuxillaNessuna valutazione finora
- La Razza Che Verra - Edward Bulwer-LyttonDocumento228 pagineLa Razza Che Verra - Edward Bulwer-LyttonAlberto Cammarata100% (1)
- Letteratura Inglese Origini-700Documento20 pagineLetteratura Inglese Origini-700Salvo Andolina50% (2)
- Letteratura IngleseDocumento16 pagineLetteratura IngleseGreta GuarnaNessuna valutazione finora
- Guida alla lettura ... Il Romanzo Gotico e oltre: breve storia del romanzo gotico inglese e suoi sviluppiDa EverandGuida alla lettura ... Il Romanzo Gotico e oltre: breve storia del romanzo gotico inglese e suoi sviluppiNessuna valutazione finora
- Il Signore Degli Anelli Di J.R.R. Tolkien e I Miti Nordici Stefano GiannatempoDocumento77 pagineIl Signore Degli Anelli Di J.R.R. Tolkien e I Miti Nordici Stefano GiannatempoIrene BerraNessuna valutazione finora
- Medioevo Fantastico PDFDocumento3 pagineMedioevo Fantastico PDFdferrixxNessuna valutazione finora
- Lloyd Alexander - (Le Cronache Di Prydain #1-3) La Saga Di PrydainDocumento447 pagineLloyd Alexander - (Le Cronache Di Prydain #1-3) La Saga Di PrydainamsahbucNessuna valutazione finora
- Bertinetti RiassuntoDocumento17 pagineBertinetti RiassuntoBeerSeekerNessuna valutazione finora
- Cap 1Documento5 pagineCap 18y8qdksxpwNessuna valutazione finora
- Letteratura IngleseDocumento58 pagineLetteratura IngleseGiadaNessuna valutazione finora
- Dracula: include Biografia / analisi del Romanzo / illustratoDa EverandDracula: include Biografia / analisi del Romanzo / illustratoNessuna valutazione finora
- LucanoDocumento3 pagineLucanoGabriele GiannoneNessuna valutazione finora
- 06 Chaucer CanterburyDocumento6 pagine06 Chaucer CanterburyEliNessuna valutazione finora
- P. Bertinetti Storia Della Letteratura IngleseDocumento21 pagineP. Bertinetti Storia Della Letteratura IngleseIna ManninoNessuna valutazione finora
- Legione Fantasma Della ScoziaDocumento4 pagineLegione Fantasma Della ScoziaMassimo CipollaNessuna valutazione finora
- Il Genere Del FantasyDocumento11 pagineIl Genere Del FantasyGabriele FabbriNessuna valutazione finora
- Letteratura-Inglese, Riassunto BreveDocumento16 pagineLetteratura-Inglese, Riassunto BreveAndreaAurora BarberoNessuna valutazione finora
- Bertinetti RiassuntoDocumento19 pagineBertinetti RiassuntoPriscilla RossettiNessuna valutazione finora
- Chaucer 3 - 7Documento12 pagineChaucer 3 - 7Lisa TaschbachNessuna valutazione finora
- La Poesia dell'Anello: Guida ai versi più famosi della Terra di MezzoDa EverandLa Poesia dell'Anello: Guida ai versi più famosi della Terra di MezzoNessuna valutazione finora
- C'era una volta...: il raccontare storie in Inghilterra dai Celti al 18° secoloDa EverandC'era una volta...: il raccontare storie in Inghilterra dai Celti al 18° secoloNessuna valutazione finora
- Lawrence DurrellDocumento9 pagineLawrence DurrellCLARA SANTOS MONTOYANessuna valutazione finora
- Figure di passaggio: Temi, generi e linguaggi della fin de siècle ingleseDa EverandFigure di passaggio: Temi, generi e linguaggi della fin de siècle ingleseNessuna valutazione finora
- Shakespeare e CervantesDocumento29 pagineShakespeare e CervantesRosalinda Di MauroNessuna valutazione finora
- All'ombra di Sherlock Holmes - 2. La dama velataDa EverandAll'ombra di Sherlock Holmes - 2. La dama velataNessuna valutazione finora
- La Figura Del VampiroDocumento8 pagineLa Figura Del VampiroIsabela GutuNessuna valutazione finora
- Appunti Latino IDocumento29 pagineAppunti Latino IDarioNessuna valutazione finora
- LUCANODocumento12 pagineLUCANOGiusy MarascoNessuna valutazione finora
- Friedrich SchillerDocumento13 pagineFriedrich Schillerdanielefrances09Nessuna valutazione finora
- Douglas E. Winter - Visioni Della Notte (Ita Libro)Documento241 pagineDouglas E. Winter - Visioni Della Notte (Ita Libro)mocanu_oanaNessuna valutazione finora
- 194395-Text de L'article-270327-1-10-20101004Documento17 pagine194395-Text de L'article-270327-1-10-20101004FrancoNessuna valutazione finora
- Letteratura IngleseDocumento30 pagineLetteratura IngleseAntonella d'AngellaNessuna valutazione finora
- Docsity Il Graal e I Cavalieri Della Tavola RotondaDocumento9 pagineDocsity Il Graal e I Cavalieri Della Tavola RotondamarziaNessuna valutazione finora
- Macbeth (Analisi)Documento7 pagineMacbeth (Analisi)Martina100% (1)
- Dispensa Seconda - Terza-NarrativaDocumento32 pagineDispensa Seconda - Terza-NarrativaSophie MiglioratiNessuna valutazione finora
- Viaggio Di Carlo Magno in Oriente - BonafinDocumento140 pagineViaggio Di Carlo Magno in Oriente - BonafinAlberto CappelliNessuna valutazione finora
- Teoria Letteratura IngleseDocumento62 pagineTeoria Letteratura IngleseVon RossNessuna valutazione finora
- Torquato TassoDocumento4 pagineTorquato TassoMarco Saverio CofoneNessuna valutazione finora
- LUCANO, Test Inglese e Versioni Tradotte Di EpicuroDocumento7 pagineLUCANO, Test Inglese e Versioni Tradotte Di Epicurogianluca.dragone6Nessuna valutazione finora
- Letteratura Delle OriginiDocumento2 pagineLetteratura Delle OriginiBarbero AlessandroNessuna valutazione finora
- Poema EpicoDocumento5 paginePoema EpicoAlin CesantiNessuna valutazione finora
- AthesDocumento2 pagineAthes6020utuNessuna valutazione finora
- Gilgamesh EpopeaDocumento22 pagineGilgamesh EpopeaNathan WilliamsNessuna valutazione finora
- Letteratura LatinaDocumento10 pagineLetteratura LatinaLichess ChadNessuna valutazione finora
- Il NovelDocumento6 pagineIl NovelLisa TaschbachNessuna valutazione finora
- Appunti IngleseDocumento6 pagineAppunti IngleseCecilia AlimentiNessuna valutazione finora
- Cthulhucaust - Nefer NeferDocumento32 pagineCthulhucaust - Nefer NeferMarco ReclaNessuna valutazione finora
- 3Documento1 pagina3MarioPùcciniNessuna valutazione finora
- 1Documento1 pagina1MarioPùcciniNessuna valutazione finora
- 5Documento1 pagina5MarioPùcciniNessuna valutazione finora
- Talkien 6Documento1 paginaTalkien 6MarioPùcciniNessuna valutazione finora
- Talkien 4Documento1 paginaTalkien 4MarioPùcciniNessuna valutazione finora
- Score 0Documento1 paginaScore 0MarioPùcciniNessuna valutazione finora