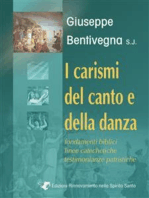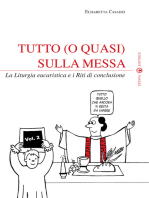Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Criteri Per La Scelta Dei Canti Nelle Celebrazioni Liturgiche
Caricato da
diapa0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
18 visualizzazioni3 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
18 visualizzazioni3 pagineCriteri Per La Scelta Dei Canti Nelle Celebrazioni Liturgiche
Caricato da
diapaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 3
Criteri per la scelta dei canti nelle celebrazioni liturgiche
a cura di don Luca Carlesi
Il criterio fondamentale per la scelta dei canti nelle celebrazioni
liturgiche e, più in generale, nel rapporto fra musica e liturgia, ci è
suggerito dalla Costituzione del Concilio Vaticano II sulla liturgia
Sacrosanctum Concilium al numero 112: «La musica sacra sarà tanto più
santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia
esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l'unanimità, sia
arricchendo di maggior solennità i riti sacri». Dall'autorevole testo
conciliare emerge chiaramente il criterio di fondo, cioè la preminenza
dell'azione liturgica su quella musicale. Quest'ultima riveste, all'
interno della liturgia, un ruolo ministeriale sia sul versante della
comprensione del senso delle celebrazioni liturgiche, come anche delle
feste o del tempo liturgico, sia sul versante della piena, attiva e
comunitaria partecipazione del popolo cristiano (cf. SC, 21). Infatti il
centro principale di interesse del rinnovamento liturgico è costituito
dall'assemblea del popolo di Dio, riconosciuto come il corpo mistico di
Cristo vivente e ricco di doni e di ministeri (cf. LG, 7-12). Il coro, o
più precisamente la schola, è parte dell'assemblea liturgica, non si
sovrappone e tanto meno si sostituisce ad essa, anche quando esegue il
canto da sola.
Dopo aver affermato che «non è sempre necessario cantare tutti i testi
che per loro natura sono destinati al canto», la Institutio Generalis
Missalis Romani (che da ora in poi citeremo come IGMR) contenuta nella
Editio typica tertia 2000 al n. 40 ci offre il primo criterio pratico:
«Nella scelta delle parti destinate al canto si dia la preferenza a quelle
di maggior importanza, e soprattutto a quelle che devono essere cantate
dal sacerdote o dai ministri con la risposta del popolo, o dal sacerdote e
dal popolo insieme».
Le parti della Messa destinate al canto sono:
- il Kyrie eleison, eseguito da tutti, in alternanza tra il popolo e la
schola o un cantore;
- il Gloria in excelsis Deo, cantato da tutta l'assemblea, o dal popolo
alternativamente con la schola, oppure dalla schola. Il testo di questo
inno non può essere sostituito con un altro;
nella liturgia della Parola, i canti fra le letture e cioè il Salmo
responsoriale, cantato per intero dal cantore oppure intercalato dal canto
del ritornello da parte dell'assemblea;
- l'Alleluia o un altro canto a seconda del tempo liturgico; l'Alleluia e
il versetto prima del Vangelo dovrebbe essere sempre cantato, tanto che se
non si canta si può addirittura tralasciare (IGMR, 63);
- nella liturgia eucaristica, sono destinati al canto il Prefazio (la IGMR
al numero 47 consiglia vivamente (valde convenit), che il sacerdote canti
le parti della Prece Eucaristica arricchite di note), il Sanctus, l'
acclamazione dopo l'anàmnesi e la dossologia finale; da notare, a
proposito del Sanctus, che questa acclamazione fa parte della Prece
Eucaristica e come tale non è lecito sostituirla con altri canti (cf. IMGR
79 e 136);
- nei riti di Comunione, l'invito o monizione, la preghiera del Signore
(Pater noster), l'embolismo e la dossologia si cantano o si dicono ad alta
voce (IGMR, 81);
- il canto dopo la Comunione, da non confondere con il canto alla
Comunione che accompagna la processione e che verrà trattato più tardi.
Uno sguardo alle Antifone di Comunione proposte dal Messale per le singole
domeniche, solennità e feste fa emergere la tradizione latina che
ripropone un versetto significativo della lettura evangelica di quella
Messa.
Nella celebrazione eucaristica sono previsti altri canti che hanno lo
scopo di accompagnare i diversi momenti rituali: introduzione,
preparazione dei doni, processione alla comunione.
La funzione del Canto d'ingresso è quella di dare inizio alla
celebrazione, favorire l'unione dei fedeli, introdurre il loro spirito nel
mistero del tempo liturgico o della festività e accompagnare la
processione del sacerdote e dei ministri (IGMR, 47). Nella scelta del
canto d'ingresso vanno tenuti presenti sia la dimensione comunitaria, sia
la funzione di introdurre nel mistero celebrato, come anche quella d'
accompagnare la processione del sacerdote e dei ministri verso l'altare.
Però non vale il criterio del "basta cantare un canto qualsiasi" o del "mi
piace", bensì quello ministeriale. Quindi sono da escludere quei canti in
stile meditativo che non favoriscono l'unione dei fedeli, ma piuttosto un
mistico individualismo. La scelta di un canto che introduca nel mistero
della celebrazione nei tempi liturgici è abbastanza facile nei tempi forti
(Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua) e più difficile nel tempo ordinario.
Per cogliere il tema della celebrazione, e quindi scegliere il canto più
adatto per introdurre i fedeli nel mistero, occorre sempre andare alla
pagina evangelica nel suo dialogo con la prima lettura tratta dall'Antico
Testamento. Un'altra positiva indicazione tematica è comunque offerta dall
'antifona d'ingresso prevista dal Messale.
Il Canto all'offertorio accompagna la processione con cui si portano i
doni: esso si protrae almeno fino a quando questi sono stati disposti sull
'altare (IMGR, 74). I canti che si adattano a questo rito sono facilmente
individuabili per i contenuti di lode e ringraziamento a Dio creatore e
provvidente.
Nei riti di Comunione particolare attenzione va posta al canto dell'Agnus
Dei che accompagna la frazione del pane e l'immixtio. Questo canto
litanico sottolinea il grande valore del gesto che ha dato il primo nome
alla celebrazione eucaristica, la fractio panis. La mancata comprensione
di questo rito ha portato a sottolineare con altri canti a tema lo scambio
della pace. Il risultato è un pericoloso sbilanciamento fra i due riti e
un'indebita sottolineatura dello scambio della pace a scapito della
frazione del pane che viene accompagnata da una sommessa recita dell'Agnus
Dei che invece è l'unico canto da eseguire e che non è lecito sostituire
con altro canto (IGMR, 366), Esso si può ripetere quante volte la durata
della frazione del pane lo richiede (IGMR, 83).
Il Canto alla Comunione, ampiamente descritto in IGMR, 86-87, ha la
funzione di esprimere, attraverso l'unità delle voci, l'unione spirituale
dei communicanti, la gioia del cuore e mettere in luce l'indole
comunitaria della processione dei fedeli per ricevere l'Eucarestia; esso
perciò dovrà essere di tipo processionale, gioioso e comunitario; sono
quindi da evitare testi in prima persona singolare che anche in questo
caso favorirebbero l'intimismo e l'individualismo spirituale.
I Riti di conclusione non prevedono un canto finale che accompagni lo
scioglimento dell'assemblea. Tuttavia, dato che si dice che «ognuno
ritorna alle sue opere buone lodando e benedicendo il Signore» (IGMR, 90),
questo può essere espresso, ma ormai fuori dalla liturgia, con un canto.
Concludendo, ci sembra opportuno descrivere brevemente le forme musicali
liturgiche. Esse derivano direttamente dalla struttura dei testi che
vengono cantati e sono:
- la litania, caratterizzata da intenzioni enunciate da un solista, a cui
il popolo si associa con una breve invocazione e rappresentata nella Massa
da Kyrie, Preghiera dei fedeli, Agnus Dei;
- l'acclamazione: Amen, Alleluia, Deo gratias, Laus tibi Christe, Sanctus,
l'acclamazione dopo l'anàmnesi (per esempio Annunziamo la tua morte,
Signore, ecc.), Agnus Dei;
- la salmodia, ovverosia la proclamazione di salmi e canti biblici che,
come testi divinamente ispirati, hanno la precedenza su tutte le
composizioni liriche ecclesiastiche;
- l'innodia: la lode e il ringraziamento a Dio sono la base dell'
espressione liturgica e quando questa espressione assume la forma lirica,
abbiamo l'inno (esempi famosi sono il Gloria in excelsis Deo e e il Te
Deum, ma molti salmi e cantici dell'Antico e del Nuovo Testamento sono
autentici inni) che è la forma più popolare del canto sacro;
- la sequenza, che va cantata dopo l'Alleluia (IGMR, 64) è riconducibile,
come forma all'inno, ma talvolta presenta degli aspetti
drammatico-rappresentativi (il Victimæ e il Dies iræ, adesso non più usato
nella Messa, ne sono spendidi esempi).
Potrebbero piacerti anche
- Sicut cervus. Composizioni per organo e coro a 4 voci per la celebrazione eucaristicaDa EverandSicut cervus. Composizioni per organo e coro a 4 voci per la celebrazione eucaristicaNessuna valutazione finora
- I carismi del canto e della danza: Fondamenti biblici linee catechetiche testimonianze patristicheDa EverandI carismi del canto e della danza: Fondamenti biblici linee catechetiche testimonianze patristicheNessuna valutazione finora
- Documenti Animazione Liturgica MusicaleDocumento4 pagineDocumenti Animazione Liturgica MusicaleAnnamaria BaldanNessuna valutazione finora
- Canto e Musica Nel Rito Del MatrimonioDocumento28 pagineCanto e Musica Nel Rito Del Matrimonioyuppete100% (3)
- Il Coro Nella Liturgia 2Documento2 pagineIl Coro Nella Liturgia 2Lucia IgnoneNessuna valutazione finora
- REPERTORIO BattesimoDocumento4 pagineREPERTORIO BattesimoRice CiprianiNessuna valutazione finora
- Canto e Musica Alla Luce Di SC 112Documento5 pagineCanto e Musica Alla Luce Di SC 112simoneNessuna valutazione finora
- Cantare La Nostra SalvezzaDocumento68 pagineCantare La Nostra SalvezzayuppeteNessuna valutazione finora
- Cantate Al Signore Giubileo Delle CoraliDocumento12 pagineCantate Al Signore Giubileo Delle Coraligallogeorge64Nessuna valutazione finora
- Musica - Santa Per La LiturgiaDocumento6 pagineMusica - Santa Per La LiturgiaClaudia CappabiancaNessuna valutazione finora
- MISTAGOGIA DELLA MESSA Riti IntroitaliDocumento8 pagineMISTAGOGIA DELLA MESSA Riti IntroitaliGiuseppePagliaroNessuna valutazione finora
- J A PiquetDocumento11 pagineJ A PiquetNestor JrNessuna valutazione finora
- Rito Della MessaDocumento2 pagineRito Della MessaAnthony ZarconeNessuna valutazione finora
- QuadConc14 FrisinaDocumento29 pagineQuadConc14 FrisinaDavid JassoNessuna valutazione finora
- Cantare La Messa - OrientamentiDocumento9 pagineCantare La Messa - OrientamentiVincenzo NocerinoNessuna valutazione finora
- Tractus Deus Deus Meus, Monodia Liturgica CristianaDocumento2 pagineTractus Deus Deus Meus, Monodia Liturgica CristianaMarco GrecoNessuna valutazione finora
- Introduzione Alla Preghiera Con I SalmiDocumento2 pagineIntroduzione Alla Preghiera Con I SalmiEnrique GuzmánNessuna valutazione finora
- Discorso JPII Congresso MusicaDocumento3 pagineDiscorso JPII Congresso MusicaNicola NorìoNessuna valutazione finora
- Acclamazioni e LiturgiaDocumento3 pagineAcclamazioni e LiturgiaMassimiliano PiciocchiNessuna valutazione finora
- Toaz - Info Liturgica Polifonica Giussepe Libertopdf PRDocumento368 pagineToaz - Info Liturgica Polifonica Giussepe Libertopdf PRLuciane Oliveira MoraesNessuna valutazione finora
- Tutto (o quasi) sulla Messa: La Liturgia eucaristica e i Riti di conclusione - Vol. 2Da EverandTutto (o quasi) sulla Messa: La Liturgia eucaristica e i Riti di conclusione - Vol. 2Nessuna valutazione finora
- Lezione 5. La Musica Dal V Al XIV SecoloDocumento23 pagineLezione 5. La Musica Dal V Al XIV SecoloCristiano MillemaggiNessuna valutazione finora
- Armonizzazioni A Più Voci Nella Casa Del Padre Pagine DiviseDocumento279 pagineArmonizzazioni A Più Voci Nella Casa Del Padre Pagine Diviseorsacchiotto8988% (26)
- (Boselli) Il Tempo Luogo Della SalvezzaDocumento11 pagine(Boselli) Il Tempo Luogo Della SalvezzaDamián BurgardtNessuna valutazione finora
- Psallite! Musica e Liturgia - Messa-di-QuaresimaDocumento7 paginePsallite! Musica e Liturgia - Messa-di-QuaresimaVannaNessuna valutazione finora
- Estratto Amen MaranathaDocumento7 pagineEstratto Amen MaranathaGiuseppe PateraNessuna valutazione finora
- Messa Di QuaresimaDocumento7 pagineMessa Di QuaresimamarcobruniNessuna valutazione finora
- La Celebrazione Vigiliare Ambrosiana: Tradizioni, Significati, ModalitàDocumento8 pagineLa Celebrazione Vigiliare Ambrosiana: Tradizioni, Significati, ModalitàTomDokNessuna valutazione finora
- La Passione Secondo MatteoDocumento6 pagineLa Passione Secondo MatteoAlessandroNessuna valutazione finora
- Canzoniere Liturgico 2018Documento984 pagineCanzoniere Liturgico 2018Mariano MarianiNessuna valutazione finora
- Raimondo Mameli - Il Canto Gregoriano E La Liturgia Tradizionale - Musica SacraDocumento11 pagineRaimondo Mameli - Il Canto Gregoriano E La Liturgia Tradizionale - Musica SacraAngeloNessuna valutazione finora
- G MariniDocumento8 pagineG MariniVol VolićNessuna valutazione finora
- Musica Liturgica PDFDocumento10 pagineMusica Liturgica PDFJacobo Lama AbreuNessuna valutazione finora
- La Riforma Del BreviarioDocumento11 pagineLa Riforma Del Breviariogaston berteroNessuna valutazione finora
- I Vespri BattesimaliDocumento14 pagineI Vespri BattesimalianjadanzeorientaliNessuna valutazione finora
- Liturgia, Chiesa e Partecipazione AttivaDocumento12 pagineLiturgia, Chiesa e Partecipazione AttivaMicheleNessuna valutazione finora
- Ci chiedevano parole di canto: La crisi della musica liturgicaDa EverandCi chiedevano parole di canto: La crisi della musica liturgicaNessuna valutazione finora
- Ufficio Per La Liturgia - Diocesi Di Como - XXI Convegno Diocesano Dei Cori Liturgici PDFDocumento52 pagineUfficio Per La Liturgia - Diocesi Di Como - XXI Convegno Diocesano Dei Cori Liturgici PDFGiuseppePagliaroNessuna valutazione finora
- Il Canto Cristiano Liturgico Nel MedioevoDocumento15 pagineIl Canto Cristiano Liturgico Nel MedioevoDenise De LucaNessuna valutazione finora
- López-Tello 2014 - 1Documento9 pagineLópez-Tello 2014 - 1Fray JuanNessuna valutazione finora
- Liturgia e Storia Della SalvezzaDocumento4 pagineLiturgia e Storia Della SalvezzaPedro OrduñaNessuna valutazione finora
- 03 MidiliDocumento14 pagine03 MidiliGiuseppePagliaroNessuna valutazione finora
- Dossier Incontrarsi 32Documento13 pagineDossier Incontrarsi 32PieroAlberto AnconaNessuna valutazione finora
- La Musica Liturgica Oggi PDFDocumento165 pagineLa Musica Liturgica Oggi PDFprisconetrunner100% (1)
- Cerimoniale MinistrantiDocumento52 pagineCerimoniale Ministrantifranclaz100% (1)
- Religioni in MusicaDocumento19 pagineReligioni in MusicaGabriele1883Nessuna valutazione finora
- La MessaDocumento4 pagineLa MessaEmilio CampoNessuna valutazione finora
- Sussidio Quaresima 2024 FINALDocumento34 pagineSussidio Quaresima 2024 FINALGiovanni PariseNessuna valutazione finora
- Sussidio I Domenica Di Avvento 2018Documento13 pagineSussidio I Domenica Di Avvento 2018Massimiliano FrancatiNessuna valutazione finora
- Musica Sacra RinascimentoDocumento15 pagineMusica Sacra RinascimentoCarolina MarchettiNessuna valutazione finora
- Leaver Bach e La Fede LuteranaDocumento1 paginaLeaver Bach e La Fede LuteranaElisabetta LellaNessuna valutazione finora
- INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA - Sacra Rituum Congregatio - 3 Sept 1958Documento30 pagineINSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA - Sacra Rituum Congregatio - 3 Sept 1958Claudiu Clau100% (1)
- Liberto - Musica Santa Per La LiturgiaDocumento8 pagineLiberto - Musica Santa Per La LiturgiaVincenzo NocerinoNessuna valutazione finora
- Innario Cristiano 281Documento30 pagineInnario Cristiano 281lauradivinNessuna valutazione finora
- Sussidio Avvento Natale 2018Documento138 pagineSussidio Avvento Natale 2018FamigliaRussoNessuna valutazione finora
- Storia e Storiografia Della MusicaDocumento5 pagineStoria e Storiografia Della MusicaDamiano FineschiNessuna valutazione finora
- Leggere La Bibbia Nella LiturgiaDocumento4 pagineLeggere La Bibbia Nella LiturgiaTomDokNessuna valutazione finora
- MeldieeeDocumento10 pagineMeldieeeJuanNessuna valutazione finora
- PARTE4Documento33 paginePARTE4Pablo RizoNessuna valutazione finora
- Compieta GiovediDocumento4 pagineCompieta GiovediiiiinicosNessuna valutazione finora
- Kyrie EleisonDocumento3 pagineKyrie EleisonNapoleon SylvesterNessuna valutazione finora
- Introduzione Alla Missionologia Studenti - 2013-IDocumento75 pagineIntroduzione Alla Missionologia Studenti - 2013-ISérgio MiguelNessuna valutazione finora
- Libretto Liturgia Dei MinistrantiDocumento12 pagineLibretto Liturgia Dei MinistrantiAnonymous FGY7go100% (1)
- OCS04 Padri Della ChiesaDocumento44 pagineOCS04 Padri Della ChiesaJhoseline Montes100% (1)
- Allocutio Ordinem Vestrum 27 Octobris 1871Documento3 pagineAllocutio Ordinem Vestrum 27 Octobris 1871MARON EXEQUIEL VALLANessuna valutazione finora
- Esame Di CoscienzaDocumento4 pagineEsame Di Coscienzacorallina80Nessuna valutazione finora
- Opuscolo Via Crucis Con Meditazioni e Preghiere Di Paolo VI - WebDocumento52 pagineOpuscolo Via Crucis Con Meditazioni e Preghiere Di Paolo VI - WebTelmoRibeiro100% (1)
- 1992 04 Ronago 92Documento23 pagine1992 04 Ronago 92Giornalini_RonagoNessuna valutazione finora
- Orazione Mentale in TeresaDocumento67 pagineOrazione Mentale in TeresaLorenzo Giusti100% (1)
- Corpo Di CristoDocumento2 pagineCorpo Di CristoLuigi ForesioNessuna valutazione finora
- LibroDocumento96 pagineLibroVincenzo MirabileNessuna valutazione finora
- Egeria ItalianaDocumento23 pagineEgeria ItalianaȘtefan NuicăNessuna valutazione finora
- Orazione Di San Gregorio Papa Per La Liberazione Delle Anime Sante Dal PurgatorioDocumento1 paginaOrazione Di San Gregorio Papa Per La Liberazione Delle Anime Sante Dal Purgatoriomaria1grazia1mazzaNessuna valutazione finora
- 佛教禅 BUDDHISMO CHANDocumento104 pagine佛教禅 BUDDHISMO CHANRaffaele SchembriNessuna valutazione finora
- 21 TareDocumento8 pagine21 TareManuel Rio CasaliNessuna valutazione finora
- Ecclesiologia e MAriologiaDocumento17 pagineEcclesiologia e MAriologiaTomi RistovNessuna valutazione finora
- Biblioteca Associazione Buddismo aMeCoDocumento9 pagineBiblioteca Associazione Buddismo aMeConichelorNessuna valutazione finora
- Domenica Delle PalmeDocumento2 pagineDomenica Delle PalmeIlemilitelloNessuna valutazione finora
- 3 Fu Detto... Le Dia L'atto Di RipudioDocumento5 pagine3 Fu Detto... Le Dia L'atto Di RipudioDomenico LucianiNessuna valutazione finora
- Novena Di Natale Con TraduzioneDocumento16 pagineNovena Di Natale Con TraduzioneAnonymous QMHJJIyRMdNessuna valutazione finora