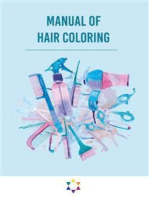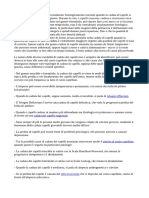Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lezione 03 - Dermatologia 15.03.2017 - Annessi Cutanei, Lesioni Elementari e Visita Dermatologica
Caricato da
dsagaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Lezione 03 - Dermatologia 15.03.2017 - Annessi Cutanei, Lesioni Elementari e Visita Dermatologica
Caricato da
dsagaCopyright:
Formati disponibili
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof.
Pistone
ANNESSI CUTANEI, LESIONI ELEMENTARI, VISITA DERMATOLOGICA
ANNESSI CUTANEI
Sommario
Follicoli Piliferi
Ghiandole sebacee
Ghiandole sudoripare apocrine
Ghiandole sudoripare eccrine
Unghia
Complesso Pilo-sebaceo
Il complesso pilo-sebaceo è
costituito dal follicolo pilifero
con il suo prodotto finale che è il
pelo. Annesse al follicolo pilifero
ci sono la ghiandola sebacea (il
cui sbocco è sempre all'interno
del follicolo pilifero) e la
ghiandola sudoripara apocrina,
che sbocca anch'essa all'interno
del follicolo pilifero.
Nel follicolo pilifero
distinguiamo due segmenti: un
segmento inferiore e un segmento superiore.
Il segmento inferiore è molto importante, perché rappresenta la parte dinamica del follicolo
pilifero. Il pelo nasce proprio per la presenza della papilla, dove arriva l'irrorazione. Infatti qualsiasi
follicolo pilifero è presente perché viene normalmente nutrito dal sangue.
Quindi, quando vi sono problemi di alopecia e mettiamo quelli che io chiamo “fertilizzanti esterni”,
non servono a granché se non sono nucleo-facenti, cioè se non rendono il cuoio capelluto molto
eritematoso, perché solo così facendo arriverebbe più sangue e di conseguenza il follicolo si
nutrirebbe molto più facilmente. Ecco perché noi dermatologi di solito preferiamo, nei casi di
alopecia, dare terapie sistemiche con le vitamine e gli aminoacidi tipici del follicolo pilifero, così
che questo possa nutrirsi e crescere più forte.
A cura di Ilaria Amato 1
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Struttura del pelo
Il prodotto del follicolo pilifero è il pelo ed è costituito da tre strati, che andando dall'interno verso
l'esterno sono:
1. Il midollo, che è la parte più interna del pelo ed è costituita da cellule arrotondate
disposte a colonna, separate, come può succedere anche nelle unghie, da degli spazi che
possono formarsi di aria;
2. La parte intermedia è, invece, rappresentata dalla corteccia, dove le cellule hanno una
forma non più arrotondata, ma fusata e sono disposte in file parallele tra di loro. Questa
parte è quella particolarmente ricca di pigmento melanico ed è, quindi, quella che
attribuisce colore al pelo;
3. Infine, la parte più esterna è la cuticola, che, invece, è costituita da un'unica fila di cellule
molto sottili disposte a scaglie. Questo significa che se voi guardate il pelo a fortissimo
ingrandimento, vedete che la superficie esterna non è perfettamente liscia, come
potremmo immaginarla, ma è come le squame del pesce.
Il bulbo è la parte più importante. È quella parte dove è presente la papilla, quindi è quello che dà
sviluppo a tutte le cellule del pelo stesso. In particolare, il bulbo circonda un vaso capillare da cui
trae nutrimento.
Tipi di Peli
I peli sono strutture in continua crescita e ne distinguiamo quattro diversi tipi:
i peli lanugo → Sono quella peluria del neonato presente nel cuoio capelluto, ma è molto
soffice, debole, non ha niente a che vedere con i nostri capelli, e sono peli che nell'arco di
breve tempo, intorno al massimo al sesto mese di vita, vengono completamente persi e
sostituiti dai capelli veri e propri. Quindi, i peli lanugo sono presenti soltanto per un breve
periodo della nostra vita;
i peli del vello → Sono quelli che tutti abbiamo e che sono presenti nelle zone non ormono-
dipendenti, cioè se ognuno di noi si guarda alcune parti, come braccia, gambe, seno,
capezzolo, può trovare la presenza di una sottile peluria di colore chiaro, presente in egual
misura sia nel sesso maschile che nel sesso femminile;
i peli terminali → Sono quei peli presenti nelle zone ormono-dipendenti. Si tratta di peli
lunghi, spessi e pigmentati, che compaiono con i caratteri sessuali secondari. Sono i peli
robusti delle ascelle, del pube e del petto;
i capelli veri e propri → Sono peli terminali del tutto specifici, presenti nel cuoio capelluto.
A seconda della morfologia, i peli si distinguono in lissotrichi, chimatotrichi e ulotrichi e tutto ciò è
sempre geneticamente determinato. I lissotrichi sono i capelli perfettamente lisci o lievemente
ondulati e sono tipici della razza caucasica. Poi abbiamo i chimatotrichi, che sono tipici delle razze
australi e sono molto più ondulati, fino ad arrivare agli ulotrichi, che sono quelli tipici della razza
negroide e sono completamente a spirale, ricci.
A cura di Ilaria Amato 2
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Ciclo di crescita del pelo
Il pelo, come l'unghia, è una struttura in continua crescita. In particolare, il pelo si rinnova
completamente e continuamente grazie a quello che viene chiamato ciclo del pelo.
Il ciclo del pelo (che è una domanda di esami) consta di tre fasi:
anagen → rappresenta la fase di crescita, di piena attività del follicolo pilifero;
catagen → è la fase di involuzione del follicolo pilifero;
telogen → è la fase di riposo ed è proprio in questa che noi perdiamo il pelo.
In particolare, gli squilibri ormonali tipici della gravidanza portano più facilmente i peli del
cuoio capelluto verso il telogen, tantochè nel post partum, tra le diverse complicanze che
può avere una donna che ha appena partorito, possiamo avere tanto la depressione post
partum quanto l'alopecia, dovuta al fatto che il pelo, quando è in telogen, ha finito il suo
ciclo di vita e quindi deve essere eliminato per poi rispuntare di nuovo.
Ricordatevi che tutti voi non avete perso i capelli perché non tutti i follicoli piliferi sono
nella stessa fase di crescita, perché se tutti in contemporanea fossero in anagen, in catagen
e poi in telogen, noi saremmo come le stagioni: per un periodo avremmo i capelli, per un
altro periodo ne avremmo la metà, per il periodo successivo zero, per poi rispuntare di
nuovo. Per fortuna, madre natura ha fatto in modo che i nostri follicoli piliferi fossero in
fasi diverse di sviluppo. Per cui, fisiologicamente, durante l'arco della giornata, perdiamo
un certo numero di capelli, che può andare anche fino a 70. Quando vi sono problemi di
alopecia, i capelli vengono perduti in maniera più cospicua e soprattutto non c'è più il
ritorno verso la fase di anagen, ma il follicolo pilifero muore definitivamente, si atrofizza e
non dà più il prodotto finale.
Chi soffre di defluvium, di alopecia, di solito per cercare di risolvere le proprie
problematiche cliniche, si costringe ad alcune sevizie, come il tricogramma.
Che cosa significa tricogramma? È un esame che consiste nel tirare 50-60 capelli, che
vengono strisciati e osservati al microscopio per quantizzare quanti sono in anagen, quanti
in catagen e quanti in telogen. Fisiologicamente una persona adulta, senza patologie al
cuoio capelluto, ha fino all'80% e oltre dei capelli in anagen, una piccola percentale in
catagen e una percentuale minore potrebbe essere anche in telogen. Il tricogramma è
importante perché se si dovesse scoprire che i follicoli piliferi, anziché essere all'80% in
anagen, sono in catagen, vuol dire che c'è un processo patologico di base.
Quindi, normalmente in anagen si trova l'80-90% dei follicoli. Logicamente la fase di anagen è
diversa a seconda dei diversi peli terminali ed ha una durata maggiore per i capelli, una durata
intermedia per gli altri: 1-6 mesi per le ciglia, 1-3 mesi per la barba così pure per il petto. La durata
varia in relazione alle diverse aree cutanee e la velocità di crescita varia nei diversi individui e nelle
A cura di Ilaria Amato 3
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
diverse sedi anatomiche. In questa fase il follicolo pilifero è più mitoticamente attivo in quanto
nell'anagen si ha l'attività mitotica delle cellule staminali e si ha anche la melanogenesi.
L'anagen è quindi la fase attiva, che porta anche alla pigmentazione del pelo.
Il catagen riguarda l'1-5% dei follicoli piliferi ed ha una durata di 7-21 giorni. Il bulbo si stacca dalla
papilla dermica e non è quindi più irrorato, tendendo così ad atrofizzarsi. Tutto questo avviene
perché si ha un declino delle proteine che si oppongono all'apoptosi, quindi alla morte cellulare
programmata, e invece si ha un aumento di quelle proteine che facilitano l'apoptosi. Nel catagen si
assiste anche all'arresto dell'attività dei melanociti. Quindi, non viene più formato pigmento e si ha
la scomparsa della guaina epiteliale interna.
Segue il telogen che è la fase di riposo. Riguarda il 10-15% di tutti i follicoli e in questa fase il bulbo
diventa atrofico, a clava e il pelo cade, viene eliminato.
Quindi, a queste varie fasi del capello segue la sua caduta fisiologica. Ogni giorno muoiono circa
70-80 capelli, ma il volume totale rimane invariato, non si nota. Se, invece, la caduta fosse
continua, senza rinnovamento, automaticamente nell'arco di 6 mesi saremmo tutti calvi.
Poi ovviamente il ciclo del pelo varia da periodi a periodi, da stagione a stagione. In particolare, in
autunno, nel così detto “periodo delle castagne”, si ha una maggiore caduta dei capelli. Non
c'entrano niente completamente le povere castagne, ma in autunno si può avere un rinnovamento
dopo gli insulti che i capelli hanno subito in estate. Quindi ci può essere una caduta maggiore, ma
si deve sempre valutare qualsiasi cosa. Devono essere sempre fatti gli esami ematochimici di
routine, va quantizzato l'emocromo, l'emoglobina, la sideremia. Va, inoltre, valutata la funzionalità
tiroidea, perché molto spesso la prima spia di una tiroide che non funziona in senso ipo o iper
potrebbe essere la caduta dei capelli.
Il ciclo del pelo dipende dall'età, dai periodi stagionali, dai fattori nutritivi (quindi condurre una
dieta perfetta è importantissimo) e dagli ormoni.
A cura di Ilaria Amato 4
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Dal punto di vista ormonale, di solito, nei fortunati il testosterone segue la linea delle aromatasi e
viene così trasformato in estradiolo, che dà incremento dell'attività dell'adenilciclasi e quindi
favorisce l'anagen. Normalmente i calvi perdono i capelli perché il testosterone abbraccia un'altra
via, cioè quella della 5 alfa reduttasi, che trasforma il testosterone in diidrotestosterone, il quale a
sua volta determina un decremento dell'attività dell'adenilciclasi che porta verso il telogen e
quindi verso la perdita del capello.
Una volta si credeva che i calvi avessero una quantità di testosterone in circolo notevole, ma oggi
in realtà si è visto che il testosterone è perfettamente uguale sia nei calvi che nei capelloni. L'unica
differenza è la via che il testosterone segue.
Hamilton, Norwood e Ludiwig hanno diviso in più fasi la caduta dei capelli.
A cura di Ilaria Amato 5
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Osservando la scala di Hamilton, si può vedere come per prima cosa inizia la stempiatura, poi si
forma la così detta “luna”, che alla fine si unisce con la stempiatura.
Le scale di Norwood e di Ludwig sono altre linee che vengono seguite per classificare l'entità del
danno e quindi la gravità dell'alopecia.
Canizie
I nostri capelli sono bellissimi da bambini, diventano ancora più belli con la montata ormonale e
poi, a poco a poco, come tutte le altre strutture del nostro organismo, vanno incontro ad una fase
di declino. Inizialmente perdono il colore e quindi si va verso quella che viene chiamata canizie,
che nei caucasici inizia a 30 anni, negli asiatici a 35 anni e nella razza degli africani verso i 40-45
anni.
Poi i capelli perdono anche il loro tono e il loro volume.
Oltre a questo processo fisiologico, ci possono essere delle forme di canizie precoce, che possono
essere espressione di malattie genetiche e possono essere anche associate a malattie autoimmuni,
turbe metaboliche, sindromi carenziali, malassorbimento e deficit nutrizionali. Quindi, quando in
una giovane donna o giovane uomo di 18-20-25 anni vedete i capelli bianchi, dovete sempre
andare a valutare tutte queste problematiche cliniche.
La canizie subita, invece, è presente nei soggetti che hanno alopecia areata e vitiligine.
In caso di alopecia areata, i pazienti perdono i capelli all'inizio in chiazze perfettamente
rotondeggianti (come una moneta), che poi tendono a fondersi dando forme poliedriche. Con le
terapie riusciamo a riattivare la crescita dei capelli, però, inizialmente questi crescono bianchi e poi
si pigmentano.
Un discorso simile vale per i pazienti con vitiligine. Se la vitiligine colpisce zone glabre, cioè senza
peli, allora avremo solo le chiazze cromiche della pelle, ma se la chiazza di vitiligine dovesse
localizzarsi a livello del cuoio capelluto o in qualsiasi sede ricca di peli, allora in quella stessa sede i
peli cresceranno completamente bianchi.
Domanda di un collega: di cosa si tratta quando si verificano i ciuffi bianchi nei giovani?
Risposta: Si tratta di Piebaldismo e rientra nelle malattie genetiche. Si ha un ciuffo di capelli bianchi
o un pezzo di sopracciglio bianco e ciò è sempre dovuto a piccoli problemi di pigmentazione, però,
circoscritti, non generalizzati.
Domanda: Anche nella donna?
Risposta: Sì, anche nella donna, stessa cosa. Uomo e donna in queste circostanze sono uguali. Può
essere semplicemente legato ad un ciuffo di capelli che cresce bianco fino in fondo.
Domanda: perché a volte i capelli cadono nella parte superiore e non nella parte inferiore della
testa?
Risposta: perché la parte superiore è più ormono sensibile. Le modificazioni ormonali inducono i
follicoli piliferi verso il telogen, causando la distruzione del pelo. La prima regione ad essere
sensibili è la parte superiore della testa, mentre questa fascia [il professore indica intorno alla
A cura di Ilaria Amato 6
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
testa] resta perché è meno sensibile agli ormoni circolanti, quindi è più resistente. Logicamente,
anche questa parte può essere deturpata nei casi più patologici.
Che cosa si fa adesso? Con le metodiche nuove, quindi con gli innesti, da dove si prendono i
capelli? Da qui [dietro la testa], per portarli qui [sopra la testa]. Molto spesso il risultato si
mantiene, poi, però, si ricomincia a perderli e si ripete la procedura, fino a quando si esauriscono
definitivamente e si diventa calvi.
Domanda: quindi non c'è soluzione?
Risposta: no, non c'è una soluzione definitiva. Il trapianto è l'ultima opzione, perché i follicoli
resistono di più. Inoltre, adesso esistono delle parrucche con calotte di gomma, che possono
essere utilizzate in maniera permanente, come se fossero dei capelli normali, però, causano
allergie del cuoio capelluto.
Nel follicolo pilifero la melanogenesi è discontinua ed è correlata alle diverse fasi del ciclo del pelo.
In particolare, in anagen, per lo stesso discorso della pelle, si possono formare due tipi di
melanina: eumelanina (responsabile del colore più scuro della nostra carnagione e dei capelli) e
feomelanina (responsabile del colorito più chiaro della nostra pelle e del colorito biondo o
rossiccio dei capelli). Le vie di sintesi sono perfettamente uguali: abbiamo sempre l'ormone
melanocito stimolante (MSH), che va a legarsi al recettore MC-1R e quindi si forma la melanina,
però, se interviene la proteina Agouti, che è inibitore competitivo dell'ormone melanocito-
stimolante, si formerà la feomelanina.
Ritornando alla canizie, la riduzione o perdita di pigmento coinvolge singole unità follicolari e può
avvenire in un unico ciclo o nel corso di più cicli di crescita del pelo.
Possibili meccanismi patogenetici della canizie
Perché si ha la canizie?
Per un'alterazione dell'interazione tra melanociti e cheratinociti. Voi sapete che ogni
melanocita è collegato con i cheratinociti e fornisce melanina. Se in qualsiasi momento, in
qualsiasi fase, viene ad essere alterato questo meccanismo per cui i melanociti non
riescono più a dare melanina ai cheratinociti, ecco che andiamo verso la canizie.
Difetti di migrazione dei melanociti dal loro microambiente al bulbo.
Il meccanismo più importante è sempre quello di un alterato rapporto tra le proteine pro-
apoptotiche e le proteine anti-apoptotiche (in questo caso la morte programmata dei
melanociti). Quando prevale la morte programmata, ecco che i melanociti sono distrutti,
non producono più pigmento e di conseguenza a poco a poco i capelli diventano bianchi.
Quali sono le funzioni dei peli?
Logicamente abbiamo i peli perché hanno funzione:
comunicativa;
protettiva: considerate che se una persona con tutti i capelli passa sotto un albero spoglio
in autunno, i capelli lo proteggono. Se, invece, una persona calva passa sotto lo stesso
albero, deve essere portata al pronto soccorso perché si sarà tranciata il cuoio capelluto;
A cura di Ilaria Amato 7
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
immunitaria;
sensoria, perché si percepisce qualsiasi cosa;
riparativa.
Le ghiandole sebacee
Le ghiandole sebacee sono ghiandole acinose a secrezione
olocrina. Che cosa significa secrezione olocrina? Vuol dire che le
cellule maturano dalla periferia verso la parte centrale, che è
costituita da cellule ricche di sebo. Queste si disfanno e versano
il loro secreto all'interno del dotto, che poi lo libererà all'interno
del follicolo pilifero1.
Sono delle ghiandole ormono-dipendenti. Pertanto,
determinate patologie quali l'acne e la dermatite seborroica non
si possono avere mai nell'impubere (cioè in una persona che
non produce ormoni), ma si hanno non appena comincia la fase
maturativa adolescenziale, perché inizia la produzione di ormoni che vanno a stimolare le
ghiandole sebacee, le quali a loro volta producono il sebo.
Il sebo viene liberato prima dentro il follicolo pilifero e poi all'esterno, a livello della fuoriuscita del
pelo stesso ed è importantissimo perché partecipa alla formazione del film idrolipidico. Se è
prodotto in eccesso, si avrà la pelle grassa, che appare lucida, untuosa, eritematosa, desquamante.
In particolare, dopo l'asportazione del sebo con detergenti, esso si ricostituisce in tempi brevi (3-6
ore) e per questo motivo non bisogna mai lavarsi spesso, cioè il seborroico non può lavarsi tutti i
giorni i capelli. Infatti, se lavate in continuazione i capelli, entro 3-6 ore le ghiandole sebacee
riproducono il sebo, perché devono ripristinare quella quantità che per il corpo è fisiologica.
Quindi, se ho la pelle grassa, non potrò mai diventare con la pelle normale: più mi lavo, più stimolo
le ghiandole sebacee che producono sebo a volontà e dopo mezz'ora siamo quasi nelle stesse
condizioni di prima.
Le ghiandole sebacee presentano tre tipi di cellule: le periferiche, le intermedie e le differenziate,
che sono quelle centrali e particolarmente ricche di sebo. Hanno una secrezione continua a partire
da quando comincia l'adrenarca e quindi la produzione di ormoni [androgeni genitali e surrenalici].
Esistono, inoltre, tre tipi di seborrea (cioè di ipersecrezione di sebo): fisiologica, patologica e
occasionale. In particolare, si può avere la seborrea nei soggetti con una diatesi neurologica un po'
alterata, ovvero nelle persone stressate ed emotive.
1 Le cellule germinative, quindi, subendo la trasformazione sebacea, diventano esse stesse il
prodotto secretivo della ghiandola.
A cura di Ilaria Amato 8
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Il sebo è costituito da acidi grassi insaturi, acidi grassi liberi saturi, trigliceridi, cere ed esteri del
colesterolo, steroli, squalene e paraffine.
La componente grassa della superficie cutanea è data principalmente dal prodotto delle ghiandole
sebacee, ma in minima parte anche dai prodotti di disfacimento delle cellule più superficiali
dell'epidermide, che contengono una certa quantità di sostanze grasse, di lipidi. Anche questi lipidi
di superficie hanno un'importante funzione protettiva e soprattutto facilitano la plasticità della
pelle, oltre al fatto che partecipano alla composizione del famoso film idrolipidico.
Film idrolipidico
Il film idrolipidico ha una componente acquosa e una lipidica. La componente lipidica si ottiene
dalla produzione delle ghiandole sebacee e dal disfacimento delle cellule più superficiali
dell'epidermide. La componente acquosa è, invece, data dalle ghiandole sudoripare eccrine.
Questo film idrolipidico è molto importante perché, anche se non si vede, umetta la nostra
superficie cutanea, che così viene mantenuta morbida, elastica. Che cosa succede quando si
lavano spesso le mani? Si rimuove il film idrolipidico e di conseguenza si va verso la xerosi, cioè la
secchezza cutanea: in particolare, le mani diventano secche, cominciano a screpolare e questo
rappresenta una porta verso forme patologiche. Infatti, le mani si spaccano e ciò rappresenta un
punto di ingresso per virus e batteri Quindi, le mani e la pelle vanno lavate tanto quanto basta e
soprattutto devono essere molto idratate.
Il film idrolipidico ha tutte queste funzioni:
preserva l'evaporazione;
protegge dagli insulti ambientali e dalla penetrazione di sostanze esogene;
svolge un controllo sulla proliferazione di batteri e miceti;
funge da schermo contro i raggi UV;
ha azione emolliente;
neutralizza i radicali liberi.
Ghiandole sudoripare apocrine
La ghiandola sudoripara apocrina, come la ghiandola sebacea, sbocca nel follicolo pilifero, mentre
la sudoripara eccrina non ha niente a che fare con il follicolo pilifero, in quanto essa sbocca
direttamente sull'epidermide attraverso l'acrosiringio.
Le ghiandole sudoripare apocrine sono delle ghiandole Illustrazione SEQ """Illustrazione""" \*
ARABIC 1:
tubulari semplici a secrezione apocrina, che producono un
secreto alcalino completamente diverso dal sebo perché si 1: ghiandola sudoripara eccrina;
fonde ad esso. Sono importanti perché si localizzano in 5: ghiandola sudoripara apocrina.
determinate sedi del nostro mantello cutaneo: cavo
ascellare; regione areolare; regione periombelicale;
genitali; solco intergluteo; perineo. Queste ghiandole sono,
A cura di Ilaria Amato 9
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
inoltre, responsabili dell'odore naturale caratteristico di ognuno di noi. In particolare, le ghiandole
apocrine servono tantissimo agli animali per circoscrivere il territorio.
L'odore corporeo dipende, quindi, dalla microflora batterica che esiste sul nostro mantello
cutaneo, dalla secrezione apocrina e dalla secrezione sebacea.
Ghiandole sudoripare eccrine
Le ghiandole sudoripare eccrine sono tubulari semplici e sboccano all'esterno attraverso
l'acrosiringio. Sono presenti alla nascita e funzionano già dalla nascita, quindi sono non ormono-
dipendenti. Sono particolarmente presenti nella regione frontale e nelle regioni palmo-plantari,
dove incominciamo a sudare perché in queste zone tali ghiandole sono particolarmente evidenti.
In particolare, il liquido che si suda è prodotto dalle ghiandole sudoripare eccrine, mentre le
apocrine sono responsabili dell'odore. Infatti, il sudore eccrino è completamente inodore.
La parte a gomitolo della ghiandola è la parte più profonda, dove viene prodotto il secreto che
man mano sale e sbocca nel tratto corneo attraverso l'acrosiringio.
Le ghiandole sudoripare eccrine sono costituite dalle cellule chiare, dalle cellule scure e dalla
cellula mioepiteliale.
La cellula mioepiteliale è importante perché contraendosi consente la risalita del sudore fino a
permetterne la liberazione. Le cellule scure e le cellule chiare hanno funzioni diverse: le cellule
scure producono soprattutto i mucopolisaccaridi e regolano la tensione superficiale del sudore,
mentre le cellule chiare sono quelle che producono la vera e propria componente acquosa, più
potassio e urea.
Logicamente, il sudore è ipotonico rispetto al plasma, perché se fosse isotonico perderemmo
tantissimo potassio e sodio e andremmo incontro a crisi ipovolemiche. Quindi, da queste cellule
chiare e scure il potassio e il sodio vengono riassorbiti e in minima quota abbandonati.
Termoregolazione
La perspiratio insensibilis e la sudorazione sono due meccanismi molto importanti per la
termoregolazione. Esiste un termometro a livello del nostro ipotalamo che va a misurare la
temperatura corporea. Nel momento in cui un vostro collega decide di fare una corsa, suda perché
aumenta la temperatura corporea. L'ipotalamo avverte ciò e inizia a scaricare attraverso il tronco
encefalico, che invia l'informazione al corno laterale del midollo spinale. Quest'ultimo informa i
gangli del simpatico, che sono in contatto con le ghiandole sudoripare. Si ha la liberazione del
mediatore chimico che è l'acetilcolina, che lega i recettori delle ghiandole sudoripare, stimolando
così la produzione di sudore.
A cura di Ilaria Amato 10
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
La sudorazione è, quindi, importantissima, perché se noi non sudassimo e passassimo da un
ambiente freddo ad uno caldissimo, andremmo subito in shock ipovolemico. Invece, sudando,
abbassiamo la temperatura in modo che non inizino tutti quei circuiti che portano all'ipotensione,
allo shock e al collasso cardiocircolatorio.
Unghia
Le strutture importanti dell'unghia sono tre:
la matrice ungueale → è quella parte che
sta sotto la cute, alla fine della falange;
la lamina ungueale → è la parte che
vediamo ed è poggiata sul letto ungueale;
il letto ungueale.
La matrice è importantissima perché, come lo era la
papilla per il follicolo pilifero, è la parte attiva che
produce l'unghia. Quindi, se creo un danno alla matrice, avrò una lesione permanente della lamina
ungueale.
La lamina ungueale è costituita da cheratine dure e cheratine molli: mentre l'epidermide è ricca di
cheratine molli, l'unghia è ricca più di cheratine dure che molli. In che cosa consiste la differenza?
È soltanto di natura biochimica: le cheratine dure, a differenza delle molli, hanno più ponti
disolfuro che assicurano stabilità alla proteina, cioè alla cheratina. Poi l'unghia ha una certa
quantità di acqua, importantissima, che deve essere in una percentuale giusta perché se ci fosse
un contenuto di acqua maggiore o minore, l'unghia perderebbe elasticità e si spezzerebbe
facilmente.
L'unghia, come i capelli, è una struttura in continua crescita: cresce all'incirca di 0,1 mm al giorno e
se non la tagliassimo mai, potrebbe anche raggiungere i 60 metri di lunghezza.
Ricordatevi che l'unghia è dura, resistente, elastica, flessibile e ha diverse funzioni:
Estetica → in passato avere delle unghia perfettamente pulite era indice di alta
professionalità;
Protettiva → protegge l'ultima falange da traumi e urti;
Sensibilità tattile;
Attività manuali → le unghie possono essere utilizzate come pinzette naturali;
Arma naturale;
Aiutano la corretta biomeccanica del piede. In particolare, l'onicomicosi, quando è nelle
fasi più importanti, porta ad un ispessimento e distruzione della lamina ungueale.
Considerate che i soggetti che ne sono predisposti sono gli stessi sportivi, che tengono i
piedi in scarpe di gomma, dentro calze di nylon sintetiche che li fanno sudare. Pertanto,
sviluppano le micosi e professionalmente spesso rendono meno perché il piede non poggia
bene, come, invece, avviene con lamini ungueali integre.
A cura di Ilaria Amato 11
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Logicamente, essendo dermatologo, vi dico che la pelle è l'organo più importante del mondo: ci
protegge da tutto ed ha funzione sensoriale (grazie alle terminazioni nervose, che sono in quantità
elevata soprattutto a livello di labbra, genitali, mani, piedi), endocrina e immunologica.
[Immagine a destra] Questo era un mio paziente, di cui
voglio parlarvi per dirvi quanto è importante la cute e
come molto spesso la vita non è compatibile se il
mantello cutaneo non è perfettamente integro.
Questo paziente non ha avuto altro che una reazione
avversa a farmaco di tipo grave, in seguito ad abusi di
FANS. Tutto incominciò con dolori alla colonna
vertebrale per un'ernia discale e questo paziente prese
Voltaren e Muscoril in elevate quantità. Incominciò
con una reazione lieve che fu sottovalutata: si
formarono delle specie di vescicole e fu fatta diagnosi
di varicella. Incominciò a prendere anche gli antivirali e
proseguì la terapia con gli antiinfiammatori,
continuando così a prendere i farmaci che davano
allergia. In particolare, aveva la Sindrome di Lyell: si
caratterizza per la superficie cutanea completamente
erosa, il che porta alla perdita di liquido e quindi allo shock ipovolemico. Appena vidi questo
paziente, che poi purtroppo è morto e che aveva sviluppato questo stato in brevissimo tempo (48
ore circa), ho subito allertato il centro ustioni, perché il paziente doveva andare nella camera
sterile: oltre allo shock ipovolemico, l'altro grossissimo rischio è dato dalle infezioni. Infatti, i
soggetti che hanno questa problematica muoiono di solito per setticemia. Quindi, avere un
mantello cutaneo integro è fondamentale.
Domanda di un collega: Ma ci sono casi in cui questa condizione regredisce?
Risposta: Sì. I soggetti vengono chiusi in ambienti completamente sterili e non vengono trattati con
i cortisonici a forti dosi, ma con le immunoglobuline umane e alcuni di loro ce la fanno, anche se
molti, purtroppo, no. Il tutto dipende dall'evoluzione, dal tempo, dalla quantità di farmaco assunto
e soprattutto dalla precocità della diagnosi: tanto più precoce è la diagnosi, tanto prima isoliamo il
paziente e più possibilità abbiamo di sopravvivenza. Ma quando lo portano in quello stato,
difficilmente si salva perché le infezioni, anche se non sono manifeste con la febbre alta, si
svilupperanno a breve e quindi bisogna infonderlo. Si danno antibiotici a dosi elevate come
copertura e immunoglobuline.
La pelle vi manda dei messaggi e ogni volta dovete porvi queste tre domande:
A cura di Ilaria Amato 12
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
1. Quando devo continuare a cercare?
2. Cosa devo cercare?
3. Cosa non deve sfuggire?
Quando devo continuare a cercare? A volte un paziente vi consulta perché ha un prurito
incoercibile, che non gli permette il riposo né giorno né notte e anche se lo spogliate e non trovate
niente, perché la pelle è perfettamente integra, non dovete fermarvi lì e prenderlo per pazzo, ma
dovete continuare a studiarlo, perché il prurito può essere la spia di qualcosa che non funziona da
un punto di vista internistico.
Le patologie più frequenti che causano prurito sono i disordini ematologici (come linfomi e
leucemie, il cui primo segno può essere il prurito incoercibile), così come una ridotta funzionalità
renale ed epatica.
Dove non vi dovete fermare? Quando vedete particolari lesioni. Per esempio, nel caso delle
malattie bollose, come il Pemfigo, esistono le forme paraneoplastiche. Quindi, quando vi sono
patologie di questo tipo, il paziente deve essere studiato nella sua interezza con l'ecografia
addome, rx torace, colonscopia, gastroscopia, per escludere la contemporanea presenza di un
carcinoma. Il Pemfigo è curato con gli steroidi e gli immunosoppressori, ma se c'è la situazione
paraneoplastica molto spesso il Pemfigo si risolve facendo l'intervento chirugico per rimuovere, ad
esempio, il carcinoma dello stomaco. Così risolviamo sia il problema iniziale [il carcinoma] sia il
secondario [il Pemfigo].
Che cosa non deve sfuggire? Logicamente tutti i messaggi che la pelle può darci.
Cute e Psiche
La psiche e la cute sono strettamente correlate tra loro: spesso si arrossisce per la vergogna o si
sbianca e si ha la pelle d'oca per la paura. La cute, inoltre, è sede di molte patologie
psicosomatiche, quindi molto spesso il paziente, che ha già una patologia cutanea, tende a
peggiorare a causa del problema psicosomatico.
Ad esempio, il ragazzo con l'acne, che si mette davanti allo specchio e si vede brutto, si stressa e
piange. Tutto questo crea un disequilibrio, un fattore stressante che induce le ghiandole sebacee a
produrre ancor più sebo.
Oppure, nel caso della psoriasi, uno dei fattori scatenanti, su terreno genetico predisponente, può
essere lo stress. Allo psoriasico si consiglia l'elioterapia, perché il sole gli fa bene. Spesso, però,
questo paziente non va al mare a prendersi il sole, perché le persone si allontanano da lui
credendolo contagioso. Tutto questo significa creare stress al paziente e quindi peggiorare la
malattia.
Secondo gli studi più recenti, non si sa se lo stress psicosomatico è dovuto veramente alla
patologia, perché il TNF alfa è sì molto importante nella patogenesi della psoriasi, ma si è scoperto
che è altresì coinvolto nella depressione. Per cui, mentre prima si pensava che le due cose fossero
correlate in maniera secondaria (cioè si sviluppa prima la psoriasi e di conseguenza mi deprimo,
A cura di Ilaria Amato 13
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
piango, mangio, fumo e divento obeso), adesso, invece, si sta vedendo che la stessa citochina che
riesce a scatenare la psoriasi, agisce scatenando anche la depressione. Inoltre, si ritiene che l'adipe
nella pancia abbia funzione endocrina e produca anch'esso TNF alfa.
Quindi il mondo sta veramente cambiando dal punto di vista patogenetico.
LE LESIONI ELEMENTARI
Sommario
Macule Ulcera
Papule Piaga
Pomfi Ragadi
Vescicole e bolle Cicatrici
Noduli Squame
Croste Pustole
Erosione, Escoriazione, Esulcarazione Sclerosi
Le lesioni elementari sono lesioni fondamentali in dermatologia, perché ci permettono di fare
diagnosi. Possono essere distinte in monomorfe o polimorfe. Monomorfe significa che sono tutte
dello stesso tipo, quindi o tutte papule o tutte macule o tutte vescicole o tutte bolle. Si parla,
invece, di lesioni polimorfe quando nello stesso soggetto sono presenti diverse lesioni elementari,
per esempio l'eritema, la vescicola e la crosta. Questo polimorfismo può essere primitivo quando
determinate patologie cutanee si caratterizzano per la contemporanea comparsa di diverse lesioni
elementari, oppure può essere evolutivo/secondario, nel caso in cui prima compare l'eritema, poi
le vescicole che si rompono, si formano quindi le erosioni e infine le croste.
Le lesioni elementari si distinguono in:
primitive → rappresentate da macule, papule, vescicole, bolle, pomfi, noduli;
secondarie → sono le croste, le erosioni, le escoriazioni, le esulcerazioni, le ulcere, le ragadi
e le cicatrici. Esse non rappresentano altro che una successiva fase evolutiva delle lesioni
primitive;
Primitivo-secondarie → è il caso delle squame, della sclerosi e della pustola. Quest'ultima
può essere primitiva (tipica dell'acne), ma se noi abbiamo uno spacco ragadiforme e ci va il
batterio, si può formare in maniera secondaria.
Lesioni elementari primitive
Macule
Le macule sono le lesioni più semplici e si caratterizzano per un diverso colore della cute della
lesione. Quindi, se la mia cute è bianca e io vedo una chiazza rossa, quella è una macula. Per
A cura di Ilaria Amato 14
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
riconoscere una macula, si devono chiudere gli occhi e toccare una pelle perfettamente liscia, in
quanto la macula non è palpabile. Si differenzia dalla pelle circostante soltanto per il colorito, che
può essere o rosso o violaceo a seconda se c'è un coinvolgimento del circolo arterioso o venoso.
Se c'è una dilatazione dei capillari arteriosi, avremo un eritema rosso vivo; se, invece, si ha una
dilatazione del circolo venoso, avremo le macule violacee, rosso-violacee.
Si parla di macule pigmentarie quando c'è un'alterazione del pigmento in senso ipo o in senso iper,
cioè quando la pelle della macula è più chiara o più scura rispetto al colorito normale della pelle.
Poi abbiamo le pseudomacule pigmentarie che sono quelle in cui il pigmento viene introdotto
dall'esterno. Qual è l'esempio più tipico di pseudomacula pigmentaria? Il tatuaggio.
Esempi:
Arti inferiori → il colorito è violaceo e queste
sono le classiche gambe ocra dei soggetti che
hanno turbe venose.
Le petecchie sono anch'esse turbe
impalpabili del colorito cutaneo.
La voglia (o disio) è una lesione pigmentaria dovuta a piccole alterazioni della vita
embrionaria. Se tali alterazioni sono di natura vascolare, abbiamo gli angiomi (e quindi il
“desiderio di fragole” dei nostri bisnonni). Se, invece, sono di natura melanocitaria, ecco
che abbiamo le macule iperpigmentate (“desideri di carne di maiale”).
A cura di Ilaria Amato 15
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Ovviamente non è vero che esiste l'associazione tra queste alterazioni e il
desiderare un qualche alimento, in quanto si tratta di disturbi emartomatosi, che
avvengono durante la fase di crescita.
Lesione pigmentata del padiglione auricolare: è
un melanoma. La pigmentazione è diversa da
punto a punto.
Inoltre, si possono avere chiazze ipercromiche, cioè con più pigmento e quindi di colore più
scuro (colorito marrone) rispetto al mantello cutaneo o chiazze ipocromiche, quindi più
chiare, come nel caso della vitiligine.
Papule
Le papule sono lesioni cutanee piccole, cioè al di sotto di 5mm di diametro, e sono rilevate. Quindi,
a differenza della macule, se voi chiudete gli occhi, sentite che c'è qualcosa sotto le mani che non
va. Inoltre, la superficie delle papule può essere liscia o verrucosa ed esse guariscono senza esiti.
La papula è dovuta a:
un'iperplasia dell'epidermide. All'esame vi posso chiedere un esempio: una tipica papula
epidermica è la semplice verruca volgare;
un infiltrato nel derma;
entrambi gli eventi;
oppure accumulo di sostanze particolari.
Se le papule finiscono con l'unirsi tra di loro, dando lesioni di maggiori dimensioni, si forma quella
che noi in dermatologia chiamiamo placca. Quindi, la placca non è altro che un insieme di papule
unite.
Ecco qui l'esempio di una papula. 5 mm di diametro, rilevata, superficie leggermente
cheratosica, palpabilissima.
A cura di Ilaria Amato Se voi passate il dito, la sentite, non è come la macula. 16
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Questa, invece, è una placca.
Pomfi
I pomfi sono delle lesioni evanescenti, cioè passano in breve tempo per poi ricomparire in altre
sedi cutanee. Sono rilevati, di forma rosata e possono essere dovuti a:
un edema del derma papillare → allora parleremo di pomfi veri e propri e quindi di
orticaria;
un edema del derma reticolare → in questo caso parleremo di angioedema. Se
l'angioedema avviene sulla cute, ha un significato, ma se si ha un angioedema della
A cura di Ilaria Amato 17
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
glottide, entriamo subito in urgenza dermatologica, otorinolaringoiatrica e chirurgica
perché dobbiamo areare le vie respiratorie.
Immagine a destra → Questo è un soggetto affetto
da orticaria, le cui lesioni scompaiono in pochissimo
tempo. Ritengo meno grave l'orticaria rispetto
all'angioedema.
In caso di orticaria, si può fare il dermografismo
(disegno del triangolo). Quando il dermografismo è
attivo, se anche non ci sono manifestazioni
cutanee, la paziente è in fase subacuta. Quindi
potrebbe ancora farlo.
Questo (immagine a destra) è l'angioedema. Può
colpire le palpebre, le labbra, il mantello cutaneo
ed è molto importante per le complicanze. Di
solito, chi fa l'angioedema soffre anche di coliche
addominali perché coinvolge l'apparato
gastroenterico.
Vescicole e Bolle
Le vescicole e le bolle sono lesioni rilevate rispetto al mantello cutaneo e contengono liquido al
loro interno, a differenza della papula che è una lesione consistente non contenente liquido.
Invece, la differenza tra la vescicola e la bolla sta nelle dimensioni: si dice vescicola quando è
minore di 5 mm; si parla di bolla quando supera i 5 mm di diametro.
Le bolle e le vescicole possono essere:
intraepidermiche → nell'eczema le vescicole si formano per spongiosi, nel pemfigo
avvengono per acantolisi e nell'Herpes per degenerazione, con danno uniforme dei
cheratinociti;
dermo-epidermiche → possono avvenire per danno della giunzione dermo-epidermica
(pemfigoidi);
sottoepidermiche → possono avvenire per danni localizzati più profondamente. Ci sono
soggetti affetti da una malattia che si chiama epidermolisi bollosa: formano soltanto bolle
perché sono geneticamente predisposti. La diagnosi di questa malattia viene fatta quando
il bambino inizia a gattonare, perché è nei punti di trauma che compaiono le bolle, quindi
ginocchia, piedini e poi su tutto il mantello cutaneo.
A cura di Ilaria Amato 18
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Esempi:
vescicole con contenuto liquido.
Nel Pemfigo si hanno bolle con diametro
maggiore di 5 mm, dal contenuto
liquido. Queste bolle poi si rompono ed
originano le erosioni. Si parla, quindi, di polimorfismo evolutivo: le lesioni iniziali sono le
bolle, alcune si rompono e diventano erosioni, altre tendono a cicatrizzare e si formano le
croste.
Bolla vista da vicino.
Epidermolisi bollosa → questi soggetti,
geneticamente predisposti, formano
lesioni bollose in seguito a traumi.
Noduli
Il nodulo non è altro che una lesione solida, rilevata, di dimensioni maggiori di 5 mm, più grande di
una papula. Il nodulo può essere:
epidermico → se si ha l'ispessimento soltanto dell'epidermide come succede nel
cheratoacantoma;
dermo-epidermico → se il processo proliferativo guadagna la sede della membrana
giunzionale;
A cura di Ilaria Amato 19
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
dermico;
sottocutaneo → esempio sono le cisti (sebacee, adipose, sono tutte noduli sottocutanei).
Lesioni elementari secondarie
Croste
Le croste sono lesioni secondarie composte da liquido organico e detriti cellulari. Servono per la
guarigione e rappresentano un polimorfismo evolutivo.
Erosione, Escoriazione, Esulcerazione
L'erosione è una perdita di sostanza circoscritta, che interessa soltanto l'epidermide e guarisce
senza esiti cicatriziali. Come mi accorgo che c'è un'erosione? Se mi graffio il dito sul muro ruvido e
non esce sangue (voi sapete che l'epidermide non è irrorata), vuol dire che mi sono creato
un'erosione, ma se esce una goccia di sangue vuol dire che sono andato più profondamente
rispetto all'epidermide, ovvero sono arrivato al derma papillare, rompendo un piccolo capillare.
Quindi, non è più erosione, ma si tratta di escoriazione, dove il danno ha raggiunto il derma
superficiale. L'escoriazione è una soluzione di continuo di origine traumatica, mentre
A cura di Ilaria Amato 20
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
l'esulcerazione è sinonimo dell'escoriazione, ma è dovuta ad un processo patologico, non è
traumatica.
Erosione → epidermide
Escoriazione → coinvolgimento del derma
Esulcerazione → dovuta a processi patologici.
Ulcera
L'ulcera è una perdita di sostanza che interessa l'epidermide, il derma e talvolta l'ipoderma, con
scarsa tendenza alla cicatrizzazione. L'origine dell'ulcera può essere:
venosa;
arteriosa;
neurotrofica;
ipertensiva;
infettiva.
Nel caso del diabete mellito l'ulcera può essere dovuta ad alterazioni del circolo venoso o
arterioso, ma, come sapete, il diabete dà anche neuropatia periferica, cioè si ha perdita di
sensibilità per esempio al piede. Per cui, il diabetico è soggetto a traumi e forma più facilmente
queste ulcere rispetto ai non diabetici, che, invece, hanno una maggiore sensibilità.
Esempi:
[Immagine a sinistra] ulcera neurotrofica nel primo dito
del piede in un soggetto diabetico.
L'ulcera si può avere anche in un soggetto affetto da deficit di prolidasi, che è un enzima
che serve tantissimo ai processi di cicatrizzazione. Chi ne è deficitario, clinicamente
manifesterà delle ulcere diffuse, soprattutto agli arti inferiori, con scarsa tendenza alla
cicatrizzazione.
Piaga
La piaga clinicamente è simile all'ulcera, ma rispetto a quest'ultima ha una tendenza alla
cicatrizzazione. Infatti, le piaghe da decubito guariscono facilmente se evitiamo il decubito vero e
A cura di Ilaria Amato 21
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
proprio. Esistono dei materassi speciali antidecubito, come i materassi ad acqua, che non
permettono il contatto fermo della pelle con il materasso, favorendo così la guarigione per
ripristino della circolazione (le piaghe sono, infatti, dovute soprattutto a compressione). Molto
spesso la sede più importante, oltre a quella lombare, è data dal tallone, in quanto questi pazienti
non muovono più gli arti: il tallone pigia così sul materasso e, se non è quello giusto, si crea
l'ischemia e poi l'ulcera. Basta mettere tre cuscini al di sotto della gamba per non fare poggiare il
tallone.
Ragadi
Le ragadi sono soluzioni di continuo, dovute a perdita di
elasticità della pelle.
Si formano nelle mani xerotiche, cioè nelle mani
secche, che vengono lavate continuamente e pertanto si
creano questi spacchi ragadiformi.
Cicatrici
Le cicatrici sono il risultato della riparazione di una perdita di tessuto superficiale o profondo. Di
solito sono atrofiche, ma le più importanti da ricordare sono le ipertrofiche, che vanno distinte dai
così detti cheloidi.
Cicatrice atrofica Cicatrice ipertrofica
A cura di Ilaria Amato 22
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Lesioni elementari primitivo-secondarie
Squame
Le squame sono accumuli di lamelle cornee sulla superficie cutanea. Si presentano in caso di
psoriasi. Infatti, il gomito e il piede del soggetto psoriasico sono caratterizzati da eritema e
squame.
Pustole
Le pustole sono raccolte di essudato purulento circoscritto. Possono essere:
primitive → come nel caso di un soggetto affetto da acne;
secondarie → come accade in un soggetto con l'Herpes simplex con segni di
impetiginizzazione, cioè sull'erosione di una vescicola rotta si crea un'infezione da parte di
un batterio.
A cura di Ilaria Amato 23
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Pustole in soggetto affetto da acne
Sclerosi
La sclerosi è un indurimento circoscritto del derma oppure può essere diffuso su tutto il mantello
cutaneo, con torace a corazza, tant'è vero che i soggetti non possono neanche respirare perché la
pelle finisce per costringerli.
[Immagine precedente] Guardate cosa accade in caso di Xeroderma pigmentoso, malattia
geneticamente determinata dovuta ad un difetto di riparazione del DNA.
A cura di Ilaria Amato 24
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Questi soggetti non riparano più il DNA ed esposti al sole sviluppano tumori cutanei. Possono
andare incontro ad atrofia e perdere anche il bulbo oculare. Hanno una vita brevissima, tantoché
non arrivano mai a 30 anni. Sono quei soggetti che devono uscire di notte.
VISITA DERMATOLOGICA
Per mettere insieme le lesioni, la visita dermatologica è importantissima.
La prima cosa da guardare sono le lesioni elementari, perché orientano verso determinati capitoli.
Bisogna osservare come sono distribuite e poi si raccoglie l'anamnesi.
A cura di Ilaria Amato 25
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
Ricordatevi che il paziente cerca sempre di dire solo le cose che vuole e mai di farvi vedere le cose
veramente interessanti.
Per cui, ad esempio, se vi fa vedere soltanto una piccola porzione di pelle perché gli brucia solo lì,
voi vedete delle vescicole disposte a grappolo e si tratta di un polimorfismo evolutivo perché ci
sono delle erosioni e croste. A cosa pensate? All'Herpes simplex, ma se guardate tutto l'arto e
anche il pube vedete che la lesione si estende più in là di quello che vi fa vedere il paziente e non
siamo davanti ad un Herpes Simplex, ma all'Herpes zoster che colpisce tutto il metamero.
Lo stesso succede con queste papule in caso di nevo epidermico e il bambino ha sulla pelle tutti
questi ghirigori. Questi soggetti nei casi più avanzati prendono il nome di “fenomeni da
baraccone”, come si può vedere nel film The Elephant Man.
A cura di Ilaria Amato 26
Dermatologia Lezione 3, 15/03/17 Prof. Pistone
A cura di Ilaria Amato 27
Potrebbero piacerti anche
- Ginnastica Facciale. La Guida CompletaDocumento24 pagineGinnastica Facciale. La Guida Completagundam0073Nessuna valutazione finora
- (Med - Ita - Istologia Sintesi - EmbriologiaDocumento31 pagine(Med - Ita - Istologia Sintesi - EmbriologiammNessuna valutazione finora
- Domande Biologia Dello SviluppoDocumento8 pagineDomande Biologia Dello SviluppoMarina Tigris100% (1)
- Caduta Dei CapelliDocumento15 pagineCaduta Dei CapelliSergio BertaniNessuna valutazione finora
- Capelli Ed OrmoniDocumento32 pagineCapelli Ed Ormoninerimarco38Nessuna valutazione finora
- Esercitazioni Istologia Vetrini, Nicola (Appunti)Documento26 pagineEsercitazioni Istologia Vetrini, Nicola (Appunti)Steisi LukuNessuna valutazione finora
- Manuale Capelli SaniDocumento30 pagineManuale Capelli SaniLaura100% (1)
- TricologiaDocumento51 pagineTricologiaisaac antifaNessuna valutazione finora
- CapelliDocumento13 pagineCapelliStefanoDiCaprioNessuna valutazione finora
- Il PeloDocumento24 pagineIl PelostefpecNessuna valutazione finora
- I CapelliDocumento3 pagineI CapelliGiulia CaterinaNessuna valutazione finora
- I CapelliDocumento3 pagineI CapelliGiulia CaterinaNessuna valutazione finora
- TerapiaDocumento92 pagineTerapiaslyramboNessuna valutazione finora
- Tricologia ForenseDocumento32 pagineTricologia Forenseestefany moralesNessuna valutazione finora
- Caduta Capelli FileDocumento6 pagineCaduta Capelli Filematteo nardiNessuna valutazione finora
- Tipi Di CapelliDocumento29 pagineTipi Di CapellibellezzasaluteNessuna valutazione finora
- Preparate Pentru Ingrijirea Parului Si ScalpuluiDocumento76 paginePreparate Pentru Ingrijirea Parului Si Scalpuluiprisacaru viorelNessuna valutazione finora
- 7 LezioneDocumento3 pagine7 Lezionechiara villanovaNessuna valutazione finora
- Alopecia Esami Clinici e Di Laboratorio Nel Paziente Con Caduta Dei CapelliDocumento6 pagineAlopecia Esami Clinici e Di Laboratorio Nel Paziente Con Caduta Dei CapelliGilfe BNessuna valutazione finora
- Dermatologia Sbobinature 2014 2015Documento64 pagineDermatologia Sbobinature 2014 2015Silvia PNessuna valutazione finora
- MarlianiDocumento255 pagineMarlianiAlessandro CuccinielloNessuna valutazione finora
- Patologia Clinica Lezione 2Documento26 paginePatologia Clinica Lezione 2FedericaNessuna valutazione finora
- Collagene e CapelliDocumento2 pagineCollagene e Capellindauria16Nessuna valutazione finora
- Mammiferi Parte 1Documento16 pagineMammiferi Parte 1Manuela BolognaNessuna valutazione finora
- 10 Euartropodi Ii CrostaceiDocumento39 pagine10 Euartropodi Ii CrostaceiEugenio StracuzzaNessuna valutazione finora
- Manuale Tricologia 1 ModDocumento17 pagineManuale Tricologia 1 ModDario MingardiNessuna valutazione finora
- Anatomia Delle Specie Minori - ConiglioDocumento7 pagineAnatomia Delle Specie Minori - ConiglioSabrina CillariNessuna valutazione finora
- 10 Anatomia Pt.5Documento81 pagine10 Anatomia Pt.5Eugenio MolestiNessuna valutazione finora
- Ematologia 2020-21Documento220 pagineEmatologia 2020-21FrancoNessuna valutazione finora
- Entomologia GeneraleDocumento24 pagineEntomologia GeneraleDiego Assis0% (1)
- Alopecia Androgenetica Maschile e Femminile - Dott. Paolo Gigli Medico TricologoDocumento34 pagineAlopecia Androgenetica Maschile e Femminile - Dott. Paolo Gigli Medico TricologoThomasNessuna valutazione finora
- Introduzione All' IstologiaDocumento6 pagineIntroduzione All' IstologiaLuana LeonardiNessuna valutazione finora
- Calvizie (Tradotto): Le sue cause, il suo trattamento e la sua prevenzioneDa EverandCalvizie (Tradotto): Le sue cause, il suo trattamento e la sua prevenzioneNessuna valutazione finora
- SpermatogenesiDocumento5 pagineSpermatogenesiFederica D'AgostinoNessuna valutazione finora
- Riassunto Dei Sistema EndocrinoDocumento5 pagineRiassunto Dei Sistema EndocrinoRoberta BaratteroNessuna valutazione finora
- Domande UniteDocumento152 pagineDomande Unitechiara.martinelloNessuna valutazione finora
- Alopecia UniversaleDocumento2 pagineAlopecia UniversaleGilfe BNessuna valutazione finora
- Dermatologia, Venerologia, Chirurgia PlasticaDocumento124 pagineDermatologia, Venerologia, Chirurgia PlasticaMorena Saudino CeisNessuna valutazione finora
- Capelli Ed OrmoniDocumento32 pagineCapelli Ed OrmoniFrancesca DifNessuna valutazione finora
- La LaringeDocumento44 pagineLa LaringeVittoria Di BisceglieNessuna valutazione finora
- Sentido Del OlfatoDocumento13 pagineSentido Del OlfatoGustavo OrdoñezNessuna valutazione finora
- Anatomia Patologica I Emo PoieticoDocumento17 pagineAnatomia Patologica I Emo PoieticoGianmarco DuranteNessuna valutazione finora
- Patologia Della CuteDocumento116 paginePatologia Della CuteAstrid MaleNessuna valutazione finora
- Sistema EndocrinoDocumento36 pagineSistema EndocrinogiorgiocaresanaNessuna valutazione finora
- Testiculo CIDocumento33 pagineTesticulo CIElizabethNessuna valutazione finora
- Wa0063.Documento70 pagineWa0063.merdadiculoNessuna valutazione finora
- I CheloniDocumento4 pagineI CheloniEdoardo MigliavaccaNessuna valutazione finora
- IstologiaDocumento3 pagineIstologiaTitti TeleseNessuna valutazione finora
- Lezione 01 - DermatologiaDocumento12 pagineLezione 01 - DermatologiadsagaNessuna valutazione finora
- Lezione 7 Patologia (27 Ottobre)Documento4 pagineLezione 7 Patologia (27 Ottobre)ste MassariNessuna valutazione finora
- EMATOLOGIADocumento130 pagineEMATOLOGIAFrancoNessuna valutazione finora
- Zoo AperteeeeDocumento4 pagineZoo Aperteeeefocaxo5386Nessuna valutazione finora
- Mcapocci,+08 RepiciDocumento28 pagineMcapocci,+08 Repicichen.simone.2021Nessuna valutazione finora
- PhylumDocumento14 paginePhylumWendy Marilyn Ysamar AlvaroNessuna valutazione finora
- Apparato TegumentarioDocumento4 pagineApparato TegumentarioSalvo Danilo LombardoNessuna valutazione finora
- Tricologia 1Documento28 pagineTricologia 1Vanessa Carneiro LeiteNessuna valutazione finora