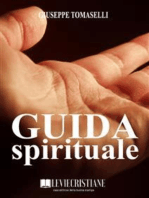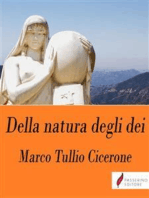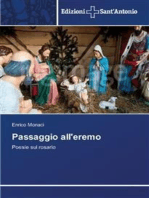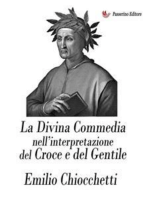Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Divina Commedia - Pungatorio Canto III Parafrasi Da Verso 79 A 93 Da Verso 106 A 145 + Analisi
Divina Commedia - Pungatorio Canto III Parafrasi Da Verso 79 A 93 Da Verso 106 A 145 + Analisi
Caricato da
Rosario GrifasiTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Divina Commedia - Pungatorio Canto III Parafrasi Da Verso 79 A 93 Da Verso 106 A 145 + Analisi
Divina Commedia - Pungatorio Canto III Parafrasi Da Verso 79 A 93 Da Verso 106 A 145 + Analisi
Caricato da
Rosario GrifasiCopyright:
Formati disponibili
Divina commedia – purgatorio
Canto III
Parafrasi da verso 79 a verso 93
Come le pecorelle escono dall'ovile, a una, a due, a tre, e le altre stanno indietro timorose e tengono il muso e
l'occhio in basso; e ciò che fa la prima fanno anche le altre, addossandosi a lei se essa si ferma, semplici e
mansuete, e non sanno il motivo; così io vidi muoversi verso di noi la testa di quella schiera di anime
fortunate, pudiche nell'aspetto e dignitose nei movimenti. Appena quelli videro che io proiettavo un'ombra
alla mia destra, da me alla parete rocciosa, si fermarono e si tirarono un po' indietro, e tutti gli altri spiriti che
venivano dietro, pur senza sapere il motivo, fecero lo stesso.
Parafrasi da verso 106 a verso 145
Io mi voltai verso di lui e lo guardai attentamente: era biondo, bello e di nobile aspetto, ma uno dei
sopraccigli era diviso da un colpo. Quando gli ebbi detto umilmente di non averlo mai visto, lui ribatté: «Ora
guarda»; e mi mostrò una piaga in alto sul petto. Poi sorridendo disse: «Io sono Manfredi, nipote
dell'imperatrice Costanza; allora io ti prego, quando tornerai sulla Terra, di andare dalla mia bella figlia
(Costanza), madre dei due eredi della corona di Sicilia e Aragona, e di dirle la verità su di me, se si racconta
altro sulla mia sorte ultraterrena. Dopo che io ricevetti (a Benevento) due ferite mortali, io mi rivolsi pentito
e in lacrime a Colui che perdona volentieri. I miei peccati furono orrendi, ma la bontà divina ha delle braccia
così ampie che accoglie tutti coloro che si rivolgono a lei. Se il vescovo di Cosenza, che allora fu incitato
contro di me da papa Clemente IV, avesse letto questo volto del perdono di Dio, le ossa del mio corpo
sarebbero ancora sepolte sotto il mucchio di sassi presso la testa del ponte, a Benevento. Ora invece le bagna
la pioggia e le disperde il vento fuori dal regno di Napoli, quasi lungo il fiume Liri, dove egli le fece traslare
a lume spento. Per la maledizione della Chiesa l'eterno amore divino non si perde al punto che non possa
tornare, finché c'è un po' di speranza. È pur vero che chi muore in contumacia della Santa Chiesa, anche se si
pente in punto di morte, deve stare nell'Antipurgatorio trenta volte il tempo che ha trascorso nella sua
ribellione, se questo decreto non viene abbreviato grazie a delle buone preghiere. Vedi ormai se puoi farmi
felice, rivelando alla mia buona Costanza come mi hai visto (tra le anime salve) e anche questo divieto; qui,
infatti, si traggono grandi benefici grazie alle preghiere dei vivi».
Analisi del testo
Il Canto si divide strutturalmente in tre parti, che corrispondono al rimprovero di Virgilio a Dante (1-45),
all'incontro con le anime dei contumaci (46-102) e al colloquio col protagonista dell'episodio, Manfredi di
Svevia (103-145). Il canto III ruota interamente intorno al complesso e delicato problema della grazia e della
giustizia divina imperscrutabile. La giustizia divina è stata clemente con il gruppo di anime che i due poeti
incontrano successivamente, dopo essersi fermati di fronte alla parete scoscesa e inaccessibile del monte che
sembra invalicabile a “chi va sanz'ala”: sono le anime dei contumaci, di coloro che sono morti dopo essere
stati scomunicati dalla Chiesa e devono trascorrere un tempo lunghissimo nell'Antipurgatorio prima di poter
accedere alle Cornici (fra loro Dante incontrerà Manfredi). L'episodio è come un intermezzo narrativo posto
tra la parte iniziale, molto sostenuta stilisticamente, e il successivo colloquio col re di Sicilia, caratterizzato
dall'estrema lentezza con cui si muovono le anime e dalla similitudine delle pecorelle che escono dal recinto
una dietro l'altra, senza sapere dove vanno e perché. È stato osservato che questo paragone non è casuale, sia
perché la pecora è animale simbolo di mansuetudine ed è spesso citato nei Vangeli come immagine del buon
fedele cristiano, sia soprattutto perché l'attitudine di queste anime (il fatto di muoversi senza opporre
resistenza, senza sapere dove vanno) è la traduzione visiva del discorso fatto prima da Virgilio, del dovere
del cristiano di accontentarsi del quia lasciandosi guidare dai ministri della Chiesa verso la salvezza, senza
avere la pretesa intellettuale di veder tutto. Il paragone acquista ancor più significato se si pensa che queste
sono appunto le anime degli scomunicati, che per motivi giusti o sbagliati si sono ribellati all'autorità della
Chiesa e non hanno certo dimostrato mansuetudine quand'erano in vita.
Tra loro c'è anche Manfredi e il suo personaggio consente a Dante di fare un importante discorso intorno alla
salvezza e alla giustizia divina, che opera una sintesi tra la prima e la seconda parte del Canto. Da un lato,
infatti, il re svevo è il cattivo cristiano che si è mostrato riottoso all'autorità ecclesiastica e che per motivi
politici si è attirato la punizione della Chiesa , ma al tempo stesso è salvo in Purgatorio e rappresenta dunque
un esempio clamoroso e inatteso di come la grazia divina possa beneficare anche un personaggio che con la
sua fama è stato posto fuori dalla comunità del fedeli. Manfredi rappresenta un vero e proprio «scandalo»,
ben più di Catone in quanto il sovrano era un protagonista della storia recente dell'Italia di Dante: morto
violentemente a Benevento, scomunicato dalla Chiesa come ribelle all'autorità papale, colpito dalla durissima
pubblicistica guelfa che lo dipingeva come una specie di Anticristo, tutto lasciava presupporre che fosse
dannato all'Inferno, mentre il suo sincero pentimento in punto di morte gli ha guadagnato la salvezza e lo
colloca tra le anime del Purgatorio. Dante vuole affermare che la giustizia divina si muove secondo criteri
che non sono sempre evidenti al mondo e che il destino ultraterreno degli uomini dipende non solo dalle loro
azioni terrene, ma soprattutto dalla sincerità del loro pentimento che solo Dio può leggere nel profondo del
cuore. La polemica di Dante è quindi rivolta contro le istituzioni ecclesiastiche corrotte, che si arrogano il
diritto di stabilire in modo irrevocabile il destino ultraterreno dei loro nemici, mentre solo Dio può sapere
con certezza se uno, dopo la morte, sia salvo o dannato: le parole di Manfredi sono rivolte soprattutto alla
figlia Costanza, che sapendo della sua salvezza può pregare per lui e accorciare il periodo di attesa
nell'Antipurgatorio. Lo «scandalo» di Manfredi riafferma dunque il discorso di Virgilio in apertura di Canto,
ovvero il fatto che l'uomo non può sapere tutto e che c'è un limite alla ragione umana, per cui la giustizia
divina non è sempre spiegabile razionalmente o alla luce soltanto delle azioni pubbliche di un personaggio:
occorre l'umiltà, anche da parte di papi e vescovi, di rimettersi al giudizio divino, come ha fatto Manfredi che
non ha parole astiose nei confronti di chi ha disseppellito i suoi resti e li ha dispersi come si usava fare con
gli scomunicati.
Potrebbero piacerti anche
- Conoscere La Massoneria PDFDocumento49 pagineConoscere La Massoneria PDFagenzia massonica internazionale0% (1)
- Michelet - Consigli Di Satana Ai GesuitiDocumento136 pagineMichelet - Consigli Di Satana Ai Gesuitileonardo7804Nessuna valutazione finora
- Purgatorio Canto 6Documento5 paginePurgatorio Canto 6verina1992Nessuna valutazione finora
- L'abominio della desolazione nelle profezie dei santiDa EverandL'abominio della desolazione nelle profezie dei santiNessuna valutazione finora
- C'è una crepa in ogni cosa: ed è così che entra la luceDa EverandC'è una crepa in ogni cosa: ed è così che entra la luceNessuna valutazione finora
- Via Col Vento in VaticanoDocumento142 pagineVia Col Vento in VaticanoAnna PoliNessuna valutazione finora
- Aspectos Neumatológicos de La Celebración de La ConfirmaciónDocumento431 pagineAspectos Neumatológicos de La Celebración de La ConfirmaciónDiego Acevedo100% (1)
- Breviario Brezio Volume 1Documento570 pagineBreviario Brezio Volume 1Giacinto B. TorchiaNessuna valutazione finora
- Reghini, Il Santo ImperoDocumento6 pagineReghini, Il Santo Imperoser pentNessuna valutazione finora
- Canto III, Purgatorio PDFDocumento6 pagineCanto III, Purgatorio PDFMarzia GazzoNessuna valutazione finora
- Purgatorio Canto 7Documento6 paginePurgatorio Canto 7Vanessa TrustNessuna valutazione finora
- Divina Commedia - 3 CantoDocumento6 pagineDivina Commedia - 3 CantoElena CiciullaNessuna valutazione finora
- DivinaDocumento6 pagineDivinaistorikos1975Nessuna valutazione finora
- Divina CommediaDocumento134 pagineDivina Commediafrankcastle72Nessuna valutazione finora
- Canto V InfernoDocumento3 pagineCanto V Inferno12andrexNessuna valutazione finora
- ManfrediDocumento12 pagineManfrediMarianna Mariagrazia IlardiNessuna valutazione finora
- Riassunto, Analisi, Parafrasi E Sintesi Dei Seguenti Canti Della Divina CommediaDocumento51 pagineRiassunto, Analisi, Parafrasi E Sintesi Dei Seguenti Canti Della Divina CommediaMartina Del BenNessuna valutazione finora
- Testo InfernoDocumento6 pagineTesto InfernoDinah Ray HansenNessuna valutazione finora
- Parafrasi 5 CantoDocumento3 pagineParafrasi 5 CantoDaniele MagliuloNessuna valutazione finora
- Canto XV Paradiso LDocumento5 pagineCanto XV Paradiso LSerena PrestinariNessuna valutazione finora
- Riassunti Inferno Divina CommediDocumento18 pagineRiassunti Inferno Divina CommediPietro BologniniNessuna valutazione finora
- Divina Commedia - 5 CantoDocumento6 pagineDivina Commedia - 5 CantoElena CiciullaNessuna valutazione finora
- Inferno - Canto QuintoDocumento35 pagineInferno - Canto QuintoAntimo Di DonatoNessuna valutazione finora
- Canto III - PurgatorioDocumento2 pagineCanto III - PurgatoriogiulyaldegheriNessuna valutazione finora
- Divina Commedia: Primo CantoDocumento6 pagineDivina Commedia: Primo CantoSusanna PalumboNessuna valutazione finora
- PurgatorioDocumento3 paginePurgatorioDaniele RampinelliNessuna valutazione finora
- Visione Dell'Al Di Là Di Beda Il VenerabileDocumento5 pagineVisione Dell'Al Di Là Di Beda Il VenerabileStefanoBalestraNessuna valutazione finora
- Valtorta Don GuidoDocumento26 pagineValtorta Don GuidoSandro Del-VittoNessuna valutazione finora
- Divina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure RetoricheDocumento2 pagineDivina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure RetoricheRosario GrifasiNessuna valutazione finora
- Francesco Uomo NuovoDocumento32 pagineFrancesco Uomo NuovoJiack4theLordNessuna valutazione finora
- Vangelo Di MariaDocumento5 pagineVangelo Di MariaarchiatiNessuna valutazione finora
- PurgatorioDocumento20 paginePurgatorioAlexofCatarinaNessuna valutazione finora
- Lorenzo Valla - La Falsa Donazione Di Cost Anti No (ITA)Documento65 pagineLorenzo Valla - La Falsa Donazione Di Cost Anti No (ITA)ginukiNessuna valutazione finora
- DANTEDocumento6 pagineDANTEYllka KosumiNessuna valutazione finora
- Divina CommediaDocumento10 pagineDivina CommediaAnnaNessuna valutazione finora
- 1 Autodifesa GalileiDocumento3 pagine1 Autodifesa GalileiClaudio Di GirolamoNessuna valutazione finora
- DANTE - y ZoroastroDocumento5 pagineDANTE - y ZoroastroJorge Echavarría CarvajalNessuna valutazione finora
- Divina Commedia - Inferno - Canto IVDocumento9 pagineDivina Commedia - Inferno - Canto IVGiulia De SarloNessuna valutazione finora
- Sesti Canti PoliticiDocumento6 pagineSesti Canti PoliticiItz MimiNessuna valutazione finora
- Annalena Libretto 2011Documento84 pagineAnnalena Libretto 2011Carlos E Reynoso TostadoNessuna valutazione finora
- Manfredi, Figlio Di Federico IIDocumento2 pagineManfredi, Figlio Di Federico IImobydick76Nessuna valutazione finora
- Mister AndrewsDocumento3 pagineMister AndrewsPinco PallinoNessuna valutazione finora
- La battaglia di Benevento: Storia del secolo XIIIDa EverandLa battaglia di Benevento: Storia del secolo XIIIValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- La Divina Commedia nell'interpretazione del Croce e del GentileDa EverandLa Divina Commedia nell'interpretazione del Croce e del GentileNessuna valutazione finora
- II Prova Argomento Letterario Linguistico 2023 2024Documento4 pagineII Prova Argomento Letterario Linguistico 2023 2024orianalaveniaNessuna valutazione finora
- L'Uomo Tra Bene e Male Giacomo MadauDocumento33 pagineL'Uomo Tra Bene e Male Giacomo MadauImmacolata MariniNessuna valutazione finora
- Messere Arlotto Mainardi, Pievano di S. Cresci a MaciuoliDa EverandMessere Arlotto Mainardi, Pievano di S. Cresci a MaciuoliNessuna valutazione finora
- XI Canto Del Purgatorio: Luogo: Prima Cornice Peccatori: SuperbiDocumento8 pagineXI Canto Del Purgatorio: Luogo: Prima Cornice Peccatori: SuperbiSara RigonatNessuna valutazione finora
- Divina Commedia Purgatorio Canto 1 Attività Dalle Fotocopie 23 10 2020Documento4 pagineDivina Commedia Purgatorio Canto 1 Attività Dalle Fotocopie 23 10 2020Rosario Grifasi100% (1)
- DanteDocumento12 pagineDante902088Nessuna valutazione finora
- 1925 Reghini Il Santo ImperoDocumento6 pagine1925 Reghini Il Santo ImperoAndrea Francesco CalabreseNessuna valutazione finora
- Canto 22esimo PurgatorioDocumento13 pagineCanto 22esimo PurgatorioSara SenaNessuna valutazione finora
- Heede Le ApparizioniDocumento4 pagineHeede Le Apparizionigiordana214Nessuna valutazione finora
- 012 SecretumDocumento23 pagine012 SecretumLudwigNessuna valutazione finora
- DanteDocumento5 pagineDantePerla VeriNessuna valutazione finora
- Chimica - Lezione Del 06-12-2022Documento3 pagineChimica - Lezione Del 06-12-2022Rosario GrifasiNessuna valutazione finora
- Chimica - Lezione Del 14-11-2022Documento2 pagineChimica - Lezione Del 14-11-2022Rosario GrifasiNessuna valutazione finora
- Divina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure RetoricheDocumento2 pagineDivina Commedia - Canto II Da Verso 61 A 133 Parafrasi-Analisi e Figure RetoricheRosario GrifasiNessuna valutazione finora
- Divina Commedia Purgatorio Canto 1 Attività Dalle Fotocopie 23 10 2020Documento4 pagineDivina Commedia Purgatorio Canto 1 Attività Dalle Fotocopie 23 10 2020Rosario Grifasi100% (1)
- Canti ReligiosiDocumento134 pagineCanti Religiosilelle62Nessuna valutazione finora
- Comunità Pastorale Di Uggiate e Ronago Agenda Della SettimanaDocumento8 pagineComunità Pastorale Di Uggiate e Ronago Agenda Della SettimanaLeCampaneNessuna valutazione finora
- Moroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 8.Documento326 pagineMoroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 8.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNessuna valutazione finora
- Saecofago Di AdelfiaDocumento3 pagineSaecofago Di AdelfiagiuseppeNessuna valutazione finora
- 1 Giovanni CommentarioDocumento104 pagine1 Giovanni CommentarioDomenico Bevilacqua100% (1)
- Corpus DominiDocumento1 paginaCorpus DominipedorotoNessuna valutazione finora
- BHLP IDocumento289 pagineBHLP IEbreo1975Nessuna valutazione finora
- Braschi Tony - Il Libro Nero Del VaticanoDocumento224 pagineBraschi Tony - Il Libro Nero Del VaticanoEva DianaNessuna valutazione finora
- Iconografia Mariana (01!12!09)Documento10 pagineIconografia Mariana (01!12!09)lezione27Nessuna valutazione finora