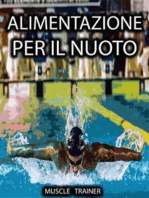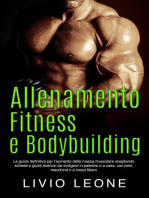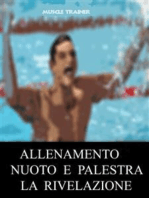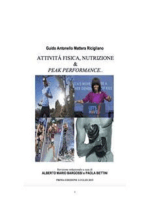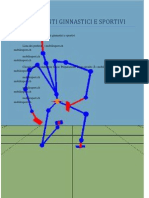Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Preparazione Fisica Degli Sport Di Lotta
Caricato da
Gerlando Russo Introito0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
487 visualizzazioni178 pagineDocumento della federazione datato ma ancora molto utile.
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoDocumento della federazione datato ma ancora molto utile.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
487 visualizzazioni178 paginePreparazione Fisica Degli Sport Di Lotta
Caricato da
Gerlando Russo IntroitoDocumento della federazione datato ma ancora molto utile.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 178
RLPJ
FEDERAZIONE ITALIANA LOTTA PESI JUDO
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO
PER LO SVILUPPO
DELLE QUALIT FISICHE
DEL LOTTATORE
Roma, 1985
RLPJ COTII
FEDERAZIONE ITALIANA LOTTA PESI JUDO
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO
PER LO SVILUPPO
DELLE QUALIT FISICHE
DEL LOTTATORE
A cura di:
Bruno ANDREANI
Carlo BULDRASSI
Carlo MARINI
Vittoriano ROMANACCI
Progetto grafico di:
Stelvio BERALDO
C E N T R O S T U D I F I L P J
Lo sviluppo delle qualit fisiche
LE QUALIT' FISICHE
Le qualit fisiche sono quei fattori che condizionano sempre
una prestazione atletica. In un principiante, il livello delle qua-
lit fisiche, sar quello necessario per affrontare gli stress della
vita quotidiana. Ma evidente che esse possono essere poten-
ziate notevolmente, mediante un allenamento razionale che se-
gua i principi dell'adattamento progressivo. Le qualit fisiche
possono essere sviluppate singolarmente con un allenamento spe-
cializzato; nelle pagine successive infatti indicheremo quali sono
le metodiche per lo sviluppo di ciascuna qualit, senza scendere
per nei particolari delle metodiche stesse ponendo per ipotesi
che il lettore conosca o comunque si documenti sul loro svolgi-
mento pratico.
Le qualit fisiche sono:
la resistenza;
la forza;
la velocit;
la destrezza;
la mobilit.
La sopra indicata suddivisione delle qualit fisiche gene-
rale in quanto ogni singola qualit sopra elencata pu essere di-
visa in sotto-gruppi, come vedremo successivamente.
LA RESISTENZA
Per capire nella maniera pi esatta il concetto di resistenza
bisogna considerarne i suoi quattro aspetti distinti che, anche
se nel gergo comune sportivo vengono tutti chiamati col nome
unico di resistenza, devono essere analizzati separatamente; un
7
atleta infatti pu possedere un tipo di resistenza e difettare in
un altro come se si trattasse di due qualit diverse.
I quattro tipi di resistenza sono:
Resistenza organica aerobica;
Resistenza organica anaerobica;
Resistenza muscolare aerobica;
Resistenza muscolare anaerobica.
E' evidente che la suddivisione fatta dei vari tipi di resisten-
za una suddivisione che ha uno scopo prettamente didattico
per chiarire tutti gli aspetti che detta qualit presenta. In pra-
tica non vi uno stacco netto fra un tipo di metodica ed un
altro, ma vi una interdipendenza. La specialit sportiva della
Lotta, pur avendo la durata corrispondente alle competizioni di
media e lunga distanza, ha una preparazione diversa per la con-
tinua alternanza delle intensit e delle forme di movimento che
un combattimento presenta. Oltre a ci nelle situazioni di gara
si manifestano numerose interruzioni di ritmo che conferiscono
al carico un carattere di tipo intervallato.
L'allenamento di resistenza deve pertanto tenere conto di
queste specifiche condizioni. La durata ed il modo di manife-
starsi della intensit, durante un combattimento, pongono ele-
vate richieste sia alla resistenza aerobica come a quella anaero-
bica. Pertanto, dopo il potenziamento della capacit aerobica,
che costituisce la base della resistenza specifica di gara, si do-
vr provvedere allo sviluppo delle capacit anaerobiche utiliz-
zando i metodi di allenamento intervallati e adattati al nostro
sport nella loro forma pi ampia. Quindi saranno sempre va-
riati, sia la durata degli stimoli, sia l'intensit, sia i tempi di ri-
pristino, costringendo l'organismo a reagire e ad assuefarsi a
quelle condizioni di ritmo e di sforzo aciclico non sempre pre-
vedibili che caratterizzano gli incontri di lotta.
E' importante inoltre che, nonostante le difficolt oggettive
che si manifestano nella nostra specialit sportiva, si cerchi
con ogni mezzo di misurare l'insieme e l'intensit dei carichi o
perlomeno di valutarli (il mezzo pi efficace a disposizione la
frequenza del polso). Infatti, senza una determinazione del ca-
rico, non possibile uno sviluppo sistematico e programmato
della resistenza.
8
RESISTENZA ORGANICA AEROBICA
Si pu definire come la qualit che consente di proseguire
il pi a lungo possibile uno sforzo muscolare generalizzato in
condizioni aerobiche. Per condizioni aerobiche si deve intendere
quelle in cui si trova un atleta che compie uno sforzo richiedente
una quantit di ossigeno inferiore od uguale a quella massima
che egli in grado di assumere ed utilizzare.
Il muscolo un motore che produce energia meccanica a
spese dell'energia chimica prodotta dalla trasformazione di so-
stanze che si trovano nel muscolo o che vi giungono per mezzo
della circolazione sanguigna. Mentre l'energia, che pu essere
sfruttata da un motore, pu essere di varia natura (elettrica, chi-
mica, idraulica, atomica, ecc.), l'unica fonte di energia che pu
essere sfruttata direttamente ai fini della produzione del lavoro
nella contrazione muscolare l'ATP (adenosintrifostato) che, tra-
sformandosi in una molecola pi semplice ADP, libera energia
chimica che viene successivamente trasformata in energia mec-
canica dai muscoli. Ogni altra sorgente di energia non pu essere
sfruttata direttamente.
Poich l'ATP contenuto in piccole quantit nei muscoli,
dopo poche contrazioni il muscolo si esaurirebbe e non sarebbe
possibile un'attivit continuata se l'ATP stesso non fosse rifor-
mato a spese di altri processi. Il pi diretto di questi la scis-
sione di un'altra molecola, la fosfocreatina, che scindendosi pro-
duce la quantit di energia necessaria per la resintesi dell'ATP.
Anche la fosfocreatina si trova nei muscoli in quantit li-
mitata e pertanto anch'essa non permetterebbe un lavoro prolun-
gato nel tempo se non fosse riformata a spese dell'energia libe-
ratasi dalla combustione delle sostanze provenienti dagli alimenti
(glicidi-lipidi). Riassunmendo in forma semplificativa, quindi di-
remo che il muscolo pu utilizzare solo una determinata sostanza
e che questa sostanza si pu formare solo a spese dell'energia
proveniente dalla combustione degli alimenti, combustione che
avviene solo in presenza di ossigeno. Da qui la necessit dell'as-
sunzione di quantit di ossigeno proporzionali all'intensit dello
sforzo ed alla quantit di muscoli interessati (respirazione). Il
livello della resistenza organica aerobica, quindi, dipende soprat-
tutto dalla capacit di un individuo di assumere e trasmettere
ossigeno sempre pi rapidamente e di eseguirne il trasporto nella
pi grande quantit nell'unit di tempo, fino alle masse musco-
lari interessate allo sforzo e di assicurare infine efficaci scambi
al livello cellulare.
9
Facciamo un esempio esplicativo:
quando un atleta passa dalle condizioni di riposo ad una
condizione di allenamento o di gara, aumenta la necessit del-
l'ATP; parallelamente per le ragioni sopraddette aumenta la ri-
chiesta di energia proveniente dalla combustione degli alimenti.
A queste maggiori richieste l'organismo provvede aumentando la
assunzione ed il trasporto della quantit di ossigeno mediante
rispettivamente atti respiratori pi ampi e frequenti e con la
frequenza cardiaca pi elevata. L'atleta potr aumentare il suo
sforzo fino a quando la richiesta di ossigeno sar uguale a quel-
la massima che l'atleta stesso potr assumere e trasportare a
livello muscolare. Fino a quando l'intensit dello sforzo rimarr
entro questi limiti, egli potr indefinitivamente continaure a
sopportarlo (condizione di steady-state ), se invece l'intensit
dello sforzo aumenter ancora, egli dovr contrarre un debito
di ossigeno che gli limiter la durata dello sforzo stesso, e delle
cui modalit tratteremo successivamente.
Gli organi responsabili della capacit di assumere, traspor-
tare ed utilizzare ossigeno in ultima analisi sono:
il cuore e la sua capacit funzionale;
l'efficacia degli scambi gassosi.
Pertanto l'allenamento per la resistenza organica aerobica
dovr seguire due metodologie distinte: una per assicurare lo
sviluppo del volume del cuore e della sua capacit funzionale;
l'altra per favorire il miglioramento della qualit degli scambi
gassosi.
Consideriamone una alla volta, separatamente:
METODOLOGIA DI ALLENAMENTO
PER MIGLIORARE LA FUNZIONALIT' CARDIOCIRCOLATORIA
L'allenamento ad- intervallo corto, lo stimolo pi potente
per assicurare lo sviluppo del cuore e della sua capacit funzio-
nale. L'allenamento ad intervallo, di cui l'interval-training il
pi noto, caratterizzato da:
durata dello sforzo;
intensit dello sforzo;
tempo di recupero;
numero delle prove.
10
Durata dello sforzo
La durata dello sforzo dovr essere di circa da 30" a 2 mi-
nuti (consiglio 1' per i lottatori).
L'allenatore, tenendo presente questo fattore, potr scegliere
il tipo di sforzo da far fare ai suoi allievi, ad esempio:
corsa di lunghezza non superiore a m. 400, esercizi con
i pesi, esercizi con il manichino, esercizi con il partner, lotta,
imitazioni, esercizi a carico naturale, nuoto, ecc.
Intensit dello sforzo
L'intensit dello sforzo non dovr superare l'80% dello
sforzo massimo che l'atleta in grado di effettuare, in pratica
cio l'atleta non dovr superare, durante lo sforzo, la frequenza
cardiaca di 170-180 battiti al minuto.
Tempo di recupero
I tempi di recupero non devono portare ad una completa
ristabilizzazione.
II nuovo carico deve intervenire quando si ottenuto al-
l'incirca una frequenza del polso da 120 a 130 al minuto e quin-
di nello stadio della ristabilizzazione incompleta.
Numero delle prove
Esso dipender dal grado di allenamento e, comunque, sar
piuttosto elevato trattandosi di prove ad intervallo corto di in-
tensit relativamente moderata; orientativamente dalle 5 alle 10
prove.
METODOLOGIA DI ALLENAMENTO
PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DEGLI SCAMBI GASSOSI
Il lavoro continuo l'allenamento per migliorare l'efficacia
degli scambi gassosi. Per lavoro continuo si deve intendere un
tipo di lavoro che per i lottatori non superi i 45 minuti e la cui
11
intensit sia tale che la frequenza cardiaca, di coloro che stan-
no eseguendo tale lavoro, non superi i 130-150 battiti al minuto
in base allo stato di allenamento.
Anche in questo caso l'allenatore potr sbizzarrirsi nel tro-
vare il tipo di esercizio da fare effettuare ai propri allievi, senza
dimenticare che uno dei migliori resta la corsa. Facciamo esem-
pio di lavoro continuo: corsa lunga e lenta in modo che la fre-
quenza cardiaca di chi la esegue non superi i 140 battiti al
minuto.
Inizialmente la durata di questa corsa sar di 10-15 minuti,
poi con una progressione lenta ma continua si arriver, dopo un
mese circa, a 30-50 minuti di corsa senza interruzioni. Dopo
aver raggiunto questo incremento di tempo di corsa non pi
necessario accrescerlo in quanto pi efficace aumentare il ritmo
della corsa stessa.
Se un atleta, per esempio, riesce a percorrere in 30 minuti
5 Km., egli non dovr aumentare la durata dell'allenamento ma
tenter di compiere pi chilometri nello stesso tempo fino a
quando sar in grado di non variare la frequenza cardiaca.
Invece nella corsa, anche se essa sempre consigliabile, un
allenatore potr far eseguire ai propri allievi esercizi pi speci-
fici per i lottatori:
lavoro con il manichino; anche qui i punti fermi saran-
no la frequenza cardiaca ed il prolungarsi nel tempo dell'eser-
cizio (140 battiti al minuto - 30 minuti), arrivati alla durata
voluta dell'esercizio, si cercher di aumentare il ritmo di lavoro
fino a quando, naturalmente, la frequenza cardiaca rimarr nei
limiti stabiliti. In questo caso aumentare il ritmo di lavoro si-
gnifica aumentare il numero dei colpi tirati al manichino nel
tempo considerato.
Ferme e restando, quindi, le caratteristiche basilari dell'al-
lenamento al lavoro continuo, l'allenatore potr far eseguire:
lotta a ritmo moderato, giuochi, esercizi a carico naturale senza
pause di recupero, esercizi con il partner, ecc.
La resistenza organica aerobica alla base della prepara-
zione di tutte le specialit in quanto, non solo permette di pro-
lungare i tempi di allenamento, ma favorisce anche il recupero
negli sforzi particolarmente intensi la cui esecuzione ci ha co-
stretti ad andare in debito di ossigeno.
12
RESISTENZA ORGANICA ANAEROBICA
Si definisce come la qualit che permette di proseguire il
pi a lungo possibile uno sforzo muscolare generalizzato in con-
dizioni anaerobiche .
Per condizioni anaerobiche si deve intendere quelle in cui
si trova un atleta che compie uno sforzo richiedente una quan-
tit di ossigeno superiore a quella massima che l'atleta stesso
pu assumere, trasportare ed utilizzare.
Abbiamo visto, precedentemente, che il consumo di ossige-
no dipende dall'intensit del lavoro effettuato e dalle dimensioni
del gruppo muscolare interessato e che la capacit di consumo
di ossigeno dipende dalla resistenza organica aerobica. E' evi-
dente che, pi alto sar il livello della resistenza organica aero-
bica, pi alta sar l'intensit dello sforzo sostenibile in condi-
zioni tali che la richiesta di ossigeno sia in equilibrio con la
capacit di assunzione ed utilizzazione.
Se per si continua ad aumentare l'intensit dello sforzo,
si arriver, naturalmente, ad un carico limite, variabile da
atleta ad atleta, in cui non sar pi possibile soddisfare le ri-
chieste di ossigeno.
In queste condizioni un motore si fermerebbe, la macchina
umana, invece, ha ancora una grande possibilit: essa pu di-
fatti trarre energia da un carboidrato che si accumula nei mu-
scoli; il glicogeno, che scindendosi in molecole pi semplici, li-
bera energia senza bisogno della presenza di ossigeno. Durante
questa scissione, per, il glicogeno si trasforma in acido lattico
che pu essere tollerato dall'organismo in quantit ridotta, in
quanto l'acido lattico inibisce i processi chimici del muscolo ed
la causa chimica della fatica. Lo sforzo in queste condizioni,
pertanto, pu essere solo di lieve durata anche se di notevole
intensit (durata massima dello sforzo anaerobico 45 secondi).
Una volta cessato la sforzo, inoltre l'organismo si trova nella
necessit di eliminare l'acido lattico accumulatosi; tale elimi-
nazione avviene risintetizzando il glicogeno, a partire dall'acido
lattico, utilizzando l'energia proveniente dalla combustione delle
sostanze provenienti dagli alimenti glicidi e lipidi in presenza
di ossigeno. Ecco perch, una volta cessato uno sforzo di note-
vole intensit, gli atti respiratori e la frequenza cardiaca non
diminuiscono in proporzione subito ma permangono, per un certo
tempo, numerosi fino a quando l'organismo che ha pressoch
eliminato la quantit di acido lattico, precedentemente accu-
mulata. Continuer, cio, il trasporto di quell'ossigeno che, per
13
un limite fisiologico, l'organismo non era riuscito a trasportare
durante l'esecuzione dello sforzo stesso. In questi casi, si dice che
l'organismo ha accumulato un debito di ossigeno perch di
un vero e proprio debito si tratta in quanto l'organismo, in tali
condizioni, non in una situazione di equilibrio e dovr portar-
cisi continuando ad assumere, trasportare ed utilizzare una quan-
tit di ossigeno che saldi il debito stesso.
In definitiva, aumentare la resistenza organica anaerobica,
significa aumentare la capacit di sopportare quantit sempre
maggiori di acido lattico, aumentare cio il debito di ossigeno
che si pu accumulare. La resistenza organica anaerobica dipen-
de principalmente da due fattori:
la resistenza organica aerobica; evidente, infatti, che
pi grande la capacit dell'organismo di trasportare ed utiliz-
zare quantit di ossigeno sempre maggiori e pi difficilmente
si andr in debito di ossigeno (occorreranno sforzi sempre
maggiori) ;
la capacit fisiologica e psicologica di resistere alla pre-
senza nell'organismo di acido lattico.
Le modalit per aumentare il primo fattore sono state viste
precedentemente; analizziamo adesso le modalit di allenamento
per l'aumento del secondo fattore.
L'allenamento ad intervallo lungo il migliore stimolo per
l'aumento delle capacit dell'organismo a sopportare presenza di
acido lattico ed aumentare, cos, la possibilit di accumulo di
debito di ossigeno. Una seduta di questo tipo di allenamento
prevede i seguenti parametri:
durata dello sforzo;
intensit dello sforzo;
tempo di recupero;
numero delle prove.
Durata dello sforzo
La durata dello sforzo dovr essere compresa, in base all'in-
tensit dello stesso, tra i 45 secondi ed i 3 minuti.
Tenendo presente questa condizione, l'allenatore potr sce-
gliere il tipo di sforzo da far fare ai propri allievi: corsa, lavori
con carico, lavoro con il manichino, con il partner, con i pesi, ed
il pi specifico nel nostro caso, la lotta.
14
Intensit dello sforzo
L'intensit dello sforzo dovrebbe essere tale che la frequen-
za cardiaca raggiunga il suo limite estremo e, pertanto, potr
raggiungere anche i 190-200 e pi battiti al minuto.
Tempo di recupero
Il tempo di recupero dovr essere quello sufficiente a far tor-
nare la frequenza cardiaca a 100-110 battiti al minuto, e per-
tanto la ristabilizzazione sar pi completa anche se non totale.
Numero delle prove
Trattandosi di un allenamento molto impegnativo, il numero
delle prove sar ridotto (orientativamente da 6 a 3).
Facciamo un esempio esplicativo in un allenamento ad inter-
vallo lungo specifico per i lottatori:
tipo di sforzo: l'allievo dovr eseguire pi colpi possibili
ad uno, a due o pi partners in un tempo di circa due minuti.
L'allievo al via dell'istruttore comincer ad eseguire il pi
velocemente possibile colpi di lotta al proprio partner ( ovvio
che si alzer in piedi anche il pi velocemente possibile).
Allo scadere dei due minuti, l'allenatore avr cura di misu-
rare la frequenza cardiaca dell'allievo e di tenere in mente il
numero dei colpi che egli ha effettuato non appena la frequenza
avr raggiunto i 100-110 battiti al minuto, egli far ripetere l'e-
sercizio con le stesse modalit all'allievo. In base al numero dei
colpi che effettuer l'allievo in questa seconda prova e nelle prove
successive, l'allenatore potr dedurre interessanti dati sullo stato
dell'allievo stesso. Quello fatto sopra, naturalmente, un esem-
pio che per pu essere modificato a piacere dall'allenatore in
base alle conoscenze che ha, al piano di lavoro che ha effettuato
ed ai tipi di esercizi che ha insegnato ai propri allievi.
L'allenamento ad intervallo lungo come detto una meto-
dica molto impegnativa, se ben eseguita, ed pertanto sconsi-
gliabile ai ragazzi inferiori agli anni 15 ed agli atleti che non ab-
biano ancora acquisito una solida resistenza organica aerobica.
La metodica stessa inoltre dovr essere eseguita tenendo conto
anche dell'et, del periodo di allenamento in riferimento alle
15
gare, della gara da preparare e della reazione psicologica del-
l'atleta nei confronti di questo metodo di lavoro.
RESISTENZA MUSCOLARE AEROBICA
Si definisce come la qualit che permette di proseguire pi
a lungo possibile uno sforzo muscolare localizzato in condizioni
aerobiche . Sappiamo ormai il significato di condizioni aerobi-
che, spieghiamo adesso il significato di sforzo muscolare loca-
lizzato : uno sforzo che si riferisce ad un particolare gruppo
muscolare, isolatamente, in modo che la richiesta di ossigeno
non molto elevata in valore assoluto ma abbastanza elevata
nel muscolo che sta effettuando quel determinato sforzo. Fac-
ciamo un esempio esplicativo: consideriamo un atleta che stia
effettuando delle distensioni su panca con un peso di lieve en-
tit rispetto alle forze dell'atleta stesso. E' evidente che, in tale
tipo di sforzo, solo i muscoli tricipite, deltoide anteriore e il
grande pettorale sono interessati, mentre quasi tutta l'altra mu-
scolatura si trova in uno stato di riposo. In queste condizioni
il bisogno di ossigeno non sar elevato in valore assoluto in quan-
to, come abbiamo detto, la maggior parte della muscolatura
si trova in stato di riposo, ma sar quello necessario per per-
mettere la contrazione dei muscoli interessati allo sforzo. L'atle-
ta potr continuare a fare il summenzionato sforzo fino a quando
avr un adeguato apporto di ossigeno e di sostanze nutritive.
Un apporto di queste sostanze in quantit sufficiente dipende in
gran parte dalla qualit della circolazione sanguigna locale (ca-
pillarizzazione, volume sanguigno locale, tempo di circolazione
sanguigna). Abbiamo visto dunque che la capacit di resistere
pi a lungo in uno sforzo, che interessa un determinato distretto
muscolare, dipende dalla capacit che ha il muscolo interessato di
ricevere ed utilizzare ossigeno, dalla quantit di sostanze nutri-
tive presenti nel muscolo e dalla capacit di eliminazione di pro-
dotti tossici. E' chiaro per che la forza muscolare gioca un ruolo
molto importante nella resistenza muscolare aerobica. Se infatti
prendiamo in considerazione due atleti i cui massimali su panca
siano rispettivamente Kg. 100 e Kg. 50 e facciamo loro eseguire
un numero di ripetizioni massimali con Kg. 25, sar chiaro che
l'atleta che ha il massimale di Kg. 100 effettuer anche il mag-
gior numero di ripetizioni, e ci non perch egli sia pi allenato
o abbia una migliore circolazione sanguigna locale, ma solo per-
ch, essendo pi forte, esegue uno sforzo percentuale minore di
16
quello che effettua l'altro atleta. Ricapitolando, possiamo dire,
dunque, che la resistenza muscolare aerobica dipende principal-
mente da due fattori:
la forza muscolare;
la qualit della circolazione sanguigna locale.
Vedremo successivamente ed in maniera particolare quali
siano le metodologie dello sviluppo della forza; analizziamo ora
quale il tipo di allenamento che assicura lo sviluppo e la qua-
lit di circolazione locale. Tale allenamento consister nel fare
eseguire ripetizioni di sforzi muscolari locali con carichi che non
superino il 25-30% della forza muscolare massima locale.
Facciamo un esempio: ad un atleta che pu distendere in
piedi un carico massimale di Kg. 60, gli faremo eseguire, per
quanto detto sopra, ripetizioni con un carico di Kg. 20. Il nume-
ro delle ripetizioni sar quello massimo che egli potr effettuare
dopo un tempo di recupero di circa 2 minuti, gli faremo ese-
guire un'altra serie e cos via fino ad un massimo di cinque serie.
Questa continua ripetizione di movimenti crea l'esigenza di
un maggiore apporto sanguigno al distretto muscolare interes-
sato. Si sviluppa allora una pi fitta rete di capillari per permet-
tere una maggior sanguificazione ed anche un rallentamento pe-
riferico del circolo sanguigno (poich aumenta la sezione totale
dei vasi) che rende pi completi gli scambi dei prodotti utili alle
combustioni e di quelli da eliminare. Crescono inoltre le riserve
di sostanze nutritive del muscolo e viene di conseguenza ad au-
mentare progressivamente la capacit di eseguire pi a lungo un
lavoro locale: aumentata cos la resistenza muscolare aerobica.
RESISTENZA MUSCOLARE ANAEROBICA
Si definisce come la qualit che permette di proseguire il
pi a lungo possibile uno sforzo muscolare localizzato, in condi-
zioni anaerobiche . Se si continua ad aumentare l'intensit di
uno sforzo muscolare localizzato, si arriva ad un punto che, per
quanto il muscolo sia capillarizzato ed abbia un'ottima circola-
zione locale (vedi resistenza muscolare aerobica), la richiesta di
ossigeno da parte del muscolo stesso sar maggiore della possi-
bilit di apporto. In tali condizioni, il muscolo potr ancora con-
trarsi accumulando per un debito di ossigeno con produzione
di acido lattico che, come sappiamo, la causa chimica della
fatica.
17
Tale tipo di sforzo pertanto potr durare un tempo molto
limitato. I due principali fattori che determinano il grado di re-
sistenza muscolare anaerobica sono:
la resistenza muscolare aerobica; evidente infatti che
pi grande questa qualit e pi grande dovr essere lo sforzo
affinch il muscolo vada in debito di ossigeno;
la capacit fisiologica e psicologica di resistere alla fa-
tica muscolare locale. Abbiamo visto precedentemente quali siano
le metodiche per lo sviluppo del primo fattore. Analizziamo ora
il tipo di allenamento da fare eseguire per lo sviluppo del secon-
do fattore. L'allenamento dovr essere tale che il muscolo inte-
ressato accumuli il maggior debito di ossigeno in modo da abi-
tuare il muscolo stesso alla presenza di acido lattico.
Questa condizione si verifica quando un atleta compie il
massimo numero di ripetizioni con un carico di intensit del 75-
80% rispetto al suo massimale. Facciamo il solito esempio: un
atleta pu distendere, in piedi, Kg. 60; con un carico di 45-47,5
Kg. effettuer il massimo numero di ripetizioni (dovrebbero es-
sere all'incirca da 8 a 10). Dopo 2-5 minuti di recupero, effet-
tuer un'altra serie e cos via fino a farne un massimo di 7 serie.
18
LA FORZA
DEFINIZIONE E CENNI ANATOMO - FUNZIONALI DI MIOLOGIA
La forza muscolare, qualit fisica dell'uomo, riguarda essenzialmente la capacit che hanno i muscoli
di sviluppare tensioni per opporsi o vincere una resistenza. Essa dipende direttamente da: la sezione
trasversa del muscolo in oggetto, quindi la sua dimensione; la frequenza di impulsi che i neuroni (1 ) sono in
grado di trasmettere ai muscoli.
In un individuo adulto di sesso maschile, di peso e conformazioni normali, il peso della muscolatura
scheletrica (muscoli volontari) oscilla tra i 25 ed i 35 kg, circa il 40% del peso totale. I muscoli volontari sono
ben 501.
L'unit funzionale dell'apparato muscolare rappresentata dal muscolo, considerato come l'insieme
delle unit contrattili; riunite nel ventre muscolare, e delle parti non contrattili; il tendine prossimale, quello
distale, la giunsione muscolo tendinea e quella osteo tendinea.
Il ventre muscolare formato dall'insieme di numerose fibre che rappresentano le unit strutturali del
muscolo stesso. Ogni fibra si presenta in forma cilindrica, notevolmente allungata e con gli apici arrotondati;
le fibre si accollano una all'altra nel senso della lunghezza formando una prima serie di fasci muscolari
(primari), pi fasci primari formano i fasci secondari e questi ultimi unendosi tra loro formano i fasci terziari.
Gli elementi cosi costituiti sono circondati di tessuto connettivo elastico.
La parte pi nobile del muscolo quindi rappresentata dal ventre muscolare che possiede alcune
qualit precipue.
La prima l'estensibilit, ossia la capacit di allungarsi entro certi limiti, quando sia sottoposto a forze
traenti.
La seconda l'elasticit, ossia la capacit di riacquistare gradualmente la lunghezza di partenza dopo
una contrazione o un allungamento, consentendo la continuit e l'armonia dei movimenti.
La terza propriet rappresentata dalla contrattilit, ossia la capacit del tessuto di accorciarsi
avvicinando cos i propri punti di inserzione.
La contrazione avviene con cambio di forma ma non di volume, realizza il movimento e produce la
potenza muscolare.
Quest'ultima proporzionale al numero delle fibre interessate alla contrazione, cio stimolate, tra tutte
quelle costituenti il muscolo e al diametro trasverso del muscolo stesso. Il diametro trasverso, pur rivesten-
do un ruolo importante, non quindi l'unica causa di una forza massima pi elevata, si pu notare infatti
come individui di pari masse muscolari abbiano differenti risultati di forza max. Questa differenza essenziale
dovuta al fatto che le unit motorie di un uomo riescono a sincronizzarsi in base alla condizione e al tipo di
allenamento, alle attitudini del soggetto stesso e soprattutto alla frequenza degli impulsi inviati dai neuroni.
Le unit motorie, secondo vari Autori, sono composte da numerose fibre muscolari e la numerosit varia a
seconda che il muscolo sia piccolo o grande e abbia compiti di raffinatezza del movimento o sia capace di
contrazioni grossolane.
La capacit di sviluppare la forza dipende quindi anche dalla capacit di stimolare simultaneamente il
pi alto numero possibile di unit motorie, mediante una elevata frequenza di scarica. Solitamente la
percentuale di sincronizzazione varia tra il 20 e il 30% (Kuznesiov, Zacioski) mentre la frequenza di scarica
max. di circa 40 - 50 impulsi al secondo, conservando una notevole riserva di forza che il Prof.
Marchetti quantizza in un 30% dell'intera capacit.
Ovviamente in soggetti molto allenati e di capacit eccezionali si possono raggiungere percentuali di
1 ) Cellule nervose deputate alla conduzione degli Impulsi dall'encefalo e dal midollo spinale ai muscoli e viceversa
19
utilizzazione delle unit motorie molto elevate, cio capacit di tensioni che solitamente sono posssibili solo
in casi di estrema gravit o in condizioni emotive create artificialmente (ipnosi).
Il neurone motore soggetto ad una serie di stimoli inibitori e attivatori e la sua azione la risultante di
questi stimoli, la massima frequenza di scarica si realizza in assenza assoluta di stimoli inibitori.
In base alle caratteristiche del neurone si possono distinguere due tipi di unit motorie:
1 ) unit motorie lente, con neuroni capaci di basse e prolugate frequenze di scarica che innervano le fibre
rosse, capaci di produrre tensioni muscolari poco elevate e a bassa velocit, prolungabili per nel
tempo.
2) unit motorie rapide, capaci di grande velocit di conduzione che provocano accorciamenti rapidi, sono
queste le principali fautrici delle prestazioni di forza.
Esaminiamo ora le caratteristiche delle fibre bianche o rapide e di quelle rosse o fasiche.
Le differenziazioni pi evidenti riguardano le capacit ossidative e quelle glicolitiche, la velocit,
l'intensit e la durata delle contrazioni. Le fibre rosse sono tali per la grossa presenza di mioglobina, che
aumenta la diffusione dell'ossigeno, e quindi ne predispone la fibra ad un alto consumo; a questa
caratteristica se ne affiancano altre, come la bassa velocit di reclutamento delle unit motorie, un elevato
numero di mitocondri (2) e una bassa capacit atpasica. Le fibre bianche sono all'opposto: alta velocit, alta
attivit atpasica e glicolitica. Ovviamente ci sono anche tante fibre con caratteristiche intermedie, che sono
poi le responsabili dei diversi livelli di adattamenti biochimici e nervosi a seconda dell'allenamento.
In definitiva l'atleta in base alle caratteristiche e alla distribuzione delle sue fibre si specializza in attivit
di forza max. o veloce o in quelle di resistenza. Le modificazioni ottenibili con l'allenamento non sono ancora
completamente chiarite, comunque sicuro che modificazioni significative si verificano nella quantit dei
substrati energetici (gruppo dei fosfati e glicogeno) e nella struttura nervosa (spessore dell'assone) con
variazioni della funzionalit neuromuscolare.
L'ipersincronizzazione delle contrazioni che si rileva negli atleti rappresenta dunque l'espressione
dell'abilit, acquisita con l'allenamento, di attivare i circuiti inibitori e di raggiungere quindi frequenze di
stimoli di attivazione anche doppie rispetto a quelle riscontrabili nelle persone normali (70 - 100 e perfino
130, invece che 50 al sec). Per ottmere questa esaltazione della funzionalit nervosa sono necessari
stimoli allenanti della massima intensit che sollecitino tensioni massimali.
Di pari passo con qualunque lavoro allenante per l'incremento della forza, si presenta inoltre un altro
adattamento di determinante importanza per l'acquisizione di questa qualit, l'ipertrofia.
Essa si verifica in diversa misura a seconda della somministrazione degli stimoli ed il fattore
stabilizzante della forza. Infatti i valori di forza raggiunti grazie all'aumento della ipertrofia, se si dovesse
sospendere l'allenamento specifico, regrediranno lentamente, tanto pi lentamente quanto pi prolungato
nel tempo stato l'allenamento.
Il valore di forza ottenuto con l'ipersincronizzazione delle contrazioni e l'aumento degli stimoli, regredi-
sce invece molto pi velocemente alla sospensione dell'allenamento specifico.
Va considerato per che l'aumento indiscriminato di massa muscolare si accompagna sempre ad un
aumento di peso dell'atleta, cosa che pu diminuire il rapporto peso - potenza, non essendo di solito
l'aumento di peso dovuto al puro e semplice aumento della massa muscolare.
L'ipertrofia muscolare si ottiene con allenamenti che mobilitano massimalmente il meccanismo anae-
robio) alattacido e creano condizioni di disagio sufficienti a stimolare una reazione significativa.
In pratica per ottenere questo non si pu scendere sotto certi livelli di intensit; andranno usati perci
carichi che non consentano pi di 6-10 ripetizioni in una serie, con recuperi relativamente brevi (1 -3 minuti),
2) Centri generatori di energia della cellula.
20
che non consentano un ristabilimento completo, ma che al tempo stesso permettano l'esecuzione di un
certo numero di serie.
Secondo Zacioski l'ATP viene impiegato nel lavoro muscolare in grande quantit, la sua carenza
impedisce la sintesi di nuove proteine muscolari in sostituzione di quelle disgregate. Tutto ci provoca una
fame proteica nei muscoli che viene supercompensata dall'organismo con un aumento delle proteine
muscolari.
Dal punto di vista biochimico la supercompensazione si caratterizza con un aumento delle proteine
contrattili, nella cui sintesi pare giochino un ruolo importante i composti a basso peso molecolare (creatini-
na, aminoacidi, fosfati, ADP e ATP) che si liberano in notevole quantit nei lavori intensi. Il ruolo di questi
composti prevalentemente quello di regolazione dell'attivit del genoma (3) e delle sintesi proteiche, che
si intensifica con l'aumentare della concentrazione di questi composti a basso peso molecolare. A questo
fenomeno si accompagna anche un aumento del numero dei nuclei ed un aumento del DNA e del RNA,
inoltre, contrariamente a quanto si credeva, si notato un aumento del numero delle fibre per divisione
longitudinale. La capacit di aumentare l'ipertrofia muscolare massima in et giovanile e gradatamente si
perde con l'avanzare degli anni.
3) Patrimonio genetico dell'individuo.
21
RAPPORTO TRA FORZA E PESO
Le prestazioni dei sollevatori di peso e di altri atleti di varie discipline quali il getto del peso, il lancio del
disco e il canottaggio hanno dimostrato che gli atleti pi pesanti (cio con maggiore massa muscolare e in
grado quindi di sviluppare tensioni pi elevate) ottengono risultati in assoluto migliori quando la specialit
sportiva prevede delle elevate resistenze addizionali. Se per il proprio corpo che deve essere spostato,
come nella ginnastica, allora assume importanza prioritaria soprattutto la forza relativa, cio la forza che un
atleta sviluppa in relazione al proprio peso corporeo.
La forza relativa diminuisce se il peso del corpo aumenta eccessivamente a causa di una nutrizione
eccessiva, pur potendo aumentare il valore di forza assoluta.
Esiste quindi un rapporto ottimale tra massima tensione ottenibile, velocit di applicazione della forza e
peso del soggetto, che, almeno riguardo alla nostra disciplina, situato piuttosto in alto nei valori di forza per
kg. di peso corporeo, considerando il fatto che nella lotta oltre a dover spostare il proprio corpo bisogna
vincere anche la resistenza dell'avversario.
Purtroppo non conosciamo dei valori che possano considerarsi statisticamente indicativi, e le normati-
ve di atleti di altre nazioni, che curano particolarmente questi rapporti di qualificazione dell'atleta lottatore,
non ci sono note.
importante far notare che in atleti adulti e qualificati la forza relativa pu essere migliorata anche
mediante un modesto calo di peso.
22
CLASSIFICAZIONE DELLA FORZA
Per meglio comprendere le manifestazioni tensive della forza molti Autori hanno proposto varie
classificazioni, alcune semplici e brevi, altre molto elaborate; vengono qui riportati alcuni esempi di vari
Autori che si riferiscono a parametri diversi. La prima si riferisce alle variazioni di lunghezza del muscolo
senza considerare il tempo di estrinsecazione (Zacioski).
In base a questa classificazione ogni contrazione pu avvenire:
1 ) senza modificazioni di lunghezza (statica o isometrica) - in tal caso la forza interna del muscolo e quella
della resistenza si equivalgono, con questa contrazione i capi del muscolo non vengono n avvicinati
ne si allontanano anche se la tensione proporzionale alla forza sviluppata;
2) con riduzione di lunghezza (isotonica, superante, concentrica) - in questo caso la forza interna prevale
sulla resistenza esterna ed questo il tipo di lavoro vincente che si verifica pi frequentemente nei
movimenti sportivi;
3) in allungamento contrastante (eccentrica, pliometrica) - la forza interna inferiore alla resistenza
esterna, si ha quindi un lavoro cedente con allontanamento dei capi del muscolo.
Un'altra classificazione (Kusnezov) assume come parametri l'entit della resistenza e l'accelerazione.
In base a questa classificazione la forza pu essere:
1 ) forza esplosiva: accelerazione - massima, resistenza - minima;
2) forza rapida: accelerazione minore che massima, resistenza minore che massima;
3) forza lenta: accelerazione tendente a zero, resistenza - massima.
Secondo Harre e colleghi la forza pu essere classificata in:
1 ) forza max. : forza massimale che il sistema neuromuscolare pu esercitare in una contrazione massima
volontaria, determinante in sport con notevoli resistenze (sollevamento pesi, lotta ecc . . . . ) ;
2) forza rapida: capacit che il sistema neuromuscolare ha di superare la resistenza con alta velocit di
contrazione (salti, lanci);
3) forza resistente: capacit di prestazioni protratte nel tempo in caso di lunghe applicazioni di forza
(canottaggio, canoa).
L'allenamento per la forza costituisce un fondamento essenziale per la elevazione della prestazione
sportiva. Riguardo alla struttura del movimento e al rapporto forza-tempo, l'allenamento per la forza deve
basarsi sulle esigenze specifiche della prestazione di gara.
Per lo sviluppo di qualit complesse quali la forza rapida e la forza resistente sono necessarie
esercitazioni con dosaggi particolari e stimoli specifici; per questo motivo che dei metodi efficacissimi per
una certa disciplina sportiva non lo sono affatto per un'altra, e non quindi assolutamente giusto adottare
incondizionatamente la metodica del sollevamento pesi in altri sport.
Quando si lavora per esaltare le qualit di forza del lottatore bisogna ricordare quali sono le finalit che
ci proponiamo, considerare la muscolatura pi interessata nei movimenti di gara e la capacit di sviluppare
certe tensioni da parte dell'atleta e quindi, dopo un lavoro ben organizzato di sviluppo generale, specializza-
re la sua preparazione per esaltarne le qualit peculiari.
Non bisogna pero dimenticare che la forza rapida e quella resistente dipendono notevolmente dal
livello della forza max, da ci si pu capire che un atleta in grado di sviluppare tensioni piu elevate rispetto ad
un altro, pu vincere un uguale resistenza con maggiore velocit e sostenere una applicazione di forza per
maggior tempo a parit di resistenza opposta.
23
ESERCITAZIONI PER L'ALLENAMENTO DI FORZA
1 ) Esercitazioni per lo sviluppo generale - queste esercitazioni sono la base della preparazione in
tutti quegli sport che richiedono un allenamento di forza intensivo, in questo modo si impedisce una precoce
e non valida specializzazione di qualit, che tende a svilupparsi soprattutto nei giovani, in seguito alla
applicazione di sole esercitazioni specifiche per i movimenti di gara.
Le esercitazioni per la forza generale si basano pertanto su esercizi diversi, nella loro struttura di
movimento e nella loro applicazione nel tempo, alla tensione riscontrabile in gara. La forza acquisita in virt
di questo lavoro viene in seguito convertita, mediante esercizi specifici, o di gara, in forza specifica.
Esercizi generali possono essere considerati le trazioni alla sbarra, i piegamenti alle parallele, i vari tipi
di balzi, gli esercizi vari con bilancieri, interessanti per il maggior numero possibile di distretti muscolari,
ecc.. . . (vedi tab. n. 1 pag. 14).
La esercitazione generale pu comprendere esercizi fisici generali, che servono al rafforzamento di
molti gruppi muscolari, ed esercizi fisici particolari, attraverso i quali si ricerca il rafforzamento di un settore
muscolare ben preciso mediante esercizi il pi possibile indirizzati; nel primo caso si carica in maniera
elevata l'intero organismo, nel secondo caso invece si impegna soltanto una parte specifica del sistema
locomotore, quindi il carico per l'organismo relativamente basso. Ovviamente la scelta delle esercitazioni
di forza dipende dalle esigenze della disciplina sportiva, dallo stato individuale di allenamento e dalla meta
prefissata per l'allenamento di forza nei singoli periodi di allenamento.
Le esercitazioni per lo sviluppo generale della forza sono alla base della preparazione del giovane
atleta e sono inserite prevalentemente nel periodo preparatorio della pianificazione di un atleta evoluto, con
cicli di 4/6 settimane. Gli esercizi pur avendo le stesse finalit devono essere abbastanza vari, onde evitare
un affaticamento psicologico dovuto alla monotonia delle esercitazioni.
2) Esercitazioni specifiche - esse devono accordarsi sostanzialmente nella struttura e nel decorso
forza-tempo con il movimento di gara. Esercitazioni specifiche del lottatore possono essere considerate le
girate al petto con il bilanciere, le iperestensioni del busto con bilanciere, vari esercizi per aumentare la forza
del ponte e in ponte ecc. . . . (vedi tab. n. 2 pag. 15). Le esercitazioni specifiche sono inserite in qualsiasi
tappa della preparazione di un atleta evoluto, alternate al lavoro generale visto in precedenza, nel periodo
preparatorio, e sempre pi frequentemente in quello competitivo. opportuno protrarre tali esercitazioni
anche nel microciclo della gara onde evitare una perdita di forza.
3) Esercitazioni di gara - sono valide in quegli sport dove esiste una resistenza addizionale (lanci,
sollevamento pesi, lotta ecc. . . .), gli esercizi vengono strutturati avendo cura di riprodurre fedelmente il
movimento di gara, es. (lavoro con il partner, sollevamenti da in piedi, cinture e sollevamenti del partner da
terra ecc. . ..) e mirano a ottenere la rifinitura della coordinazione della forza e la capacit di convogliare in
un gesto tecnico le tensioni raggiunte con le precedenti esercitazioni per lo sviluppo della forza. Questa
esercitazione se protratta a lungo (una o due ore) tende ad esaltare la resistenza dell'atleta, ma se si
finalizza il momento coordinatorio, e quindi la capacit neuromuscolare di esprimere una tensione giusta al
momento opportuno, oltre che lavoro per la tecnica e la resistenza specifica pu essere considerato lavoro
per la rifinitura delle qualit di forza.
Prima di elencare e consigliare i metodi di allenamento pi consoni per l'incremento della forza nelle
sue varie forme, opportuno illustrare alcuni aspetti riguardanti i principi generali di questo allenamento.
Gli aspetti da esaminare sono tre:
1 ) l'intensit dello stimolo;
2) la specificit dello stimolo;
3) la super compensazione.
L'intensit dello Stimolo, affinch lo stimolo risulti allenante, deve essere tale da produrre una attivazi-
24
ne significativa dei processi biologici, plastici e di funzionalit nervosa, cos da suscitare una reazione
nell'organismo; solo in questo caso si ha un miglioramento delle capacit di lavoro dell'atleta.
La specificit dello stimolo, per essere efficace, deve suscitare l'adattamento essenziale in quegli
organi, strutture e apparati che si assumono l'onere di compiere o coadiuvare il lavoro, cosi da trasferire su
movimenti specifici le qualit ottenute con il lavoro generalizzato.
La supercompensazione si ottiene quando durante la fase di allenamento si realizzano nell'organismo
delle modificazioni di tipo biochimico, plastico, umorale e di funzionalit nervosa, tali da spostare in avanti
l'equilibrio omeostatico dell'organismo. Tali modificazioni sono reversibili. Durante la fase del recupero (se
la sua durata giusta e lo stimolo allenante stato ottimale) la reazione dell'organismo non si fermer con il
ritorno ai valori precedenti l'allenamento, ma andr oltre, aumentando i suoi potenziali.
A questo punto si pu gi capire l'importanza della corretta applicazione dell'intensit degli stimoli
allenanti, della loro specificit e di un giusto rapporto tra lavoro e recupero, nei vari periodi della
preparazione.
25
MEZZI E METODI DELL'ALLENAMENTO PER LA FORZA
I metodi di sviluppo della forza muscolare sono tre:
1 ) utilizzazione di una intensit o resistenza massimale;
2) utilizzazione di una resistenza non massimale fino all'esaurimento;
3) utilizzazione di una resistenza da vincere con velocit massimale.
I mezzi possono suddividersi in tre categorie:
1) esercizi generali;
2) esercizi speciali;
3) esercizi di gara.
I vari esercizi possono essere eseguiti:
a) con sovraccarichi di vario genere;
b) con il partner;
e) con attrezzi grandi e piccoli (sbarra, parallele ecc.);
d) utilizzando gravit ed inerzia (cadute dall'alto, accelerazioni, cambiamenti del senso del movimento
ecc.).
Adottando la classificazione della forza proposta da Harre (forza massimale - forza resistente - forza
veloce), che riteniamo la pi completa e la pi utile da un punto di vista metodologico, entriamo ora nel vivo
dell'argomento, esaminando dettagliatamente metodologie e mezzi per lo sviluppo dei sopracitati tipi di
forza.
La forza massimale
Prendiamo in considerazione la forza massimale come prima qualit da sviluppare (considerata nella
sua pi ampia generalit di distretti muscolari). Le metodiche prevedono lavori relativamente brevi,
resistenze elevate e tempi di recupero dell'ordine dei 3-4 minuti. I mezzi di attuazione sono gli esercizi
generali e gli esercizi speciali, con uso prevalente di sovraccarichi e di attrezzi.
Sappiamo ormai che per lo sviluppo trofico dell'atleta e quindi per il suo conseguente aumento di forza
la metodologia piu valida prevede l'esecuzione di 3-5 serie di 7-10 ripetizioni ciascuna con un peso pari al
60%-80% del max. Sappiamo anche per che in questa situazione lo stimolo nervoso non abbastanza
elevato, perch la resistenza opposta non richiede la mobilitazione massimale delle unit motorie, possia-
mo quindi affermare che indispensabile adottare anche la metodologia che prevede l'esecuzione di serie
di 1-5 ripetizioni con un carico che va dall'85% al 100% del massimale.
Questi due diversi metodi di usare come mezzo di allenamento il bilanciere (attrezzo facilmente
adattabile alle resistenze che si vanno richiedendo) possono e devono integrarsi per ottenere lo sviluppo
delle capacita di tensione muscolare
Considerando la vita di un atleta, possiamo dire che la metodologia con carichi pi bassi a maggior
numero di ripetizioni, si adatta maggiormente ai giovani e quindi a quella fascia di preparazione tendente a
valutare le qualit muscolari dell'atleta esaltandole; da ribadire che con questa metodologia si ricerca
anche la generalizzazione del lavoro muscolare, la capacit quindi di ipertrofizzare tutta la muscolatura
scheletrica del lottatore senza ancora specializzarla. Uno schema preciso di questo metodo prevede
l'esecuzione di 5-7 esercizi fondamentali, di ogni esercizio si dovranno fare 3-5 serie di 7-10 ripetizioni, con
2-3 minuti di riposo tra una serie e la successiva (il carico sar del 70%-75% del max). Gli esercizi devono
essere scelti in funzione di una normale costituzione fisica e con rapporti normali di forza tra muscolatura
anteriore e posteriore e tra busto e gambe interessando sempre vari distretti muscolari (vedi tab. n. 3
pag. 15).
26
Quando il giovane avr raggiunto un sufficiente sviluppo muscolare ed una sufficiente maturit fisica si
integrer la metodologia sopra indicata con quella che prevede l'uso di carichi massimali o appena
sub-massimali.
Successivamente dopo un lavoro per la forza basato prevalentemente sugli esercizi generali, si
passer ad usare prevalentemente gli esercizi speciali che prevedono gesti molto simili a quelli agonistici
veri e propri e quindi interventi muscolari molto specifici.
Anche in queste esercitazioni da considerare quanto detto per la forza max. generalizzata, si partir
cio da 3-5 serie di 7-10 rip., eseguite con carichi pari al 70%-75% del max., per arrivare a 3-5 serie di 1-5
rip. con carichi pari all'85%-100% del max. (vedi tab. n. 4 pag. 16).
Per la forza max queste esercitazioni sopra riportate possono essere integrate con un lavoro che pur
con resistenze molto pi basse (40%-45% del max.), possa provocare uno stimolo nervoso max. L'eserci-
zio consiste nell'eseguire il maggior numero di ripetizioni per una durata di 6-8 sec. Le serie saranno sempre
3 con 4-6 minuti di recupero. Le difficolt maggiori sorgono nella scelta degli esercizi in quanto spesso la
velocit di esecuzione va a scapito dell'ampiezza del movimento e della giusta coordinazione, quindi una
metodologia eseguibile con esercizi semplici nella loro struttura (es. distensione nei vari piani, bal zi . . . ).
Esistono ovviamente altri metodi derivanti da quelli gi visti per il raggiungimento della forza massima-
le. Uno dei pi noti il piramidale il quale prevede una successione carico ripetizioni, di questo genere: 8 rip.
con il 75% - 6 rip. con l'80% - 4 rip. con l'85% - 2 rip. con il 90% - 2 rip. con il 95% -4rip. con l'85% - 6 rip. con
I'80% - 8 rip. con il 75%.
Con questo metodo si fa nella stessa seduta un lavoro specifico per l'incremento della massa
muscolare ed un lavoro che stimola considerevolmente il sistema neuro-muscolare data l'entit delle
resistenze da vincere (vedi tab. n. 5 pag. 16).
Un'altra metodica per la forza max. prevede contrazioni isometriche della durata di 2"- 4" se massima-
li, e fino a 8"-9" se pari al 75% del max. Questa metodologia utile perch si pu esplicare in qualsiasi
posto e in assoluta mancanza di attrezzi. inoltre facile, individuata un'angolatura in cui l'estrinsecazione di
forza da parte della muscolatura carente, o un'angolatura in cui necessaria un'estrinsecazione di forza
particolare, allenare la muscolatura stessa a esprimere la max. forza possibile con quella particolare
posizione relativa dei segmenti ossei. Solitamente consigliabile riservare a questa metodologia, che
prevede contrazioni muscolari senza cambiamenti di lungezza del muscolo, non pi del 15% dell'intero
allenamento per la forza max.
Di uguale importanza possono considerarsi gli esercizi in contrazione eccentrica cio cedenti a una
resistenza esterna maggiore della forza esplicata. Sono esercitazioni sempre max. e si fanno eseguire
cedendo a carichi addizionali (per esempio in sospensione alla sbarra, dalla trazione massima fino a braccia
distese). Tutti questi espedienti sono importantissimi perch abituano il muscolo a situazioni e a tensioni il
piu possibile diverse, secondo il criterio della multilateralit.
Inoltre l'alternanza di esercitazioni differenti tra loro pu rendere meno noiose e anche piu motivate dal
punto di vista psicologico dell'atleta le sedute di allenamento per la forza massimale. La frequenza di questi
allenamenti per la forza max deve essere molto elevata nel periodo preparatorio del giovane e dell'atleta
evoluto, con almeno tre sedute di allenamento, usando varie metodologie, nell'arco di sei, sette allenamenti
alla settimana. Nella fase generale della preparazione del giovane che abbia necessit di incrementare il
proprio peso l'incidenza potr essere ancora pi frequente, se il soggetto si dimostrer in grado di assorbire
tali allenamenti.
Nel periodo fondamentale le esercitazioni per la forza max dovranno persistere a livello di mantenimen-
to in almeno uno, due allenamenti ogni sette previsti in una settimana. Generalmente nei giorni in cui si
lavora per esaltare la forza max opportuno non inserire altre esercitazioni impegnative dal punto di vista
psichico, si deve inoltre fare della ginnastica di allungamento con molta accuratezza, e il riscaldamento sar
breve e finalizzato. Nella tab. n. 6 pag. 16 si riporta un esempio di una tabella di mantenimento per la forza
max. per atleti evoluti, periodo fondamentale.
27
Un'ulteriore specializzazione dell'atleta prevede l'esaltazione di altre qualit di forza, correlate a quella
max, cio la resistenza alla forza e la forza veloce. Abbiamo gi appurato che il lottatore, per poter eseguire i
gesti che questo sport prevede, ha bisogno pi che altro di capacit di forza max ma dobbiamo sapere pero
che la frequenza di alte applicazioni di forza pu affaticare il sistema neuromuscolare e limitare le
prestazioni delle successive contrazioni. A questo punto si ha la necessit di intervenire con un allenamento
che consenta una resistenza alla forza.
La forza resistente
Il metodo per esaltare la forza resistente consiste nell'utilizzazione di una resistenza non massimale
fino all'esaurimento, i mezzi possono essere esercizi generali, speciali e di gara. La metodologia per
l'esaltazione di questa qualit muscolare prevede l'esecuzione del massimo numero di ripetizioni, ripetute
per 3-5 serie, con ricuperi molto brevi (45"-1 ') e con un carico che varia dal 40% al 60% del massimale.
Il segreto di questa esercitazione sta nel riprendere il lavoro muscolare prima che nel muscolo si siano
ristabilite le condizioni preesistenti all'esecuzione della serie precedente. La crisi che viene provocata con
questo continuo affaticamento fa si che il muscolo si premunisca, con opportune modificazioni biochimiche,
per sostenere in futuro un lavoro analogo nel miglior modo possibile.
Questa qualit di forza resistente legata fortemente al meccanismo energetico anaerobico lattacido,
quindi facilmente comprensibile in quale modo sia legata anche alle capacit di resistenza organica e
muscolare anaerobica dell'atleta. evidente quindi che le qualit fisiche, in uno sport come la lotta, con
durate medie, variazioni di ritmo e grossi impegni muscolari, devono essere strettamente correlate tra loro e
insieme sviluppate nel periodo di crescita del giovane lottatore, per poi essere sempre allenate durante
l'intera sua vita agonistica. Il tempo da dedicare allo sviluppo delle varie qualit fisiche varier in funzione
dell'et e del periodo, ma vi sar sempre un rapporto di prevalenza di alcune rispetto alle altre, mai di
esclusione.
L'allenamento alla resistenza di forza pu essere condotto anche con l'esercizio stesso di gara (nel
nostro caso i vari tipi di incontri), ma anche opportuno far abituare l'atleta a vincere nel tempo delle
resistenze esteme pi elevate di quelle che abitualmente dovr superare in competizione.
La forza veloce
Sullo sviluppo della forza veloce si pu agire in duplice modo: 1 ) mediante una elevazione della forza
max; 2) mediante l'aumento della velocit o rapidit della contrazione muscolare.
La proporzione ottimale tra l'allenamento di forza max e quello di forza veloce non ancora sufficiente-
mente conosciuta, ed certamente diversa da specialit a specialit. Lo schermitore ad esempio ha
senz'altro bisogno di un dosaggio di stimolo e di carichi diverso dal lottatore, dovendo quest'ultimo superare
resistenze notevolmente pi elevate.
Per il nostro sport quindi anche la forza veloce dovr essere allenata con carichi relativamente elevati,
50%-60%, con contrazioni rapide ed esplosive; l'allenamento dovr inoltre essere completato da esercizi di
rimbalzi (anche con i bilancieri e i grandi attrezzi) e con carico naturale. Con quest'ultimo mezzo (ginnastica
a corpo libero) si pu intervenire infatti notevolmente per migliorare genericamente la forza veloce.
Perch questa esercitazione risulti significativa necessaria una notevole velocit dei movimenti, una
velocit che dia valore anche alle tensioni frenanti e ai cambiamenti di direzione del movimento; classici
possono essere considerati gli slanci delle braccia eseguiti alla massima velocit e con la massima
ampiezza di movimento, i balzi dalle varie posizioni, i rimbalzi sulle braccia e sulle gambe, le torsioni del
busto con bloccaggio del movimento nella posizione frontale, sempre per se eseguiti con il massimo
dinamismo. Notevole risulta dunque l'apporto della ginnastica senza carichi esterni come esercitazione
complementare a quella dei sovraccarichi.
Per chiarire ancora di pi le idee riportiamo una tabella (tab. n. 7 pag. 17) in cui si riassumono i concetti
espressi a proposito delle metodologie per l'incremento dei vari "ti pi " di forza.
28
TEST DI VALUTAZIONE
I dati di valutazione sono:
a) per la forza massimale l'entit del carico;
b) per la forza resistente il numero di ripetizioni (il carico un dato fisso);
e) per la forza veloce il numero di ripetizioni (tempo e carico sono dati fissi).
Esempio di test per la forza massimale
Si scelgono tre esercizi tra quelli pi significativi, e, dopo un accurato riscaldamento articolare, si
effettuano alcune ripetizioni dell'esercizio prescelto con dei carichi successivamente sempre pi elevati,
per passare ben presto a carichi submassimali e massimali, eseguendo naturalmente una sola ripetizione
per ogni serie. Il dato del test sar il massimo peso che il lottatore riesce a sollevare nell'esercizio prescelto.
Nella tab. n. 8 pag. 17 riportiamo delle normative per la forza Max. riferite ad alcuni esercizi base per il
lottatore.
I massimali riportati vanno riferiti ad atleti di livello medio-alto.
Esempio di test per la forza resistente
Avendo come dato fisso il carico che l'atleta deve sollevare, e che non deve superare il 60% del
massimale, il dato del test il numero di ripetizioni che il lottatore riesce ad effettuare correttamente.
Esempio di test per la forza veloce
Avendo come dato fisso il tempo (15-20 secondi) e il carico (non deve superare il 60% del massimale) il
dato del test il numero delle ripetizioni che l'atleta riesce ad effettuare nel tempo stabilito.
Nel testo, alle tabelle cui abbiamo fatto cenno segue una documentazione fotografica (pag. 18) il cui
scopo quello di illustrare l'esecuzione corretta di alcuni tra gli esercizi piu importanti per l'incremento della
forza.
29
Tab. n 1
ESERCIZI GENERALI PER LO SVILUPPO DELLA FORZA
Esercizi
Distensione lenta
Distensione lenta dietro la testa
Distensione su panca
Piegamenti alle parallele
Rematore in piedi
Rematore a 90
Trazioni impugnatura dritta
Trazioni impugnatura rovesciata
Stacchi da terra a gambe tese
Stacchi da terra a gambe tiesse
Flessioni del busto da decubito supino
Iperestensioni del busto da decubito prono
Torsioni e inclinazioni del busto
Piegamenti gambe
Flessioni della gamba sulla coscia
Molleggi dei piedi su uno spessore
Adduzioni della coscia
Muscolatura prevalentemente interessata
tricipite, trapezio, deltoide, grande dentato
come sopra, con maggiore interessamento degli scapolari e del dentato
tricipite, grande pettorale, deltoide
tricipite, pettorale, deltoide, grande dorsale
bicipite, trapezio, deltoide
bicipite, dorsale, romboide, fissatori della scapola
dorsale, romboide, fissatori della scapola, bicipite
come sopra, con maggiore interessamento del bicipite
lunghi del dorso, glutei, posteriori delle cosce
lunghi del dorso, glutei, quadncipiti
retto dell'addome, retto del quadricipite, psoas iliaco
lunghi del dorso, glutei, posteriori della coscia
addome, obliqui, quadrato dei lombi
quadricipite, estensori della gamba sulla coscia
posteriori della coscia
polpacci (gastrocnemio, soleo)
adduttori
N. B. - Tutti questi esercizi possono essere eseguiti con pesi, e devono essere considerati come la base dell'esercitazione generale
per lo sviluppo della forza. Una tabella valida deve tener presente due principi fondamentali: 1) alternare esercizi per
muscoli agonisti a quelli per muscoli antagonisti (es.: dopo una serie di panca opportuno fare una serie di rematore a
90): 2) rispettare i dovuti tempi di recupero.
A pag 18 viene riportata una documentazione fotografica riguardante alcuni degli esercizi sopra esposti.
30
Tab. n. 2
ESERCIZI SPECIALI PER LO SVILUPPO DELLA FORZA
Esercizi
Portate al petto
Rematore in piedi
Rematore 90
Stacco a gambe tese
Stacco a gambe flesse
Strappo
Slancio
Distensioni varie
Trazioni varie
Muscolatura prevalentemente interessata
trapezio, deltoide, quadricipite, glutei, dorso
bicipite, trapezio, deltoide
bicipite, dorsale, romboide, fissatori della scapola
lunghi del dorso, glutei, posteriori delle cosce
lunghi del dorso, glutei, quadricipite
trapezio, deltoide, gran dentato, lunghi del dorso, quadricipite, glutei
quadricipite, tricipite, grande dentato, trapezio
tncipite, pettorale, trapezio, grande dentato, deltoide
bicipite, dorsale, romboide, scapolari, deltoide
A pag. 18 viene riportata una documentazione fotografica riguardante alcuni degli esercizi sopra esposti.
Tab. n. 3
ESEMPIO DI-UNA TABELLA PER LA FORZA MAX.
BASATA SUGLI ESERCIZI GENERALI PER ATLETI IN VIA DI SPECIALIZZAZIONE (2 alien settim i
l ' eser c. - distensione lenta
2
3
4
5
6
7
B)
1 es
2
3
4
5
6
7
- rematore in piedi
- stacchi a gambe tese
- flessioni del busto da supini
- piegamenti alle parallele
- trazioni impugnatura dritta
- trazioni impugnatura rovesciata
ere. - distensione su panca
- rematore a 90
- iperestensione tronco da proni
- piegamenti gambe
- trazioni dietro la testa
- piegamenti braccia in verticale
- trazioni impugnatura rovesciata
SERIE
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RIPETIZI
7
7
7
7
max
ma
max
7
7
7
7
max
max
max
N.B. Il carico sar del 75% del massimale in ogni esercizio, tranne parallele e sbarra che saranno eseguiti a carico naturale. I
recuperi saranno di 3 minuti tra una serie e l'altra
31
Tab. n. 4
ESEMPIO DI UNA TABELLA PER LA FORZA MAX.
BASATA SUGLI ESERCIZI SPECIALI PER ATLETI IN VIA DI SPECIALIZZAZIONE (2 alien, settim.)
A)
1 ' eserc.
2" "
3 ' "
4 ' "
5" "
6" "
B)
1 eserc
2" "
3 ' "
4"
5" "
- portate al petto
- distensioni dietro la testa
- stacco a gambe flesse
- trazioni imp dritta
- trazioni dietro la testa
- trazioni imp. rovesciata
- rematore in piedi
- slanci
- rematore a 90
; strappo
- trazioni (salita alla fune)
SERIE
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
RIPETIZIONI
5
5
5
max
max
max
5
5
5
5
max
NB I carico sar dell' 80% del massimale con 3 minuti di recupero.
Tab. n. 5
ESEMPIO DI UNA TABELLA A PIRAMIDE
1 eserc - portata al petto
2 " - slancio
3 " - stacco da terra
4 - distensioni
5 - trazioni sbarra
7/75% 5/85% 3/90% 1/95% 3/90% 5/85% 7/75%
max max max
NB I recupero sar di 3 minuti.
Tab n 6
ESEMPIO DI UNA TABELLA PER IL PERIODO COMPETITIVO PER ATLETI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
(ESERCIZI DI MANTENIMENTO O DI RICHIAMO PER LA FORZA MAX)
1 eserc - portata al petto
2" " - slanci
3 - rematore in piedi
4 - trazioni (salita alla fune)
SERIE
3
3
3
3
RIPETIZIONI
3
3
3
max
NB IL carico sar del l ' 85%-90% e si potranno effettuare anche tentativi con il 100% del massimale.
32
Tab. n. 7
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE VARIE METODOLOGIE DI INCREMENTO DELLA FORZA
% del max.
85%- 100%
70%- 75%
40%- 60%
40%- 60%
N. rip.
1-5
7-10
6-8 sec
max.
N. serie
3-5
3-5
3-5
3-5
velocit
intensit
vel. bassa
vel. bassa
vel. max.
vel. bassa
tempo di
recupero
2'-5'
2- 4'
4'-6'
30"-45"
Specificit
F. max
F. max (ipertrofia)
F. veloce
F. resistente
N.B. - La tabella limitata agli esercizi fatti con i sovraccarichi e non prevede contrazioni di altro tipo che quelle concentriche (con
variazioni di lungezza del muscolo in azione, vincendo la resistenza estema).
Tab. n. 8
NORMATIVA PER LA FORZA MAX (atleti livello medio-alto)
Categ
48
52
57
62
68
74
82
90
100
+ 100
Portata
al petto
70
75
85
90
100
105
110
115
120
+ 120
Stacchi da
terra
120
130
150
160
170
180
190
200
+ 200
+ 200
Distensione
avanti
45
50
50
60
65
70
72,5
75
80
+ 80
Trazioni dietro
la testa
25
25
25
25
22
20
20
18
15
10
Piegamenti
alle parai.
30
30
30
30
28
25
25
25
20
15
Piegam
gambe
80
85
95
105
115
120
125
130
140
+ 140
33
LO SVILUPPO CORPOREO DEI BAMBINI E RAGAZZI
E L'ALLENAMENTO PER LA FORZA
Dal primo al ventesimo anno l'individuo nasce e diventa adulto. In questi anni si compiono veloci
processi che variano le proporzioni corporee in modo notevole e creano specializzazioni tissutali e
funzionali sempre pi accentuate. provato che i fattori che condizionano l'accrescimento sono in parte
endogeni (patrimonio genetico) e in parte esogeni (ambiente, alimentazione ecc.); di questo secondo
gruppo fa parte l'attivit sportiva.
L'influenza di questi fattori varia a seconda dell'et dei soggetti, ma pu non essere omogenea, per cui
spesso l'et cronologica non corrisponde all'et biologica, vale a dire che soggetti aventi la stessa et
presentano un grado di sviluppo diverso.
Questo fatto molto importante perch naturalmente nella scelta delle metodologie di allenamento da
adottare si deve tener conto dell'et biologica e non di quella cronologica.
L'allenatore deve essere in grado di valutare l'et cronologica dei ragazzi anche per essere in grado di
giudicarne le capacit, infatti talvolta capita che alcuni mostrino una superiorit fisica dovuta non tanto ad un
superiore talento, quanto ad un precoce sviluppo.
Uno degli apparati pi importanti dell'organismo l'apparato locomotore, le cui trasformazioni durante
la crescita sono imponenti. Lo sviluppo di questo apparato condizionato sia da fattori endogeni che da
fattori esogeni, poco si conosce dei primi e pressoch nulle sono le possibilit di intervento. I fattori esogeni
sono invece ben conosciuti e sono notevoli le possibilit di influenzare positivamente tramite essi, in
particolar modo con una appropriata attivit fisica, lo sviluppo dell'organismo in generale e dell'apparato
locomotore in particolare.
r
O.K. Sperling afferma che molti bambini e adolescenti non raggiungono la loro massima capacit
potenziale di rendimento solo perch gli stimoli di sviluppo rivolti all'apparato locomotore sono troppo ridotti.
Da questa considerazione nasce il problema della somministrazione dei giusti carichi allenanti, cio del
rapporto tra carico e caricabilit; in alcuni casi infatti sono da addebitare alla errata applicazione degli stimoli
allenanti i danni prodotti ai vari tessuti o, ancora in maggior misura, la non riuscita sportiva.
Lo stesso autore, definendo le tre fasi dello sviluppo puberale (cio la fase pre-puberale, la prima
fase puberale e la seconda fase puberale), delinea la particolarit di questi periodi.
La fase prepuberale, che caratterizzata da uno sviluppo armonico, viene definita fase di riposo prima
della crescita.
Nella prima fase puberale appaiono invece crescenti disarmonie, e l'apparato di sostegno spesso non
adeguato allo sviluppo della muscolatura, gli arti inoltre presentano una particolare fragilit. In questa fase
un accentuato e troppo rapido sviluppo della forza pu costituire un pericolo per lo scheletro, per cui bisogna
avere cura di evitare tensioni massimali.
La seconda fase puberale caratterizzata da un ritardo della maturazione dello scheletro rispetto agli
altri tessuti morbidi, che hanno gi raggiunto una stabilit paragonabile a quella dell'adulto. In questa fase
non si dovr sovraccaricare la colonna vertebrale o ricercare elementi di forza concentrati nel tempo,
considerando l'inadeguatezza delle articolazioni a reggere lo stimolo. Il pericolo maggiore si verifica
quando si sottopone il ragazzo troppo a lungo a carichi impegnativi per i singoli settori del corpo, oppure gli si
richiedono prestazioni dove l'intensit prevale sulla quantit.
Un corretto allenamento deve quindi evitare lavori unilaterali, senza sufficienti intervalli di recupero e
deve tener presenti i vari tempi di adattabilit delle strutture; per esempio la muscolatura in grado di
recuperare molto piu in fretta dell'apparato scheletrico e delle strutture passive.
In definitiva sono da tener presenti i limiti di caricabilit superiori, ma anche i limiti inferiori, in quanto, se
34
nel primo caso si rischia di compromettere le strutture dell'atleta, nel secondo si rischia di compromettere le
sue possibilit potenziali non sottoponendo l'organismo a stimoli adeguati.
I benefici di una attivit precoce sono senza dubbio notevoli, se si considera che le riserve di carboidrati
muscolari possono aumentare fino al doppio rispetto ad individui non allenati e che tutti gli apparati sono
influenzati in maniera favorevole dall'adattamento all'attivit motoria.
Per realizzare ci vengono ritenuti opportuni carichi stabiliti in base al peso corporeo.
Per gli atleti di 13/15 anni sono da consigliare carichi che vanno dal 40% al 60% del peso corporeo,
soprattutto se sollevati sopra la testa. Il carico globale di una seduta dovrebbe essere collocato attorno ai
4.000 Kg.
Gli intervalli tra una serie e l'altra dovranno essere abbastanza lunghi, 5/7 minuti.
Per i giovani di 16/17 anni il limite superiore di carico pu raggiungere il 120% del proprio peso e il
carico globale di una seduta pu raggiungere gli 8.000 Kg.
Esempio di lavoro generale per l'ipertrofia e la forza max. per i giovani: sei esercizi di 3 serie x 9
ripetizioni, riguardanti lo sviluppo generale muscolare del giovane (senza specializzazione).
I giovani che hanno buone condizioni di adattamento possono essere portati rapidamente ad una
seduta con i sovraccarichi al giorno per lo sviluppo della forza. Sar opportuno rispettare delle precauzioni
per evitare danni alle strutture in via di evoluzione (curando particolarmente la corretta esecuzione di alcuni
movimenti e facendo assumere al giovane, che solleva da terra un carico, la posizione di <> schiena piatta ,
in modo da non sollecitare in maniera scorretta la colonna vertebrale). Al termine di ogni seduta di
allenamento con i carichi indispensabile fare un buon allungamento per non perdere le qualit di
estensibilit e articolarit.
Per concludere l'uso del sollevamento pesi, come metodologia per lo sviluppo della forza nei giovani,
non da considerare controindicato per una armonica crescita dell'organismo, anzi, secondo alcuni autori
una pressione periodicamente interrotta e sub-massimale la favorisce, mentre solo l'uso frequente di
carichi percentualmente troppo elevati che la ritarda.
35
INDICAZIONI PER EVITARE DANNI FISICI O LESIONI
L'allenamento con carichi pu esporre a lesioni osteo articolari e muscolari qualora non vengano prese
opportune misure e semplici precauzioni. Eccone alcune:
a) apprendere pazientemente ogni nuovo esercizio prima di aumentare il carico;
b) svolgere un accurato riscaldamento e mantenersi caldi durante tutto l'allenamento;
e) eseguire ogni esercizio con la opportuna concentrazione;
d) non richiedere sforzi massimali a muscoli gi stanchi;
e) smettere di allenarsi all'approssimarsi di dolori e fitte della muscolatura.
Per quanto riguarda le articolazioni degli arti inferiori, in particolare delle ginocchia, si dovr evitare di
esercitare le gambe esclusivamente con serie molto dure di piegamenti; eseguendo i piegamenti si dovr
inoltre mantenere i piedi in posizione corretta ed avere cura di usare calzature adatte.
Per quanto riguarda la colonna vertebrale, i suoi legamenti e i dischi intervertebrali, le precauzioni da
prendere sono:
a) evitare di sollecitare troppo la colonna nella stessa unit di allenamento;
b) scaricare la colonna con esercizi eseguiti in sospensione alla sbarra dopo l'esecuzione di esercizi che
l'hanno compressa;
e) rafforzare la muscolatura dorsale e addominale;
d) mantenere la colonna eretta, in modo da distribuire uniformemente il carico su tutti gli elementi
vertebrali.
Un accorgimento importante riguarda il controllo della respirazione durante l'esecuzione di esercizi di
forza.
Durante l'esecuzione s provoca una tensione della muscolatura respiratoria e la chiusura della glottide
con un notevole incremento della pressione intratoracica e con minore apporto di sangue al cervello, cosa
che comporta il pericolo di perdite di conoscenza o annebbiamenti per ipossia.
Per evitare questi inconvenienti si consiglia:
a) mantenere la tensione per breve tempo;
b) non eseguire troppe ripetizioni successive in apnea;
e) evitare tensioni max ai principianti;
d) evitare inspirazioni max;
e) nei soggetti che cominciano esercitazioni di forza si osservi, ove possibile, un intervallo a met
esercizio (es. portata al petto, intervallo, succesiva distensione).
Accorgimento pratico per i principianti quello di invitarli ad espirare rumorosamente a ogni ripetizione
in modo da poterne controllare il ritmo esecutivo.
36
LA VELOCIT
DEFINIZIONE E FATTORI CHE LA DETERMINANO
La velocit, qualit fisica dell'uomo, la capacita di realizzare azioni motorie in un tempo minimo.
Secondo alcuni autori determinata da tre fattori fondamentali:
1 ) il tempo di reazione motoria;
2) la rapidit del singolo movimento;
3) la frequenza dei movimenti.
Bisogna precisare che le componenti sopra menzionate non sono dipendenti l'una dall'altra, si pu ad
esempio essere rapidi nella reazione e lenti nei movimenti, per cui lo sviluppo della velocit nasce da una
influenza complessiva sui fattori che la determinano.
Possiamo dividere la velocit in ciclica e aciclica. La velocit ciclica si compone di azioni tendenzial-
mente identiche ripetute rapidamente, come ad esempio nella corsa veloce dopo la fase di accelerazione e
nella velocit del ciclismo su pista dopo la fase di lancio. La velocit aciclica si differenzia dalla precedente in
quanto il gesto non viene ripetuto, ma si tratta di coordinare i movimenti rapidamente, in una singola azione,
come ad esempio in una azione di lancio o, nel nostro caso, nell'esecuzione di un qualsiasi tipo di azione
tecnica.
Gli eventi fisiologici che si verificano nell'effettuazione di un qualsiasi movimento attraversano 5 fasi:
1 ) il prodursi di una eccitazione del recettore;
2) il passaggio dello stimolo nella rete nervosa e la formazione del segnale effettore;
3) la trasmissione dello stimolo al S.N.C. (1);
4) la trasmissione del segnale di risposta dal S.N.C, ai muscoli;
5) la stimolazione del muscolo e la conseguente contrazione di questo.
Ognuna di queste fasi richiede un certo tempo, in pratica quindi il passaggio attraverso di esse
contribuisce a limitare la velocit.
Biochimicamente i fattori limitanti sono la velocit di demolizione dei substrati energetici immediata-
mente disponibili (a.t.p. e C.P.), la concentrazione enzimatica e la qualit degli stimoli nervosi.
Un ruolo importante, anche se non determinante, gioca la rapidit delle reazioni motorie; queste
possono essere divise in semplici e complesse.
Per reazione semplice si intende la reazione ad un segnale predisposto con un movimento anch'esso
predisposto.
Per reazione complessa si intende la reazione ad una situazione non prevista o parzialmente non
predisposta, comprendendo nel tempo di reazione quello necessario alla scelta del movimento di risposta.
Questo ultimo tipo di reazione quello caratteristico degli sport di combattimento; in pratica si realizza
seguendo questa successione:
1 ) il lottatore percepisce visivamente la posizione (guardia) dell'avversario;
2) valuta la direzione dei suoi spostamenti;
3) sceglie un piano di azione, valutando la possibilit reale di realizzarlo;
4) invia ai muscoli lo stimolo necessario per realizzare il movimento.
1)- S.N.C. - Sistema nervoso centrale
37
Queste fasi, eccetto l'ultima, costituiscono il periodo latente, che pu durare da 0,25 a 1 sec., la somma
delle quattro fasi d il tempo di reazione motoria; dimostrato che non esiste relazione tra velocit di
reazione motoria e velocit di movimento.
Alla velocita di movimento concorrono in forma determinante la forza veloce, la mobilit articolare e la
coordinazione specifica.
La prima favorisce la rottura dello stato di quiete e il superamento di eventuali resistenze esterne; la
seconda permette una diminuzione delle resistenze interne, un'escursione piu ampia del movimento e
quindi un'applicazione di forza per un tempo pi lungo; la terza consente di eseguire il movimento con piu
precisione facendo intervenire con perfetta sincronia tutti, e solo, i muscoli deputati al movimento.
Un ruolo importante nella realizzazione di azioni esplosive riveste anche la capacit di concentrazione.
Questa capacita varia notevolmente a seconda degli individui ed migliorabile solo con esercitazioni che
coinvolgono notevolmente la volont stessa dell'atleta.
38
MEZZI E METODI PER LO SVILUPPO GENERALE DELLA VELOCIT
Considerando le varie componenti fisiche e nervose che concorrono alla qualit in oggetto, possiamo
definire dei principi generali di intervento.
Il primo stadio prevede la determinazione nel giovanissimo del grado di reattivit motoria a stimoli visivi,
uditivi e tattili, dapprima con il metodo delle reazioni semplici (segnale conosciuto e risposta gi predispo-
sta), e poi con quello delle reazioni complesse. Come abbiamo precedentemente esposto, non esiste un
legame tra velocit di reazione motoria e velocit di movimento, ma entrambe concorrono a esaltare il
rendimento dell'atleta nello sport di combattimento.
Stabilito questo fattore di origine prettamente nervosa e poco modificabile si comincia a lavorare sulla
prima componente della velocit di movimento, la forza veloce, senza ricercare per una specializzazio-
ne alla lotta e tenendo presente che per questa qualit in particolare opportuno intervenire molto
precocemente (non dopo gli 11 anni).
I mezzi piu congeniali sia dal punto di vista metodologico che da quello pedagogico sono i giochi sportivi
e i giochi tradizionali.
Per giochi sportivi si intende tutto l'insieme dei giochi con la palla, che presentano una vasta gamma di
movimenti e un'alternanza tra momenti di relativo riposo e momenti di impegno notevole sia fisico che
nervoso (coordinativo)
Per giochi tradizionali si deve intendere alcuni giochi che richiedono in buona misura abilit motoria e
impegno muscolare (il gioco della campana, vari tipi di staffette con percorsi di equilibrio o con ostacoli da
superare o da aggirare ecc.).
Come mezzo complementare ai giochi sopra indicati da considerare il preatletismo generale con tutto
l'insieme di esercizi a carico naturale che lo compongono.
Per atleti in via di qualificazione (16/18 anni) necessario intervenire anche con quelle metodologie e
con quei mezzi esposti, a proposito della forza veloce, nella trattazione della forza.
Seconda componente essenziale come abbiamo visto , la mobilit articolare e la capacita di rapida
decontrazione del muscolo
II mezzo piu indicato per migliorarle la ginnastica di allungamento, attiva e passiva, da eseguirsi in
ogni allenamento, ma esistono anche altri mezzi, quali il fare abituare l'atleta all'ampiezza del movimento,
correggendolo quando durante gli esercizi tende a non sfruttare al massimo le sue escursioni articolari.
L'importante che ogni allenatore sappia che una grande mobilita articolare indispensabile per ottenere il
massimo rendimento da qualsiasi atleta.
Per esercizi e metodologia si rimanda alla trattazione di questa qualit fisica.
Terza componente la coordinazione generale e specifica. Ovviamente il primo intervento deve
essere generale; il suo scopo sar quello di ampliare il piu possibile la capacita di eseguire movimenti,
sfruttando una enorme gamma di esercizi il piu disparati, abbinandoli tra loro e obbligando cosi il giovane a
rielaborare degli schemi motori gi acquisiti. Cosi facendo si sprona l'intelligenza motoria dell'atleta senza
mai consentirgli di adagiarsi sull'abilit che ha raggiunto nei movimenti ormai noti. Tra questi mezzi
possiamo inserire l'acrobatica, con tutta la sua successione di esercizi.
L'intervento successivo consiste nell'insegnamento della tecnica sportiva, ricordando che una ampia
conoscenza dei movimenti rende possibile un migliore apprendimento della tecnica. questa la prima fase
della coordinazione specifica.
In seguito si passera alla seconda fase della coordinazione specifica, cercando di migliorare la capacita
di esecuzione di un gesto tecnico in situazioni particolari di movimento. Questa fase riservata ad atleti
qualificati, in quanto l'acquisizione del gesto tecnico ormai data per scontata, e noi dovremo preoccuparci
39
solo di elevare il pi possibile la velocit di esecuzione dei colpi conosciuti e di abituare il lottatore a
riconoscere un notevole numero di situazioni favorevoli alla esecuzione dell'azione tecnica in oggetto e,
quindi, a realizzarla nel pi breve tempo possibile. Tutto ci possibile solo se con il continuo addestramen-
to tecnico e la ripetizione dell'azione riusciamo ad automatizzare il movimento escludendo dal normale
percorso che deve compiere lo stimolo per ottenere una risposta motoria il sistema nervoso centrale
(riflesso condizionato).
Per la velocit di movimento possiamo ancora intervenire migliorando un altro dei fattori che la
determinano, la volont, o meglio, la capacit di concentrazione.
A questo scopo dobbiamo elaborare delle situazioni nelle quali l'atleta sia spronato a fornire prestazioni
altamente qualificate. I test possono gi considerarsi un allenamento per la volont e la concentrazione, ma
tanti altri sono i mezzi di cui possiamo servirci, ad esempio, l'uso di partner o di manichini per rendere piu
difficoltosa la coordinazione, l'esecuzione di azioni in condizioni di grave disagio ecc . . . .
Prima di concludere opportuno ricordare che la velocit ha due matrici:
1 ) la prima prettamente nervosa, fatta di percezioni, di trasporti pi o meno veloci degli stimoli recettori ed
effettori dai muscoli al sistema nervoso centrale e viceversa;
2) la seconda prettamente fisica, correlata alle capacit di forza veloce, di mobilit articolare, di coordina-
zione generale e specifica.
Solo intervenendo in tempo su queste componenti, in particolare sulla seconda, perch, come abbiamo
gi detto, la prima poco modificabile, si pu migliorare in misura apprezzabile. Infatti la velocit, come le
altre qualit fisiche, ha un andamento condizionato dallo sviluppo complessivo dell'individuo e in primo
luogo dalla sua maturazione fisiologica; comunque rispetto ad altre qualit fisiche, quali la forza e la
resistenza, la sua alienabilit di norma sensibilmente inferiore. Secondo alcuni autori gli incrementi non
superano il 18%-20% e possibilit concrete di miglioramento si possono avere solo nell'et precoce,
diciamo entro i 14-15 anni. In seguito gli incrementi saranno relativi e in pratica per ottenerli si potr agire
solo sulla forza veloce.
Per concludere diamo alcune indicazioni metodologiche che devono essere sempre tenute presenti
quando si faccia sostenere allenamenti volti ad incrementare la velocit generale e specifica.
L'intensit dello stimolo deve essere massimale, tenendo conto che esiste gi, o almeno dovrebbe
esistere, una padronanza totale del gesto; la ripetizione sistematica di uno stesso esercizio a velocit
costante e non massimale, crea infatti una stabilizzazione e una assimilazione del movimento a quella
velocit, rendendo estremamente difficoltoso il passaggio ad esecuzioni pi veloci.
La durata dello stimolo deve consentire la realizzazione di movimenti della massima velocit e deve
protrarsi per un tempo che risulti sufficientemente allenante, 10-15 sec; infatti esecuzioni troppo brevi 2-3
sec. non hanno l'efficacia massimale ed esecuzioni troppo lunghe non consentono l'estrinsecazione della
massima velocit.
Il tempo di recupero dovr essere abbastanza lungo, dai 4 ai 6 minuti, e durante esso si dovr stare
bene attenti a non perdere la dovuta concentrazione nervosa; dobbiamo tener presente infatti che le
esercitazioni volte all'allenamento della velocit sono stressanti sia dal punto di vista nervoso, in quanto si
richiede sempre all'atleta una prestazione massimale, che da quello muscolare e che l'insorgere della fatica
compromette la capacit di produrre intensit elevate e di eseguire movimenti corretti.
La quantit di lavoro dovr essere ridotta, essendo alta l'intensit, e il lavoro specifico per la velocit
dovr essere inserito preferibilmente all'inizio dell'allenamento, dopo un riscaldamento accurato, ma non
affaticante. Settimanalmente sono sufficienti, per la velocit, una o al massimo due sedute di allenamento,
secondo le necessit soggettive dell'atleta ed il periodo di preparazione in atto.
40
LA MOBILITA ARTICOLARE
TIPI DI MOBILIT E FATTORI CHE LA INFLUENZANO
La mobilit la capacit di eseguire movimenti con la massima ampiezza.
La mobilit di estrema importanza per il lottatore, poich per l'esecuzione corretta di moltissime azioni
tecniche indispensabile il possesso di questa qualit fisica (passaggio in ponte, vari tipi di proiezioni, vari
tipi di rovesciamenti, ecc.). Lo sviluppo della mobilit rende possibile inoltre un piu rapido apprendimento dei
gesti motori, ed una migliore utilizzazione di altre qualit fisiche, quali la forza, la velocit e la coordinazione.
Si hanno due tipi di mobilit articolare: attiva e passiva. Per mobilit attiva si intende la capacit di un
atleta di far compiere ad una articolazione dei movimenti della massima ampiezza con l'intervento esclusivo
della propria muscolatura. Per mobilit passiva si intende, invece, la capacit di un atleta di far compiere ad
una articolazione dei movimenti della massima ampiezza con l'ausilio di un partner, di un attrezzo, o del
peso del proprio corpo.
Nel corso di questa dispensa troveremo i valori della mobilit espressi in gradi angolari. Useremo
questo tipo di misura poich gli standard medi fornitici dai test consultati sono cosi espressi. Nella pratica
per la determinazione della mobilit, generalmente, si usa prendere dei punti di riferimento sul corpo
dell'atleta (es. nell'inclinazione laterale del busto sul piano frontale, a gambe unite, si prende come punto di
riferimento il contatto della punta delle dita della mano sulla coscia).
I valori che si raggiungono con esercizi di mobilit passiva sono sempre maggiori rispetto ai valori che si
raggiungono con analoghi esercizi di mobilit attiva La differenza in gradi angolari fra i due valori
importante perch ci permette di conoscere il grado di mobilit dell'atleta. Quando la differenza minima
l'atleta ha un buon grado di mobilit.
I fattori che influenzano la mobilit sono le articolazioni (con le varie componenti), i muscoli agonisti e i
muscoli antagonisti. Le articolazioni, sono superfici ossee o cartilaginee attraverso le quali si pongono in
contatto reciproco due segmenti scheletrici oppure un segmento scheletrico ed uno cartilagineo. Un
esempio classico di articolazione si pu vedere nella fig. n. 1.
Per capire a fondo la meccanica delle articolazioni esaminiamo gli elementi che le compongono; essi
sono:
1) le superfici articolari;
2) i mezzi di connessione;
3) le cartilagini articolari;
4) la membrana sinoviale.
Le superfici articolari (fig. 1-c, e) possono essere ossee o cartilaginee. Generalmente le superfici
ossee sono ricoperte da uno strato di tessuto cartilagineo o ialino.
I mezzi di connessione sono: a) i legamenti, b) la capsula articolare, e) i tendini dei muscoli interessati
all'articolazione. I legamenti articolari sono costituiti da cordoni fibrosi, molto resistenti, che tengono uniti i
due capi ossei uno all'altro. Essi possono trovarsi sia fuori che dentro la capsula articolare. La capsula
articolare (fig. n. 1 -a) costituita da un manicotto di tessuto connettivo che avvolge le superfici articolari.
I tendini dei muscoli inseriti nelle vicinanze delle articolazioni hanno funzioni di legamenti.
Le cartilagini articolari (fig. n. 1-d) sono il rivestimento che ricopre le superfici articolari. In alcune
articolazioni tra le due cartilagini esiste un disco di natura cartilaginea chiamato menisco cartilagineo.
La membrana sinoviale (fig. n. 1 -b) aderente alla capsula sinoviale ed ha il compito di secernere un
liquido vischioso destinato alla lubrificazione dell'articolazione onde ridurre l'attrito tra le superfici articolari.
41
Tipi di articolazione
Le articolazioni sono di tre tipi:
1) diartrosi;
2) anfiartrosi;
3) sinartrosi.
Le diartrosi, chiamate anche articolazioni mobili, sono le pi numerose nel nostro organismo ed hanno
diverse forme. Dalle diverse forme assumono i vari nomi specifici (fig. n. 2):
a) enartrosi o articolazioni sferiche;
b) condiloidee;
e) trocoidi;
d) artrodie con superfici articolari piatte o quasi, il movimento si attua per slittamento;
e) trocleari;
f) a sella o a incastro reciproco;
g) trocoide semplice.
Le anfiartrosi - o articolazioni semimobili, uniscono tra di loro due segmenti ossei, le cui superfici
articolari sono piatte o quasi, permettendo cos movimenti molto limitati.
Le sinartrosi - uniscono, tra di loro, due segmenti ossei, per non permettono alcuna possibilit di
movimento.
Movimenti articolari
I movimenti articolari possibili nelle diartrosi, sono:
1) flessione - si ha la flessione quando due segmenti articolari si avvicinano (es. coscia sul bacino,
avambraccio sul braccio, ecc.);
2) estensione - l'estensione il movimento opposto al precedente, si ha quando i due segmenti
scheletrici si allontanano;
3) adduzione - quando i segmenti articolari si avvicinano al piano sagittale (piano passante per l'avanti
dietro, divide il corpo umano in due parti, una sinistra, una destra);
4) abduzione - il movimento contrario all'adduzione, cio l'allontanamento di un segmento articolare
dal piano sagittale;
5) cireumduzione o circonduzione - l'insieme dei movimenti sopra descritti quando si succedono l'uno
all'altro;
6) rotazione - il movimento di un osso intorno ad un asse pi o meno parallelo alla maggior dimensione
dell'osso;
7) scivolamento - quando le superfici articolari scorrono l'una sull'altra senza perdere il reciproco
contatto, comune a tutte le diartrosi.
Esamineremo ora pi dettagliatamente le articolazioni che pi rivestono importanza ai fini della
mobilit, cio quelle che consentono movimenti pi vari e pi ampi. Esse sono:
a) le articolazioni della colonna vertebrale;
b) l'articolazione scapolo omerale;
e) l'articolazione coxo-femorale.
42
Fig.1
ES. DI ARTICOLAZIONE
CAPO ARTXOLARE SUPERIORE
RI VESTMENTO CAf i TLAGI NEO
CAPO ARTI COLARE INFERIORE
TROCOOE SEMPLICE
tt^T)
ARTROCHA
ENARTROSI 0
ARTIC SFERICA
Rg. 2 TIPI DI DIARTROSI
43
ARTICOLAZIONI DELLA COLONNA VERTEBRALE O RACHIDE
La colonna vertebrale (fig. n. 3) costituita da trentatre o trentaquattro vertebre cosi suddivise: sette
cervicali, dodici dorsali, cinque lombari, nove o dieci sacrali. Le vertebre sacrali sono saldate insieme e
formano due ossa distinte, il sacro e il coccige.
Caratteristiche delle vertebre
Generalmente le vertebre hanno delle caratteristiche morfologiche uguali che possono essere identifi-
cate in una vertebra dorsale (fig. n. 4-5).
La vertebra dorsale costituita da un corpo cilindrico anteriore, denominato corpo della vertebra, nella
parte posteriore esiste un foro, denominato foro vertebrale, nel quale situato il midollo spinale. Il foro
limitato lateralmente da due tratti ossei, denominati peduncoli. Posteriormente ai peduncoli ed al foro si
trova la massa apofisaria da cui hanno origine due sporgenze laterali denominate apofisi trasverse, una
mediana detta apofisi spinosa, quattro piccole sporgenze verticali, due per lato, una superiore ed una
inferiore, denominate apofisi articolari, perch servono a fare articolare ciascuna vertebra con quelle sotto e
quelle sopra.
Tra l'apofisi spinosa e le apofisi articolari esistono due masse ossee appiattite denominate lamine
vertebrali.
Le vertebre cervicali
Le vertebre cervicali (fig. n. 6) si differenziano dalla vertebra precedentemente descritta per le
caratteristiche seguenti: corpo vertebrale allungato in senso trasversale, sul margine superiore del quale
sono posti due piccoli uncini ossei; apofisi spinosa bifida, essendo divisa in due parti, ad eccezione
dell'ultima vertebra; esistenza di un foro detto foro intertrasversale.
Caratteristiche ancora diverse presentano l'atlante e l'epistrofeo, che sono rispettivamente la prima e
la seconda vertebra.
L'atlante non ha n corpo vertebrale n apofisi spinosa, al loro posto si trovano due archi distinti,
l'anteriore e il posteriore (fig. n. 7).
Lateralmente agli archi si trova la massa laterale in cui si possono notare le apofisi articolari ed una
superficie articolare, sia per la faccia superiore che per la faccia inferiore. La faccia superiore serve per
l'articolazione tra l'atlante e l'osso occipitale, quella inferiore per l'articolazione fra l'atlante e l'epistrofeo.
L'epistrofeo (fig. n. 8) che la caratteristica di possedere, sopra il suo corpo, una protuberanza cilindrica,
detta apofisi odontoide. Ai lati della apofisi odontoide esistono due superfici pianeggianti, che servono per
l'articolazione dell'epistrofeo con la faccia inferiore dell'atlante.
Gli elementi vertebrali sono uniti insieme da una serie di articolazioni del tipo anfiartrosi. Ogni
elemento unito all'altro da un disco cartilagineo, dai legamenti longitudinali anteriori e posteriori (che
interessano l'intera colonna vertebrale), dal legamento giallo, dai legamenti intertrasversari, dai legamenti
interspinosi e sovraspinosi.
Movimenti della colonna vertebrale
Data la poca mobilit tra le singole vertebre, prendere in considerazione il movimento tra due elementi
vertebrali non ha un grande interesse, pertanto prenderemo in considerazione l'intero movimento della
colonna vertebrale. I movimenti che pu compiere la colonna vertebrale sono: flessione in avanti, estensio-
ne indietro, inclinazione (flessione) laterale, rotazione o torsione intorno all'asse longitudinale,
cireumduzione.
44
Fig. 3
RACHIDE 0 COLONNA
VERTEBRALE
VERTEBRE
CERVICALI
VERTEBRE
DORSALI
VERTEBRE
LOMBARI
Fig.4 VERTEBRA DORSALE VISTA DALL'ALTO
- CORPO DELLA VERTEBRA
FORO VERTEBRALE
APOFISI TRASVERSE
APOFISI SPINOSA
Fig. 5 VERTEBRA DORSALE VISTA LATERALMENTE
CORPO VERTEBRALE
NCISURA VERTEBRALE
Flg.6 VERTEBRA CERVICALE
APOFISI SPNOSA
BFIDA
FORO VERTEBRALE
APOFISI TRASVERSE
Fig.7 ATLANTE
ARCO ANTERIORE
-APOFISI TRASVERSE
CAVIT GLENOIDI
ARCO POSTERIORE
Fig. 8 EPISTROFEO
APOFISI ODONTOIDE
APOFISI ARTICOLARI
SUPERIORI
APOFISI TRASVERSI
45
Si ha il movimento di flessione in avanti quando la colonna vertebrale compie un arco con concavit
orientata verso l'avanti (fig. n. 9).
Questo movimento limitato da:
la tensione del legamento longitudinale posteriore;
la limitata elasticit dei legamenti gialli;
la distensione dei legamenti inter e sovraspinoso;
la distensione della parte posteriore dell'anello fibroso dei dischi intervertebrali.
Si ha il movimento di estensione quando la colonna verteorale compie un arco con concavit verso
l'indietro (fig. n. 9).
I fattori che limitano l'estensione sono:
la tensione del legamento longitudinale anteriore;
l'allargamento delle fibre collagene della parte anteriore del disco invertebrale;
l'urto che avviene tra le apofisi spinose della regione toracica.
Si ha la inclinazione laterale destra quando la colonna vertebrale si inclina sul piano frontale,
formando un arco con concavit a destra, viceversa per la inclinazione laterale sinistra (fig. n. 10).
La inclinazione laterale, per la regione cervicale e toracica, limitata dall'incontro delle apofisi
trasverse delle vertebre; per la regione lombare da:
la tensione dei legamenti gialli e della capsula delle articoiazioni interapofisarie;
la distensione della parte laterale dell'anello fibroso e dei legamenti trasversali nel lato contrario a
quello verso cui si realizza l'inclinazione.
Si ha il movimento di rotazione, quando le vertebre ruotano verso destra o sinistra intorno ad un asse
ben individuato ma che si pu identificare con quello longitudinale.
La rotazione limitata da:
la torsione dell 'anello fibroso del disco intervertebrale;
la distensione del legamento giallo dal lato contrario a quello in cui avviene la rotazione.
Si ha il movimento di cireumduzione quando i movimenti precedentemente descritti si combinano con
un certo ordine, descrivendo una figura geometrica a forma di cono, il cui apice si trova sopra la base del
bacino.
Nella colonna vertebrale i movimenti variano di qualit e di quantit, da regione a regione. Essi
dipendono dallo spessore dei dischi intervertebrali, dalla loro superficie, dalla struttura diversa delle
vertebre.
Una grande mobilit la troviamo nella regione cervicale, essendo i dischi intervertebrali molto alti e i
corpi vertebrali piccoli. La regione cervicale pu compiere movimenti di:
flesso-estensione, sono molto ampi e possono raggiungere i 130-150;
inclinazione laterale, limitata dal contatto delle apofisi trasverse delle vertebre;
rotazione destra e sinistra, pu raggiungere i 150in totale.
Molto meno mobile della regione cervicale la dorsale essendo i dischi intervertebrali poco spessi, i
corpi vertebrali molto grossi e l'inclinazione delle apofisi spinose molto marcata.
I movimenti che pu compiere questa regione sono:
flesso-estensione, secondo Dittemar pu raggiungere un'ampiezza media di 40per la flessione ed
altrettanti per l'estensione;
inclinazione laterale, pu raggiungere un'ampiezza media di 30per lato;
rotazione, il movimento di rotazione ampio in virt della favorevole disposizione delle apofisi
articolari vertebrali superiori ed inferiori, secondo alcuni autori il suo valore compreso fra i 30-90.
Nella regione lombare il movimento di maggiore interesse la flesso-estensione, pu raggiungere
un'ampiezza totale tra i 100-140, la ragione dovuta all'altezza relativamente grande dei dischi
intervertebrali.
II movimento di rotazione pressoch nullo, essendo il centro di rotazione delle articolazioni interapofi-
sarie alla base delle apofisi spinose. Per le stesse ragioni le inclinazioni laterali hanno poca ampiezza, circa
40in totale.
46
W\
Fig. 9 FLESSIONE IN AVANTI
AA' FLESSIONE IN AVANTI (L'ESCURSIONE E' DI 50CIRCA)
AB ESTENSIONE (L'ESCURSIONE E' DI 40" CIRCA I
Fig.10 INCLINAZIONE LATERALE
AA
1
FLESSIONE LATERALE DESTRA (CIRCA 45)
AA
2
FLESSIONE LATERALE SINISTRA (CIRCA 45)
47
ARTICOLAZIONE OCCIPITO - ATLANTOIDEA
Notevole importanza riveste l'articolazione occipito-atlantoidea, esse unisce la testa alla colonna
vertebrale. L'articolazione costituita dai due condili dell'occipite del cranio e dalle cavit glenoidee
dell'atlante.Questa articolazione pu eseguire movimenti di flesso-estensione sul piano sagittale ed incli-
nazioni sul piano frontale (piano parallelo alla fronte dell'individuo); il movimento di rotazione avviene invece
tra l'atlante e l'epistrofeo (seconda vertebra), essendo quest'ultimo inserito tramite l'apofisi odontoide
nell'arco ventrale dell'atlante.
Nel movimento di flessione in avanti i condili dell'occipite slittano verso l'indietro sulle cavit glenoidi
permettendo al mento di ruotare verso il basso ed all'indietro, avvicinandosi cos al manubrio dello sterno,
mentre la nuca effettua un movimento contrario.
Il movimento limitato da:
il legamento cervicale posteriore che unisce l'occipite alle apofisi spinose delle vertebre cervicali;
i legamenti occipito-atlantoidei laterali;
i legamenti occipito-odontoidei;
la parte dorsale del manicotto capsulo-legamentoso.
Nel movimento di flessione dorsale o estensione avviene il movimento contrario alla flessione in avanti,
i condili dell'occipite slittano in avanti sulle cavit glenoidi, permettendo cos al mento di ruotare verso l'alto,
spostandosi leggermente indietro, e la nuca esegue il movimento contrario ruotando verso il basso in avanti.
Questo movimento limitato da:
il legamento occipito-odontoideo medio;
il legamento occipito-atlantoideo anteriore;
la distensione del legamento vertebrale comune anteriore;
l'urto dell'occipite con l'arco posteriore dell'atlante.
La flesso-estensione pu raggiungere in media valori di circa 50, di cui 20per la flessione e 30per
l'estensione.
Nel movimento di inclinazione laterale i condili occipitali slittano, l'uno avvicinandosi alla linea mediale
l'altro allontanandosene.
Questo movimento limitato da:
la distensione del legamento occipito-atlantoideo laterale;
la distensione del legamento occipito-odontoideo.
L'inclinazione laterale pu raggiungere in media un'ampiezza di 15-20per ogni lato.
Si pu notare, dai dati fornitici dai testi, che la testa ha poca mobilit, mentre invece i movimenti di cui gli
atleti sono capaci risultano di gran lunga pi ampi. Ci dovuto al fatto che ai movimenti della testa si
accompagna sempre un movimento delle vertebre cervicali (per esempio il contatto del mento con il
manubrio dello sterno non potrebbe avvenire totalmente a carico della articolazione occipito-atlantoidea).
48
ARTICOLAZIONE SCAPOLO - OMERALE
L'articolazione scapolo omerale formata dalla testa dell'omero e dalla cavit glenoide della scapola.
Essa una diartrosi del tipo delle enartrosi per cui pu compiere tutti i movimenti.
Le ossa interessate a questa articolazione sono la scapola e l'omero.
La scapola, chiamata anche omoplata, un osso piatto di forma triangolare situato nella parte
superiore e postero laterale del torace. La faccia anteriore, rivolta verso il torace, ha una larga fossa,
denominata fossa sottoscapolare, dalla quale si ergono alcune creste, da cui originano i fasci del muscolo
sottoscapolare (fig. n. 11).
Sulla faccia posteriore si pu notare una sporgenza ossea, che divide in due parti la faccia stessa,
denominata spina della scapola (fig. n. 12). La spina si estende dal basso in alto e dall'interno all'esterno in
forma obliqua, termina poi lateralmente con l'acromion, che ha una forma piatta allargata. Superiormente
alla spina si pu notare una fossa, denominata fossa sopraspina, da cui origina il muscolo omonimo.
Nell'angolo esterno della faccia anteriore si pu notare una cavit, denominata cavit glenoide, in cui si
articola la testa dell'omero, formando cosi l'articolazione scapolo omerale. Superiormente e medialmente
alla cavit glenoide si pu notare un protuberanza ossea, denominata apofisi coracoide.
L'omero un osso lungo, formato da una parte intermedia, denominata corpo o diafisi, e da due
estremit o epifisi. Sulla faccia laterale del corpo si pu notare una cresta rugosa a forma di V, denominata V
deltoidea, in cui si inserisce il deltoide, nella sua estremit distale (fig. n. 13). Sulla faccia posteriore del
corpo si pu notare una doccia, che va dall'alto in basso e dall'interno all'esterno, denominata doccia di
torsione (fig n. 14). Nell'estremit superiore dell'omero situata la testa dell'omero, che con la cavit
glenoide della scapola forma l'articolazione scapolo omerale. La testa collegata al corpo dell'omero
tramite il collo anatomico.
Lateralmente al collo anatomico si trovano due protuberanze ossee separate tra loro da una doccia
longitudinale, denominata doccia o solco bicipitale, entro la quale scorre il capo lungo del bicipite. Le due
protuberanze sono denominate trochite la pi grande, situata in posizione postero laterale, trochine la pi
piccola, situata in posizione antero mediale (fig. n. 13).
Per quanto riguarda la parte distale ed inferiore dell'omero rimandiamo la descrizione ai testi di
anatomia.
Per aumentare la superficie articolare la cavit glenoide dotata di un orletto fibroso-cartilagineo
denominato cercine glenoide (fig. n. 15). I mezzi di unione sono rappresentati da:
la capsula articolare;
il legamento coraco-omerale, che va dalla base dell'apofisi coracoide della scapola al trochite
dell'omero;
i legamenti gleno-omerali, superiore, medio ed inferiore, che vanno dal cercine glenoideo alla su
perfide ossea vicina al trochine;
i muscoli del cingolo scapolo-omerale (fig. n. 16).
Movimenti dell'articolazione scapolo omerale
I movimenti che l'articolazione pu compiere sono: abduzione, adduzione, anteroversione, retrover-
sione, rotazione mediale e laterale, circonduzione. Esaminiamo singolarmente i pi significativi per la
mobilit dell'articolazione.
Abduzione il movimento di elevazione del braccio sul piano frontale (fig. n. 17), esso consta di due
49
fasi: La prima, in cui il braccio arriva a 90rispetto al corpo, si ha mediante uno scorrimento verso il basso
della testa dell'omero nella cavit glenoide; essa limitata da:
la tensione nella parte inferiore che esercita la capsula;
il legamento gleno-omerale inferiore;
il contatto del tronchite con la parte superiore del cercine glenoideo.
Questa prima fase dell'abduzione dovuta alla contrazione del fascio medio del deltoide. Il deltoide si
inserisce in alto sul terzo laterale del margine anteriore della clavicola, sull'apice e sul margine laterale
dell'acromion, sul labbro inferiore del margine posteriore della spina della scapola; in basso fissato sulla V
deltoidea dell'omero.
La seconda fase, in cui il braccio pu arrivare fino a 180 dovuta ad un basculamento della scapola.
La scapola tramite questo movimento, sposta l'angolo inferiore in fuori, dirige l'orientamento della cavit
glenoide verso l'alto, permettendo cosi al braccio di elevarsi fig. n. 18
Il muscolo interessato a questo movimento il grande dentato, che si estende dalla faccia esterna delle
prime nove coste al margine spinale della scapola.
Anteroversione - il movimento, che si ha, quando dalla posizione eretta (braccia lungo i fianchi) si
porta il braccio in avanti, descrivendo con l'estremo distale dell'omero un arco di cerchio.
Il movimento avviene tramite lo slittamento della testa dell'omero nella parte bassa posteriore della
cavit glenoide.
Questo movimento limitato da:
la distensione della parte posteriore della capsula;
lo stiramento delle fibre posteriori del legamento coraco brachiale;
la distensione del tendine del muscolo piccolo rotondo.
Il muscolo interessato a questo movimento il fascio anteriore del deltoide.
Retroversione - l'opposto del movimento precedente. In esso la testa dell'omero slitta in avanti alto
sopra la superficie della cavit glenoide, descrivendo con l'estremo distale, verso l'indietro, un arco di
cerchio meno ampio del precedente.
Questo movimento limitato da:
la tensione delle fibre anteriori del legamento coraco omerale;
la distensione della parte anteriore della capsula;
l'arrotolamento intorno alla testa dell'omero del tendine del muscolo sottoscapolare.
Il muscolo interessato a questo movimento il grande rotondo, che si inserisce da un lato sul terzo
inferiore della superficie ossea sottospinosa e sulla faccia posteriore dell'angolo inferiore della scapola,
dall'altro sul labbro posteriore del solco bicipitale dell'omero.
Circonduzione - l'insieme dei movimenti precedentemente descritti che si susseguono in ordine
cronologico, descrivendo una figura conica molto piatta, la cui base descritta dalla parte distale dell'ome-
ro, ed il cui vertice sta nell'articolazione scapolo-omerale.
Questo movimento ha una grande ampiezza. La ragione sta nella grande mobilit della scapola, la
quale con i suoi movimenti orienta la cavit glenoide in tutte le direzioni, evitando cos il contatto tra il trochite
dell'omero ed il cercine glenoideo.
50
APOFISI CORACOIDE MARGINE SUPERIORE
Fig.11
SCAPOLA DESTRA-FACCIA ANTERIORE
SPINA DELLA SCAPOLA
ANGOLO INFERIORE
Fig.12
SCAPOLA DESTRA-FACCIA POSTERIORE
TROCHITE
TROCHINE
SOLCO
BICIPITALE
V. DELTOIDEA
FOSSETTA CORONOIDEA
J: \\/
EPICONDILO
-EPITROCLEA
-TROCLEA
CONDILO
Flg. 13
OMERO DESTRO VEDUTO DAL DAVANTI
EPITROCLEA
TROCLEA -
V. DELTOIDEA
SOLCO RADIALE 0 DOCCIA DI TORSIONE
FOSSA OLECRANICA
Flg.14
OMERO DESTRO VEDUTO DA DIETRO
51
Fig.15
ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE
SOPRASPINOSO
SOTTOSCAPOLARE
CAPO LUNGO DEL TRI CI PI TE
GRANDE ROTONDO
CAPOLUNGO DEL
Fig.16
ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE (INSERSIONI
MUSCOLARI)
Fig. 17 ELEVAZIONE DEL BRACCIO Fig.18
Scherno delle escursioni angolari delle vore articolazioni
che concorrono al movimento di elevazione verticale
del braccio
52
ARTICOLAZIONE COXO - FEMORALE
L'articolazione coxo-femorale formata dalla testa del femore e dalla cavit cotiloide dell'osso iliaco.
L'osso iliaco si articola con l'osso iliaco del lato opposto e con la porzione sacro-coccigea della colonna
vertebrale per formarne il bacino.
L'osso iliaco (fig. n. 19) nella vita fetale diviso in tre ossa distinte: ileo, pube, ed ischio. Nell'adulto
queste tre ossa sono unite e formano un solo osso. Sulla faccia esterna si pu notare una cavit in cui si
articola la testa del femore, denominata cavit acetabolica o cavit cotiloide. Davanti alla cavit acetabolica
vi un foro, detto foro otturato.
Nella faccia intema dell'osso (fig. n. 20) vi una linea arrotondata, denominata linea innominata, al di
sopra di questa linea si estende la fossa iliaca, costituita da una larga superficie leggermente concava. I
margini dell'osso sono divisi in quattro: superiore, inferiore, anteriore e posteriore.
Il margine superiore chiamato anche cresta iliaca.
Il margine inferiore presenta la tuberosit ischiatica, la branca discendente del pube ed ascendente
dell'ischio.
Il margine anteriore presenta nell'ordine dall'alto in basso: la spina iliacaantero-superiore, l'incisura
innominata, la spina iliaca antero-inferiore, una superficie pianeggiante ed informe, il tubercolo e la spina
del pube.
Il femore costituito da un corpo e due estremit (fig. n. 21 ). Sul corpo del femore possiamo distinguere
le facce, mediale e laterale, dove sono inseriti i fasci del muscolo quadricipite femorale. Sulla parte
posteriore del corpo si pu notare un margine munito di una triforcazione sulla quale si inseriscono numerosi
muscoli, chiamato linea aspra. Sulla estremit superiore, l'osso ha una conformazione sferica, chiamata
testa del femore, collegata al corpo del femore dal collo anatomico, in posizione postero-laterale al collo del
femore vi una protuberanza ossea, chiamata grande trocantere, mentre in posizione mediale ed inferiore
vi un'altra protuberanza denominata piccolo trocantere. La testa del femore si inserisce nella cavit
cotiloide dell'osso iliaco, formando con essa P articolazione dell'anca o coxo-femorale.
Sull'estremit inferiore si possono notare due protuberanze ossee, una mediale ed una laterale, dette
condili. In mezzo a questi due condili si pu notare una doccia profonda a forma di puleggia, chiamata
troclea.
L'articolazione coxo-femorale (fig. n. 22) tra le pi importanti, su di essa gravano circa i due terzi del
peso corporeo. una enartrosi ed ha una grande mobilit, anche se inferiore a quella della scapolo
omerale. formata, come si gi detto, dalla testa del femore e dalla cavit cotiloide.
La cavit cotiloide ha una forma emisferica, che si pu dividere in due parti; la facies lunata all'esterno,
e la fossa acetabolare all'interno, dove si inserisce il legamento rotondo. Nel margine esterno della cavit
cotiloide c' un orletto, che aumenta la superficie articolare, chiamato cercine cotiloideo.
I mezzi di unione dell'articolazione sono rappresentati dalla capsula fibrosa, che si inserisce sul collo
del femore nella parte inferiore, sul cercine cotiloideo e sulla superficie ossea adiacente nella parte
superiore, e dai seguenti legamenti (fig. n. 23):
a) ileo femorale, che nella parte prossimale si inserisce sulla spina iliaca antero-inferiore, e nella parte
distale si divide in due fasci, uno inserito sul piccolo trocantere, ed uno sul grande trocantere;
b) pubo-femorale, che va dal bordo della cavit cotiloide alla capsula fibrosa;
e) rotondo, un legamento intracapsular che si inserisce sulla testa del femore da un lato e nella cavit
acetabolare dall'altro (fig. n. 22).
53
Movimenti dell'articolazione coxo - femorale
I movimenti che pu compiere l'articolazione coxo-femorale sono: flessione, estensione, abduzione,
adduzione, rotazione, ed una circonduzione limitata. Esaminiamoli singolarmente.
Flessione della coscia sul bacino. Per la flessione abbiamo diversi valori a seconda che venga
effettuata a gamba tesa o a gamba flessa, in forma attiva o in forma passiva. I valori, in forma passiva,
fornitici dal Dal Monte sono: a gamba tesa 120, a gamba flessa 145.
I differenti valori sono dovuti alla tensione dei muscoli flessori della gamba sulla coscia.
I muscoli che intervengono in questo movimento (fig. n. 24) sono:
il tensore della fascia lata che si inserisce in alto sulla spina iliaca antero-superiore, in basso sulla
tuberosit laterale della tibia;
lo psoas-iliaco, costituito in alto da due parti, inserite rispettivamente sulla base e sul corpo delle apofisi
trasverse della dodicesima vertebra dorsale e di tutte le lombari lo psoas, sulla fossa iliaca interna e
sulla cresta iliaca l'iliaco, in basso il muscolo si inserisce sul piccolo trocantere del femore;
il sartorio, in alto si inserisce sulla spina iliaca antero-superiore e sull'incisura sottostante, in basso sulla
parte pi alta della faccia mediale della tibia.
Estensione della coscia sul bacino. Anche per questo movimento abbiamo dei diversi valori, a
seconda che venga effettuato a gamba tesa o flessa, in forma attiva o passiva. Essi sono:
in forma attiva a gamba tesa 20;
in forma attiva a gamba flessa 30.
Questi differenti valori sono dovuti alla tensione dei muscoli estensori della gamba sulla coscia, e dei
legamenti.
I muscoli che interessano questo movimento sono:
il grande gluteo, si inserisce in alto sulla faccia laterale dell'osso iliaco e sulla parte adiacente del labbro
esterno della cresta iliaca, in basso sulla tuberosit glutea del femore;
il bicipite femorale, in alto diviso in due capi, il lungo si inserisce sulla tuberosi ischiatica, il breve sul
terzo medio del labbro laterale della linea aspra, in basso si inserisce sulla testa del perone;
il semitendinoso, in alto si attacca sulla tuberosit ischiatica, vicino al bicipite femorale, in basso sulla
parte pi alta della faccia mediale della tibia;
il semimembranoso, in alto ha origine sulla tuberosit ischiatica, in basso il tendine si divide in tre fasci,
il discendente, che si inserisce sulla parte posteriore del condilo mediale della tibia, l'orizzontale che si
inserisce sulla parte antero-mediale di detto condilo, il ricorrente che si inserisce sul guscio fibroso del
condilo laterale del femore e sullo spazio intercordileideo.
Abduzione - Per questo movimento occorre prendere in considerazione ambedue gli arti inferiori,
perch abducendo un arto si ha una rotazione del bacino nel senso dell'abduzione, per cui automaticamen-
te l'altro arto rimane abdotto (fig. n. 25).
I fattori che delimitano questo movimento sono il legamento pubo-femorale, l'ischio femorale, ed il
contatto del grande trocantere sull'ileo.
Altro fattore che influenza l'ampiezza del movimento lo stato di flessione dell'arto, maggiore ad arto
flesso, minore ad arto esteso.
I valori che si possono raggiungere, con il movimento contemporaneo di ambedue gli arti, sono di
120-130in forma attiva, fino a 180in forma passiva.
I muscoli interessati a questo movimento sono:
il tensore della fascia lata, gi descritto in precedenza;
il piccolo gluteo, che si origina in alto sulla faccia laterale dell'osso iliaco e sul labbro esterno della
cresta iliaca, in prossimit della spina iliaca antero-superiore, e in basso si inserisce sul margine
anteriore del grande trocantere;
54
CAVIT* COTILOIDE 0
ACETABOLICA
FORO OTTURATO
Fig. 19
OSSO ILIACO DESTRO-FACCIA ESTERNA
CAVITA COTILOIDE
SINFISI PUBICA
Fig. 20
BACINO-VISTO DAL DAVANTI
LINEA
INNOMINATA
GRANDE TROCANTERE
FACCIA ANTERIORE
CONDILO LATERALE
TROCLEA
Flg. 21 FEMORE DESTRO-VEDUTO DAL
DAVANTI
CERCINE
COTILOIDEO
FOSSA ACETABCUC
Flg 22 ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE
55
MUSCOLO RETTI
ANTERIORE
LEGAMENTO
PUBOFEMORALE
PSOAS ILIACO
Fig.23 MUSCOLATURA DELL'ARTICOLAZIONE
DELL'ANCA
Fig. 24 MUSCOLI FLESSORI DELL'ANCA
A- ABDUZIONE VERA DELLA
COSCIA
B-ABDUZIONE DELLA COSCIA
CON BASCULA DEL BACINO
Flg. 25
56
il medio gluteo, che si inserisce in alto sulla faccia esterna dell'osso iliaco e in basso sulla faccia laterale
del grande trocantere.
Adduzione - un movimento che pu verificarsi quando l'arto inferiore in flessione o in estensione.
Il valore che pu raggiungere questo movimento di 30-40.
I muscoli interessati sono:
il muscolo gracile, ha origine in alto sulla superficie angolare del pube, termina in basso sulla parte
prossimale della faccia mediale della tibia;
il pettineo, si inserisce in alto sul tubercolo del pube e sulla cresta pettinea e termina in basso sulla linea
pettinea del femore (tra la linea aspra ed il piccolo trocantere)
il lungo adduttore, si inserisce in alto sulla faccia anteriore del pube (fra il tubercolo e la sinfisi), termina
in basso sul terzo medio del labbro mediale della linea aspra del femore;
l'adduttore breve, si origina sulla superficie angolare del pube e termina sul terzo superiore del labbro
mediale della linea aspra;
il grande adduttore, si inserisce in alto sulla tuberosit ischiatica e sulla branca ischio pubica, in basso
sul labbro mediale e sul ramo mediale di biforcazione della linea aspra del femore.
Rotazione - Anch'essa condizionata dalla posizione dell'arto, infatti a coscia flessa pu raggiunge-
re i 90, a coscia distesa non supera i 50-60.
Per i muscoli interessati a questo movimento dobbiamo fare una distinzione tra rotazione in dentro e
rotazione in fuori.
Per la rotazione in dentro i muscoli interessati sono:
il medio gluteo (gi descritto);
il piccolo gluteo (gi descritto).
Per la rotazione in fuori i muscoli sono:
il grande gluteo (gi descritto);
il bicipite femorale (gi descritto);
il muscolo gracile (gi descritto);
il pettineo (gi descritto);
il lungo adduttore (gi descritto);
l'adduttore breve (gi descritto);
il grande adduttore (gi descritto);
l'otturatore interno, si attacca sulla faccia interna della membrana otturatrice, dalla superficie quadrila-
tera posta tra la grande incisura ischiatica ed il foro otturato, e termina nella parte superiore della cavit
digitale del grande trocantere del femore;
l'otturatore esterno, si origina dal ramo ascendente dell'ischio, dalla faccia anteriore del ramo orizzon-
tale e discendente del pube e dalla benderella sottopubica, termina nel fondo della cavit digitale del
grande trocantere del femore;
il piramidale del bacino, prende origine in alto, mediante tre fasci, sulla faccia anteriore dell'osso sacro,
precisamente intorno al secondo e terzo foro, e termina sul margine superiore del grande trocantere";
i gemelli pelvici, sono distinti in superiore e inferiore, il gemello superiore si attacca sulla faccia esterna
e sul margine inferiore della spina ischiatica, il gemello inferiore,invece, si attacca sulla tuberosit
ischiatica; ambedue terminano in parte sul tendine dell'otturatore interno e in parte nella cavit digitale
del grande trocantere del femore;
il quadrato del femore, prende origine sul margine laterale della tuberosit ischiatica e termina sul
grande trocantere del femore.
Circonduzione - l'insieme, in ordine cronologico, dei movimenti precedentemente descritti, la sua
ampiezza molto pi limitata di quella del movimento corrispondente della scapolo omerale.
57
ESERCIZI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILIT
Mobilizzazione dell'articolazione occipito-atlantoidea e del tratto cervicale del rachide
Mobilizzazione attiva
1 ) Flessioni ed estensioni della testa sul piano sagittale.
Posizione di partenza:
eretta, testa rivolta in avanti, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
flessione - portare la testa in avanti-basso, in modo tale che il mento urti sullo sterno;
estensione - portare la testa indietro in modo tale che la nuca urti sul dorso.
2) Inclinazioni laterali della testa a destra ed a sinistra, sul piano frontale.
Posizione di partenza:
eretta, testa rivolta in avanti, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
portare la testa in modo tale che il lobo dell'orecchio vada ad urtare sulla spalla.
3) Circonduzioni della testa.
Posizione di partenza:
eretta, testa appoggiata sullo sterno, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
portare la testa sulla spalla destra, indietro, sulla spalla sinistra e di nuovo sullo sterno, senza soluzione
di continuit.
Osservazioni:
eseguire l'esercizio ad occhi aperti, cambiare senso di rotazione ogni due o tre ripetizioni, per evitare il
senso di vertigine che si viene a creare eseguendo l'esercizio sempre nello stesso senso.
4) Torsioni della testa.
Posizione di partenza:
eretta, testa rivolta in avanti, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
ruotare la testa alternativamente a destra ed a sinistra, intorno ad un asse passante all'incirca al centro
dell'articolazione dall'alto verso il basso.
Mobilizzazione passiva.
1 ) Flessioni (avanti e indietro), inclinazioni laterali, circonduzioni.
Attrezzo: Materassina.
Posizione di partenza:
a terra in ginocchio, testa appoggiata sul tappeto, mani sulla materassina all'altezza della testa.
Esecuzione:
caricando sulla testa il peso del tronco eseguire i movimenti gi descritti.
Variante:per aumentare il carico sull'articolazione occipito-atlantoidea passare dalla posizione in
ginocchio ad una posizione a gambe divaricate e tese, con testa il pi vicino possibile alla linea
passante per i piedi, e mani dietro la schiena.
58
Mobilizzazione prevalente del tratto dorsale del rachide
Mobilizzazione passiva
1 ) Inclinazioni laterali del busto a destra e sinistra.
Posizione di partenza:
eretta, gambe leggermente divaricate, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
portare il busto di lato facendo compiere alla colonna vertebrale un arco con concavit verso un lato e
successivamente verso l'altro.
Variante:
portare le mani dietro la nuca.
Mobilizzazione attiva
1 ) Torsioni del busto.
Posizione di partenza:
eretta, gambe divaricate, braccia orizzontali piegate a 90.
Esecuzione:
ruotare alternativamente il busto a destra ed a sinistra.
Variante:
braccia tese in fuori.
2) Circonduzioni del busto (mobilit fortemente anche il tratto lombare)
Posizione di partenza:
gambe divaricate, posizione del busto inclinata in avanti, mani ai fianchi.
Esecuzione:
portare il busto inclinato su un lato, indietro, sull'altro lato, in avanti.
Osservazioni:
far eseguire i movimenti ad occhi aperti ed invertire il senso di rotazione ogni due tre ripetizioni.
Variante:
portare le mani dietro la nuca.
Mobilizzazione prevalente del tratto lombare del rachide
Mobilizzazione passiva.
1 ) Flessione del busto in avanti.
Posizione di partenza:
eretta, braccia in alto distese, gambe unite e tese.
Esecuzione:
portare il busto in avanti-basso, fino a toccare la faccia sulle gambe e le palme delle mani per terra.
Variante:
per aumentare l'impegno dell'esercizio, portare le mani dietro la nuca, o dietro la schiena.
2) Estensioni del busto indietro.
Posizione di partenza:
eretta, braccia in alto distese, gambe unite.
Esecuzione:
portare il busto indietro-in basso ed il bacino in avanti, testa estesa indietro.
Variante:
come l'esercizio precedente;
3) Estensioni alla spalliera del busto all'indietro (mobilita anche l'articolazione scapolo omerale)
Attrezzo: spalliera.
Posizione di partenza:
seduti dorso alla spalliera, gambe piegate in appoggio plantare, braccia che impugnano la spalliera
all'altezza della testa.
59
Esecuzione:
raddrizzare le gambe, spostare il bacino e le spalle in avanti, stendendo le braccia, e terminare in
iperestensione dorsale.
Mobilizzazione attiva.
1) Flessioni del busto in avanti.
Attrezzo: panca.
Posizione di partenza:
decubito supino, arti inferiori bloccati, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
portare il tronco in alto-in avanti in modo da toccare le ginocchia con la faccia.
Variante:
per aumentare l'impegno portare le mani dietro la nuca oppure in alto sopra la testa.
2) Estensioni del busto indietro.
Attrezzo: panca.
Posizione di partenza:
decubito prono, arti inferiori bloccati, tronco sporgente sulla panca, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
portare il tronco in alto.
Variante:
per aumentare l'impegno portare le mani dietro la nuca oppure in alto sopra la testa.
Mobilizzazione della articolazione scapolo - omerale
Mobilizzazione attiva.
1 ) Slanci delle braccia per avanti-alto e in basso-dietro.
Posizione di partenza:
eretta, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
portare le braccia, slanciandole, in avanti-alto e, di seguito, in avanti-basso-dietro.
2) Slanci delle braccia in fuori.
Posizione di partenza:
eretta, braccia in avanti.
Esecuzione:
portare le braccia, slanciandole, in fuori, portando contemporaneamente le palme verso l'alto.
3) Circonduzione delle braccia.
Posizione di partenza:
eretta, braccia lungo i fianchi.
Esecuzione:
portare le braccia in avanti, alto, dietro, basso, avanti; dopo alcune ripetizioni invertire.
Mobilizzazione passiva.
1 ) Circonduzione forzata degli arti superiori.
Attrezzo: bastone.
Posizione di partenza:
eretta, braccia in basso avanti, impugnare con ambedue le mani un bastone.
Esecuzione:
portare il bastone in avanti, alto, dietro, basso e ritornare per basso, dietro, alto, avanti.
Osservazioni:
durante l'esecuzione mantenere gli arti superiori distesi e non allargare l'impugnatura di partenza sul
bastone.
60
2) Retroversione (o proiezione indietro) forzata degli arti superiori.
Con partner.
Posizione di partenza:
supini, braccia in fuori, partner seduto dietro con presa ai polsi.
Esecuzione:
il partner porta le braccia dell'esecutore, facendole passare per il basso-dietro, in retroversione
forzata, portandole pi in avanti possibile ed avvicinandole fino a far toccare le mani tra di loro.
Mobilizzazione della articolazione coxo - femorale
Mobilizzazione attiva.
1 ) Flessione della coscia sul bacino sul piano sagittale.
Posizione di partenza:
eretta, braccia lungo i fianchi, gambe unite.
Esecuzione:
portare la coscia in avanti alto, in modo tale da toccare il petto con il ginocchio.
Osservazioni:
l'arto che rimane a terra deve rimanere disteso, il busto non deve flettersi in avanti.
2) Flessione della coscia sul bacino sul piano frontale.
Posizione di partenza:
eretta, braccia in avanti basso con le palme delle mani appoggiate sull'inguine, gambe unite.
Esecuzione:
portare la coscia in alto di lato, avvicinando il pi possibile il ginocchio alla spalla.
Osservazioni:
l'arto che rimane a terra deve rimanere disteso, il busto non deve flettersi di lato.
3) Circonduzione della coscia sul bacino.
Posizione di partenza:
eretta, braccia in avanti basso con le palme delle mani appoggiate sull'inguine, gambe unite.
Esecuzione:
portare la coscia in avanti-alto, in fuori, indietro e quindi di nuovo in posizione di partenza.
4) Slanci dell'arto inferiore in avanti e in dietro sul piano sagittale.
Posizione di partenza:
eretta, mani sui fianchi, gambe unite.
Esecuzione:
portare l'arto inferiore verso l'avanti-alto, avvicinando il pi possibile il ginocchio al petto, e successiva-
mente verso l'indietro-alto.
Osservazioni:
l'arto che rimane a terra deve rimanere disteso, il busto non deve flettersi in avanti, l'arto che si muove
deve essere a ginocchio bloccato.
5) Slanci dell'arto inferiore verso l'esterno (in fuori) e verso l'interno (in dentro) sul piano frontale.
Posizione di partenza:
eretta, mani sui fianchi, gambe unite.
Esecuzione:
portare l'arto inferiore verso l'esterno-alto e successivamente verso l'interno-alto sollevandolo il pi
possibile.
Osservazioni:
l'arto che rimane a terra deve rimanere disteso, il busto non deve inclinarsi, l'arto che si muove deve
essere a ginocchio bloccato.
61
TEST DI VALUTAZIONE PER LA MOBILIT
1 ) Estensione all'indietro della colonna vertebrale.
Misurare la distanza che intercorre tra la testa ed i piedi del giovane che si trova nella posizione di ponte
al massimo dell'altezza.
2) Flessione in avanti della colonna vertebrale.
Dalla posizione eretta sopra di una panca si effettua una flessione massima del busto in avanti. La
misurazione si far tenendo fisso un metro con i 50 cm. in corrispondenza del piano della panca.
3) Inclinazione laterale della colonna vertebrale.
Si mette il giovane con le spalle al muro e si misura nella posizione eretta il punto in cui arriva la mano, si
fa effettuare una inclinazione massima laterale e si prende nuovamente la misura dove arriva la punta
delle dita. La differenza fra questi due punti il valore della flessibilit laterale.
4) Circonduzione degli arti superiori con bastone centimetrato.
Mettere il giovane in posizione eretta. Fare impugnare il bastone con ambedue le mani. Portare il
bastone in avanti, alto, dietro, senza piegare gli arti superiori. Il valore della mobilit dato dall'impu-
gnatura delle mani sul bastone.
5) Divaricata degli arti inferiori sul piano sagittale (spaccata).
Sorreggendosi ad un appoggio, divaricare gli arti inferiori uno in avanti e l'altro indietro. La mobilit
data dalla distanza tra il pube e la terra.
62
La periodizzazione dell'allenamento
CONCETTO E PRINCIPI DELLA PERIODIZZAZIONE
Individuati tutti i mezzi di allenamento di cui si pu disporre, importante attingervi a pie-
ne mani, non privilegiandone alcuni a scapito degli al tri , ma dando solo la preferenza in senso
quantitativo a quelli che, in funzione dell'et e della qualificazione dell'atleta, devono essere
usati pi degli altri in quel determinato periodo della stagione agonistica.
Si deve quindi operare una scelta che determini il contenuto degli allenamenti, vale a
dire una scelta dei mezzi da usare e della metodologia con cui vanno usati.
Cos facendo non si fa altro che pianificare gli allenamenti o, per meglio dire, program-
marli, in quanto la programmazione la realizzazione pratica della pianificazione, intendendo-
si per pianificazione la proiezione di una attivit futura per un periodo di tempo piuttosto
lungo.
Attualmente il principio razionale ispiratore della pianificazione, e quindi della program-
mazione dell'allenamento sportivo quello della periodizzazione, cio della suddivisione in
periodi del ciclo annuale dell'allenamento.
In passato si faceva dipendere la periodizzazione dal calendario agonistico, oggi si cerca
di far dipendere il calendario agonistico dalla periodizzazione, si cerca cio di compilare il ca-
lendario in modo tale che i principi basilari della periodizzazione vengono rispettati.
I principi della periodizzazione obbediscono a precise leggi fisiologiche che governano
la capacita dell'organismo di raggiungere il miglior grado di forma e di mantenerlo per un
certo tempo; essi possono venir riassunti in poche parole: le gare importanti devono essere
concentrate in uno od al massimo due periodi non troppo lunghi; ogni periodo agonistico vero
e proprio deve essere preceduto da un periodo preparatorio sufficientemente lungo; al ter-
mine di ogni periodo preparatorio vanno inserite gare non importanti, di controllo, con im-
pegno crescente, per disputare le quali pero non va modificato il piano di lavoro; al termine
di ogni periodo agonistico (fondamentale) bene fare un periodo transitorio, anche se breve,
di relativo riposo.
Un calendario razionalmente concepito deve inoltre tenere conto anche dell'et degli atle-
ti cui e destinato
Purtroppo ancora oggi il calendario agonistico risponde solo in parte a questi requisiti,
dovendo coloro che lo stilano barcamenarsi tra il rispetto dei principi che ispirano la perio-
dizzazione ed altre esigenze di varia natura di cui impossibile non tener conto.
Nel prosieguo di questo lavoro si cercher di teorizzare la periodizzazione dell'allena-
mento in modo abbastanza pratico, portando varie esemplificazioni per chiarirne al massimo
i principi Sara compito poi di ogni singolo allenatore adattare questi principi alle proprie esi-
genze nel miglior modo possibile, tenendo conta del calendario effettivo, dell'et degli atleti,
della loro qualificazione e del tempo a disposizione per gli allenamenti.
65
CONCETTO E FASI DELLA FORMA SPORTIVA
Cerchiamo ora di analizzare un po' pi a fondo il concetto di forma sportiva e le leggi
che ne regolano lo sviluppo, poich, come si gi detto, la periodizzazione dell'allenamento
deve, per quanto possibile, basarsi su di esse.
Innanzitutto distinguiamo tra condizione fisica e forma. La condizione fisica determi-
nata da un alto livello delle capacit funzionali dell'organismo, possiamo dire che uno
status di base dell'atleta che pu essere mantenuto molto a lungo. La forma, che un atleta
pu raggiungere solo partendo da una buona condizione fisica, molto difficile da definire;
potremo indicarla come quello stato in cui l'atleta riesce a sintetizzare tutte le proprie ca-
pacit fisiche ed a finalizzarle ad uno scopo ben preciso, quello agonistico, rendendosi dispo-
nibile al massimo rendimento sia da un punto di vista fisico che psichico.
Vi sono tre teorie sul raggiungimento e sj l mantenimento della forma. La prima la con-
sidera uno stato estremamente labile che pu essere raggiunto rarissime volte nella carriera
agonistica di un atleta, a volte anche inaspetta:amente. Questa teoria, pur fondandosi su dei
dati di fatti obiettivi, si riferisce solo a punte estreme che non possono ovviamente condizio-
nare la periodizzazione. La seconda, al contrario, considera possibile mantenere un alto gra-
do di forma per periodi molto lunghi; evidente come qui si confonda lo stato di condizione
con lo stato di forma. La terza, che quella che riteniamo pi rispondente alla realt e quin-
di quella da prendere in considerazione nella periodizzazione, considera la forma uno stato che
pu essere raggiunto uno, due. al massimo tre volte in un anno e mantenuto per un certo pe-
riodo di tempo, la cui durata determinata dal numero d picchi annuali che intendiamo far
raggiungere allo stato di forma. Fig. n. 6
wr//////^-//y/>A
<0J
X.
, *
| 11
! I l
t
.
y
L
V
(
v y
V
v
FIGN 6
Zi " VS/MVW*
Uuiq*pr.airi der isorllulnn Form
Fig. n. 6 - Tipi pri nci pal i di dinamica del rendi mento nel l ' arco di un ci cl o annuale di al l enamento e loro supposto
rapporto con le fasi della forma sporti va. Gli esempi sono presi dai l anci atori del l ' at l et i ca l eggera;
val ori medi .
Legenda:
JD = media annuale dei ri sul t at i .
ZE = fase i ntermedi a.
Moriate des Zykl us = mesi del ci cl o.
Entwi ckl ungsphasen des sportl i chen Form = fasi di svi l uppo del l a forma sport i va.
Sportl i che Leistung rel ati v zum Jahresmi ttel ni veau = prestazi one agoni sti ca rel ati va al l i vel l o annuale
medi o.
66
Nel processo di acquisizione della forma si distinguono tre fasi: di sviluppo, di manteni-
mento e di perdita temporanea.
La fase di sviluppo comprende due tappe:
1) ricerca di una efficienza generale allo scopo di aumentare le capacit funzionali dell'or-
ganismo. Ci si ottiene attraverso una attivit il pi multiforme e poliedrica possibile;
2) ricerca degli elementi che portano al raggiungimento della forma vera e propria attra-
verso la prevalenza del lavoro specifico sia per quanto riguarda le qualit fisiche che le
capacit tecnico-tattiche.
La fase di mantenimento o di stabilizzazione caratterizzata da leggere ondulazioni del
grado di forma, dovute all'andamento ondulatorio dei carichi di allenamento, che si realizza
con opportune variazioni della quantit e della intensit, oppure dovute a cause contingen-
ti di lieve entit come piccoli traumi o leggere indisposizioni; le oscillazioni in ogni modo
non devono essere marcate.
La fase della perdita temporanea della forma si ha nel periodo transitorio ed caratteriz-
zata da un calo della condizione generale che per non deve essere troppo pronunciato. A ta-
le proposito chiaramente da evitare un abbandono assoluto dell'attivit fisica; si deve anzi
cercare, con un allenamento appropriato, di mantenere la condizione fisica ad un livello ac-
cettabile, cos da poter raggiungere nel successivo periodo di formazione (prima tappa dello
sviluppo) un livello pi elevato di rendimento di quello raggiunto nel ciclo precedente.
E' molto importante ricordare che l'eccessivo prolungamento del periodo di mantenimento
causa delle difficolt notevoli nello sviluppo della forma nel ciclo successivo.
Per quanto riguarda la durata ottimale delle varie fasi del ciclo di sviluppo della forma
(fase di formazione pi fase di mantenimento pi fase di perdita temporanea), questa dipende
dall'et dell'atleta, dalle sue peculiarit individuali e dal livello della sua condizione fisica
generale. Per i giovani la periodizzazione deve essere pi elastica, gli obiettivi immediati
sono meno importanti e il fine principale deve essere quello di alzarne il livello delle qua-
lit fisiche facendogli nel contempo fare esperienze agonistiche molteplici; di conseguenza il
tempo da dedicare alla prima tappa della fase di formazione sar notevole, mentre sar di mol-
to inferiore il tempo da dedicare alla seconda tappa, sempre della fase di formazione, ed alla
fase di mantenimento.
Per gli atleti pi anziani ed evoluti invece la possibilit di miglioramento delle qualit
fisiche ormai limitata, mentre la loro stabilit notevole, quindi potr essere pi breve il
tempo dedicato allo sviluppo della forma e conseguentemente pi lungo il tempo dedicato al
mantenimento della stessa. Per questi ultimi l'allenamento in sostanza potr e dovr essere
finalizzato esclusivamente per il raggiungimento di determinati obiettivi. Adottando un ciclo
annuale il periodo dedicato allo sviluppo della forma potr essere di 5-6 mesi, non pretenden-
do ovviamente di mantenere la forma al massimo per tutta la fase di mantenimento, ma fa-
cendole compiere leggere ondulazioni.
Adottando un ciclo semestrale invece, allo sviluppo della forma saranno destinati non
pi di 1-2 mesi. In quest'ultimo caso si verificher una sovrapposizione tra la fase di per-
dita della forma di un ciclo e la fase di sviluppo del ciclo successivo, questo perch i periodi
non debbono considerarsi rigidamente delimitati, ma collegati tra loro nel tempo.
L'adozione di tre cicli ogni anno da scorsigliarsi perch meno razionale delle due sopra
esposte, quindi ogni calendario ben congegnato dovrebbe non invogliare gli allenatori ad adot-
tarla.
Per i giovani si deve consigliare una periodizzazione con un ciclo annuale, per gli atleti
pi evoluti quella semestrale: anche per questi ultimi comunque ogni 4-6 cicli semestrali
bene introdurre un ciclo annuale, in quanto c'ue cicli semestrali implicano, rispetto ad un ci-
clo annuale, un maggior numero di impegni agcnistici ad alto livello e di conseguenza una mag-
gior fatica psico-fisica.
67
LA COSTRUZIONE DELL'ALLENAMENTO
Si realizza partendo dai principi dell'allenamento che abbiamo esposto: la multilateralit,
la continuit, la dinamica e la ciclicit dei carichi, la individualizzazione.
L'allenamento nella sua totalit va costruito programmandolo unit per unit; ogni alle-
namento singolo per va programmato tenendo conto del microciclo in cui inserito e degli
altri allenamenti singoli del microciclo; ogni microciclo tenendo conto del mesociclo in cui
inserito e degli altri microcicli del mesociclo; ogni mesociclo tenendo conto del periodo cui
si riferisce.
Vediamo ora come si pu costruire razionalmente un singolo allenamento, un microci-
clo e un mesociclo, portando anche alcuni esempi in modo da chiarire ancor pi le idee.
Struttura di un allenamento singolo
Ogni allenamento singolo, si compone di tre parti: preparatoria, fondamentale, conclusiva.
La parte preparatoria detta comunemente riscaldamento , in essa si eseguono eserci-
zi di ginnastica generale, di mobilit, di imitazione, per la concentrazione ed alcuni esercizi
specifici come gli esercizi in ponte. La durata media della parte preparatoria sar di circa 20
minuti; sar pi breve per allenamenti in cui si dedicher molto tempo alla parte fondamen-
tale e pi lunga e pi ricca di contenuti per allenamenti in cui la parte fondamentale sar ab-
bastanza breve e molto intensa.
La parte fondamentale avr una durata che potr variare dai 60 ai 120 minuti e pi, na-
turalmente la durata dipender dai contenuti e dall'intensit del carico. In genere la parte fon-
damentale sar finalizzata, vale a dire che essa sar dedicata prevalentemente allo sviluppo
delle qualit fisiche o della tecnica (apprendimento o perfezionamento) o della tattica (pre-
parazione colpi) o della tecnica e della tattica (perfezionamento e preparazione colpi). Per quan-
to riguarda le qualit fisiche in genere, sar bene finalizzare ulteriormente l'allenamento, e
non dedicare la stessa seduta allo sviluppo di tutte le qualit fisiche; vi deve essere perlo-
meno la netta prevalenza di una sulle altre.
Naturalmente nella parte fondamentale ricadono tutti i tipi di incontro.
La parte conclusiva, durata media 20 minuti, sar dedicata ad esercizi di allungamento e
rilassamento, potr comprendere anche la sauna e i massaggi e, come la parte preparatoria,
sar pi lunga e varia se la parte fondamentale stata breve e con grande intensit di carico.
Alcuni esempi di come si costruisca una singola unit di allenamento si possono vedere
negli schemi n. 2-3-4-5.
68
ESEMPIO DI UNA SINGOLA UNITA' DI ALLENAMENTO
Parti
<
oc
O
i -
<
ce
<
a.
LU
CE
Q_
LU
_ l
<
1
z
LU
<
Q
z
O
Li .
<
>
CO
_ J
o
z
o
o
CONTENUTO
Corsa l eggera; Corsa vari a; Eser-
cizi di gi nnasti ca general e; Eser-
cizi per la concentrazi one nervo-
sa; Esercizi di mobi l i t
Esercizi di acrobati ca (tuffi a pe-
sce capri ol e i ndi etro, ri bal tate
in avanti , ri bal tate i ndi et ro, sal ti
mort al i in avanti , sal ti mortal i
i ndi et ro, vari ti pi di ruota . . . )
Al t r i t i pi di balzi vari (i n l ungo,
in al to, l ateral i , su una gam-
ba. . . )
Corsa, scatti brevi (50 mt.)
Corsa scatti media di st. (200 mt.)
Corsa vel oci t prolungata
Giuochi sport i vi (a t enere la pal-
la, due squadre di 4-5)
Esercizi di ri l assamento e allun-
gamento
INDICAZ. METODOLOG.
Brevi ri cuperi tra un
eserci zi o e l' altro
Di vi si in gruppi di 5-6,
con sostegno o senza
secondo l' abilit
Ricupero tra una ese-
cuzione e l' altra
Balzi si ngol i e in seri e
di 5-6, buon ri t mo
Ricupero tra una esecu-
zione e l' altra
10 scat t i , 1 ogni 45"
Ri cupero fine esercizio
4 scat t i con 1 ' 30" di
ri cupero tra uno e l'al-
t ro
Ricupero fi ne eserci zi o
1 serie di 1'
Ricupero fi ne eserci zi o
2 x 1 0 ' con 5' di ricupe-
ro, ri t mo el evato
Ri cupero fine eserci zi o
Brevi ri cuperi t ra un
eserci zi o e l ' al tro
TOTALE
D U R A T A
ef f et t i va
15'
10'
10'
f
2'
r
20'
8'
57'
ri cupero
5'
20'
10'
6'
2'
4' 30"
3'
5'
5'
5'
2'
67' 30"
compl es.
20'
30'
20'
9'
9' 30"
6'
30'
10'
124'30"
Pulsazioni
120-130
140-150
150-160
160-180
180-200
ol t re 200
150-160
80-100
Periodo preparatorio, 1 gruppo.
Allenamento per abilit motoria, velocit e resistenza generale.
Carico medio, infatti intensit medio-grande = 6,7, quantit medio-leggera
Previsti 6 allenamenti settimanali nel piano di lavoro.
57.
69
ESEMPIO DI UNA SINGOLA UNITA' DI ALLENAMENTO
Parti
<
ce
O
CC
<
a.
LU
ce
Q_
w
- J
<
1 -
z
5
<
Q
Z
o
LL
<
>
CO
= >
- J
o
z
O
O
CONTENUTO
Corsa l eggera; Corsa vari a; Eser-
ci zi di gi nnasti ca general e; Eser-
ci zi per la concentrazi one nervo-
sa (es. scat t i brevi ); Esercizi di
ri scal damento per il pont e; Eser-
cizi di mobi l i t
Esecuzioni t ecni che con partner
per apprendi mento nuove azioni
t ecni che
Incontro di datti co di al l enamento
Esercizi speciali per il ponte
Scatti su distanza medi a (200 mt.)
Giuochi sport i vi (Pallacanestro)
Esercizi di ri l assamento e allun-
gamento
INDICAZ. METODOLOG.
Brevi ri cuperi tra un
eserci zi o e l' altro
6 x 5 ' (6 seri e di 5 mi -
nuti ) 3 seri e si esegue,
3 seri e si fa il partner;
partner che non fa re-
si stenza
Ricupero fi ne eserci zi o
10 x 2' al ternando chi
esegue, partner che fa
resi stenza medi a, ogni
2 seri e 1' di ri cupero
Ricupero fi ne eserci zi o
Il ri cupero va i nseri t o
tra un eserci zi o e l ' al tro
6 seri e di ci rca 30", ri -
cupero T30" vel . appe-
na i nf eri ore alla max.
Ricupero fi ne eserci zi o
2 x 5 ' con 3' di ricupe-
ro, ri t mo el evato
Ricupero fine eserci zi o
Brevi ri cuperi t ra un
eserci zi o e l ' al tro
TOTALE
D U R A T A
effetti va
20'
30'
20'
r
3'
10'
10'
100'
ri cupero
5'
5'
4'
5'
3'
7' 30"
2' 30"
3'
3'
2'
40'
compl es.
25'
35'
29'
10'
13'
16'
12'
140'
Pulsazioni
120-130
130-140
140-150
140-150
180-200
150-160
80-100
Periodo preparatori o, 1 gruppo.
Al l enament o per apprendi mento e perfezi onamento azioni t ecni che.
Cari co grande, i nfatti i ntensi t media = 5 e quanti t grande = 100.
Previ sti 6 al l enamenti setti manal i nel piano di l avoro.
70
ESEMPIO DI UNA SINGOLA UNITA' DI ALLENAMENTO
Parti
<
ce
O
l
<
ce
<
UJ
ce
Q.
UJ
<
i -
Z
UJ
5
<
D
Z
o
L_
<
>
co
3
O
z
O
u
CONTENUTO
Corsa l eggera; Corsa vari a; Eser-
ci zi di gi nnasti ca general e; Eser-
cizi per la concentrazi one nervo-
sa; Esercizi di mobi l i t ; Esercizi
speci al i per il ponte
Tecnica i ndi vi dual e guidata (si
parte da una presa i ndi cata dal-
l ' al l enatore e si eseguono alcune
combi nazi oni , ogni atl eta sce-
glie le pref eri t e)
Incontro di al l enament o:
Lotta a terra
Riprese brevi e massi mal i di lot-
ta in piedi
Proiezioni con il mani chi no
Gi uochi sporti vi (Pallacanestro)
Esercizi di ri l assamento e al l un-
gamento
INDICAZ. METODOLOG.
Brevi ri cuperi tra un
eserci zi o e l' altro
10 x 2'. ogni seri e ese-
gue un solo l ot t at ore.
resistenza del partner
media, ri t mo el evato.
ogni 2 serie 1' di ricu-
pero
Ricupero fine esercizio
2 x 5 ' con 2' di ri cupero
Ricupero fine eserci zi o
2 x 5 ' alternando chi sta
sotto, ri cupero 2'
Ricupero fine esercizio
5 x 1 con 1' di ri cupero
tra le seri e
Ricupero fine eserci zi o
3 x 1 ' con 1' ri cupero,
ri tmo sub. max.
Ricupero fine esercizio
Ritmo medio
Ricupero fine eserci zi o
Brevi ri cuperi tra un
eserci zi o e l' altro
TOTALE
D U R A T A
effetti va
15'
20'
10'
10'
5'
3'
10'
r
80'
ri cupero
3'
4'
5'
2'
5'
2'
3'
4'
5'
2'
3'
3'
3'
44'
compl es.
18'
29'
17'
15'
14'
8'
13'
10'
124'
Pulsazioni
130-140
160-180
160-180
140-150
180-200
180-200
130-140
80-100
Periodo f ondament al e, \" gruppo.
Al l enament o per tecni ca e resistenza speci fi ca, ci rca 20 gi orni pri ma di una gara i mport ant e.
Cari co grande, i nf at t i .i ntensi t tra medio-grande, e grande = 6,5; quanti t tra medi a e medio-grande = 80
Previ sti 6 al l enamenti set t i manal i nel piano di l avoro.
71
ESEMPIO DI UNA SINGOLA UNITA' DI ALLENAMENTO
Parti
<
ce
O
5
ce
<
Q.
UJ
ce
a.
_i
<
i
z
LU
2
<
Q
Z
o
u_
<
>
co
3
O
z
O
o
CONTENUTO
Corsa l eggera; Corsa vari a; Eser-
ci zi di gi nnasti ca general e; Eser-
ci zi per la concentrazi one nervo-
sa; Esercizi di mobi l i t ; Esercizi
per il ponte
Esercizi di i mi tazi one, con part-
ner e senza
Giuochi sport i vi (Rugby sul tap-
peto, due squadre di 4-5)
Esercizi di ri l assamento e di al-
l ungamento
INDICAZ. METODOLOG.
Brevi ri cuperi tra un
eserci zi o e l' altro
1 0 x 1 ' con f di ricupe-
ro tra le seri e
Se esegui ti col partner
il recupero avviene du-
rante l' esecuzione di
questi - Ritmo l eggero
Ricupero fi ne eserci zi o
Ri tmo el evato
Ricupero fine eserci zi o
Brevi ricuperi tra un
eserci zi o e l' altro
TOTALE
D U R A T A
effetti va
15'
10'
15'
10'
50'
ri cupero
5'
9'
5'
5'
5'
29'
compl es.
20'
24'
20'
15'
79'
Pulsazioni
120-130
120-130
150-160
80-100
Periodo fondamentale, 1 gruppo.
Allenamento di compensazione.
Carico, leggero, infatti intensit tra medio-leggera e media
Previsti 6 allenamenti settimanali nel piano di lavoro.
4,5: quantit leggera = 50'.
72
Struttura dei microcicli
Il microciclo di allenamento un frammento breve, ma abbastanza completo, dell'intero
processo dell'allenamento; esso pu comprendere dalle 5 alle 12 sedute di allenamento, ge-
neralmente, come si gi detto, copre l'arco di tempo di una settimana, questo per ragioni
pratiche facilmente intuibili.
Il microciclo va considerato la struttura di base dell'allenamento e nella sua costruzione
vanno rispettati i principi dell'allenamento di cui abbiamo parlato (p. della multilateralit, p.
della continuit, p. della dinamica dei carichi), basandoci soprattutto sull'andamento ondulato-
rio dei carichi.
Il microciclo potr essere strettamente finalizzato oppure no. Lo sar spesso nel periodo
fondamentale, quasi mai nel periodo preparatorio; si dovr in ogni modo parlare, come al so-
lito, solo di prevalenza di determinate esercitazioni su altre anche quando sar finalizzato.
Tra esercitazioni di diverso tipo vi dovr inoltre essere sempre una giusta successione,
in modo tale da rendere efficace al massimo il lavoro svolto. Ripetiamo che in linea di massi-
ma bene inserire all'inizio del microciclo al enamenti per la velocit, per la tecnica e la
tattica, quindi allenamenti per la forza ed infine quelli per la resistenza specifica e generale,
anaerobica e aerobica, questo sempre rispettando il criterio della prevalenza e non quello della
uniformit.
Il contenuto degli allenamenti naturalmente varier a seconda del periodo e quindi degli
scopi che si vogliono ottenere.
Una suddivisione, per quanto sommaria, dei microcicli li distingue in:
a) Microcicli di allenamento propriamente detti
b) Microcicli precompetitivi (comprendenti la gara)
e) Microcicli di compensazione.
I microcicli di allenamento propriamente detti si suddividono a loro volta in: microcicli di
preparazione fondamentale, microcicli di preparazione specifica. Questo a seconda della ten-
denza del loro contenuto.
I microcicli precompetitivi precedono le gare del periodo fondamentale e si distinguono
per il particolare andamento del carico, normalmente abbastanza ridotto e caratterizzato da
basse quantit di lavoro.
I microcicli di compensazione sono anch'essi microcicli a carico ridotto che vengono in-
seriti, per rispettare il principio dell'andamento ondulatorio dei carichi, dopo uno o due micro-
cicli piuttosto pesanti. Possono venir anche intesi come microcicli post-competitivi.
Alcune esemplificazioni della costruzione dei microcicli relative a diversi periodi dell'alle-
namento si possono vedere negli schemi n. 6-7-8-9.
73
Esempio di microciclo di allenamento di preparazione fondamentale
1 gruppo. 6 al l enamenti set t i manal i previ sti dal piano di l avoro.
LUN - Al l enament o per abi l i t motori a general e e per vel oci t (rapi di t) general e. Cari co medi o (i ntensi t
medio-grande, quanti t medi o-l eggera).
MART. - Al l enament o per il perfezi onamento della tecni ca e per la resi stenza speci fi ca. Cari co grande (i ntensi t
grande, quanti t medi a).
MERC. - Al l enament o per il perfezi onamento della tecni ca e per la forza speci fi ca. Cari co medio-grande (i nt ensi t
medio-grande, quanti t medi a).
GIOV. - Al l enament o di compensazi one. Cari co l eggero.
VEN. - Al l enament o per il perfezi onamento del l a tecni ca e per la resi stenza speci fi ca. Cari co grande (i ntensi t
media, quanti t grande).
SAB. Al l enament o per la forza general e e per la resistenza general e. Cari co medio-grande (i nt ensi t medi a,
quanti t medi o-grande).
Rappresentazione grafica del l ' andamento del cari co
L M M G V S
Esemplo di mlcroclclo di allenamento di preparazione specifica
1 gruppo, 6 al l enamenti setti manal i previ st i dal piano di l avoro.
LUN. - Al l enament o per abi l i t motori a speci fi ca e per vel oci t (rapi di t) applicata alle eserci tazi oni t ecni che.
Cari co medio (i ntensi t medio-grande, quanti t medi o-l eggera).
MART. - Al l enamento per il perfezi onamento del l a tecnica e per la forza speci fi ca. Cari co grande (i ntensi t gran-
de, quanti t medi a).
MERC. - Al l enament o per il perfezi onamento del l a tecni ca e per la resi stenza speci fi ca. Cari co grande (i ntensi t
medio-grande, quanti t medi o-grande).
GIOV. - Al l enament o di compensazi one. Cari co l eggero.
VEN. - Al l enament o per il perfezi onamento del l a tecni ca e per la vel oci t (rapi di t) speci fi ca. Cari co medio-
grande (i ntensi t medio-grande, quanti t medi a).
SAB. - Al l enament o per il perfezi onamento della tecnica e per la resistenza speci fi ca. Cari co grande (i ntensi t
media, quanti t grande).
Rappresentazione grafica del l ' andamento del cari co
L M M G V S
74
Esempio di microciclo precompetitivo
1 gruppo. 6 allenamenti settimanali previsti dal piano lavoro.
LUN. - Allenamento per abilit motoria specifica e per velocit (rapidit) applicata alle esercitazioni tecniche.
Carico medio-leggero (intensit media, quantit leggera).
MART. - Allenamento per il perfezionamento della tecnica individuale e per la resistenza specifica. Carico me-
dio-grande (intensit grande, quantit media).
MERC. - Allenamento per la forza specifica. Carico leggero (intensit medio-leggera, quantit leggera).
GIOV. - Allenamento per il perfezionamento della tecnica individuale e per la resistenza specifica. Carico medio
(intensit medio-grande, quantit medio leggera).
VEN. - Allenamento di compensazione carico molto leggero (intensit media, quantit molto leggera).
SAB. e DOM. - Gara importante.
Rappresentazione grafica dell'andamento del carico
M M
Esempio di microciclo d compensazione
1 gruppo, 6 allenamenti settimanali previsti dal piano di lavoro.
LUN. - Allenamento di compensazione. Carico molto leggero.
MART. - Allenamento per abilit motoria generale e per velocit (rapidit). Carico medio leggero (intensit me-
dia, quantit leggera).
MERC. - Allenamento per forza specifica. Carico medio-leggero (intensit media, quantit leggera).
GIOV. - Allenamento di compensazione. Carico molto leggero.
VEN. - Allenamento per il perfezionamento della tecnica e per la resistenza specifica. Carico medio (intensit
medio-leggera, quantit medio grande).
SAB. - Allenamento per la resistenza generale. Carico leggero (intensit leggera, quantit medio-leggera).
Rappresentazione grafica dell'andamento del carico
L M M G V S
75
Struttura dei mesocicli
Il mesociclo di allenamento un frammento non troppo breve, e certamente completo
nella sua struttura, dell'intero processo dell'allenamento.
Ogni mesociclo si dipana, come si gi detto, in un periodo di tempo che pu variare
dai 20 ai 40 giorni, e pu essere quindi inteso come la somma di un certo numero di microci-
cl i , da 3 a 6.
Le necessit che hanno reso consigliabile la suddivisione dell'allenamento in mesocicli so-
no principalmente due:
1) rispettare l'andamento ondulatorio dei carichi di lavoro anche durante un arco di tempo
ben pi ampio di un microciclo, in modo tale che nel processo di allenamento si produca
quel sommarsi di carichi necessario per incrementare lo sviluppo di qualsiasi qualit
e si rispettino nello stesso momento i tempi di ripristino dell'organismo; ci si ottiene al-
ternando opportunamente microcicli di compensazione a periodi contraddistinti da grande
carico di lavoro;
2) modificare periodicamente il contenuto e la metodologia di allenamento nei diversi periodi.
In base a ci si possono distinguere i seguenti tipi di mesocicli:
a) introduttivo
b) di base
e) preagonistico (comprendente la gara)
d) interagonistico (comprendente la gara)
e) di compensazione.
a) I mesocicli introduttivi sono caratterizzati da un aumento costante sia della intensit che
della quantit con netta prevalenza di quest'ultima. Ci riferendoci all'andamento medio, per-
ch, come abbiamo visto, sono consigliabili periodiche brusche inversioni di tendenza. Ogni
ciclo agonistico comincia con un mesociclo del genere che quindi quello che contraddi-
stingue l'inizio del periodo preparatorio. Un esempio dell'andamento del carico in un mesoci-
clo introduttivo si pu vedere nella fig. n. 7.
b) I mesocicli di base costituiscono i mesocicli pi importanti dell'intero periodo preparato-
rio.
E' durante i mesocicli di base, che sono anche i pi lunghi, che viene svolto il lavoro fon-
damentale dell'allenamento, volto a incrementare le capacit funzionali dell'organismo e ad as-
sicurare l'apprendimento ed il perfezionamento della tecnica e della tattica; soprattutto l'ap-
prendimento per i giovani, e il perfezionamento per gli atleti di media e alta qualificazione.
A seconda del loro contenuto si distinguono in mesocicli di preparazione generale e in
mesocicli di preparazione specifica; per gli atleti di alto livello i mesocicli di preparazione ge-
nerale debbono per essere gi abbastanza specifici.
A seconda della tendenza delle esigenze di allenamento si distinguono in mesocicli di svi-
luppo e in mesocicli di stabilizzazione.
Durante questi mesocicli il carico di lavoro solitamente molto elevato anche se vi si
dovr inserire uno o due microcicli di compensazione per concedere all'organismo un recu-
76
pero adeguato, cos da permettergli in seguito di sostenere ancora carichi di lavoro molto ele-
vati. Due esempi dell'andamento del carico in un mesociclo di base dedicato alla preparazione
generale e in un mesociclo di base dedicato alla preparazione specifica si possono vedere nel-
le figg. n. 8-9.
;) I mesocicli preagonistici precedono le competizioni pi importanti. In essi l'allenamento
sar prevalentemente specialistico e il carico di lavoro sar influenzato soprattutto dall'inten-
sit pur nella variet delle esercitazioni. Cominceranno generalmente con un microciclo di com-
pensazione, per consentire all'atleta di recuperare le energie, se il mesociclo di base prece-
dente stato particolarmente impegnativo e non terminato con un microciclo di compensa-
zione; comunque termineranno sempre con un microciclo agonistico che avr il suo culmine
nella gara vera e propria. Un esempio dell'andamento del carico in un mesociclo preagoni-
stico si pu vedere nella fig. n. 10.
d) I mesocicli interagonistici sono inseriti tra le competizioni importanti La loro durata sar
determinata dall'intervallo di tempo fra una competizione e l'altra ma non superer normal-
mente le 3-4 settimane Se le due gare dovessero essere pi distanziate nel tempo tra esse sa-
rebbe bene inserire un mesociclo di preparazione specifica, di sviluppo o di stabilizzazione, e
quindi un mesociclo preagonistico.
I mesocicli interagonistici cominceranno sempre con un microciclo di compensazione e
saranno volti al mantenimento o alla rifinitura della forma attraverso un opportuno andamento
ondulatorio dei microcicli che li compongono. Il carico sar prevalentemente determinato dal-
l'intensit e anche essi termineranno con un microciclo agonistico comprendente la gara vera
e propria. Un esempio dell'andamento del carico in un mesociclo interagonistico si pu ve-
dere nella fig. n. 11.
e) I mesocicli di compensazione sono caratterizzati da carico non elevato e da una variet di
mezzi vastissima. Hanno lo scopo di consentire all'organismo un recupero completo, sia fisi-
co che psichico, dopo alcune gare importanti.
Vengono usati nella periodizzazione semestrale tra la fine del 1periodo agonistico e l'ini-
zio del 2 periodo preparatorio annuale. La loro durata non superer mai le due-tre settimane,
sia la quantit che l'intensit, ma soprattutto quest'ultima saranno basse e il contenuto degli
allenamenti il pi vario possibile. Va rispettato comunque il principio dell'andamento ondula-
torio dei carichi, con periodiche brusche inversioni di tendenza, caratterizzate da allenamenti
con carico abbastanza elevato, alla cui determinazione contribuisca in maniera elevata l'inten-
sit. Per consentire all'organismo il recupero nacessario da sconsigliarsi nella maniera pi
assoluta l'astensione completa da ogni attivit fisica, ci sarebbe molto dannoso e compromet-
terebbe il lavoro dei successivi mesocicli. Un esempio dell'andamento del carico in un me-
sociclo di compensazione si pu vedere nella fig. n. 12.
77
ANDAMENTO DEL CARICO I N UN MESOCICLO I NTRODUTTI VO
-f? GRUPPO periodizzazione semestrale , 6 allenamenti 4 settimane
MEDIO
LE&6CM -
Fi t ti. %
L M M 6 V S D L M N S V S D L M M G V S D L M M G V S 0
ANDAMENTO DEL CARICO I N UN MESOCICLO DI BASE DI PREPAR. GENERALE
4! GRUPPO, periodi J semestrale , 6 allenamenti settimanali, 6 settimane
L I VLLO
01 CARICO
. 4
.H
L
FIG. ti.
L n M G V S 0 L n H C V D L M H e v S 0 L H M a V S D L n M a v S D L n n 6 V S
ANDAMENTO DEL CARICO IN UN MESOCICLO DI BASE DI PREPAR SPECIFICA
I' GRUPPO , periodiz. semestrale , 6 allenamenti settimanali
s
settimane
LIVELLO
DEL COKKO
flEWO
LU*
FK.M.5
L M M t V S D L M M f r V S , D L M M S V S D L M M 5 V S D L M M G V S D
78
ANDAMENTO DEL CARICO IN UN MESOCICLO PREAGONISTICO
-I? GRUPPO
;
pQriodizza2ione semestrale , allenamenti settimanali, A settirmana
LIVELLO
DEL CARICO
6Q.AHDE
MEDIO
LE GCCat .
Fig. N. 10
L M M S V S D L M M C i V S O L M M & V S D L M M & V S O
ANDAMENTO DEL CARICO IM UN MESOCICLO IMTERAGONISTICO
. GRUPPO, penodi i . semestrale, 6 allenamenti settimanali, 3 settimane
LIVLLO
DEL CURILO
6RANDE
MED"J
LEW.tJ
Fig. N. 11
I '
I
I I
I I
L M M 6 V S D L M M G V S D L H M C - V S D
ANDAMENTO DEL CARICO DI UN MESOCICLO DI COMPENSATONE
H? GRUPPO , penooliz semestrale , fe allenamenti settimanali, 3 settimana
LIVELLO
DEL CARICO
CrMftDt
MEDIO
LEOGEtO
Fig. N. 12
L M M G - V S b L M N & V S D L r l n c V V S D
79
IL PERIODO PREPARATORIO
E' il periodo dedicato alla preparazione dela stagione agonistica vera e propria, i suoi
mezzi per non si limitano ai mezzi di preparazione propriamente detti, ma vengono scelti in
un'ampia gamma e tra essi vanno inseriti anche quell'impegni agonistici che serviranno di
rodaggio alle gare pi importanti. Nella realt questo periodo deve servire quindi non solo al-
la preparazione di base, ma anche, nella sua fase conclusiva, alla ricerca di un buon stato
di forma che dovr essere solo rifinito nel successivo periodo agonistico o fondamentale.
Per questa sua grande variet di scopi, diversificati nel tempo, quindi di mezzi e di me-
todologie da usare, opportuno dividere il periodo preparatorio in due tappe, una dedicata
prevalentemente alla preparazione generale e l'altra prevalentemente alla preparazione speci-
fica.
La durata dell'intero periodo preparatorio e delle due tappe di cui si compone varia a se-
conda che si adotti una periodizzazione annuale o semestrale.
Adottando una periodizzazione annuale l'intero periodo preparatorio avr mediamente una
durata di 4-6 mesi, fino ad arrivare ai 7-8 mesi per atleti giovani. Le due tappe avranno una du-
rata media di 3-4 mesi la prima, 1 V2-2 la seconda, per arrivare a 5-6 mesi la prima e 2-3 la se-
conda per i pi giovani e meno qualificati.
Nel caso di una periodizzazione semestrale, l'intero periodo preparatorio avr una durata
media di circa 3 mesi, potendo arrivare ad un massimo di 4 per gli atleti meno qualificati,
mentre le due tappe che lo compongono avranno una durata di 2 mesi, fino a un massimo di
3 la prima, e di 1 mese, un mese e mezzo al massimo, la seconda.
La durata del periodo preparatorio strettamente legata all'intensit e sar tanto maggio-
re quanto minore risulter l'intensit media degli allenamenti. All'intensit anche legata la
durata delle due tappe, pi flessibile la prima, perch meno intensa, pi rigida la seconda per-
ch maggiormente condizionata dalla intensit. Una schematizzazione della durata del periodo
preparatorio e delle tappe di cui si compone si pu vedere nella fig. n. 13.
Prima tappa del Periodo preparatorio
Nella prima tappa del periodo preparatorio si dovr cercare di allargare il pi possibile
la base . si dovr cio incrementare al massimo quella condizione generale partendo dalla
quale, in seguito, si potr ricercare il raggiungimento della forma .
Il raggiungimento di questa condizione, che si fonda sulle aumentate capacit funzio-
nali dell'organismo, si ha attraverso l'incremento delle qualit fisiche di base: forza, resisten-
za, velocit, mobilit, coordinazione.
Allenamento quindi generalizzato al massimo, senza alcuna remora per i pi giovani, per
i quali eventuali transfert (adattamenti che si hanno su una qualit fisica facendo un allena-
mento volto ad incrementarne un'altra) saranno senz'altro positivi, con un po' pi di attenzione
per gli atleti pi qualificati, per i quali eventuali transfert possono essere anche negativi,
Si pu ovviare a questo inconveniente, inserendo gi in questa fase alcune sedute pi speci-
80
DURATA PERIODO PREPARATORIO - SCHEMATI ZZAZI ONE
PERI ODI ZZAZI ONE ANNUALE
J L
ys TAPPA 2 TAPPA
SGRUPPO : Atleti giovani, dotati, ma di 1* qualificatone
fino a 4P - 48 anni
y TAPPA
2* TAPPA
2 GRUPPO : Atleti di media Qt/alifi canone, livello nazionale,
dopo i - / / - /<? Anni
PERI0DI2ZAZI0NE SEMESTRALE
V G-RUPPO
y * TAPPA 2*TAPPA
2
?
GROPPO
V_
/ * TAPPA 2* TAPPA
FI&.N.I3
81
fiche, rispettando il principio della interruzione periodica della gradualit e, soprattutto, ren-
dendo l'allenamento oltre che generalizzato il piu multilaterale possibile, cos da sviluppare le
varie qualit fisiche in modo parallelo attraverso una grande variet di mezzi.
Solo se l'atleta presentasse una lacuna vistosa, cosa che, d'altro canto, non dovrebbe
accadere nella maniera pi assoluta per un atleta qualificato, allora sarebbe opportuno cer-
care di colmarla attraverso un allenamento finalizzato, anche correndo il rischio di un tran-
sfert negativo.
Per quanto riguarda specificamente il lavoro per la tecnica e la tattica, in questa prima
fase del periodo preparatorio le esercitazioni devono volgere soprattutto ad ampliare l'abilit
motoria generale e ad acquisire abilit motorie specifiche con l'apprendimento di nuove azioni
tecniche. In parte, e quasi esclusivamente con atleti di alta qualificazione, si cercher di mi-
gliorare abilit motorie specifiche gi possedute attraverso il perfezionamento di azioni tec-
niche.
Per quanto riguarda lo sviluppo della tecnica e della tattica c' da tener presente, che
esso strettamente legato allo sviluppo delle qualit fisiche, non potendo certe azioni tecni-
che essere acquisite se l'atleta non in possesso di sufficiente forza o velocit o mobilit
articolare e cos via. E' necessario quindi incrementare prima le qualit fisiche, almeno fino
a portarle a quel livello che indispensabile per poter passare all'insegnamento di determi-
nate azioni tecniche, e questa prima fase del periodo preparatorio la fase pi indicata per
farlo.
Scendendo un po' pi nei particolari, per quanto riguarda i mezzi e i metodi di allena-
mento da usare in questa fase, c' da dire che la loro scelta dipende in larga misura dalle ca-
ratteristiche dell'atleta e dal suo grado di qualificazione. Come si gi detto per gli atleti
giovani l'allenamento dovr essere molto generalizzato, volto a migliorare le capacit funzio-
nali dell'organismo, incrementando in pari misura tutte le qualit fisiche, e ad aumentare il
bagaglio tecnico e tattico.
La preparazione generale avr nettamente il sopravvento su quella specialistica, il rap-
porto sar inizialmente di circa 4 : 1 , 3 : 1 ; per portarsi sul 2 : 1 alla fine della tappa.
I mezzi da usare con prevalenza saranno: la corsa di durata a ritmo costante; gli scatti
brevi; gli esercizi con carichi (bilancieri, manichini, sacconi, palle mediche, ecc. . . .) e agli
attrezzi; gli esercizi con partner; gli esercizi di ginnastica generale e di acrobatica; i giuochi
sportivi; gli esercizi speciali preparatori; gli esercizi di esecuzione delle azioni tecniche, li-
mitati per all'insegnamento puro e semplice; gli incontri didattici (vedi tab. riassuntiva pag.
58).
Solo saltuariamente si inseriranno esercizi pi specifici ed esercizi si mi l i , come impe-
gno, alla gara, gli incontri didattici di allenamento e gli incontri di allenamento.
Solo in casi particolari di effffettivo bisogno per alcuni atleti si potr prevedere, oltre al
tipo di allenamento suddetto, esercitazioni specifiche volte a colmare eventuali lacune, condi-
zionanti negativamente il rendimento, che si pensa non possono essere colmate con il solo
lavoro di gruppo.
Per gli atleti di livello pi elevato il principio sempre valido, cambiano solo le propor-
zioni tra lavoro generale e lavoro specifico che saranno di 2 : 1 all'inizio per portarsi sull'1 : 1
alla fine di questa prima tappa. I mezzi da usare saranno pressoch gli stessi, ma ad essi se
ne aggiungeranno alcuni pi specifici, come parte degli esercizi speciali, che modificheranno so-
stanzialmente il lavoro tecnico vero e proprio. L'allenamento infatti deve ricercare meno l'ac-
quisizione di abilit motorie generali e pi l'acquisizione di abilit motorie particolari, neces-
sarie per eseguire azioni tecniche complesse, e il perfezionamento, fino alla raffinatezza del
gesto, di movimenti gi posseduti, utilissimi a tale scopo gli esercizi di imitazione.
82
Per gli atleti di alto livello il discorso sulle lacune da colmare dovrebbe essere ridotto,
in ogni modo se ce ne fosse la necessit, questa tappa certamente la pi indicata per farlo.
Per quanto riguarda l'andamento dei parametri del carico di lavoro, si nota come la ten-
denza generale sia per un aumento notevole della quantit di lavoro e per un contemporaneo,
ma molto pi ridotto, aumento dell'intensit. In effetti la quantit alla fine di questa tappa do-
vr raggiungere pressoch il suo culmine, mentre l'intensit raggiunger circa il 50-60% dei
suoi valori massimali, ma dovr comunque essere quasi la massima che quella determinata
quantit di lavoro consente.
Il problema di trovare la giusta combinazione tra massa e intensit, cosa di non facile
soluzione, poich si pu correre il rischio, privilegiando l'intensit e il lavoro specifico, di
non allargare sufficientemente la base, intesa come livello delle capacit fisiche dell'atleta e,
privilegiando oltre misura la quantit e il lavoro generale, di ritardare troppo l'aumento dell'in-
tensit e del lavoro specifico e perci il raggiungimento della forma .
Naturalmente anche in questo caso il discorso va diversificato a seconda che si tratti di
atleti giovani o di alto e medio livello, dovendo temersi pi la prima evenienza per i giovani
e la seconda per gli al tri .
Seconda tappa del periodo preparatorio
Questa seconda tappa del periodo preparatorio che pu anche essere definita tappa di
preparazione speciale caratterizzata, rispetto alla precedente da un incremento del lavoro
specifico e da una progressiva diminuizione di quello generalizzato; in pratica per i conte-
nuti dell'allenamento variano di poco, pi che altro varia la sua struttura, cio il rapporto tra
lavoro specifico e lavoro generalizzato, e il rapporto tra intensit e quantit.
Anche qui la difficolt sta nel trovare il rapporto ottimale tra questi parametri. In ogni
modo, come indirizzo generale, inizialmente la quantit si manterr pressoch costante e l'in-
tensit continuer ad aumentare; poco dopo per, dovendo l'intensit continuare ad aumenta-
re, si dovr diminuire la quantit per non portare il carico a livelli insostenibili. L'intensit
prender il sopravvento verso la fine della tappa, e quindi dell'intero periodo preparatorio.
Nell'applicazione pratica di questo, concetto generale bisogna comunque tenere conto de-
gli atleti cui si rivolge, tenendo presente che per i giovani non ancora consigliabile, in questa
tappa rendere l'allenamento troppo specifico n troppo intenso.
Per gli atleti evoluti si potr invece anticipare il momento in cui l'intensit predominer
sulla massa, e acuire l'influenza che l'intensit avr nella determinazione del carico a scapito
della quantit; quest'ultima verso la fine della tappa potr essere anche quasi dimezzata ri-
spetto ai valori massimali raggiunti. Anche il lavoro specifico prender abbastanza presto il
sopravvento su quello generalizzato, pur rispettando sempre il criterio della variet.
All'inizio della tappa comunque opportuno mantenere sufficienti quantit di lavoro ge-
neralizzato, per non correre il rischio di diminuire l'efficienza funzionale raggiunta con un pas-
saggio troppo brusco dall'attivit generalizzata a quella specifica.
Volendo esprimere numericamente il rapporto tra lavoro generalizzato e lavoro specifi-
co si pu dire che per i giovani esso sar di 2 : 1 all'inizio per portarsi sul I '1 : 1 verso la fine
della tappa, mentre per gli atleti evoluti esso dovr essere di 1 : 1 all'inizio per portarsi sul-
l'1 : 2 e, verso la fine, anche sull'1 : 3.
I mezzi da usare in prevalenza saranno: la corsa di durata a ritmo prima costante, poi
variabile; gli scatti brevi; la corsa di velocit prolungata (300-400), anche se non troppo spes-
so, almeno inizialmente; gli esercizi con carichi e con il partner, scegliendo per esercizi
83
abbastanza specifici; gli esercizi di acrobatica; i giuochi sportivi, che avranno per una inten-
sit pi elevata rispetto alla prima tappa e. psicologicamente, una funzione di evasione; gli
esercizi speciali preparatori; gli esercizi introduttivi; gli esercizi di esecuzione di azioni tecniche
e tattiche, anche complesse, sfruttando varie metodologie (partner che non fa resistenza, che fa
una resistenza parziale, che fa resistenza, da fermo, in movimento, a tempo, ecc.); gli incontri di-
dattici di allenamento; gli incontri di allenamento (vedi tab. riassuntiva pag. 58).
Saranno questi ultimi i veri e propri esercizi di competizione, che acquisteranno man ma-
no pi importanza. Non dobbiamo per standardizzarli nella durata delle serie, nella loro inten-
sit e nel recupero tra una serie e l'altra, ma, al contrario, variarli spesso.
Verso la fine della tappa sar opportuno inserire anche vere e proprie competizioni con
carattere preparatorio e di controllo, molto utili per verificare l'allenamento sostenuto fino a
quel momento e per preparare l'atleta a rientrare gradualmente nel clima agonistico delle gare
pi importanti.
L'allenamento comunque non dovr mai essere modificato in prossimit di queste gare che
dovranno anzi essere inserite nel piano considerandole solo come degli allenamenti puri e
semplici.
La diminuizione della quantit in questa tappa si ottiene pi che altro diminuendo la du-
rata degli esercizi, mentre l'incremento dell'intensit si ottiene aumentando il ritmo con cui
gli esercizi si eseguono e dando pi spazio ai veri e propri esercizi di competizione
E' importante notare che, a causa del cambiamento abbastanza accentuato della struttu-
ra degli allenamenti, in questa tappa i mesocicli saranno pi brevi e la loro durata sar al
massimo di 3-4 settimane
84
IL PERIODO FONDAMENTALE O COMPETITIVO
E' il periodo in cui sono addensate le gare importanti, quelle verso cui si finalizzata
la pianificazione dell'allenamento. E' perci il periodo in cui, avendo come base la ottima con-
dizione fisica raggiunta alla fine della seconda tappa del periodo preparatorio, si cercher di
acquisire gradatamente il vero e proprio stato di forma sportiva, in modo da raggiungere l'opti-
mum in occasione della gara pi importante.
Adottando una periodizzazione annuale la durata del periodo fondamentale sar di 5-7 mesi
per gli atleti pi evoluti e di 3-4 mesi per i pi giovani. Gli atleti qualificati potranno porsi
nell'arco dell'intero periodo pi di un obiettivo principale, vale a dire pi di una gara in cui
cercare di ottenere il massimo della forma, ci sar possibile attraverso una opportuna oscil-
lazione della stessa determinata dai contenuti degli allenamenti; comunque sconsigliabile cer-
care di raggiungere l'apice pi di due, tre volte in un anno.
Per i pi giovani invece l'ideale senz'altro quello di andare in forma una volta al-
l'anno, al massimo due, se esigenze contingenti proprio lo richiedessero; in ogni modo, ba-
sandosi l'allenamento su un lavoro meno intenso e meno specifico, per loro l'arco di tempo in
cui la forma pu essere mantenuta pi lungo, anche se il suo livello sar proporzionalmente
pi basso.
Nel caso di una periodizzazione semestrale la durata del periodo competitivo osciller
tra i 2-3 mesi per gli atleti evoluti e 1-2 mesi per i pi giovani. L'acquisizione del massimo gra-
do di forma potr essere ricercato non pi di due volte dagli atleti evoluti e una volta dai
pi giovani, restando valido il concetto espresso per la pianificazione annuale.
Durante questo periodo il lavoro generale diminuisce un po' rispetto a quello sostenuto
nella seconda tappa del periodo preparatorio, mentre aumenta l'incidenza del lavoro specifico
e delle competizioni vere e proprie. Questo valido per gli atleti qualificati a patto che il lavoro
specifico sia abbastanza multiforme e non troppo standardizzato, cosa non difficile da realiz-
zare nel nostro sport.
Se viceversa il lavoro specifico eccessivamente standardizzato e si basa, per esempio,
quasi esclusivamente sugli incontri di allenamento, allora si corre il rischio di avere una di-
minuzione dello stato generale di allenamento e del livello delle singole capacit funzionali
dell'organismo.
Per gli atleti giovani invece si pu mantenere costante il volume del lavoro generalizzato
rispetto a quello specifico, sempre rispetto alla seconda tappa del periodo preparatorio, varian-
do opportunamente solo gli altri parametri dell'allenamento, l'intensit e la quantit.
Se tuttavia il periodo competitivo particolarmente lungo, il caso della periodizzazio-
ne annuale, allora ad un certo punto di esso, durante quella che potremo definire la tappa in-
termedia del periodo, si dovr ristabilire tra lavoro generalizzato e lavoro specifico un rap-
porto meno favorevole a quest'ultimo. Ci si ottiene inserendo nell'allenamento, per circa
3-4 settimane, discrete quantit di lavoro generalizzato e multiforme.
Questa provvisoria inversione di tendenza dovr essere inserita quando tra due gare
importanti vi sia un lasso di tempo abbastanza lungo (45-60 giorni), il che dovrebbe acca-
85
dere. con un calendario razionale, all'incirca a met del periodo II suo scopo quello di cer-
care di mantenere per tutto il periodo competitivo, che molto lungo, un buon stato di forma,
da cui sia possibile passare, in occasione delle gare clou, allo stato di forma ottimale.
Nella periodizzazione semestrale, in cui il periodo fondamentale non lungo, si potr in-
vece mantenere costante il rapporto tra lavoro generale e lavoro specifico senza correre ec-
cessivi rischi di scadimenti di forma.
Quest'ultime notazioni valgono sia per gli atleti evoluti sia per i giovani, anche se i con-
tenuti dell'allenamento sono diversi
Una schematizzazione della durata del periodo fondamentale e delle tappe di cui si com-
pone si pu vedere nella fig. n. 14,
DURATA PERI ODO FONDAMENTALE - SCHEMATI ZZAZI ONE
PERI 0 DI 2 ZA2 I 0 NE ANNUALE
-f me s e
I I 1 1 I i I M G-RUPPO
J 1 1 1 i I i I I 2? GRUPPO
tappa
intermedia
PERIODIZZAZIONE SEMESTRALE
-I? GRUPPO
J I I I i 2? GRUPPO
86
I mezzi pi indicati in linea generale sono: la corsa a ritmo variabile; gli scatti; la corsa
di velocit prolungata; gli esercizi con carichi e agli attrezzi; gli esercizi con il partner, sce-
gliendo soprattutto esercizi si mi l i , come struttura dei movimenti, alle azioni tecniche vere e
proprie; gli esercizi di acrobatica; i giuochi sportivi, che dovranno avere pi che altro il com-
pito di interrompere la monotonia degli allenamenti, pur mantenendo una loro precisa funzio-
ne allenante; gli esercizi speciali preparatori; gli esercizi introduttivi; gli esercizi di esecuzio-
ne delle azioni tecniche e tattiche, usando prevalentemente metodologie tendenti al perfezio-
namento e alla rifinitura delle azioni in condizioni simili a quelle di gara (con partner che fa
resistenza, in movimento, a comando, a tempo ecc.); gli incontri didattici di allenamento;
gli incontri di allenamento; gli incontri di controllo; gli incontri di competizione (vedi tab.
riassuntiva pag. 58).
Gli incontri di competizione assumono in questo periodo un ruolo fondamentale per il per-
fezionamento delle capacit tecniche e tattiche e per l'ulteriore incremento delle capacit fi-
siche. Tutto ci perch in gara determinate azioni vengono compiute in condizioni psicologiche
ed emozionali tali, per cui la mobilitazione di tutte le proprie energie e capacit massima e
quindi massimo anche l'effetto che gli esercizi compiuti in tali condizioni hanno sull'organi-
smo.
E' perci molto importante che nel calendario, opportunamente intramezzate alle gare
fondamentali, siano inserite gare secondarie; se cos non fosse necessario creare saltuaria-
mente in allenamento l'atmosfera degli incontri di controllo tra atleti della stessa societ,
usando, se necessario, opportuni accorgimenti, come l'handicap, per rendere gli incontri mol-
to incerti e combattuti.
Venendo ad analizzare l'andamento del carico, all'inizio del periodo fondamentale la quan-
tit diminuisce, anche se non di molto, rispetto alla seconda tappa del periodo preparatorio;
in seguito si stabilizza. L'intensit invece aumenta il pi possibile, considerando il livello
della quantit, e poi si stabilizza anch'essa sui valori massimi.
Questo discorso per quanto valido relativo. Infatti la stabilizzazione della quantit e del-
l'intensit riferita a periodi di tempo piuttosto lunghi; mediamente cio si stabilizzano, ma
nell'ambito di periodi brevi (mesocicli) e brevissimi (microcicli) tutte e due presentano del-
le oscillazioni che, per quanto riguarda i microcicli, possono essere talvolta anche notevoli.
Nel caso che il periodo competitivo sia piuttosto lungo, il che accade nella periodizzazione
annuale in quella che abbiamo definito la tappa intermedia del periodo, opportuno variare,
in parte, la dinamica del carico di allenamento. All'inizio della tappa vi dovr essere un au-
mento della quantit e una contrazione, anche se non eccessiva, dell'intensit, mentre nella
seconda parte vi sar la tendenza inversa, e, attraverso un aumento dell'intensit ed una rela-
tiva diminuizione della quantit, la dinamica del carico riprender l'andamento dominante del
periodo.
In pratica in questa tappa nella dinamica del carico si ritroveranno alcune caratteristiche
proprie della seconda tappa del periodo preparatorio, per in misura pi sfumata, non arrivan-
do la quantit ai livelli toccati in quella fase e restando invece l'intensit a livelli un po' pi
alti.
In ogni modo mentre nella periodizzazione semestrale non opportuno inserire questa va-
riazione di tendenza, a causa della brevit del periodo fondamentale, nella periodizzazione an-
nuale consigliabile adottarla, ma non pi di una volta, e per non pi di 3-4 settimane; in caso
contrario, per buona parte del periodo seguente il rendimento agonistico non risulter ade-
guato.
Per quanto riguarda il rapporto tra la quantit del lavoro nel periodo fondamentale e quel-
la della seconda tappa del periodo preparatorio, mediamente si pu pensare che la quantit
87
del p.f. debba essere I '80 % di quella della 2-' tappa del p.p., mentre i valori massimi del p.f.
possono arrivare al livello dei valori medi, sempre della 2
J
tappa del p.p.
Queste convinzioni sono scaturite dall'osservazione da parte di numerosi studiosi delle
prestazioni ottenute da atleti praticanti varie discipline (nuoto, corsa veloce, mezzofondo) e
dal confronto delle prestazioni stesse con quelle precedenti e con la dinamica di carico che
aveva contraddistinto gli allenamenti.
Le altre due varianti, quella caratterizzata da una eccessiva diminuizione della quantit e
quella caratterizzata da una limitata contrazione della stessa, che in pratica avveniva solo
molto vicino alle competizioni, non hanno dato buoni risultati e gli atleti che le hanno adotta-
te hanno peggiorato le proprie prestazioni.
L'intensit dovr invece aumentare proporzionalmente alla diminuizione del volume in mo-
do da mantenere il carico, che ne pressoch una risultante, anche se dipende in misura mag-
giore dall'intensit, all' inarca agli stessi livelli.
Sottolineando ancora una volta l'importanza delle competizioni in questo periodo, c' da te-
nere presente la maggior influenza che le stesse hanno sull'andamento del carico rispetto ad
un lavoro analogo sostenuto in allenamento, essendo naturalmente la motivazione, e quindi
l'impegno fisico e psichico, molto maggiore.
Durante il periodo fondamentale, pi che nel preparatorio, si dovr comunque ricorrere al-
l'alternanza di carichi relativamente bassi con carichi alti o addirittura massimali. Questo con-
cetto rispecchia il principio della dinamica dei carichi di allenamento e va sempre tenuto pre-
sente nella strutturazione dei mesocicli e dei microcicli di questo periodo.
In occasione delle gare principali, nei 7-10 giorni precedenti la gara, in pratica nel micro-
ciclo precompetitivo, bisogna ridurre la quantit dell'allenamento in misura sensibile, mante-
nendo l'intensit pressoch costante, in modo tale che il carico diminuisca, ma non oltre il 30-
40% rispetto ai valori medi del periodo.
Il numero di competizioni fondamentali nel caso di una periodizzazione semestrale non
dovrebbe essere superiore a tre e nel caso di uns periodizzazione annuale, a 5-6. In caso con-
trario difficile programmare l'allenamento in modo tale da rispettare una giusta dinamica del
carico E' opportuno invece inserire tra le competizioni principali un certo numero di compe-
tizioni secondane per noi mantenere iroppo a lungo gli atleti lontano dal clima agonistico,
ma per le quali, bene insistere su questo pur.o. non va alterata la dinamica del carico di
allenamento.
88
IL PERIODO TRANSITORIO
E' il periodo intercorrente tra la fine di una stagione agonistica e l'inizio della prepara-
zione per la stagione successiva; il cosiddetto periodo di riposo attivo . Durante questo pe-
riodo l'atleta deve cercare di smaltire la fatica psico-fisica eventualmente accumulata durante
il periodo agonistico precedente, ricaricandosi per affrontare nel migliore dei modi il lavoro
futuro..
Si deve evitare nella maniera pi assoluta il riposo totale, in quanto l'interruzione improv-
visa dell'allenamento particolarmente dannosa e i suoi effetti si fanno poi sentire nel tempo.
Non d'altro canto consigliabile neppure il passaggio immediato da un periodo di compe-
tizione ad uno preparatorio, perch in questo caso, oltre a correre il rischio di un sovraffatica-
mento fisico, non si consente il necessario recupero psichico all'atleta e, anche se inizialmen-
te i risultati sembrano buoni, in seguito egli ne risente negativamente.
L'importanza di questo periodo non va sottovalutata. Il buon andamento di una program-
mazione si basa su una giusta attivit fisica svolta nel periodo transitorio. Questa, rispettan-
do sempre il principio dell'alternanza dei carichi, contraddistinta da carichi non elevati e
da un lavoro quasi esclusivamente generalizzato, che si basa sulla quantit, pur con sporadici
richiami della intensit. Vale a dire che almeno una volta la settimana, anche nel periodo tran-
sitorio bene inserire un allenamento breve ma intenso, che determini l'instaurazione di un
debito di ossigeno piuttosto elevato, anche se non massimale.
I mezzi propri di questo periodo sono soprattutto gli esercizi di preatletismo generale,
i giuochi sportivi e gli sport ausiliari (vedi tabella riassuntiva pag. 58); il rapporto tra prepa-
razione generale e preparazione specifica dovr essere di circa 5 : 1 .
La durata del periodo varia: nel caso di una periodizzazione annuale oscilla dalle 3-4 set-
timane, per gli atleti qualificati, alle 8-10 sett nane, per i pi giovani. Nel caso di una perio-
dizzazione semestrale si deve distinguere tra il periodo di transizione vero e proprio, che
oscilla dalle 2-3 settimane per atleti qualificati, alle 4-5 per gli atleti giovani, a quel periodo
transitorio sui generis che passa tra i due cicli semestrali in cui si spezza l'anno agonistico,
che necessariamente pi breve ed anche diverso nei contenuti, identificandosi praticamen-
te con un mesociclo di compensazione (fig. n. 12, pag. 47).
In definitiva il periodo transitorio un punto fermo della moderna concezione di allena-
mento senza soluzione di continuit. Il lavoro che si sostiene durante esso, mentre da un
lato consente il recupero fisiologico dell'organismo, dall'altro mantiene un certo stato di al-
lenamento, in modo tale da riprendere con il successivo periodo preparatorio, ad un livello
di condizione superiore a quella di partenza dell'anno precedente.
89
TABELLA RIASSUNTIVA DEI MEZZI DA USARE NEI VARI PERIODI
Periodo preparatorio 1* tappa
Corsa di durata a ritmo costante
Scatti brevi
Esercizi con carichi (bilancieri, manichini, sacconi, palle mediche) e agli attrezzi (paralle-
le, sbarra, palco per salite)
Esercizi con partner
Esercizi di ginnastica generale e di acrobatica
Giuochi sportivi
Esercizi speciali preparatori
Esercizi di esecuzione delle azioni tecniche
Incontri didattici e. saltuariamente, incontri didattici di allenamento e di allenamento.
Periodo preparatorio 2' tappa
Corsa di durata a ritmo costante
Corsa di durata a ritmo variabile
Scatti brevi
Corsa di velocit prolungata (300-400 mt)
Esercizi con carichi e agli attrezzi
Esercizi con partner
Esercizi di ginnastica generale e di acrobatica
Giuochi sportivi
Esercizi speciali preparatori
Esercizi introduttivi
Esercizi di esecuzione delle azioni tecniche e tattiche
Incontri didattici di allenamento
Incontri di allenamento e, saltuariamente, incontri di controllo e di competizione
90
Periodo fondamentale
Corsa a ritmo variabile
Scatti
Corsa di velocit prolungata
Esercizi con carichi e agli attrezzi
Esercizi con il partner
Esercizi di acrobatica
Giuochi sportivi
Esercizi speciali preparatori
Esercizi introduttivi
Esercizi di esecuzione delle azioni tecniche e tattiche
Incontri didattici di allenamento
Incontri di allenamento
Incontri di controllo
Incontri di competizione
Periodo transitorio
Esercizi di preatletismo generale
Giuochi sportivi
Sport ausiliari
N. B. - Non tuttavia da escludere che in un periodo possano essere usati saltuariamente dei
mezzi indicati per un altro; vi sempre comunque da tener presente il criterio della
prevalenza.
91
C O N C L U S I O N I
Concludendo questo lavoro si ritiene opportuno ribadire che l'organizzazione dell'allena-
mento cos come prevista dalla programmazione esposta, resta valida a tutt'oggi per atleti
giovani di prima qualificazione, anche se evidentemente abbastanza dotati, e per atleti di me-
dia qualificazione, diciamo di livello nazionale, con le opportune diversificazioni che sono sta-
te via via fatte.
Come compendio generale delle nostre riflessioni riportiamo quattro rappresentazioni
grafiche dell'andamento dei parametri del carico (quantit, intensit) relative ad una periodiz-
zazione annuale e ad una semestrale, rispetti/amente per gli atleti del 1 gruppo (giovani) e
del 2 gruppo (di media qualificazione) (vedi figg. n. 15-16-17-18).
L'andamento riportato graficamente quello medio. Esso non tiene conto, infatti, della di-
namica del carico, e quindi della intensit e della qualit, in periodi di tempo brevi (allenamen-
to singolo e microcicli).
Le cifre riportate in ordinata devono intendersi come cifre convenzionali e servono solo
per apprezzare meglio visivamente il rapporto tra i valori della quantit e dell'intensit nei
vari periodi e il rapporto tra i differenti valori che l'intensit e la quantit assumono in funzio-
ne del periodo.
Al esempio per il r gruppo, periodizzazione annuale, si ha: all'inizio quantit quasi il dop-
pio dell'intensit, rapporto 8,3 4.5; alla fine della r tappa del periodo preparatorio quantit
quasi il doppio dell'intensit, rapporto 15.1 : 8, 1; alla fine dell'intero periodo preparatorio quan-
tit quasi uguale all'intensit, rapporto 12,5 : 12.4; nel periodo fondamentale quantit quasi
la met dell'intensit, rapporto 8 : 15: nel periodo fondamentale quantit quasi la met della
quantit alla fine della 1 tappa del periodo preparatorio, rapporto 8: 15,1, e quasi due terzi
della quantit alla fine dell'intero periodo preparatorio, rapporto 8 : 12,5; alla fine della pri-
ma tappa del periodo preparatorio intensit quasi la met dell'intensit nel periodo fonda-
mentale, rapporto 8.1 : 15, e quasi due terzi dell'intensit alla fine dell'intero periodo preparato-
rio, rapporto 8.1 : 12,4,
A proposito della quantit e dell'intensit specifichiamo che:
1) la quantit del lavoro data dalla somma della durata netta degli esercizi in minuti, 1 = 1
minuto (convenzionalmente si pensato bene di prendere come metro di paragone un
valore facilmente misurabile in pratica da chiunque) ed essendo Q,, Q,, Q, . . . Q = quan-
tit in minuti di ogni esercizio e 0., = quantit di lavoro di un allenamento, Q., = Q, + Q, +
O, + Q,
2) l'intensit degli esercizi viene convenzionalmente stabilita in punti, in base ad una scala
appositamente studiata (tab. pag. 65), con un metodo scientificamente poco ortodosso,
ma pratico, che l'esperienza e appositi studi hanno dimostrato essere comunque abbastan-
za aderente alla realt: i valori riportati nella scala, in corrispondenza dei vari tipi di eser-
citazione, sono stati infatti determinati in base al numero delle pulsazioni cardiache che,
mediamente, l'esecuzione degli esercizi provoca in un atleta allenato; essendo I,, l
2
, l
3
. . . .
92
fig. N. 15
I *** t 2 t r i I ac M I jr. I M i I X D i I jz ln7f t n wj:
P E R I O D O P - R E P H T t ) R I O
I T H P P ft -Hp T fl I M'
K i i r E i i i m
F O f V D f l we wT t e
( D U l J I T i r l
6 B V P P O P E R I O D
z z P z t o r e
n * u fl L E
fio. /V. 76
fjPE 81C B 0 P I E P Sf cl i TO R I > ~ j Pi I 0 o n I',
E r TUPPf t-<f -"H rKPPrt-^j FOMOflrtEwrnLE [
I V I t * f I T *
I TAPPP-
0 : O u m T I T '
t o m o | P E RI O DO PE RIO DO
B Tf l PPP-^ FCN6ftri6llirt6 [ TBPWITOmO
6 R (/ p p 0 P E ft I 0 Is. 2 Z A I I 0 E I f N E t T R f l L E
93
Fig. N. 1 7
I
*
l
u
n
u
e
a
a
11
* >
*
*
*
i
it
3
X
1
o
0
I
1
' * > ~~J
/ l \ j
X i \ /
/ 1 \ /
0 / 1 X
/ i / \
S ^ 1
^ 1
1
1
: !
i
1
* r 1 :w+st * * * # / 1 JE [> I * M i t "
p r ft f- ft fi > l * [ r r f l n n t r ) n i ^
r t n ' u v v r it c r nn n i Ki7 I I/ ,
* Jt
1 1
1 j
! 1 y^
\ 1 1 /
\. Y
i \ _ ^ (
i i
i ^^^ i
' / \
y \ I N.
- _ -*^ i i ^
i i
i i
1
!
1 1
I |
I |
1 1
' JHf * * i * ' m **et j i xw* i | * / e
b r Q 1 A A A . A U n H C I T B I C
, r f r f l 1" Vv O r U N d H f l t f i i H L c
1 ' M 1
I i * r e * rifar 1 .
1 Jt i nWr j e '
Wrt t
_2ff J I k*Xot
PE R1 ODO
TMin i TOflio
I * r fc* s r tA". r QO * T I 7ft
& R V P P PFft I O f l 2 2 & 2 l H F R ti H U fl I
fig. A/. T8
St WtSt
PEfflQOO PREPfflftTOfrlO
I Tf i f PA) f cI T*Pr*ft
i JT r jv 11 r
1*
6 * .0 e :f o r* f n . o H n fi n o . S E M E S T R A L I
94
I = intensit di ogni esercizio e La = intensit media di un allenamento.
(Q, I,) + (Q
2
- l
2
) + , . . . ( Q - U
Ima - ""
Q, + Q
2
+ . . . . Q
I valori della quantit e dell'intensit cos determinati ci permettono di conoscere l'anda-
mento di questi due parametri allenamento per allenamento, cos da apprezzarne tutte le va-
riazioni per periodi di tempo non troppo lunghi (microcicli e mesocicli). Viceversa, stabi-
lita quale debba essere l'intensit e la quantit dei singoli allenamenti, si ha la possibilit
di costruirli razionalmente, scegliendone il contenuto e le metodologie, in modo tale da rispet-
tare le scelte fatte.
Se, invece, si vuol conoscere l'andamento medio della quantit e dell'intensit per un pe-
riodo di tempo pi lungo che non il singolo allenamento, si dovr calcolarne i valori medi setti-
manali. Questi ultimi non riportano fedelmente il comportamento ondulatorio della quantit e
dell'intensit nell'ambito dei microcicli, ma danno un'idea abbastanza precisa, del loro anda-
mento in periodi di tempo mediamente lunghi (uno o pi mesocicli).
Vediamo come si calcolano la quantit media settimanale e l'intensit media settima-
nale:
essendo Q
a
= quantit di lavoro di un allenamento
Q
E
= quantit di lavoro giornaliero
Q
ms
= quantit media settimanale
Q
g
= Q
a]
+ Qa
2
+ Q" dove Qa,, Q,
2
Q
a
= quantit di lavoro dei vari allenamenti so-
stenuti in un giorno
Qu + Qg
2
+ - Q
e n
Q
ms
= dove Q
g
|, 0,2 . . . . Q, = quantit di lavoro nei vari giorni in cui
7
si sono sostenuti gli allenamenti.
essendo l
m
, = intensit media di un allenamento
|
mg
= intensit media giornaliera
|
ms
= intensit media settimanale
(I m, , Qa, ) + (lma2 " Qa2) + . . . . (Iman 0, )
u =
Qa , + Qa2 + Qam
dove La,, La
2
, . . . Lan = intensit media dei vari allenamenti giornalieri
Umg, * vj gj j - r Umg2 ' vJg2J + Umgn ' UgnJ
Ims
Og, + Qg
2
+ . . . . Ogn
dove Lg,, L
g2
, Lgn = intensit media dei vari giorni in cui si sono sostenuti gli allenamenti.
95
Nelle tabelle a pag. 66 riportiamo indicativamente un termine di paragone numerico per
la quantit e l'intensit riferito ad un singolo allenamento e alla media settimanale.
Per gli atleti di livello internazionale il discorso diverso. Pur restando validi infatti i
concetti generali esposti, per essi vanno fatte delle considerazioni particolari: cambia per
esempio il rapporto tra lavoro generalizzato e lavoro specifico, a favore del secondo, gi nella
prima tappa del periodo preparatorio, pur rispettando sempre il criterio della variet dell'eser-
citazioni; cambia l'incidenza dell intensit nel carico, essendo pi determinante; i mesocicli
sono pi corti e piu finalizzati gi nel periodo preparatorio; le punte di carico che si fanno rag-
giungere sono di conseguenza pi elevate, e pi frequenti i momenti in cui vengono toccate
le punte massime
Per fare un'ultima precisazione, relativa questa alla strutturazione del periodo fondamen-
tale, sempre con riferimento ad atleti di livello internazionale, vi da dire che, nel caso in
cui nell'annata ci sia un traguardo che primeggia sugli altri (olimpiadi, camp, del mondo, camp,
europei) la preparazione dovr essere imperniata su quello e le altre gare, anche importanti,
sia in campo nazionale che internazionale, dovranno essere considerate come gare prepara-
torie per quella pi importante.
Non tutti gli anni potranno per essere strutturati cos, Dopo un anno del genere, in-
fatti , bene far seguire un'annata meno finalizzata su di un unico traguardo, diciamo pi leg-
gera, almeno da un punto di vista psicologico.
Un pi approfondito esame delle problematiche inerenti la programmazione dell'allena-
mento di atleti di cos alto livello esula comunque dai limiti del presente lavoro che, ripe-
tiamo, va ritenuto valido per atleti di prima qualificazione e per atleti di livello nazionale o
di media qualificazione.
96
TABELLA INTENSIT'
TIPI DI ESERCIZI
Lotta a ri t mo massi mal e (ri presa da 30" a 1'). - Esecuzione azioni tecni che con
partner o con il mani chi no max. vel . di esecuzione (seri e da 30" a 1'). - Corsa
di vel oci t prol ungata al max. del l a vel oci t (ci rca 1').
Incontri di cont rol l o. - Incontri di competi zi one i mpegnat i vi . - Lotta a ri t mo sub.
max
1
(ri prese da 1' a 2' ). - Esecuzione az. t ecni che con partner o con il ma-
ni chi no a ri t mo sub. max. (seri e da 1' a 2' ). - Corsa di vel . prol ungata a ri t mo
sub. max. (seri e da 1' a 1'30").
Incontri di al l enamento (ri prese da 3' a 5'). - Inc. di compet. medi amente impe-
gnat i vi . - Esecuz. az. tecni che con partner o con mani chi no a ri t mo el evat o
2
(varie seri e da 1'-2). - Esercizi di i mi tazi one a ri t mo el evato. - Esercizi i n cir-
cui t o. - Corsa distanza media ( 2- 3) a ri t mo el evato. - Pratica al tri sport indi-
vi dual i a ri t mo el evato.
Incontri di allenarti, (ri prese ol t re 5'). - Esecuz. az. tecni che con partner o ma-
ni chi no a buon r i t mo
3
(seri e di 3'-5'). - Eserc. di i mi taz. e speci al i preparatori a
buon ri t mo (seri e da 3'-5'). - Corsa distanza medio-lunga (ci rca 5') a buon
ri t mo. - Giuochi sport i vi a ri t mo el evato. - Ri scal damento a ri t mo el evato. - Preatl.
a ri t mo el evato.
Incontri di dat t i ci di al l enamento. - Esecuz. az. t ecn. con partner o mani ch. a
ri t mo medio
4
(seri e ol tre 5'). - Eserc. di i mi taz. e speci al i preparatori a ri t mo
medi o. - Corsa distanza lunga (ci rca 10') a ri t mo medi o. - Pratica sport i ndi vi d.
a ri t mo medi o. - Serie di sal ti e acrobatica vari a.
Incontri di dat t i ci . - Esecuz. az. t ecn. con partner o mani ch. a ri t mo l egger o' . -
Es. di i mi t . e spec. prep, a ri t mo l eggero. - Corsa prolungata a ri t mo varia-
bi l e. - Giuochi sport i vi a ri t mo medi o. - Preatl. a ri t mo medi o. - Riscald. a
ri t mo medi o.
Corsa prolungata ri t mo cost ant e. - Sport indiv. a ri t mo l eggero. - Preatl. e ri se,
a ri t mo l eggero.
Corsa a ri t mo l eggero. - Giuochi sporti vi a ri t mo l eggero. - Gi nnasti ca general e
a ri t mo l eggero.
Passeggiate a buon ri t mo di marcia. - Eserc. di al l ungamento e ri l assamento. -
Sauna. . .
Pulsazioni
(val ore indie.)
ol t re 200
180-200
160-180
150-160
140-150
130-140
120-130
100-120
80-100
Intensi t
i n punti
10
9
8
7
6
5
4
3
1-2
t. Al 90% del massimale
2. All' 80% del massimale
3. Al 70% del massimale
4. Al 60% del massimale
5. Al 50% del massimale
97
TABELLE INDICATIVE VALORE QUANTIT' E INTENSIT'
ALLEN. SINGOLO MEDIA SETTIMANALE
o
C
CO
3&
5
TI
0)
2
oS
f a
es
o
Ouantit
in minuti
1 Gr.
85
70
57
45
30
2 Gr.
95
80
65
50
35
Intensit
in punti
1 Gr.
6
5
4
3,2
2,5
2 Gr.
7
6
5
4
3
' o
' N
T I
0
C
CO
co co
CO
CO
5
o 2
v S,
m CO
2_GD
CO
CD
DI
D)
CD
- J
Quantit
In minuti
1 Gr.
110
90
70
55
40
2 Gr.
120
100
80
60
45
Intensit
In punti
2 Gr.
7
6
5
4
3
1 Gr.
8
7
6
5
4
N. B. - I valori medi settimanali sono calcolati sulla base di un piano di allenamento che prevede 6 allenamenti
la settimana.
I valori della quantit sono netti, si riferiscono cio alla durata effettiva degli esercizi, escludendo i tem-
pi di ricupero.
98
350 esercizi per lo sviluppo
delle qualit fisiche del lottatore
ESERCIZI DI PREATLETISMO
Il preatletismo comprende tutti gli esercizi ginnici a carico naturale e si
divide in preatletismo generale e preatletismo specifico.
Il preatletismo generale costituito da quelli esercizi e quelle metodiche
di esecuzione che hanno come finalit lo sviluppo armonico di tutte le qualit
fisiche ed alla base di tutte le specialit sportive.
Il preatletismo specifico costituito da quelli esercizi e quelle metodiche
di allenamento che hanno come finalit lo sviluppo di quelle qualit fisiche che
caratterizzano una determinata specialit sportiva ed una tappa intermedia
tra il condizionamento generale e l'esercitazione tecnica vera e propria.
Gli esercizi di preatletismo si eseguiranno in apposite sedute, molti di es-
si inoltre, con la sola esclusione dei pi impegnativi dal punto di vista musco-
lare ed organico, costituiranno la base del riscaldamento.
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
1) Andatura di passo veloce Tutte le andature e i
vari tipi di corsa hanno
come finalit principale
l'incremento della resi-
stenza organica e della
coordinazione
2) Andatura con rullata del piede Prendere contatto con il
tappeto con il tacco (tac-
co, pianta, punta)
3) Andatura sulla parte esterna dei
piedi
Ruotare al max. i piedi in
dentro
4) Andatura sulla parte interna dei Ruotare al max i piedi in
piedi fuori
101
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
5) Marcia sportiva Attacco (tacco, pianta, < >
punta) \->
6) Corsa a ritmo blando
7) Corsa a ginocchia alte in avanti Flettere le ginocchia al
petto
8) Corsa a ginocchia alte in fuori Ruotare il pi possibile la
coscia in fuori
9) Corsa calciata dietro Toccarsi i glutei con i tal- <M|
Ioni c_
102
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
10) Corsa calciata dietro in fuori Ruotare il pi possibile la
gamba in fuori
11) Corsa calciata dietro in dentro
12) Corsa sul fianco
13) Corsa all'indietro
14) Corsa incrociata in avanti
Ruotare il pi possibile la
gamba in dentro
Partire con la gamba an-
teriore (nel senso della di -
rezione di marcia) prima
che la posteriore vada a
toccarla
Incrociare bene a gambe
tese
103
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
15) Corsa incrociata sul fianco Guardare avanti, accen-
tuare la torsione del baci-
no
16) Corsa incrociata all'indietro Incrociare bene a gambe
tese
17) Corsa balzata Ginocchio dell'arto avan-
zante flesso al petto, arto
posteriore teso dietro
18) Corsa balzata incrociando i balzi es.
19) Corsa saltellata
104
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
20) Corsa saltellata all'indietro
21) Corsa saltellata in avanti, due
saltelli successivi per parte
22) Corsa saltellata all'indietro, due
saltelli successivi per parte
23) Spinte degli arti superiori in avanti Posiz. di partenza, mani
alle spalle; spinta molto
dinamica, il ritorno deve
avvenire sfruttando l'ela-
sticit muscolare (rimbal-
zo)
Tutti gli esercizi di
spinte, slanci e cir-
conduzioni degli arti
superiori, fatti in corsa,
incrementano in varia
misura le qualit fisiche
a seconda del ritmo
esecutivo.
Con ritmo esecutivo di
andata su un appog-
105
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
24) Spinte degli arti superiori in alto Posiz. di partenza, mani
alle spalle; spinta molto
dinamica, il ritorno deve
avvenire sfruttando l'ela-
sticit muscolare (rimbal-
zo)
25) Spinte degli arti superiori in fuori
26) Spinte degli arti superiori in a- es
vanti, in alto, in fuori
27) Slanci degli arti superiori in avanti
fino a 90 gradi
gio e ritorno sull'altro si
incrementa la rapidit,
la coordinazione, la
mobilit articolare, la
resistenza organica
aerobica.
Con ritmo esecutivo di
andata e ritorno ogni
appoggio, oppure di
andata e ritorno ogni
saltello a piedi uniti, si
incrementa la rapidit,
la coordinazione, la re-
sistenza organica e
muscolare aerobica e
anaerobica (la com-
ponente anaerobica
varia a seconda della
durata di ogni singolo
impegno e della durata
dei recuperi), la mobili-
t articolare.
Se gli stessi esercizi
sono eseguiti da fermo
si incrementa pi che
altro la rapidit, la mo-
bilit articolare, la resi-
stenza muscolare
Posiz. di partenza con
braccia lungo i fianchi
28) Slanci degli arti superiori in fuori es.
fino a 90
106
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
291 Slanci degli arti superiori da 90
in alto per avanti
Da braccia in avanti, non
piegare le braccia ma te-
nerle tese e parallele, for-
zare lo slancio
30) Slanci degli arti superiori da 90
in alto per fuori
Da braccia in fuori, non
piegare le braccia, palme
in fuori
31) Slanci completi degli arti superio-
ri in alto per avanti
Da braccia lungo i fianchi,
curare l'ampiezza e la
correttezza del movi-
mento
32) Slanci completi degli arti superio-
ri in alto per fuori
33) Slanci degli arti superiori in avanti
da braccia in fuori
Curare al max. la rapidit
del gesto, non battere le
mani l'una contro l'altra
107
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
1
34) Slanci degli arti superiori indietro
da braccia in avanti
35) Slanci degli arti superiori indietro
da braccia piegate a 90 e rivolte
verso l'alto (pdsiz. a candelabro)
Forzare al max. lo slancio,
slanciare le braccia leg-
germente verso l'alto
supinandole
Non portare l'avambrac-
cio in avanti durante lo
slancio, slanciare verso I'
indietro-alto e non verso I'
indietro - basso, mante-
nere gli angoli di 90 du-
rante lo slancio
36) Slanci degli arti superiori indietro
da braccia piegate a 90 e rivolte
verso il basso (posiz. a candela-
bro rovesciato)
37) Piccole circonduzioni delle brac-
cia nei due sensi
Da braccia in fuori, brac-
cia tese
38) Circonduzioni di un braccio nei
due sensi
Da braccio in alto, curare
al max. l'ampiezza del mo-
vimento
108
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
39) Circonduzioni delle due braccia
nei due sensi
Da braccia in alto, curare
al max. l'ampiezza del mo-
vimento
40) Flessioni della coscia sul bacino,
in avanti
Gamba portante tesa, ac-
centuare al max. la fles-
sione senza venire in
avanti col petto
41) Flessioni della coscia sul bacino,
in fuori
Ruotare bene la coscia in
fuori, non inclinarsi col
tronco
42) Flessioni in avanti della coscia sul
bacino e successiva abduzione
della coscia stessa
Non ruotare in fuori il ba-
cino abducendo l'arto
43) Flessione in fuori della coscia sul
bacino e successiva adduzione
della coscia stessa
Ruotare bene la coscia in
fuori flettendola sul baci-
no
Tutti gli esercizi di fles-
sione, flessione e spin-
ta, slanci degli arti in-
feriori possono essere
eseguiti con varie me-
todiche:
1) di passo, una ese-
cuzione ogni tre passi;
2) di passo, una ese-
cuzione ogni due pas-
si;
3) di passo, una ese-
cuzione ogni passo;
4) di corsa, una esecu-
zione ogni tre appoggi;
5) di corsa, una esecu-
zione ogni due appog-
gi:
6) di corsa, una esecu-
zione ogni appoggio,
con saltello di recupe-
ro, partendo dopo che
arrivato a terra l'altro
arto (successive);
7) di corsa, una esecu-
zione ogni appoggio,
senza saltello di recu-
pero, partendo prima
che arrivi a terra l'altro
arto (alternate).
Le finalit variano a
seconda del ritmo e-
secutivo, in analogia a
guanto visto per gli e-
sercizi degli arti supe-
riori.
Gli esercizi per gli ar-
109
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
44) Flessioni e spinte degli arti infe-
riori in avanti
45) Flessioni e spinte degli arti infe-
riori in fuori
46) Slanci degli arti inferiori in avanti
47) Slanci degli arti inferiori in fuori
48) Piegamenti braccia con mani in
appoggio su una panca e piedi a
terra
110
Gamba portante tesa, pri-
ma flettere la coscia sul
bacino, quindi estendere
la gamba sulla coscia,
dando come un colpo di
tallone in avanti
es.; ruotare bene l'arto
in fuori prima di esegui-
re la flessione-spinta
Gamba portante tesa, arto
slanciato teso; accentua-
re al max. lo slancio senza
andare indietro con il
tronco
es.; accentuare al max. lo
slancio senza inclinarsi di
fianco con il tronco
Corpo teso dietro, max.
escursione del movi-
mento. L'impugnatura
pu essere larga, me-
dia o stretta. Con im-
pugnatura media i mu-
scoli prevalentemente
interessati sono gran-
de pettorale, deltoide
anteriore e tricipite.
Con impugnatura larga
relativamente mag-
giore l'impegno del
grande pettorale. Con
impugnatura stretta
relativamente mag-
giore l'impegno del tri-
cipite
ti inferiori si possono
combinare variamente
con quelli per gli arti
superiori. Le possibili
combinazioni sono
molte e si lascia alla in-
ventiva dei singoli alle-
natori il compito di sc-
glierle. Combinando
esercizi per gli arti in-
feriori con quelli per gli
arti superiori si compli-
ca notevolmente l'ese-
cuzione e quindi assu-
me importanza de-
terminante la coordina-
zione
Tutti gli esercizi se-
guenti hanno come fi-
nalit l'incremento di
tutte le qualit fisiche,
con prevalenza dell'
una o dell'altra a se-
conda della metodica
esecutiva
Dal 48 al 56 impegno
del cingolo scapolo-
omerale, della parte
superiore del tronco e
degli arti superiori
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
49J Piegamenti braccia con mani e
piedi a terra
50) Piegamenti braccia con mani a
terra e piedi su di una panca ()
51) Piegamenti braccia con mani ri -
volte verso l'esterno
52) Piegamenti braccia con mani ri -
volte verso l'interno con le dita
che si toccano
' es.; relativo
maggior impegno
del tricipite
53) Piegamenti braccia con braccia
in avanti in appoggio sugli avam-
bracci
54) Piegamenti braccia in verticale
(vari tipi) ()
Vedi esercizi di potenzia-
mento
) Gli esercizi contraddistinti dal pallino sono piu impegnativi da un punto di vista muscolare od organico, hanno una
influenza pi marcata sullo sviluppo delle qualit indispensabili al lottatore e quindi sono da ritenersi piu "Specifi-
ci.
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
55) Piegamenti alle parallele () Vedi esercizi di potenzia- il M i
mento
56) Trazioni alla sbarra (vari tipi) ()
57) Piccoli slanci alternati degli arti
inferiori sul piano sagittale
Bacino bloccato
e -schiacciato
sul tappeto,
braccia lungo i
fianchi o incro-
ciate sul petto,
testa flessa in
avanti, posiz. di
partenza supina
Dal 57 al 72 impegno
dei flessori della co-
scia sul bacino e della
fascia addominale (ret-
to dell'addome, obliqui,
trasversi), con esclu-
sione dei flessori della
coscia quando l'eser-
cizio viene eseguito a
gambe flesse
58) Circonduzioni degli arti inferiori
descrivendo con i piedi piccoli
cerchi
59) Circonduzioni degli arti inferiori a
gambe unite, descrivendo con i
piedi cerchi piu ampi
112
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
60) Abduzioni e adduzioni degli arti
inferiori dopo averli sollevati da
terra
61) Slanci simultanei degli arti inferio-
ri verso lavanti-alto sul piano sa-
gittale, fino a toccare con i piedi
sopra la testa
62) Flessioni in avanti del tronco a
gambe tese
63) Flessioni in avanti del tronco a
gambe raccolte
64) Flessioni e torsioni del tronco a
gambe raccolte
65) Flessione e torsioni del tronco a
gambe raccolte
es. ; arti inferiori tesi
degli arti
forzare l'abd. e l'add.
Da supini, gambe tese, braccia lungo i
fianchi, tronco bloccato.
Da supini, gambe tese e bloccate, braccia
in alto
Da supini, gambe raccolte con i piedi bloc-
cati, mani dietro la testa, testa flessa in
avanti; non sdraiarsi completamente in-
dietro e non arcuare la schiena andando in-
dietro, ma tenere il bacino bloccato e
schiacciato sul tappeto
es.; dopo ogni flessione eseguire una tor-
sione, una volta a dx., una a sx.
l ' i ^
es. ; dopo la flessione eseguire una suc-
cessione di torsioni a dx. e a sx., cercando
di mantenere l'inclinazione del tronco a 45
es. ; con interessa-
mento anche degli ad-
duttori e abduttori della
coscia
113
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
66) Chiusure a libro a gambe tese Da supini, flettere contemporaneamente Je es.
gambe e il tronco
i W/7 ^
67) Chiusure a libro a gambe rac-
colte
68) In sospensione alla spalliera max. Arrotolarsi cercando di
raccolta degli arti inferiori al pet- arrivare con le ginocchia
tot.) al petto
69) In sospensione alla spalliera,
slanci simultanei degli arti inferiori
per avanti-alto a gambe tese()
Arrotolarsi, slanciare le
gambe in alto e cercare di
arrivare con i piedi pi in
alto possibile
70) Flessioni in avanti del tronco su
un piano inclinato a gambe rac-
coltel)
Piedi bloccati in alto, mani dietro la testa,
testa flessa in avanti; non sdraiarsi indie-
tro, tenere il bacino bloccato e schiaccia-
to
114
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
71) Flessioni e torsioni su un piano in-
clinato a gambe raccolte ()
72) Flessione e torsioni del tronco su
un piano inclinato a gambe rac-
colte ()
es. ; dopo ogni flessione eseguire una tor-
sione, una volta a dx.. una a sx
es. ; dopo la flessione eseguire una suc-
cessione di torsioni a dx. e a sx.
73) Iperestensioni alternate degli arti
inferiori
Da proni, sul tappeto, tronco bloccato sulla
materassina, gambe tese
74) Iperestensioni simultanee degli es.
arti inferiori
Dal 37 al 78 impegno
della muscolatura po-
steriore delle cosce,
dei glutei e dei lunghi
del dorso
75) Iperestensioni simultanee degli
arti inferiori e del tronco
Mani dietro la testa, iperestendere simulta-
neamente tronco e arti inferiori; gambe te-
se, testa iperestesa all'indietro
115
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
76) Iperestensioni del tronco Su pan-
ca orizzontale ()
Supini, mani dietro la testa, testa iperestesa
ali indietro, tronco fuori della panca, gambe
bloccate W
Dal 37 al 78 impegno
della muscolatura po-
steriore delle cosce,
dei glutei e dei lunghi
del dorso
77) Iperestensioni e torsioni del
tronco su panca orizzontale ()
78) Iperestensione e torsioni del
tronco, su panca orizzontale ()
79) Serie di saltelli a gambe unite dal-
la stazione eretta (in avanti, sul
fianco, indietro, in avanti laterali,
indietro laterali, in avanti e indie-
tro incrociati con torsione del
tronco)
80) Traslocazione e brevi passi mol-
leggiati in posizione di massima
accosciata ()
81) Serie di balzi in lungo e in alto
dalla mezza accosciata ()
116
e s . dopo ogni iperestensione eseguire una
torsione, una volta a dx . una volta a sx.
es.: dopo la ipe-
restensione ese-
guire una suc-
cessione di tor-
sioni a dx. e a sx.
Gambe quasi tese, spingere bene con il
piede
e s . con interessa-
mento anche degli o-
bliqui e dei trasversi
es. , con interessa-
mento anche degli o-
bliqui e dei trasversi
Prevalente impegno
del tricipite surale (po-
steriori della gamba)
mx
Non sollevare il bacino
durante la traslocazio-
ne
Gambe unite
Negli esercizi seguenti
vi un impegno della
totalit della muscola-
tura degli arti inferiori e
dei glutei
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT'
82) Serie di balzi in lungo e in alto
dalla massima accosciata ()
Gambe unite
83) Serie di balzi in avanzamento con
completa estensione degli arti in-
feriori
es. ; spingersi ver-
so lavanti - alto,
quindi iperesten-
dere leggermente
il corpo indietro
84) Sene di balzi in avanzamento con es. ; prima spingersi, quindi flettere le gi -
flessione delle ginocchia sul ba- nocchia
cino
85) Serie di balzi in avanzamento con
flessione delle gambe sulla co-
scia
es. ; prima spingersi, quindi flettere le
gambe
117
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
86) Balzi in alto superando un osta-
colo ()
87) Salti in basso ()
es. ; da fermo e con una piccola rincorsa
fr
88) Salti in basso con successivo
balzo in alto o in lungo ()
89) Traslocazione in massima piegata
(.)
es. ; ammortizzare e spingere, cercando di
sfruttare l'elasticit muscolare
w
Non sollevare il bacino
durante la traslocazio-
ne
90) Successione di piegate in avan-
zamento sul piano sagittale con
molleggio
118
Sollevare un arto e cadere elasticamente in
avanti sull'arto sollevato; busto eretto, gam- | ^
ba dietro tesa (tipo spaccata del solleva- / \ * \ c ^ '
mento pesi) Iflf
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE FINALIT
91) Successione di piegate sul posto,
sul piano sagittale previa esten-
sione e con cambio in aria degli
appoggi ()
92) Contropiegate sul piano sagittale
93) Piegate sul piano frontale
94) Contropiegate sul piano frontale
Dopo aver effettuato la piegata spingersi
verso l'alto e invertire in aria la posizione
delle gambe
Piegare un arto ed
estendere indietro
l'altro, busto eretto
Sollevare un arto e, sbilanciandosi di fianco,
caderci elasticamente sopra; piedi rivolti in
avanti e paralleli, busto eretto, l'altro arto
teso
13
Piegare un arto e
protendere in fuori
l'altro; piedi rivolti
in avanti e paralleli,
busto eretto, arto
proteso in fuori te-
so
119
ESERCIZI DI POTENZIAMENTO CON PESI E ATTREZZI
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA ( + )
1) Distensione lenta dietro
la testa
Piedi leggermente diva-
ricati, gambe tese, im-
pugnatura un po' pi
larga dell'ampiezza delle
spalle, scendere ogni
volta con il bilanciere all'
altezza delle scapole
Trapezio, deltoide, grande
dentato, tricipite
2) Distensione lenta avanti Piedi leggermente diva-
ricati, gambe tese, im-
pugnatura larga quanto I'
ampiezza delle spalle,
non schienarsi durante
l'esecuzione
3) Piegamenti in verticale,
dietro la testa (con ca-
valletto)
Altezza del cavalletto 40 cm.,
non spostare i piedi sulla parete
durante l'esecuzione, affonda-
re bene, impugnatura un po'
pi larga dell'ampiezza delle
spalle
4) Piegamenti in verticale,
avanti (con cavalletto)
Tricipite, deltoide, grande
dentato, trapezio
Trapezio, deltoide, grande
dentato, tricipite
Tricipite, deltoide, grande
dentato, trapezio
( + ) - Altri muscoli possono intervenire nell'esecuzione degli esercizi, ma il loro intervento secondario rispetto a
quelli citati. L'ordine con cui sono citati i muscoli rispetta l'importanza che essi hanno nell'effettuazione degli
esercizi, cio la prevalenza di impegno.
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
5) Distensione con manubri
6) Rematore in piedi
Piedi leggermente divaricati, gam-
be tese, impugnatura rivolta verso
l'interno
Impugnatura stretta,
partire in piedi dopo
aver staccato il bilan-
ciere, effettuare la tira-
ta concludendo l'es.
con il bilanciere al
mento e con i gomiti alti
Deltoide, tricipite, grande
dentato, trapezio
4f#V
Deltoide, trapezio, flessori
dell'avamb. sul braccio
icipite, brachiale ante-
riore, coraco brachiale)
7) Aperture laterali con ma-
nubri
8) Distensione su panca in-
clinata in alto
9) Distensione su panca o-
rizzontale, impugnatura
media
Braccia tese, non fer-
r marsi con le braccia
lungo il corpo, portare
/ le braccia fino a 90
Deltoide laterale, trapezio
Spingere lungo la vertica-
le, non fare il ponte
staccando i glutei dalla
panca
Non fare il ponte-
staccando i glutei dalla
panca
Tricipite, deltoide anterio-
re, grande pettorale, tra-
pezio
Grande pettorale, deltoi-
de anteriore, tricipite
121
ESERCIZI
MUSCOLATURA
INDICAZIONI METODOLOGICHE PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
10) Distensione su panca in-
clinata in basso, impu-
gnatura media
111 Croce su panca con ma-
nubri, dal decubito supi-
no
Braccia tese, partire
da braccia in fuori
(orizzontali) e portarle
in avanti (verticali)
Spingere lungo la verti-
cale
Grande pettorale, deltoi-
de, tricipite
Grande pettorale, deltoi-
de anteriore
12) Pull-over a braccia pie-
gate su panca
Testa fuori dalla pan-
ca, partire con il
bilanciere al petto,
andare molto in bas-
so con il bilanciere
senza fare ponte-
Grande pettorale, grande
dorsale, deltoide anterio-
re
13) Pull-over a braccia tese
su panca
Partire con il bilan-
ciere in alto, lascia-
rlo scendere fino al -
I orizzontale fuori
dalla panca, non
piegare le braccia
tornando nella posi-
zione di partenza
Grande pettorale, grande
dorsale, deltoide anterio-
re
14) Piegamenti alle parallele Affondare bene senza andare in
avanti col petto e indietro con le
gambe
Tricipite, pettorale, deltoi-
de, grande dorsale
122
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
15) Estensione dell'avam-
braccio sul braccio con
bilanciere, impugnatura
dritta
16) Estensione dell'avam-
braccio sul braccio con
bilanciere, impugnatura
inversa
In piedi, braccia pie-
gate con i gomiti
verso l'alto, estende-
re l'avambr. sul brac-
cio senza portare il
braccio in avanti
Tricipite
Tricipite
17) Piegamenti dell'avam-
braccio sul braccio con
bilanciere, impugnatura
dritta
In piedi, braccia lungo i
fianchi, flettere le brac-
cia senza aiutarsi an-
dando indietro con il bu-
sto
Flessori dell'avambraccio
sul braccio, muscoli dell
avambraccio
18) Piegamenti dell avam-
braccio sul braccio con
bilanciere, impugnatura
inversa
19) Piegamenti dell'avam-
braccio sul braccio con
manubri
es. , mani rivolte verso I in-
terno, piegamenti alternati
(un braccio steso, uno in
posizione di massima fles-
sione)
es. con un maggior inte-
ressamento del bicipite
123
ESERCIZI. INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
20) Trazioni
dritta
impugnatura Impugnatura un po' pi
larga dell'ampiezza delle
spalle, eseguire l'es. par-
tendo a braccia tese e ar-
rivare con il petto a toc-
care la sbarra
Dorsale, bicipite, fissatori
della scapola
21) Trazioni impugnatura in-
versa
Impugnatura uguale alla
larghezza delle spalle, cu-
rare la massima ampiezza
del movimento come nell'
es. precedente
es. con maggior interes-
samento del bicipite
22) Trazioni col triangolo Curare la massima ampiezza
del movimento
23) Trazioni dietro la testa Impugnatura molto larga, curare
la massima ampiezza del movi-
mento
24) Trazioni con impugnatu-
ra rivolta in dentro
124
es. con maggior interes-
samento del grande dor-
sale
es. con maggior interes-
samento del bicipite e del
grande dorsale
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
25) Trazioni con impugnatu-
ra rivolta in fuori
26) Salita alla fune Senza l'aiuto delle gambe, senza oscilla-
zioni del corpo
es. con maggior interes-
samento del grande dor-
sale
es. con maggior interes-
samento del bicipite, del
trapezio e dei muscoli
dell avambraccio
27) Trazioni con corpo oriz-
zontale
Corpo teso a tavo-
la, massima am-
piezza di movi-
mento
Dorsale, deltoide poste-
riore, bicipite, fissatori
della scapola
28) Rematore a 90
29) Rematore a 90 con bi -
lanciere bloccato a terra
ad una estremit
Schiena piatta, impugnatura
larga, concludere la tirata
con il bilanciere al petto e i
gomiti alti
Schiena piatta, im-
pugnatura stretta
(col triangolo), non
sollevare il busto
durante la tirata
es. con interessamento
anche dei lunghi del dorso
(bassa schiena)
e s
125
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
30) Slanci delle braccia in
fuori dal decubito, prono
su panca orizzontale,
con manubri
31) Circonduzioni delle spal-
le con bilanciere
32) Tirate al mento
33) Portate al petto
34) Spinte delle braccia in
alto con bilanciere al
petto
126
Partire a braccia in avanti (verticali) e slanciarle in
fuori fino all'orizzontale -r\_^
Deltoide posteriore, fissa-
tori della scapola
In piedi, impugnatura
stretta, gambe leg-
germente divaricate,
circondurre nei due
sensi, usare carichi
pesanti-
Impugnatura stretta, schiena piatta, effettuare la
tirata concludendo l'es. con il bilanciere al mento
e i gomiti alti
Trapezio
Quadricipite, glutei, lunghi
del dorso, trapezio, deltoi-
de, bicipite
Impugnatura larga quanto l'ampiezza delle spalle,
partire a braccia tese, effettuare la tirata a
schiena piatta, girare il peso andandovi sotto e
(
concludere l'es. in posizione eretta
es. con un maggior inte-
ressamento del quadrici-
pite e dei glutei
Flettere le gambe (non molto), spingere il bilan-
ciere verso l'alto sfruttando la spinta delle gambe
e, data una inerzia al bilanciere, stendere com-
pletamente le braccia, riflettendo le gambe che
avevamo esteso alla fine della spinta, per andare
sotto al peso; tornare quindi in posizione eretta
stendendo di nuovo le gamb
Quadricipite, glutei, trape-
zio, deltoide, tricipite
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
35) Strappi
36) Stacchi da terra a gam-
be tese
37) Stacchi da terra a gam-
be flesse
38) Estensioni del tronco dal
piegamento in avanti
(good morning) con cari-
co
39) Iperestensioni del tronco
dal decubito prono su
panca, con carico
Impugnatura larga, effettuare la tirata a schiena
piatta e riprendere il peso andandogli sotto, con-
cludere I es. a braccia tese; il bilanciere deve sa-
lire il pi vicino possibile al corpo dell'atleta
Lunghi del dorso, quadri-
cipite, glutei, trapezio,
deltoide
Impugnatura con una mano inversa per consenti-
re una presa pi forte, partire a braccia tese ti -
rando di gambe e schiena, schiena piatta (per
quanto possibile), concludere l'es. in posizione
eretta
Gambe divaricate, bilanciere
sulle spalle, piegarsi fino a
90 a schiena piatta, tornare
in posizione eretta
Proni su panca con il tronco fuori, gambe bloc-
cate, carico dietro la testa, piegarsi a 90 e quindi
iperestendere il tronco indietro
Lunghi del dorso, poste-
riori delle cosce
es. con interessamento
anche del quadricipite e
dei glutei
Lunghi del dorso, poste-
riori delia coscia, glutei
127
MUSCOLATURA
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
40) Torsioni del tronco con
bilanciere dietro la testa
In posizione eretta, gambe
divaricate, torcere il busto
tenendo bloccate le gambe
e il bacino
4 &
Obliqui, trasversi
41) Torsioni dalla posizione
in ginocchio, con bilan-
ciere bloccato a terra ad
una estremit
Impugnare l'estre-
mit libera del bilan-
ciere andando mol-
to sotto con le gi -
nocchia, effettuare
la torsione portando
l'estremit del bilan-
ciere di fianco
Obliqui, traversi, deltoide,
trapezio
42) Inclinazioni del tronco
con manubri
In piedi, gambe leggermente
divaricate, braccia lungo i
fianchi, mantenere le braccia
tese durante l'esecuzione
dell'esercizio
Obliqui
43) Flessioni del tronco dal
decubito supino, su pan-
ca orizzontale, con cari-
co
Supini su panca, gambe tese e bloccate, carico
dietro la testa, non fermarsi col tronco verticale
Retto dell'addome, retto
del quadricipite, psoas i-
liaco
44) Flessioni del tronco dal
decubito supino su pan-
ca inclinata in basso,
con carico
128
es. ma a gambe pie-
gate, non sdraiarsi
completamente an-
dando gi
Retto dell'addome
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
45) Slanci degli arti inferiori
a gambe tese in sospen-
sione alla spalliera
46) Piegamenti gambe in ac-
cosciata fino a 90
Slanciare le gambe tese
verso l'alto e arrotolarsi
cercando di arrivare con i
piedi pi in alto possibile
Non estendere le
gambe incurvandosi in
avanti, ma cercare di
mantenere la schiena
piatta
47) Piegamenti gambe in ac-
cosciata completa
Inizialmente retto del qua-
dricipite e psoas, in segui-
to retto dell'addome
Quadricipite, glutei, po-
steriori della coscia (bici-
pite femorale, semimem-
branoso, semitendinoso),
lunghi del dorso
es. con un maggior inte-
ressamento dei glutei
48) Balzi in accosciata con
bilanciere sulle spalle
49) Piegamenti
spaccata
gambe in Il ginocchio della gamba
anteriore non deve sor-
passare la punta del pie-
de, busto eretto, gamba
dietro tesa
es. con un maggior inte-
ressamento dei posteriori
della coscia
129
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
50) Estensioni della gamba
sulla coscia, con carico
o con elastici
51) Flessioni della gamba
sulla coscia con carico o
con elastici
Mantenere la coscia
orizzontale, partire
sempre con la gam-
ba a 90 rispetto al-
la coscia
Portare la gamba a 90
rispetto alla coscia
Quadricipite
Flessori della gamba (bici-
pite femorale, semimem-
branoso, semitendinoso)
52) Slanci dell'arto inferiore
in avanti con carico
(scarpa di ferro) o elasti-
ci
53) Slanci dell'arto inferiore
indietro con carico
(scarpa di ferro) o elasti-
ci
54) Slanci dell'arto inferiore
in fuori con carico
(scarpa di ferro) o elasti-
ci
Slanciare la gamba
tesa senza prende-
re lo slancio
Flessori della coscia, (ret-
to del quadricipite. psoas
iliaco, tensore della fascia
lata)
Glutei, posteriori della co-
scia
Abduttori della coscia
130
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
MUSCOLATURA
PREVALENTEMENTE
INTERESSATA
55) Slanci dell arto inferiore
in dentro con carico
(scarpa di ferro) o elasti-
ci
Slanciare la gamba te-
sa senza prendere lo
slancio
Adduttori della coscia
56) Estensione dei piedi con
appoggio della punta su
di uno spessore
Bilanciere sulle spalle, bu-
sto eretto, max. esten-
sione possibile
Tricipite surale (gastroc-
nemio, soleo)
131
ESERCIZI CON IL PARTNER
Gli esercizi con il partner sono da considerarsi fondamentali per la prepa-
razione di un lottatore.
La loro influenza sul processo dell'allenamento molto varia a seconda
della metodica di esecuzione, ma essi sono indispensabili soprattutto perch
abituano il lottatore a muoversi con il partner e ad esercitarsi con lui in una si-
tuazione di equilibrio, statico e dinamico, che si avvicina alla lotta vera e pro-
pria.
Abbiamo diviso gli esercizi con il partner in due gruppi:
Esercizi da fermo
Esercizi in movimento
Gli esercizi da fermo sono stati raggruppati, per facilitare la loro com-
prensione, secondo il settore muscolare che interessano; essi, variando op-
portunamente la metodica di esecuzione, sono particolarmente indicati per in-
crementare nell'ordine: la forza, la resistenza muscolare, la rapidit e la mobili-
t articolare.
Gli esercizi con il partner specifici per la mobilit articolare non sono qui
di seguito riportati perch sono stati inseriti negli esercizi specifici per la mobi-
lit (vedi pag. 69).
Gli esercizi in movimento comprendono tutti i tipi di trasporti ed i cosiddet-
ti giochi di lotta, e costituiscono una tappa intermedia obbligatoria tra la pre-
parazione fisica generale e la lotta vera e propria.
Gli esercizi in movimento servono prevalentemente per migliorare nell'or-
dine: la resistenza organica e muscolare, il senso della posizione, l'equilibrio, I
abilit motoria specifica.
Per quanto riguarda la resistenza bene fare una precisazione: per lo svi-
luppo della resistenza generale (sia organica che muscolare) si utilizzer una
vasta gamma di esercizi in modo da interessare tutti I settori muscolari, il ritmo
esecutivo non sar eccessivamente elevato e la durata di ogni singola eser-
citazione superer i 60 minuti; per lo sviluppo della resistenza specifica si utiliz-
zer un minor numero di esercizi, ma specifici per il settore su cui vogliamo
agire, con un ritmo pi elevato ed una durata inferiore.
ESERCIZI CON IL PARTNER DA FERMO
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
1) Piegamenti sulle braccia affer-
randosi le mani:
A supino braccia in avanti, B pro-
no corpo proteso dietro con le
mani in appoggio sulle mani di A
Flettere ed estendere contemporaneamen-
te le braccia, scambiare la posizione ogni
serie
Muscolatura degli arti
superiori, del cingolo
scapolo-omerale e del-
la parte superiore del
tronco
2) Piegamenti sulle braccia affer-
randosi le caviglie:
A supino braccia in avanti, con le
mani afferra le caviglie di B che
sta prono sopra di lui con la testa
verso i piedi di A, B a sua volta af-
ferra le caviglie di A
132
es.
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE I SETTORI INTERESSATI
3) Croce dal decubito supino:
A supino braccia in fuori, B sopra
di lui con le mani afferra i polsi di
A, A cerca di portare le braccia
avanti vincendo la resistenza di B
4) Pull-over a braccia tese dal de-
cubito supino:
A supino braccia in alto, B sopra
di lui con le mani afferra i polsi di
A, A cerca di portare le braccia in
avanti, vincendo la resistenza di B
5) Pull-over a braccia piegate dal
decubito supino:
A supino braccia in alto, B seduto
dietro con i piedi contro le spalle
di A; A e B si afferrano le mani, A
esegue il pull-over tirando e flet-
tendo le braccia
6) Piegamenti sulle braccia con
partner che tiene l'esecutore per
le caviglie
7) Piegamenti in verticale con part-
ner che aiuta e mantiene in ver-
ticale
A a braccia tese, B deve regolare la forza in
modo da far fare un conveniente numero di
ripetizioni ad A K_
Muscolatura degli arti
superiori, del cingolo
scapolo-omerale e del -
la parte superiore del
tronco
B deve lavorare di schiena cedendo len-
tamente ad A, in partenza A a braccia te-
se
Mantenere il corpo teso 0jK
Spingere verso I alto cercan-
t
es.
do di mantenere la posizione
di equilibrio
133
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
8) Aperture laterali con partner:
A in posizione eretta braccia in
fuori, B afferra le braccia ai polsi
e spinge in basso; da braccia
lungo i fianchi A cerca di riportare
le braccia in fuori vincendo la re-
sistenza di B
9) Distensione da seduti con partner
che oppone resistenza:
A seduto sul tappeto con braccia
a candeliere, B in piedi dietro di
lui oppone resistenza
10) Slanci del partner:
A e B si pongono l'uno di fronte
all'altro, A afferra B sotto le a-
scelle e dopo un leggero piega-
mento sulle gambe lo slancia in
alto
A deve man-
tenere le brac-
cia tese con
palme rivolte
verso il basso,
B deve regolare
la forza in modo
da far fare ad A
un conveniente
numero di ripe-
tizioni
B deve tenere le gi -
nocchia contro la
schiena di A per man-
tenerlo a schiena piat-
ta, regolare la forza
es.
La spinta delle gambe deve
servire a spingere il partner
in alto a braccia tese ed aiu-
ta soltanto la spinta delle
braccia, qualora questa non
sia sufficiente
Muscolatura degli arti
superiori, del cingolo
scapolo-omerale e del-
la parte superiore del
tronco
es. con interessamen-
to anche degli arti infe-
riori
11) Chiusure delle braccia al tronco:
A e B di fronte, A con le braccia a
candeliere, B pone le proprie
braccia sopra quelle di A e cerca
di chiudergliele al tronco
12) Stesso esercizio con A seduto e
B in ginocchio dietro di lui
134
A palme verso l'interno,
braccia in fuori a 90; B
cerca di chiudergliele
facendo forza con i
gomiti verso il basso in
dentro
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
13) Flessioni ed estensioni dell'avam-
braccio sul braccio con partner
che oppone resistenza:
A seduto, B dietro ad A; B afferra
A per un polso e blocca con il
braccio libero il braccio di A, A
effettua flessioni ed estensioni
dell'avambraccio sul braccio
14) Stessa posizione dell'esercizio
precedente, B tiene fermo con un
braccio il braccio di A e con I'
altro gli afferra il pugno cercando
di flettergli il polso e quindi I'
avambraccio sul braccio
B deve mantenere ben
fermo il braccio di A e
deve regolare la forza
in modo da far fare un
conveniente numero di
ripetizioni ad A
es., A deve cercare di
resistere al max. con il
polso in estensione
Muscolatura degli arti
superiori, del cingolo
scapolo-omerale e del-
la parte superiore del
tronco
15) Tirate e spinte delle braccia a
stantuffo:
A e B di fronte piegati a 90, testa
contro testa, mani reciproca-
mente afferrate
16) Tirate delle braccia a stantuffo:
posizione come I esercizio pre-
cedente
Compiere il movimento il piu veloce possi-
bile
Compiere il movimento di forza- cedendo
lentamente a chi tira
17) Movimenti forzati del collo:
a) A in greca, B dietro di lui, A
cerca di mantenere il collo
eretto, B gli fa compiere delle
flessioni, estensioni, inclina-
zioni e circonduzioni forzate
della testa
b) A in piedi, B di fronte, A cerca
di mantenere il collo eretto, B
gli fa compiere delle flessioni
e delle inclinazioni forzate
Non fare forza di scatto, ma sempre pro-
gressivamente e anche in posizione statica.
Altri esercizi di potenziamento del collo con
il partner sono stati inseriti negli esercizi in
ponte e per il ponte
Muscolatura propria del
collo
135
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
18) Estensioni del tronco con partner
appeso al collo:
A disteso a terra, B dietro la sua
testa piegato a 90. A afferra il
collo di B, B lo solleva esten-
dendo il tronco
L'esecutore (B) non deve aiutarsi con le
gambe n tantomeno con le braccia, il part-
ner (A) deve tenere il corpo teso a tavola
Muscolatura della schie-
na, con interessamento
anche dei muscoli del
collo
19) Stacchi con presa in cintura in-
versa:
A in greca, B gli si pone di fianco,
lo afferra in cintura inversa ed
esegue una successione di stac-
chi
L'esecutore deve far passare il partner ogni
volta con i piedi verso l'alto e lo deve ripog-
giare a terra con la testa dalla parte oppo-
sta
Muscolatura della schie-
na, con interessamento
anche degli arti inferiori
20) Oscillazioni del partner sul piano
frontale:
A prende B in cintura dal davanti
con presa di braccio e tronco e,
dopo averlo sollevato, compie
delle oscillazioni sul piano fron-
tale
21) Oscillazioni del partner sul piano
sagittale:
A prende B in cintura dal di dietro
con presa di braccio e tronco e,
dopo averlo sollevato, compie
delle oscillazioni sul piano fron-
tale
136
Portare ogni vol-
ta il partner in
posizione oriz-
zontale
A a gambe diva-
ricate, durante
le oscillazioni de-
ve rimanere, per
quanto possibile,
a schiena piatta
e deve ipere-
stendersi all'in-
dietro al termine
dell'oscillazione
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
22) Sollevamento e slancio indietro
del partner.
A sta in piedi a gambe divaricate.
B entra sotto con la testa e. sol-
levando A, lo scarica dietro di se
23) Slancio degli arti inferiori in avanti
stando attaccati al collo del part-
ner:
A sta dietro B. B afferra il collo di
A. si appende a lui e slancia gli ar-
ti inferiori in avanti portandoli a
squadra
Non aiutarsi con le braccia sollevando il
partner, scaricarlo spingendo con le gambe
ed estendendo dinamicamente la schiena
Mantenersi bene a squadra mentre il part-
ner si sposta sul tappeto
Muscolatura della schie-
na, con interessamento
anche degli arti inferiori
Muscolatura della schie-
na (A) e della fascia ad-
dominale (B)
24) Flessioni del tronco agganciati al-
la vita del partner con le gambe:
A in piedi, B gli aggancia con le
gambe la vita, si appende a lui ed
esegue delle flessioni del tronco
25) Flessioni del tronco agganciati al-
la vita del partner che sta in gre-
ca:
A in greca, B seduto sul collo con
mani dietro la testa e piedi ag-
ganciati all'inguine di A
A corpo proteso dietro
e ben piazzato sulle
gambe, mani sotto i
glutei del partner, B
mani dietro la testa; ad
ogni flessione del
tronco B deve andare
a toccare con il proprio
petto il petto del part-
ner
A deve stare ben piazzato ed
aiutare con il collo le fles-
sioni del tronco di B, B deve
prima iperestendersi, per
quanto possibile, indietro,
quindi eseguire la flessione
del tronco in avanti
es. , A impegna anche la
muscolatura del collo
137
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
26) Flessioni del tronco da seduti con
partner:
A e B seduti a gambe divaricate
schiena contro schiena si affer-
rano per le mani ed eseguono
delle flessioni in avanti con part-
ner che oppone resistenza
27) Torsioni del tronco da seduti con
partner:
es. partendo da braccia in fuori
A e B devono stare appoggiati I uno contro
l'altro con tutta la schiena, senza andare in
avanti. La resistenza pu essere parziale,
allora sia A che B eseguono delle ripetizio-
ni, o max. allora sia A che B cercano di vin-
cere la resistenza del partner
Muscolatura della fa-
scia addominale
28) Inclinazioni del tronco da seduti
con partner:
es. partendo da braccia in fuori
29) Flessioni del tronco da supini con
partner che tiene le caviglie
30) Slanci degli arti inferiori da supini
con partner che respinge le
gambe verso il basso, a dx. e a
sin.
138
Gambe raccolte, mani dietro la testa, non
sdraiarsi completamente ogni ripetizione,
tenere la testa flessa in avanti
A si agguanta alle caviglie di B e dopo aver
slanciato gli arti inferiori verso l'alto deve
cercare di resistere al partner che li re-
spinge in basso
.9
es. con interessa-
mento anche dei fles-
sori della coscia
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
31) Inclinazioni del tronco da sdraiati
su di un fianco con partner che
tiene ferme le gambe
32) Torsioni con partner sulle spalle,
presa di testa e coscia
33) Salto del partner a piedi uniti:
A salta il partner battendo a piedi
uniti, B in posizione di:
a) decubito prono
b) in ginocchio (greca alta)
e) ponte
Mani dietro la nuca, accentuare al max. l'in-
clinazione; eseguire anche delle serie rima-
nendo per qualche istante in posizione di
max. inclinazione
Muscolatura della fa-
scia addominale
Sollevare il partner con
presa di braccio e co-
scia, quindi portare una
mano dietro la nuca; il
partner deve portare le
braccia in alto e stare
steso e rigido
Eseguire delle serie di numerosi salti, anche
a tempo
Muscolatura degli arti
inferiori e dei glutei
34) Piegamenti gambe con partner
che oppone resistenza
A e B in piedi uno di fronte ali altro
A esegue i pieg gambe, B gli po-
ne le mani sulle spalle e oppone
resistenza
35) Piegamenti gambe con partner
dorso contro dorso:
A e B si pongono in piedi dorso
contro dorso ed eseguono un
piegamento contemporaneo
Mantenere la schiena piatta
e la testa eretta
Mantenersi con la schiena
verticale e completa-
mente appoggiata a quel-
la del partner
139
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
36) Piegamenti gambe con partner
seduto sulle spalle:
A si pone in piedi a gambe divari-
cate, B gli entra sotto con la
schiena e dopo averlo sollevato
esegue dei piegamenti gambe
Schiena piatta (per
quanto possibile)
37) Piegamenti gambe con partner
posto trasversalmente sulla
schiena:
A afferra B con presa di braccio e
coscia, lo solleva ed esegue i
piegamenti
38) Piegamenti su una gamba con
partner che tiene l'altra:
A e B in piedi di fronte, si afferra-
no reciprocamente una gamba,
tenendola sollevata, ed eseguono
un piegamento sull'altra
39) Slanci delle gambe in fuori e in-
dietro con partner che oppone
resistenza:
a) in fuori stando sdraiati su di un
fianco
b) in dietro stando proni
40) Flessioni ed estensioni della gam-
ba sulla coscia, con partner che
afferra la caviglia dell'esecutore
e oppone resistenza, da supini
Muscolatura degli arti
inferiori e dei glutei
con notevole interes-
samento anche della
schiena
Eseguire il piegamento simultaneamente,
mantenere steso l'arto sollevato
Muscolatura degli arti
inferiori e dei glutei
a b
Partner seduto sui glutei deli esecutore, te- e s
nere il ginocchio a terra
140
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE SETTORI INTERESSATI
41) Adduzioni ed abduzioni delle co-
sce, con partner che oppone re-
sistenza:
A e B seduti l uno di fronte ali
altro. A con le gambe dentro-
quelle di B. cerca di abdurre le
sue (allargarle) mentre B cerca di
addurle (stringerle)
Non entrare molto
con le gambe, ma
tenere la parte i n-
terna ed esterna del
ginocchio l una con-
tro laltra, invertire la
posizione dopo ogni
serie
Muscolatura degli arti
inferiori e dei glutei
42) Saltelli in coppia su di una sola
gamba:
A e B si pongono di fronte, con
una mano si afferrano una cavi-
glia, tenendo laltra sulla spalla
del partner
Spingere fin sulla
punta del piede, e-
seguire i saltelli in
tutte le direzioni
8J
^ i
43) es ponendosi fianco contro
fianco
141
ESERCIZI CON IL PARTNER IN MOVIMENTO
ESERCIZI
INDICAZIONI METODOLOGICHE
1) Trasporto del partner con partner a
cavalcioni sulla schiena
2) Trasporto del partner con partner sulle
spalle
3) Trasporto del partner con partner
posto trasversalmente sulle spal-
le (presa di braccio e coscia)
Alternare la presa della coscia, destra e sinistra
4) Trasporto del partner con
partner in collo
5) Trasporto del partner con presa del partner attraverso la
schiena:
a) con presa di braccio e testa
b) con presa di braccio con due braccia
e) con presa di braccio e tronco
Eseguire con presa a destra e a sinistra, testa ri-
volta dalla parte opposta rispetto alla presa
142
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
6) Trasporto del partner camminando all'indietro con presa:
a) di braccia e tronco dal davanti
b) di braccia e tronco di fianco
e) di tronco dal di dietro
Eseguire la presa di fianco a destra e a sinistra,
camminare iperestendendosi ali indietro
7) Trasporto del partner cam-
minando in avanti e indietro
con partner appeso al collo
8) Trasporto del partner
tenendolo per le cavi-
glie, con partner ri -
volto verso il tappeto
e in appoggio sulle
braccia tese (carrio-
la); il trasporto pu
avvenire in avanti e
indietro
Il partner non deve piegare le gambe cam-
minando in avanti e indietro sulla materassina
con le braccia
9) Trasporto del partner
tenendolo per le cavi-
glie, con partner ri -
volto verso l'alto (pro-
no) e in appoggio sul-
le braccia tese (car-
riola rovesciata); il tra-
sporto pu avvenire
in avanti e indietro
10) Passaggio sotto- con tuffo tra le gambe del partner:
A in piedi a gambe divaricate, B esegue un tuffo tra le
gambe di A, si alza in piedi dall'altra parte, gira intorno ad
A e ripete
partner deve stare piu disteso possibile
Eseguire il tuffo simulando uno schiacciamento,
girare intorno al partner una volta a dx., una a sx.;
eseguire numerose ripetizioni a tempo
143
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
11) Salto del partner con appoggio delle mani sulle spalle:
A in piedi a gambe divaricate, B lo salta aiutandosi con la
spinta delle braccia, gira intorno al partner e ripete
A deve stare ben piazzato sulle gambe, B gira in-
torno al partner una volta a dx., una a sx.; esegui-
re numerose ripetizioni a tempo
12) Passaggio sotto con tuffo tra le gambe e salto del part-
ner con appoggio delle mani sulle spalle
13) Spinte petto contro petto
14) Spinte spalla contro spalla:
a) spalla dx. contro spalla dx.
b) spalla dx. contro spalla sx.
15) Spinte schiena contro
schiena, gambe pie-
gate a 90
Alternare i due esercizi precedenti; eseguire nu-
merose ripetizioni a tempo
Mani dietro la schiena testa di fianco, cercare di
far indietreggiare il partner
Mani dietro la schiena cercare di vincere la resi-
stenza del partner spingendo di fianco
a b
Appoggiare la schiena contro la schiena del part-
ner, piegarsi contemporaneamente sulle gambe e
spingersi cercando di far indietreggiare il partner;
mantenere il tronco verticale
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
16) Spinte a braccia tese palme contro palme Cercare di far indietreggiare il partner
17) Spinte a braccia tese
con presa reciproca di
collo e spalla
18) Spinte laterali con il collo:
A e B di fronte con la parte de-
stra del viso contro quella del
partner, ripetere a sinistra
19) Spinte e strappi a brac-
cia tese con presa reci-
proca di collo e spalla
Mani dietro la schiena, tronco leggermente flesso
in avanti, inclinare il collo cercando di vincere la
resistenza del partner
Cercare di far uscire il partner da un cerchio deli-
mitato
20) es. afferrandosi per i pois
21) Tiro della fune agganciati
per le mani a braccia tese
22) es. afferrandosi per un
polso
Piegarsi leggermente sulle gambe, agganciare le
mani del partner e cercare di vincerne la resi-
stenza trascinandolo
Vince chi riesce a raccogliere un oggetto dietro
di s
145
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
23) es. afferrandosi un polso e tenendosi per una caviglia Vince chi riesce a raccogliere un oggetto dietro
di s
24) Lotta per un oggetto (palla M f
medica), dopo averlo affer-
rato reciprocamente con
due mani
Cercare con una serie di spinte e strappi di
strappare l'oggetto dalle mani del partner
25) Sbilanciamenti del partner saltellando su di un piede con
braccia al petto
Saltellare e urtare il partner cercando di fargli
perdere l'equilibrio
26) Sbilanciamenti del partner saltellando a gambe unite con
braccia tese in avanti
Saltellare e urtare con le mani le mani del partner,
cercando di fargli perdere l'equilibrio
es. urtando il petto contro il petto
146
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
28) Sbilanciamenti del partner saltellando in accosciata con
mani davanti al petto
Saltellare e urtare con le mani le mani del partner
cercando di fargli perdere I equilibrio
29) Di fronte, guardia bassa, cercare
di colpire con le mani i glutei del
partner
30) Di fronte, guardia bassa,
mani sulle spalle, cercare di
pestare i piedi del partner
31) Supini, in appoggio sulle braccia tese, cercare di colpire Corpo teso dietro, gambe appena divaricate
con le mani le mani del partner
32) Passaggio dietro il partner che sta in greca, dopo avergli
appoggiato le mani sulla testa, braccia tese
33) es. con mani appoggiate sulla schiena
34) es. con mani dietro la schiena e petto appoggiato sulle
spalle
Il partner deve cercare di ostacolare il passaggio
dietro spostandosi e annullando la rotazione dell'
esecutore. L'esecutore deve riuscire a passare
dietro invertendo velocemente il senso di rota-
zione
ESERCIZI DI PREACROBATICA ED ACROBATICA
La terminologia quella propria della ginnastica artistica, pu accadere
quindi che alcuni esercizi siano indicati con nomi diversi da quelli che siamo
soliti usare.
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
1) Capovolta avanti (capriola) Flettere la testa sul petto, la testa non deve
mai entrare in contatto con il tappeto
2) Capovolta saltata (da fermo) es. staccarsi dal tappeto, eseguendo un
salto, prima di prendere contatto con le ma-
3) Tuffo sviluppato in lungo
%e*~
Corsa coordinata e senza variazioni di rit-
mo, battuta a piedi uniti, testa es.
5) Verticale ritta in appoggio sulle mani, piedi al muro, con par-
tenza prima dal basso, poi dall'alto
148
. Cercare la posizione di equilibrio portando
le gambe a compasso poi riunirle; per
mantenere la posizione lavorare di polso
cercando di non spostare le mani
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
6) Verticale ritta in appoggio sulle mani, con l'aiuto del partner,
con partenza prima dal basso, poi dall'alto
7) es. senza l'aiuto del
partner, con partenza
prima dal basso, poi dall
alto
8) Capovolta avanti passando dalla verticale
10) Capovolta dietro passando dalla verticale
Cercare la posizione di equilibrio portando
le gambe a compasso poi riunirle; per
mantenere la posizione lavorare di polso-
cercando di non spostare le mani
Eseguita la verticale a gambe riunite, piega-
re le braccia, flettere la testa sul petto e,
prendendo contatto col tappeto prima con
le spalle e poi con la schiena, rialzarsi in
piedi senza l'aiuto delle braccia
Dalla mezza accosciata lasciarsi cadere
seduti, quindi, portando le mani ai lati della
testa, capovolgersi dall'altra parte
Partire in piedi, lasciarsi cadere seduti,
quindi, portando le mani ai lati della testa,
spingersi in verticale
149
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
11) Capovolta avanti passando dalla verticale e di seguito capo-
volta dietro tornando in verticale s^..
Eseguire di seguito, passando dalla vertica-
le alla posizione in piedi e viceversa
12) Ruota con l'aiuto del partner che sostiene l'esecutore affer-
randolo per la vita
L'appoggio delle mani deve essere non
troppo lontano, le braccia devono essere
g tese cosi come le gambe; le gambe, aperte
a compasso, devono prendere contatto
con la materassina sulla stessa linea di ap-
poggio delle mani
14) Rondata con I aiuto del partner che sostiene l'esecutore affer-
randolo per la vita
Nella parte iniziale come la ruota, pas-
sando dalla verticale per le gambe si riuni-
scono e il contatto con la materassina av-
viene a gambe unite dopo aver eseguito
una rotazione di 90 verso la direzione di
provenienza
15) Rondata senza l'aiuto del partner W^
150
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
16) Rovesciata avanti (passando a braccia tese)
17) Rovesciata dietro (passando a braccia tese)
18) Pre-slancio Kippe sulla nuca,
con l'aiuto del partner che so-
stiene l'esecutore con una
mano sotto la schiena e una
sotto le cosce
Andare in verticale con le gambe aperte a
compasso, quindi lasciarsi cadere arcuan-
dosi il pi possibile e, preso contatto con il
tappeto con un piede, richiamare in avanti
braccia, testa e tronco
Da in piedi arcuarsi indietro andando in
ponte sulle braccia, quindi, senza soluzione
di continuit, slanciare le gambe, aperte a
compasso e uscire dal ponte passando per
la verticale
Da supini portare le gambe tese verso la te-
sta, quindi slanciarle di scatto verso l'a-
vanti-alto, spingendo contemporaneamente
con le braccia che erano in appoggio ai lati
della testa
19) Kippe partendo su un livello pi alto dell'arrivo, con l'aiuto del
partner
20) Kippe- con l'aiuto del partner
Dopo aver eseguito i movimenti descritti
richiamare di scatto braccia, testa e tronco,
terminando l'es. in piedi
151
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
21) Kippe Dopo aver eseguito i movimenti descritti
richiamare di scatto braccia, testa e tronco,
terminando l'es in piedi
22) Ribaltata (ribaltamento di slancio in avanti con appoggio delle
mani al suolo) da fermo appoggiandosi sul dorso del partner
23) Ribaltata poggiando le mani su un rialzo (manichino) con l'aiuto
del partner che con una mano dietro la nuca facilita il ribalta-
mento
Andare in verticale, appoggiarsi col dorso
sul partner in quadrupedia e, richiamando di
scatto braccia, testa e tronco, ricadere in
piedi dall'altra parte
Eseguita una breve rincorsa poggiare le
mani sul manichino e, dopo essere passati
in verticale, richiamare di scatto testa,
braccia e tronco ricadendo in piedi dall
altra parte a gambe unite
24) Ribaltata poggiando le mani su un rialzo (manichino)
^ ^ - ^
25) Ribaltata^ poggiando le mani sul tappeto
91
Richiamare di scatto testa, braccia e tronco
ricadendo in piedi dall'altra parte a gambe
unite
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
26) Ribaltata con battuta a piedi pari (ribaltata saltata)
fr fr
27) Rovesciamento del partner indietro, dopo averlo sollevato en-
trandogli con la testa fra le gambe; (es. preparatorio per il flic-
flac)
Richiamare di scatto testa, braccia e tronco
ricadendo in piedi dall'altra parte a gambe
unite
28) Rovesciamento del partner indietro, spingendolo, da supini,
con le gambe (piedi in appoggio sui glutei) e sostenendolo con
le braccia (tese in appoggio sulle spalle); (es. preparatorio per il
flic-flao)
Si entra dal di dietro con la testa fra le
gambe dell'esecutore e lo solleviamo scari-
candolo dietro; l'esecutore, dopo essere
passato in verticale, richiama le gambe di
scatto e arriva in piedi
L'esecutore, dopo essere passato in ver-
ticale, richiama le gambe di scatto e arriva
in piedi
29) Flic-flac con l'aiuto del partner chesosti ene e spinge l'esecu-
tore
Sedersi, spingere con le gambe verso l'in-
dietro-alto, slanciare violentemente le brac-
cia e la testa verso l'indietro-alto, arcuarsi
indietro, passare dalla verticale, spingendo
con le braccia, richiamare le gambe di scat-
to terminando l'es. in piedi
153
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
31) Salto mortale avanti arrivando su un taooetone Dopo breve rincorsa battere spingendosi
verso lavanti-alto, slanciare le braccia in
alto, quindi raccogliersi e andare con le ma-
ni verso le caviglie; effettuato il giro,
aprirsi e arrivare sul tappeto a piedi uniti
ammortizzando con le gambe
32) Salto mortale avanti con l'aiuto del partner che facilita la ro- es.
fazione
33) Salto mortale avanti
34) Salto mortale dietro con partenza da un rialzo e con l'aiuto
del partner che sostiene e facilita la rotazione
154
Spingere con le gambe verso l'indietro-alto,
slanciare le braccia e la testa violen-
temente verso l'indietro-alto e chiudersi
raccogliendo le gambe al petto; effettuato il
giro, aprirsi ed arrivare sul tappeto a piedi
uniti ammortizzando con le gambe
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
35) Salto mortale dietro con partenza da un rialzo Spingere con le gambe verso l'indietro-alto,
slanciare le braccia e la testa violen-
temente verso l'indietro-alto e chiudersi
raccogliendo le gambe al petto; effettuato il
giro, aprirsi ed arrivare sul tappeto a piedi
uniti ammortizzando con le gambe
36) Salto mortale- dietro con I aiuto del partner che sostiene e fa-
cilita la rotazione
37) Salto mortale dietro
155
UNIONE FRA ALCUNI DEGLI ESERCIZI DESCRITTI
38) Ribaltata e tuffo
39) Ribaltata e successiva ribaltata con battuta a piedi pari
40) Ribaltata e salto mortale- avanti
41) Rondata e flic-flac
156
42) Rondata e salto mortale dietro
43) Rondata, flic-flac e salto mortale dietro
157
ESERCIZI IN PONTE E PER IL PONTE
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
Dalla posizione in ginocchio
con testa appoggiata sul tap-
peto, flessioni ed estensioni,
inclinazioni laterali e circondu-
zioni della testa
2) es. dalla posiz. a gambe diva-
ricate e tese, testa in appog-
gio sul tappeto il pi vicino
possibile alla linea passante
per i piedi
Mani sulla materassina all'altezza della te-
sta; aumenta la mobilit dell'articolazione,
serve come es. di riscaldamento specifico
Mani dietro la schiena, es.
3) Dalla posiz. di greca- esecuzione del ponte con ribaltata in
avanti (attraverso la testa)
Spingersi con le gambe, arcuarsi bene e
cadere con i piedi sulla materassina in posi-
zione corretta
4) In ponte, flessioni, iperestensioni, incli-
nazioni laterali e circonduzioni del capo
5) In ponte, corsa- intorno
alla testa, mantenendo
fissa la fronte sul tap-
peto; compiere l'es. nei
due sensi
6) In ponte, ribaltate successive
con uscita attraverso la testa
Forzare man mano i movimenti fino a rag-
giungere la max. escursione possibile in
ciascuno di essi
Piedi piu sotto possibile, compiere alcuni
passi prima di ogni scavalcamento, nello
scavalcamento un piede deve rimanere in
appoggio sul tappeto
Trovato il ritmo esecutivo, eseguire le ri-
baltate slanciando prima una sola gamba ed
in seguito le due gambe unite
158
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
7) Dalla posiz di greca andare in ponte con ribaltata in avanti e
di seguito uscire in avanti dalla parte dei piedi
Non fermarsi in ponte
8) Eseguire l'es. n. 7, ma ripetendo le ribaltate di seguito, cosi da
percorrere una striscia di tappeto
9) Dalla posiz. in piedi eseguire una
iperestensione indietro, con ca-
duta in ponte sulle braccia
10) Dalla posiz. di ponte in appoggio
sulle braccia, deambulazione in
tutte le direzioni
11) Dalla posiz. in piedi andare in ponte sulle braccia e di seguito
eseguire una uscita dal ponte con ribaltata dalla parte della te-
sta
Prima eseguire serlza staccarsi mai dal tap-
peto, sfruttando soprattutto la mobilit; in
seguito eseguire pi velocemente, richia-
mando il tronco in avanti prima di arrivare
con i piedi sulla materassina (maggior coor-
dinazione)
Testa bene iperestesa indietro, non andare
in avanti con le ginocchia
Eseguire l'es. pi volte e senza soluzione di
continuit
159
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
12) Dalla posiz di ponte in appoggio sulle braccia eseguire una
corsa intorno al punto di appoggio delle braccia
Vedi es. n. 5
13) Dalla posiz. in piedi eseguire una
iperestensione indietro, con ca-
duta in ponte
14) Dalla posiz. in piedi andare in ponte all'indietro e di seguito
eseguire una uscita dal ponte, con ribaltata dalla parte della te-
sta, tornando in piedi
Vedi es n. 9
Vedi es. n. 11
15) Dalla posiz. sdraiati su di un fianco, passare in ponte e uscire
sull'altro fianco
Gamba verso il tappeto raccolta con ginoc-
chio alto, fare un passo con l'altra, rac-
cogliendola pi possibile, spingere verso la
testa passando in ponte
16) In ponte con partner seduto sulle
cosce eseguire delle flessioni e
successive iperestensioni
160
Caricare al max. il ponte raggiungendo la
max. escursione possibile
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
17) Da supini, con partner posto trasversalmente sul petto, andare
di scatto in ponte scaricando il partner
Vedi es. n. 16, possibile tenere le mani di
fianco alla testa
18) Dalla posiz di ponte con partner che afferra un braccio, con
due braccia corsa intorno (descrivendo un semicerchio) con
uscita dal ponte per mezzo di uno scavalcamento
Eseguire la corsa verso l'esterno, usciti
dal ponte riandarci, con ribaltata attraverso
la testa, ed eseguire di nuovo
19) es. con partner che afferra un braccio ed il collo dall'alto
20) Dalla posiz. di ponte, con partner sopra, petto contro petto,
piedi in direzione opposta e presa reciproca sotto le ascelle,
eseguire dei rotolamenti passando alternativamente in ponte
Eseguire l'es. pi volte e senza soluzione di
continuit, raccogliere bene le gambe per
poter spingere e caricare al max. il ponte
161
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE
21) In ponte, il partner si pone di fianco, presa reciproca di tronco
e collo, uscire dal ponte portandoci il partner il quale esegue a
sua volta l'es.
Eseguire pi volte di seguito senza soluzio-
ne di continuit, il partner deve cadere per-
pendicolarmente all'esecutore
22) Dalla posiz. sdraiati su di un fianco con il partner in presa di
braccio e di collo (conclusione di una proiez. attr. la schiena),
effettuare la presa al tronco e quindi un rovesciamento del
partner passando in ponte
23) Da supini, con partner in presa di braccio e di tronco, andare in
ponte ed eseguire una corsa con le gambe verso l'esterno,
liberandosi dalla presa ed uscendo dal ponte per mezzo di uno
scavalcamento
162
Andare bene sotto al partner, raccogliere
i piedi e spingere verso la testa passando in
ponte
Caricare al max. il ponte, quindi, senza so-
luzione di continuit, eseguire la corsa e lo
scavalcamento
ESERCIZI PER LA MOBILITA' ARTICOLARE
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
1) Flessioni ed estensioni
della testa sul piano sa-
gittale
2) Inclinazioni laterali della
testa sul piano frontale
3) Circonduzioni della testa
Posizione di partenza in piedi,
testa eretta; max. escursione
dei movimenti
Posiz. di part, es. , il lobo dell'
orecchio deve andare a toc-
care la spalla
Posiz. di part, es. , portare la te-
sta sulla spalla destra, indietro,
sulla spalla sinistra, sullo sterno,
senza soluzione di continuit,
quindi invertire il movimento;
max. escursione dei movimenti
Occipito-atlantoidea (testa-
colonna vertebrale), tratto
cervicale del rachide (colon-
na vertebrale)
4) Torsioni della testa
5) Flessioni ed estensioni,
inclinazioni laterali, cir-
conduzioni della testa
6) es.
Posiz. di part, es., ruotare la testa
alternativamente a destra e a sini-
stra intorno ad un asse passante
all'incirca al centro dell'articolazio-
ne; max. escursione dei movimenti
Posiz. di part, in ginoc-
chio a terra, testa ap-
poggiata sul tappeto,
mani sulla materassina
all'altezza della testa;
max. escursione dei
movimenti
Posiz. di part, a gambe
divaricate e tese, testa
in appoggio sulla mate-
rassina il pi vicino
possibile alla linea pas-
sante per i piedi, mani
dietro la schiena; max.
escursione dei movi-
menti
163
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
7) Inclinazioni laterali
tronco
del
8) Torsioni del tronco
Posiz. di part, eretta,
gambe leggermente
divaricate, mani die-
tro la nuca; max. e-
scursione del movi-
mento; eseguire an-
che con bastone
dietro la testa
Posiz. di part, eretta, gambe divari-
cate, braccia in fuori; eseguire an-
che con bastone dietro la testa
Tratto dorsale e lombare del
rachide
9) Flessioni del tronco in
avanti
Posiz. di part, eretta, gambe
unite e tese, mani dietro la nuca;
mantenere le gambe tese du-
rante l'esecuz.; forzare il movi-
mento con leggeri molleggi
10) Iperestensioni del tronco
indietro
Posiz. di part, eretta, gambe
leggermente divaricate, mani
dietro la nuca, non piegare le
gambe venendo avanti con le
ginocchia
11) Torsioni e flessioni del
tronco
12) Torsioni ed iperesten-
sioni del tronco
164
Posiz. di part, eretta, gambe di -
varicate, mani dietro alla nuca;
dopo aver effettuato la torsione
effettuare la flessione senza
soluzione di continuit
Posiz. d
;
part, eretta, gambe di -
varicate, cercare di andare con
la mano a toccare il tallone del
piede opposto
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
13) Circonduzioni del tronco
14) Circonduzioni del bacino
Posiz di part eretta, gambe
divaricate, mani dietro la nu-
ca, effettuata la flessione
eseguire le circonduzioni
prima in un senso, poi nell'al-
tro
Posiz. di part eretta, gambe ap-
pena divaricate, mani sui fian-
chi; cercare di mobilizzare il ba-
cino, tenendo, per quanto pos-
sibile, bloccate le gambe e il
petto
Tratto dorsale e lombare del
rachide
Tratto lombare del rachide
15) Torsioni del tronco dalla
posizione di greca
Cercare di entrare il piu
possibile sotto, con la
spalla, portandola verso il
ginocchio opposto
Tratto dorsale e lombare del
rachide
16) Torsioni del tronco dalla
posizione di seduta su di
un fianco
17) Flessioni del tronco da
seduti a gambe unite
18) Flessioni del tronco da
seduti a gambe divarica-
te
19) Torsioni e flessioni del
tronco da seduti a gam-
be divaricate
20) Flessioni degli arti infe-
riori, dal decubito supino
(es. dell'aratro)
Seduti su di un fian-
co con appoggio
sulle braccia; for-
zare il movimento
con leggeri molleggi
Posiz. di part, seduti
a gambe unite e te-
se; effettuare una
flessione in avanti
con molleggio man-
tenendo le gambe
tese (l'es. pu esse-
re eseguito anche
con l'ausilio del
partner)
Posiz. di part, seduti, gam-
be divaricate e tese; ese-
cuzione es.
Posiz. di part, es. ; effettuare una torsione e
una flessione su di una gamba, quindi sull'altra,
con molleggio (l'es. pu essere eseguito an-
che con l'ausilio del partner)
Portare i piedi sopra la testa, gambe lese
punte in estensione, braccia parallele rivolte
verso il basso, palme sul tappeto
Se le gambe sono molto di -
varicate si mobilita anche I
articolazione coxo-femorale
oltre al tratto dorsale e lom-
bare del rachide
es.
Tratto dorsale e lombare del
rachide
165
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
21) Flessioni del tronco alla
spalliera
22) Flessioni del tronco con
una gamba in appoggio
alla spalliera
23) Inclinazioni del tronco
con una gamba in ap-
poggio alla spalliera
24) Torsioni e flessioni del
tronco con una gamba in
appoggio alla spalliera
25) Iperestensioni del tronco
alla spalliera
Posiz. di part
con mani e piedi
in appoggio alla
spalliera, gambe
e braccia larghe
e tese; scendere
con l'impugnatu-
ra avvicinando
sempre pi le
mani all'appoggio
dei piedi
Tratto dorsale e lombare del
rachide
Gambe tese a 90, por-
tare possibilmente la fron-
te a toccare sul ginocchio
Gambe tese a 90,
non venire in avanti
con il busto ese-
guendo l'inclinazio-
ne
Gambe tese a 90, prima
fare la torsione poi la fles-
sione, su una gamba e
sull'altra
166
Seduti gambe flesse, mani
all'altezza della testa; man-
tenere i piedi in appoggio
plantare anche nel momento
della max. iperestensione
Tratto dorsale e lombare del
rachide e coxo-femorale
Tratto dorsale e lombare de
rachide
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
26) Iperestensioni del tronco
su panca dal decubito
prono, con partner che
tiene le gambe
27) Iperestensione forzata
del tronco dal decubito
prono (es. del cobra)
Partire da una posizione di flessione in avanti
del tronco con mani dietro la testa; quindi ipe-
restendere indietro oltre al tronco anche la te-
sta
Estendere il tronco
all'indietro spingen-
dosi con le braccia
e portando pi sot-
to possibile l'ap-
poggio sulle mani
Tratto dorsale e lombare del
rachide
28) Iperestensione forzata
del tronco, dal decubito
prono, con partner
29) Iperestensione forzata
degli arti inferiori dal de-
cubito prono, con part-
ner
Il partner effettua la
presa al di sopra
delle ginocchia e
forza gradatamente
l'iperestensione
Il partner afferra per
i polsi e fa rag-
giungere la ipere-
stensione forzata;
tenere le braccia
tese e la testa indie-
tro
Tratto dorsale e lombare del
rachide, scapolo-omerale
Tratto lombare del rachide
30) Iperestensioni del tronco
da seduti con partner
31) Piegamento del tronco
all'indietro andando in
ponte sulle braccia
Seduti gambe flesse il
pariner afferra per le mani
e sostiene l'esecutore dal
di dietro mentre questi,
spingendosi con le gam-
be, si iperestende all'in-
dietro
Portare le mani il pi vi-
cino possibile alla ver-
ticale della testa, spin-
gere con i piedi verso I
avanti alto, arcuare al
max. il ponte
Tratto dorsale e lombare del
rachide
Tratto dorsale e lombare del
rachide
167
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
32) Flessioni ed estensioni
della schiena dalla posi-
zione in ginocchio (es.
del gatto)
33) Slanci delle braccia per
avanti-alto e basso-die-
tro
34) Slanci delle braccia in
fuori
36) Circonduzioni delle due
braccia nei due sensi
37) Sollevamento del tronco
da seduti (es. del tavolo)
168
Braccia tese, angolo
gamba-coscia 90; nella
flessione si ritira la pan-
cia e si arcua al max. la
schiena, nell'estensione si
spinge con la pancia in
basso e si iperestende la
testa indietro
Rachide (anche il tratto cer-
vicale)
Posiz eretta, gambe legger-
mente divaricate, braccia te-
se; esecuzioni molto veloci
Scapolo-omerale
Posiz. di part, es. ;
durante lo slancio
supinare le mani
35) Circonduzioni di un
braccio nei due sensi
Posiz. di part, es. ; curare che le
\ circonduzioni siano pi ampie '
J possibili
Seduti, gambe raccolte,
braccia tese dietro pi
strette possibile; sollevare
il tronco fino a portarlo in
posizione orizzontale
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
38) Circonduzione forzata
delle braccia con basto-
ne
39) Slanci forzati delle brac-
cia indietro alla spalliera
40) Retroversione e proie-
zione indietro forzata
degli arti superiori, con
partner
41) Flessioni della coscia sul
bacino sul piano frontale
e su quello sagittale
42) Circonduzioni della co-
scia sul bacino
Braccia tese, presa pi stret-
ta possibile; sfruttare la velo-
cit iniziale per eseguire il
movimento, eseguire la cir-
conduzione nei due sensi
Scapolo-omerale
Piegati a 90 gambe unite
e tese, mani alla spalliera,
forzare in basso col petto
molleggiando ripetuta-
mente
Posiz. di decubito prono, il partner seduto so-
pra afferra i polsi e porta le braccia gra-
dualmente in retroversione forzata; molleggia-
re forzando in avanti e facendo toccare le ma-
ni tra loro
Eretti, braccia lungo i
fianchi, gambe unite,
gamba portante tesa;
non abbassare il petto
durante l'esecuzione
Coxo-femorale
Eretti, braccia lungo i fianchi,
gambe unite, portare la coscia in
avanti alto, in fuori, indietro; gamba
portante tesa, non abbassare il
petto durante l'esecuzione
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
43) Slanci dell'arto inferiore
in avanti e indietro sul
piano sagittale
44) Slanci dell'arto inferiore
in fuori e in dentro sul
piano frontale
Eretti, mani sui fian-
chi, gambe unite, ar-
to portante teso;
non abbassare il
petto durante l'ese-
cuz., arto slanciato
a ginocchio blocca-
to
45) Piegate sul piano fron-
tale
Piedi paralleli, talloni a
terra, busto eretto
46) Piegate sul piano sagit-
tale
Coxo-femorale
es. ; non inclinare il
petto durante l'ese-
cuz.
e s
Busto eretto, gamba
dietro tesa
47) Divaricata, sul piano fron-
tale
Stare con il busto verticale, per quanto pos-
sibile, il peso del tronco deve forzare la divari-
cata; possibile appoggiarsi leggermente sul-
le mani quando la divaricata molto pronun-
ciata
170
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
48) Divaricata sul piano sa-
gittale
Busto eretto, gambe, per quanto possibile, te-
se; cercare di arrivare a toccare per terra con
il pube
Coxo-femorale
49) Adduzione e rotazione
verso linterno della co-
scia da seduti a gambe
raccolte
50) Dalla posizione dell'o-
stacolista flessione del
tronco sulla gamba tesa
avanti
51) Dalla posizione dell'o-
stacolista torsione e
flessione del tronco sulla
gamba flessa
Portare il ginocchio in avanti fino a farlo toc-
care per terra, restare seduti, non muovere I'
altra gamba ^* ^+
Portare il ginocchio
della gamba flessa
piu indietro possibi-
le, gamba avanti te-
sa; alternare la posi-
zione delle gambe
Coxo-femorale, tratto dorsa-
le e lombare del rachide
52) Dalla posizione dell'o-
stacolista torsione e
flessione del tronco dal-
la parte della gamba tesa
es. ; cercare di non
sollevare il ginoc-
chio della gamba
essa
53) Dalla posizione dell o-
stacolista spingersi ver-
so l'alto e invertire la po-
sizione delle gambe sen-
za spostare i piedi
es.; possibilmente senza I aiuto (spinta) delle
braccia ^ ^
Coxo-femorale
171
ESERCIZI INDICAZIONI METODOLOGICHE ARTICOLAZIONI INTERESSATE
54) Dalla posizione dell'o-
stacolista- sdraiarsi in-
dietro
55) Dalla posizione in ginoc-
chio sdraiarsi indietro
sedendosi sui talloni
Coxo-femorale
Cercare di non sollevare
le ginocchia
Coxo-femorale, artic. del gi -
nocchio, arti e della caviglia
56) Flessione forzata del
tronco da seduti a gam-
be divaricate, con retro-
versione forzata degli
arti superiori, con part-
ner
Gambe tese; il partner
deve ruotare le braccia
dell esecutore in den-
tro, spingerle per avan-
ti alto e contempora-
neamente flettere in
avanti il busto dello
stesso
Coxo-femorale, tratto dor-
sale e lombare del rachide,
scapolo-omerale
57) Flessione ed estensione
dei piedi
Seduti, gambe solleva-
te; forzare al massimo il
movimento
Artic. della caviglia
58) Flessione forzata del
piede con punta appog-
giata contro il muro
59) Rotazione dei piedi in
dentro e in fuori
60) Circonduzione dei piedi
nei due sensi
Piede in max flessione, avvicinarsi
con il tronco il piu possibile al mu- -jflft
ro; molleggiare ' >
Seduti, gambe sollevate;
\y)f forzare al massimo il mo-
vimento
172
INDICE
- LO SVILUPPO DELLLE QUALIT FISICHE "Pag. 5
- LE QUALIT FISICHE: 7
LA RESISTENZA
- RESISTENZA ORGANICA AEROBICA 9
- METODOLOGIA DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA FUNZIONALIT
CARDIOCIRCOLATORIA 10
- METODOLOGIA DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DEGLI
SCAMBI GASSOSI 11
- RESISTENZA ORGANICA ANAEROBICA 13
- RESISTENZA MUSCOLARE AEROBICA 16
- RESISTENZA MISCOLARE ANAEROBICA . 17
LA FORZA
- DEFINIZIONE E CENNI ANATOMO-FUNZIONALI DI MIOLOGIA Pag. 19
- RAPPORTO TRA FORZA E PESO 22
- CLASSIFICAZIONE DELLA FORZA 23
- ESERCITAZIONI PER L'ALLENAMENTO DI FORZA 24
- MEZZI E METODI DELL'ALLENAMENTO PER LA FORZA 26
La forza massimale 26
La forza resistente 28
La forza veloce 28
- TEST DI VALUTAZIONE 29
- TABELLE 30
n. 1 - Esercizi generali per lo sviluppo della forza 30
n. 2 - Esercizi speciali per lo sviluppo della forza 31
n. 3 - Esempio di una tabella per la forza max basata sugli esercizi gene-
rali 31
n. 4 - Esempio di una tabella per la forza max basata sugli esercizi speciali
per atleti in via di specializzazione 32
n. 5 - Esempio di una tabella a piramide 32
n. 6 - Esempio di una tabella per il periodo competitivo per atleti di alta
specializzazione 32
n. 7 - Tabella riassuntiva delle varie metodologie di incremento della
forza 33
n. 8 - Normativa per la forza max' 33
- LO SVILUPPO CORPOREO DEI BAMBINI E RAGAZZI E L'ALLENAMENTO
PER LA FORZA 34
- INDICAZIONI PER EVITARE DANNI FISICI O LESIONI 36
LA VELOCIT
- DEFINIZIONE E FATTORI CHE LA DETERMINANO 37
- MEZZI E METODI PER LO SVILUPPO GENERALE DELLA VELOCIT . . . . 39
173
LA MOBILIT ARTICOLARE
TIPI DI MOBILIT E FATTORI CHE LA INFLUENZANO 41
Tipi di articolazioni 42
Movimenti articolari 42
ARTICOLAZIONI DELLA COLONNA VERTEBRALE 44
Caratteristiche delle vertebre 44
Le vertebre cervicali 44
Movimenti della colonna vertebrale 44
ARTICOLAZIONE OCCIPITO-ATLANTOIDEA 48
ARTICOLAZIONE SCAPOLO OMERALE 49
Movimenti dell'articolazione scapolo omerale 49
ARTICOLAZIONE COXO-FEMORALE 53
Movimenti dell'articolazione coxo-femorale 54
ESERCIZI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILIT 58
Mobilizzazione dell'articolazione occipito-atlantoidea e del tratto cervica-
le del rachide . . 58
Mobilizzazione prevalente del tratto dorsale del rachide 59
Mobilizzazione prevalente del tratto lombare del rachide 59
Mobilizzazione della articolazione scapolo-omerale 60
Mobilizzazione della articolazione coxo-femorale 61
TEST DI VALUTAZIONE PER LA MOBILIT 62
LA PERIODIZZAZIONE DELL'ALLENAMENTO
- CONCETTO E PRINCIPI DELLA PERIODIZZAZIONE 65
- CONCETTO E FASI DELLA FORMA SPORTIVA 66
- LA COSTRUZIONE DELL'ALLENAMENTO 68
Struttura di un allenamento singolo 68
Struttura dei microcicli 73
Struttura dei mesocicli 76
- IL PERIODO PREPARATORIO 80
Prima tappa 80
Seconda tappa : 83
- IL PERIODO FONDAMENTALE O COMPETITIVO 85
- IL PERIODO TRANSITORIO 89
- TABELLA RIASSUNTIVA DEI MEZZI DA USARE NEI VARI PERIODI 90
- CONCLUSIONI .. 92
350 ESERCIZI PER LO SVILUPPO DELLE QUALIT
FISICHE DEL LOTTATORE
Esercizi di preatletismo 101
Esercizi di potenziamento con pesi e attrezzi 120
Esercizi con il partner 132
a) da fermo 132
b) in movimento 142
Esercizi di preacrobatica ed acrobatica 148
Esercizi in ponte e per il ponte 158
Esercizi per la mobilit articolare 163
174
Arti Grafiche San Marcello - Viale Regina Margherita, 176 - Roma
Potrebbero piacerti anche
- Prep-Fis-2019 - Felice Romano-Mobilità Articolare e FlessibilitàDocumento105 paginePrep-Fis-2019 - Felice Romano-Mobilità Articolare e FlessibilitàVeronaNessuna valutazione finora
- Lettura Veloce EcgDocumento33 pagineLettura Veloce EcgGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Il Dolore CronicoDocumento168 pagineIl Dolore CronicoGiovanni FrattaliNessuna valutazione finora
- FITNESS Wiki PDFDocumento254 pagineFITNESS Wiki PDFsboffonchione100% (1)
- Ginnastica Cinese Stretching E Pa Tuan ChinDocumento4 pagineGinnastica Cinese Stretching E Pa Tuan ChinRebecca HayesNessuna valutazione finora
- PROFESSIONE PERSONAL TRAINER - Elementi per una formazione integraleDa EverandPROFESSIONE PERSONAL TRAINER - Elementi per una formazione integraleValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Performance sportiva e alimentazione: Guida pratica ai fattori nutrizionali che influenzano la prestazione fisicaDa EverandPerformance sportiva e alimentazione: Guida pratica ai fattori nutrizionali che influenzano la prestazione fisicaNessuna valutazione finora
- Allenamento, fitness e bodybuilding: La guida definitiva per l’aumento della massa muscolare scegliendo schede e giusti esercizi da svolgere in palestra o a casa, con pesi, macchine o a corpo liberoDa EverandAllenamento, fitness e bodybuilding: La guida definitiva per l’aumento della massa muscolare scegliendo schede e giusti esercizi da svolgere in palestra o a casa, con pesi, macchine o a corpo liberoNessuna valutazione finora
- Ebook Allungamenti PDFDocumento61 pagineEbook Allungamenti PDFep1618100% (1)
- Il Ritorno Ala Competitivita Dell'Espresso Italiano - Giuli, Maurizio & Pascucci, FedericaDocumento445 pagineIl Ritorno Ala Competitivita Dell'Espresso Italiano - Giuli, Maurizio & Pascucci, FedericapienezzaNessuna valutazione finora
- Manuale Corso IstruttoreDocumento203 pagineManuale Corso IstruttoreMatteo NanettiNessuna valutazione finora
- Le Capacità Motorie - Cond - ForzaDocumento16 pagineLe Capacità Motorie - Cond - Forzaantodefi78Nessuna valutazione finora
- Hard Stretching + Flessibilità + Forza + Potenza Per le Arti Marziali e gli Sport da CombattimentoDa EverandHard Stretching + Flessibilità + Forza + Potenza Per le Arti Marziali e gli Sport da CombattimentoValutazione: 3.5 su 5 stelle3.5/5 (2)
- Postura JudoDocumento6 paginePostura JudoJudo Castelfranco EmiliaNessuna valutazione finora
- Alberto Balasso - Riatletizzazione e Prevenzione PDFDocumento65 pagineAlberto Balasso - Riatletizzazione e Prevenzione PDFMauroAstrologoNessuna valutazione finora
- Allenarsi Con La Tabella Di PrilepinDocumento8 pagineAllenarsi Con La Tabella Di PrilepinantoniozanniniNessuna valutazione finora
- Lezione Terminologia - MOVIMENTO UMANO PDFDocumento68 pagineLezione Terminologia - MOVIMENTO UMANO PDFsteNessuna valutazione finora
- Swiss BallDocumento22 pagineSwiss BallpatruoxNessuna valutazione finora
- Bagoli - Gli Aspetti Allenanti Di Balzi e Salti - Relazione 1 Feb 2015Documento21 pagineBagoli - Gli Aspetti Allenanti Di Balzi e Salti - Relazione 1 Feb 2015officinaatletica100% (1)
- Biomeccanica Del Powerlifting e Il Sollevamento Pesi ESERCIZIDocumento69 pagineBiomeccanica Del Powerlifting e Il Sollevamento Pesi ESERCIZIXXXXXXXXNessuna valutazione finora
- TTD Attivita Motoria PreventivaDocumento22 pagineTTD Attivita Motoria PreventivaAntonio PappaleporeNessuna valutazione finora
- Allenare La Forza Nei Giovani - Andrea Dell'AngeloDocumento94 pagineAllenare La Forza Nei Giovani - Andrea Dell'Angelowmgs5b6rfhNessuna valutazione finora
- Bodybuilding: I segreti per la costruzione di un corpo sano, forte e muscolosoDa EverandBodybuilding: I segreti per la costruzione di un corpo sano, forte e muscolosoNessuna valutazione finora
- Periodizzazione Nell'allenamento Della Forza RapidaDocumento72 paginePeriodizzazione Nell'allenamento Della Forza RapidafaxmolderNessuna valutazione finora
- 000007-Preparazione Atletica II e III Livello 2012Documento24 pagine000007-Preparazione Atletica II e III Livello 2012Ciro NepiNessuna valutazione finora
- L To Della Forza Secondo Jean Pierre EggerDocumento2 pagineL To Della Forza Secondo Jean Pierre EggerbarabbaladroNessuna valutazione finora
- Functional Training Summit: Guido BrusciaDocumento19 pagineFunctional Training Summit: Guido BrusciaTeresa CoccoNessuna valutazione finora
- L’allenamento di successo: Il riscaldamento e il recupero dopo l’allenamento per una performance sportivaDa EverandL’allenamento di successo: Il riscaldamento e il recupero dopo l’allenamento per una performance sportivaNessuna valutazione finora
- Attività fisica, Nutrizione & Peak PerformanceDa EverandAttività fisica, Nutrizione & Peak PerformanceNessuna valutazione finora
- Ti A Circuito PugilatoDocumento3 pagineTi A Circuito PugilatoStefano GiuseppiniNessuna valutazione finora
- Dal Montreal Track Test Agli Yo-Yo Test - RuspantiniDocumento25 pagineDal Montreal Track Test Agli Yo-Yo Test - RuspantinialexruspNessuna valutazione finora
- La Preparazione Fisica Nel RugbyDocumento12 pagineLa Preparazione Fisica Nel RugbyGiorgio MarrasNessuna valutazione finora
- Programmazione Dell'allenamentoDocumento13 pagineProgrammazione Dell'allenamentoFrancesca BarzanNessuna valutazione finora
- Metodo Coniugato MistoDocumento11 pagineMetodo Coniugato MistoRaffoNessuna valutazione finora
- Movimenti Ginnico SportiviDocumento25 pagineMovimenti Ginnico Sportivigrass7stopNessuna valutazione finora
- Warm Up e RugbyDocumento29 pagineWarm Up e Rugbyaz1985100% (2)
- Sport e Letteratura Nella StoriaDocumento32 pagineSport e Letteratura Nella StoriaRaffaele Di PasqualeNessuna valutazione finora
- 20 2016 2017 Lo Sport Nella StoriaDocumento20 pagine20 2016 2017 Lo Sport Nella StoriaStefano LivieraNessuna valutazione finora
- SDS N°56Documento64 pagineSDS N°56Pierpaolo PolinoNessuna valutazione finora
- La Forza Rapida Nel Giocatore Di Pallacanestro, Metodi e Test Per La ValutazioneDocumento24 pagineLa Forza Rapida Nel Giocatore Di Pallacanestro, Metodi e Test Per La ValutazioneAlberto BiolchiNessuna valutazione finora
- Elementi Di Valutazione Funzionale 12 Dicembre Pre 1230Documento33 pagineElementi Di Valutazione Funzionale 12 Dicembre Pre 1230gabriel ungureanuNessuna valutazione finora
- Metodologia Salto in Lungo e TriploDocumento60 pagineMetodologia Salto in Lungo e TriploPasquale BelluscifotografoNessuna valutazione finora
- 1996 Stefano Ottanelli TECNICHEDIFENSIVEDocumento51 pagine1996 Stefano Ottanelli TECNICHEDIFENSIVE666Nessuna valutazione finora
- Laboratorio Fitness e Wellness - 1 - Sistema Tonico Posturale Dott - Romilda - Palma PDFDocumento51 pagineLaboratorio Fitness e Wellness - 1 - Sistema Tonico Posturale Dott - Romilda - Palma PDFXXXXXXXXNessuna valutazione finora
- Il Maestro Di Karate TradizionaleDocumento28 pagineIl Maestro Di Karate TradizionaleovettaNessuna valutazione finora
- Laboratorio-Dello-Sport 1Documento24 pagineLaboratorio-Dello-Sport 1api-243361066Nessuna valutazione finora
- Doping MinisteroDocumento30 pagineDoping MinisteroGiacomoCarlucciNessuna valutazione finora
- Eat - Libretto Sport. 7 Luglio PDFDocumento92 pagineEat - Libretto Sport. 7 Luglio PDFsteNessuna valutazione finora
- Bibliografia Necessaria BiomeccanicDocumento2 pagineBibliografia Necessaria BiomeccanicLorenzoGoriNessuna valutazione finora
- Piede e PodoscopioDocumento114 paginePiede e Podoscopiopaolo68audisioNessuna valutazione finora
- Metabolismi EnergeticiDocumento11 pagineMetabolismi EnergeticiStefan VladNessuna valutazione finora
- KARATE - Combinazioni Tecniche Personali - Un Approccio Biomeccanico Alla Pratica Del KihonDocumento13 pagineKARATE - Combinazioni Tecniche Personali - Un Approccio Biomeccanico Alla Pratica Del KihonisononamiNessuna valutazione finora
- Calcio Ed Educazione MotoriaDocumento23 pagineCalcio Ed Educazione MotoriaPaulo JuniorNessuna valutazione finora
- Maiorano - Gli Esercizi Della PesisticaDocumento32 pagineMaiorano - Gli Esercizi Della PesisticaPippusNessuna valutazione finora
- SACRIPANTI - Biomeccanica Del Judo Per Bambini e Metodologia Allenamento TecnicoDocumento50 pagineSACRIPANTI - Biomeccanica Del Judo Per Bambini e Metodologia Allenamento TecnicoCostantino Isononami Dojo Brandozzi0% (1)
- Appunti Atletica LeggeraDocumento137 pagineAppunti Atletica LeggeraGiorgio MarrasNessuna valutazione finora
- Scheda Parte Superiore FitprimeDocumento1 paginaScheda Parte Superiore FitprimemarcoNessuna valutazione finora
- Gesione Fa in Medicina GeneraleDocumento49 pagineGesione Fa in Medicina GeneraleGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Nutrizione in GravidanzaDocumento1 paginaNutrizione in GravidanzaGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Guida Al Corso Di Medicina Generale Regione LombardiaDocumento31 pagineGuida Al Corso Di Medicina Generale Regione LombardiaGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Atti SIGG 2019Documento333 pagineAtti SIGG 2019Gerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Terapia TBCDocumento1 paginaTerapia TBCGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- La Perdita Di Peso Non E' LineareDocumento1 paginaLa Perdita Di Peso Non E' LineareGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Simg Dolore A 360 GradiDocumento6 pagineSimg Dolore A 360 GradiGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- SIFILIDEDocumento1 paginaSIFILIDEGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Tecniche Speciali Per Massimizzare L'ipertrofiaDocumento2 pagineTecniche Speciali Per Massimizzare L'ipertrofiaGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Tumori NeurologiaDocumento1 paginaTumori NeurologiaGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- PriapismoDocumento1 paginaPriapismoGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Tabella Alimenti InranDocumento29 pagineTabella Alimenti InranGerlando Russo Introito100% (1)
- TabellasostiDocumento5 pagineTabellasostiGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Liceo ScientificoDocumento58 pagineLiceo Scientificolore1983scribdNessuna valutazione finora
- Tutto Quello Che Un Medico Dovrebbe Avere Nella Sua BorsaDocumento3 pagineTutto Quello Che Un Medico Dovrebbe Avere Nella Sua BorsaMichele Scilla FresielloNessuna valutazione finora
- Analisi Del SangueDocumento2 pagineAnalisi Del SangueGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Allenamento GluteiDocumento3 pagineAllenamento GluteiGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- CelluliteDocumento1 paginaCelluliteGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- FumettiDocumento2 pagineFumettiGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Tecniche Di Allenamento Nel BodybuildingDocumento26 pagineTecniche Di Allenamento Nel Bodybuildingyeast60Nessuna valutazione finora
- Medicina Di Famiglia e Gestione Della CronicitàDocumento10 pagineMedicina Di Famiglia e Gestione Della CronicitàGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Corso BLSDDocumento3 pagineCorso BLSDGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Procedimento Ricerca PubmedDocumento2 pagineProcedimento Ricerca PubmedGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Rice TteDocumento2 pagineRice TteGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Depression eDocumento8 pagineDepression eGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Flowchart Diagnostico Terapeutico Malattia DiverticolareDocumento4 pagineFlowchart Diagnostico Terapeutico Malattia DiverticolareGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- Psichiatria - Programma D'esameDocumento1 paginaPsichiatria - Programma D'esameGerlando Russo IntroitoNessuna valutazione finora
- CORSO PEDIATRIA Argomenti Esame 2010Documento2 pagineCORSO PEDIATRIA Argomenti Esame 2010Irene ZolfaroliNessuna valutazione finora
- Ebook Come Leggere I Grafici Di Borsa (Quarta Parte)Documento23 pagineEbook Come Leggere I Grafici Di Borsa (Quarta Parte)CampeanIvonaNessuna valutazione finora
- 30Documento31 pagine30nirvanafansNessuna valutazione finora
- Criminologia SozzoDocumento10 pagineCriminologia SozzoAnonymous GdiiB9oINessuna valutazione finora
- GIORGI:ZAPPALA - Verso Un Nuovo Catalogo Tematico Di Alessandro Rolla (2011)Documento32 pagineGIORGI:ZAPPALA - Verso Un Nuovo Catalogo Tematico Di Alessandro Rolla (2011)Paolo GiorgiNessuna valutazione finora
- ST HIT-HY150FR+rebar ITADocumento11 pagineST HIT-HY150FR+rebar ITADoryNessuna valutazione finora