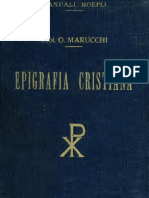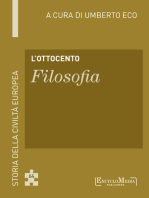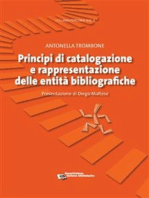Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Di Marzo 1946 Prosodia e Metrica Latina
Caricato da
strajder7Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Di Marzo 1946 Prosodia e Metrica Latina
Caricato da
strajder7Copyright:
Formati disponibili
Opere curate da ENRICO DI MARZO
Roma, viges. Antologia latina pn il Ginnasio Superiore
e le prime classi del Liceo Scientifico.
Prosodia e metrica latina. Per il Liceo Classico e
l'Istituto .Magistrale.
E. DI MARZO - C. CARAMELLO
Romana progenies. Antologia latina per il Ginnasio
Superiore.
ENRICO DI MARZO
PROSODIA
E
METRICA
LATINA
PER IL LICEO CLASSICO
E L'ISTITUTO MAGISTRALE
G. B. PARAVIA & C.
TORINO. MILANO. GENOVA. PADOVA. BOLOGNA. FIRENZE PESCARA. RO:r.IA
NAPOLI BARI. PALERMO
SECONDA EDIZIONE - TRENTOTTESIMA RISTAMPA
PROPRIETA' LETTERAHIA
Printed in ltaly
O 1946 Paravia, Torino
Si ritengono contralf atte le copie non firmate
o non munite del timbro della S. I. A. E.
Societ per Azioni G. B. Paravia & C . 10139 Torino Corso Racconigi, 16
70 (eA) 1974- 16771 [205)
PREFAZIONE
Il presente volume dir iso in tre parti: la parte prosodica,
come preparazione indispensabile ad ulteriori indagini me-
triche (ed in essa vi sono delle novit, quali, ad esempio, il
richiamo di certe regole grammaticali, necessarie per la com-
prensione e l'applicazione di altre regole prosodichc , il capi-
tolo riguardante la quantit delle sillabe interne delle furme
verbali, ecc.), la parte metrica, con le sue indispensabili no-
zioni preliminari, e con l'esame dei singoli notissimi metri che
s'incontrano nei testi dei poeti latini che vanno lett-i nelle
Scuole superiori, infine la terza parte riguardante la metrica
oraziana.
La trattazione piana, abbiamo bandito ogni frammen-
taria erudizione che, secondo il nostro modesto giudi.zio, riesce
sempre inutile e non raggittnge lo scopo che un buon trattato
di prosodia e di rnet1ica latica deve proporsi, quello, cio, di
porre il discentc in condi.zioni di stabilire prontamente la
quantit della sWaba latina, individuare un metro, scompo-
nendolo negli elementi costitutivi, tracciandone la struttura,
sia che detto metro venga considerato isolatamente, sia in
aggruppamento con altri metri; riconoscere sen.za tituban.m,
una composi.zione poetica oraziana, scandendo e leggendo
metricamente i versi che la compongono.
Ogni capitolo del volume presenta degli esercizi pratici:
l'alunno, eseguendoli con pazienza ed amore, finir col trovare
accessibile una via alquanto dura, e coll'interessarsi, forse,
allo studio della metrica. Parecchie tavole riassuntire corre-
dano il libro, chiare e lineari, che s'imprimeranno con sicura
-IV-
traccia nello spirito del discente. Dopo l'esame delle singole
forme metr-iche oraziane, divise in composizioni monastiche
e nei sistemi distici, tetrastici ed ipermetri, chiude il volume
una tavola riassuntiva di tutta la metrica oraziana, tracciata
nei suoi caratteri essenziali, che far orientare con sicurezza
il giovane studioso.
Se in questo volumetto ci sono delle manchevolezze (quale
libro ne esente?), prego gli egregi Colleghi a volermele se-
gnalare ed io sar loro grato.
E. DI l\IARZO.
P .ARTE PRIMA
PROSODIA
- I;;, DI }IARZo, Prosodia t metrica latino.
l. - La parola (da 7tp6, ad e cantus) fu
resa in latino con l'espressione: ad cantum, da cui si ebbe
accentua.
Il termine greco etimologicamente valse a significare l'ele-
vazione della voce nel pronunziare la sillaba accentata; poi
. indic la durata della pronunzia di ciascuna sillaba nel corpo
della parola; da ultimo signific l'insieme delle regole e dei
precetti che ci fanno conoscere la quantit delle sillabe, dalle
quali formata una parola.
Noi intendiamo il vocabolo in quest'ultimo significato, sl
che ((la prosodia la dottrina che studia la quantit delle sillabe
che compongono la parola >>,
CAPO I.
POESIA ACCENTUATIVA E QUANTITATIVA
A) Poesia accentuativa.
2. - Leggiamo ad alta voce:
N el mzzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una slva osc1a,
ch la diritta via era smarrita >>.
(DANTE, Inferno, c. I, v. 1-3).
Ciascuna di codeste righe contiene un verso endecasillabo,
cio, di undici sillabe; alCune di dette sillabe sono accentate
-4-
o toniche, altre disaccentate o atone. Prova ne sia che se noi
leggiamo uno dei tre versi, ad es.: il primo, calchiamo la voce,
quasi senza accorgercene, su la sillaba m di mezzo, su la sil-
laba min di cammin, su la sillaba no di nostra e su la sillaba
vi di vita; vale a dire pronunziamo accentandole la seconda,
la sesta, l'ottava e la decim::t sillaba; all'incontro, pronun-
ziamo lievemente le rimanenti sillabe disaccentate, dette
atone, che compongono il verso prescelto.
Questo svolgersi di suoni forti e di suoni deboli, questo
succedersi ad intervalli determinati di sillabe accentate e disac-
centate, genera una certa piacevole musicalit, che accarez-
zando l'orecchio, sviluppa una cadenza ritmica, la quale co-
stituisce il principio formativo ed essenziale della poesia ita-
liana, che detta, perci, accentuativa, giacch basata sul-
l'accento.
L'accento governa non soltanto il verso italiano endeca-
sillabo, ma anche tutti gli altri versi semplici e composti,
usati nella nostra lingua.
Versi accentuativi italiani semplici e composti.
3. - I versi semplici italiani sono:
l) l'endecasillabo, che consta di undici sillabe, con ac-
centi forti, sulla quarta, ottava e decima sillaba (ovvero:
sulla sesta e decima sillaba; ovvero: sulla quarta, settima e
decima sillaba, ecc.);
2) il decasillabo, che consta di dieci sillabe, con tre ac-
centi forti, sulla terza, sesta e nona sillaba;
3) il novenario, che consta di nove sillabe, con tre ac-
centi forti, sulla seconda, quinta e ottava sillaba;
4) l'ottonario, che consta di otto sillabe, con accenti
forti sulla terza e settima sillaba (ovvero: sulla seconda,
'
quinta e settima sillaba; ovvero: sulla seconda, quarta e set-
tima sillaba);
5) il settcna rio, eh e consta di sette sillabe, con due ac-
centi forti, sulla sesta e su una delle prime quattro sillabe;
-5-
6) il senario, che consta di sei sillabe, con accenti soli-
tamente sulla seconda e quinta sillaba;
7) il quinario, che consta di cinque sillabe, con un solo
accento fisso sulla quarta s llaba;
8) il quadrisillabo, che consta di quattro sillabe, con un
accento fisso sulla terza sillaba;
9) il trisillabo, che consta di tre sillabe, con un solo ac-
cento sulla seconda sillaba.
I versi composti italiani pi usati sono: l'ottonario doppio,
il settenario doppio, il senario doppio, il quinario doppio.
B) Poesia quantitativa.
4. - La poesia latina, diversamente dall'italiana, si basa
soltanto sulla quantit delle sillabe che compongono il verso:
ossia, sulla durata di pronuncia, di ciascuna sillaba nel corpo
della parola. Il verso latino, come si vedr pi innanzi, non
tiene affatto conto del numero delle sillabe che lo compongono.
Cenni intorno all'origine della poesia quantitativa
ed accentuativa.
5. - da sapere che i Romani furono soliti distinguere
le sillabe componenti una parola, in due specie o categorie:
lu7:tghe e brevi, a seconda della durata di tempo che essi impie-
gavano nel pronunziarle, come si vedr pi innanzi. La sil-
laba lunga, sia. in prosa che in poesia, era pronunziata lenta-
mente; la sillaba breve, celermente. Con l'andare del tempo
accadde che tale distinzione di brevit e di lunghezza delle
sillabe nel corpo delle parole, and sempre pi attenuandosi
nella lingua parlata, sino a che non se ne tenne pi conto:
all'incontro, tale distinzione si conserv e rimase nella poesia
che, come si detto, si bas unicamente sulla qnantit delle
sillabe formanti il verso.
In quanto all'origine della poesia accentuativa italiana,
gli studiosi unanimemente ammettono che essa derivi dalla
poesia latina. Ma come mai dalla poesia quantitativa si pass
-6-
alla poesia accentuativaY Pare che ci i'!ia derivato da una
lenta e graduale trasformazione della prima. noto, infatti,
che nel secolo IV circa dopo Cristo il senso della quantit and
a poco a poco estinguendosi nella poesia latina, e si fini, in
seguito, col badare soltanto al ritmo risultante dal numero
determinato delle sillabe e dalla successione degli accenti che
coincisero con gli accenti grammaticali. Non si pu stabilire
con precisione quando finisca la poesia quantitativa ed inco
minci la accentuativa. Alcuni inni della Chiesa ed i cosi detti
canti goliardici, per non citare altre poesie dell'et medioevale,
sono regolati ad un tempo dal ritmo e dalla quantit, cio,
dal ritmo quantitativo-accentuativo
1
CAPO II.
NOZIONI PRELIMINARI INTORNO ALLA SILLABA LATINA
E ALLA SUA QUANTIT
A) La sillaba latina.
6. - Comunemente intendiamo per siilaba l'articolazione
o il gruppo fonetico, che si pronunzia con una sola emissione
di fiato. Anche in latino la sillaba pu talora essere costituita
da una semplice vocale o da un dittongo.
B) Divisione delle sillabe latine nel corpo della
parola.
7. - Le sillabe latine nel corpo della parola generalmente
vengono divise come nella lingua italiana. C' da osservare
le seguenti regole fondamentali:
l In tempi non molto lontani. alcuni illustri studiosi della lingua e della lette
ra.tura di Roma intravidero nel pi antico verso latino, il sclturnio, un verso silla-
bico accentuativo, formato di cinque parole, divise in due emistichi, con tre o due
accenti; se tale ipotesi fosse stata provata, si sarebbe potuto conchiudere che la
primissima. poesia. latina. sarebbe stata accentuativa: se non che, alcuni valenti
studiosi moderni hanno sostenuto con validi argomenti la scansione quantita.tiva
di questo antichissimo verso e la sua derivazione da schemi lirici greci. (Cfr. Leo,
Pasquali, ecc.).
-7-
l) Una vocale seguita da un'altra vocale, eccetto cho
non formi dittongo, fa sillaba a s: de-a, pi-e. All'incontr<>:
poe-na, Oae-sar.
2) Una consonante posta fra due vocali appartiene alla
sillaba seguente: pa-nis, ma-ter.
3) Di due consonanti uguali, la prima va con la sillaba
precedente e l'altra con la seguente: ter-ra, an-nus.
4) Una consonante muta (c, p, t, g, b, d) seguita da una
liquida (l, r) forma con quest'ultima un gruppo inseparabile:
a-gri-co-la, te-ne-brae.
5) Se fra due vocali c' un gruppo di due o pi conso-
nanti con le quali pu cominciare la parola latina, queste
fanno parte della sillaba seguente: e-sca, a-strum, scri-psi.
6) Le parole composte sono separate nelle parti com
ponenti: ad-eo, prae-mo-ve-re.
7) Il gruppo ps appartiene alla sillaba seguente: nu-psi;
il gruppo mn nelle parole derivate dal greco appartiene alla
sillaba seguente: Le-mnos, ma nelle parole latine d'ordinario
si divide: om-nis.
O) Sillabe aperte e chiuse.
8. - Le sillabe latine si distinguono in aperte e chiuse,
Sono aperte quelle che terminano per vocale: ro-sa, fe-ro.
S ~ o chiuse quelle che terminano per consonanti: carmen,
tem-pus.
D) Quantit delle sillabe latine.
9. - Secondo la durata o la quantit le sillabe latine
possono essere brevi, lunghe, ancipiti, a seconda che le vocali
che le formano siano brevi, lunghe o ancipiti
1
a) Dicesi sillaba breve quella che ha la durata di un
tempo primo, cio, quella che si pronunzia in un solo tempo.
l Quando parliamo di vocali brevi, lunghe, ancipiti, non intendiamo gi parlare
delle sole vocali, ma. di tutta la sillaba., cui la vocale o.ppartiene.
-8-
A chiarimento di quanto diciamo da sapere che la durata
di un tempo primo, presso i Romani, non era affatto deter-
minata da frazione di minuto, ma era lasciata all'arbitrio di
chi parlava o di chi leggeva. Un tempo primo poteva durare
uno o pi secondi: tuttavia i Romani osservavano sempre il
rapporto di durata tra sillaba breve e sillaba lunga, e questa
ultima aveva sempre una durata doppia di tempo della sil-
laba breve.
Si suole indicare la sillaba breve con un semicerchio che
va posto sopra la vocale che la forma (v): terra, poeta.
b) Dicesi sillaba lunga quella che ha una durata di tempo
doppia della breve, cio, quella che si pronunzia in due tempi
primi. La sillaba lunga indicata con una linea orizzontale
sulla vocale o dittongo che la forma (-): iimplus, a,uriga.
c) Dicesi sillaba ancipite (da anceps: amb e caput, con
due teste, doppio) quella che viene considerata ora breve ed
ora lunga. Per indicare una sillaba ancipite si collocano i due
segni su accennati sopra la vocale che la forma ('=:'): voliicris,
tcnebrae.
E) Rapporto fra l'accento tonico e la quantit
delle sillabe.
10. - L'accento tonico non affatto legato alla quan-
tit delle sillabe; esso pu cadere tanto sulle sillabe brevi
quanto sulle lunghe. In un solo caso l'accento tonico coincide
con la quantit della sillaba, e cio, nelle parole polisillabe,
quando la penultima sillaba lunga: N eptunus, timre.
In quanto alla posizione dell'accento tonico si possono
fissare le seguenti leggi:
a) le parole monosillabe, tmnne le enclitiche e le procli-
tiche, hanno l'accento tonico su se stesse: fans, rx, p6ns, m;
b) le parole bisillabe hanno l'accento t(mico sulla penul!
tima sillaba, sia essa lunga o breve: prcfztor, pater;
-9-
c) le parole polisillabe hanno l'accento tonico:
ll
' l ,
l) su a penultima, se questa e unga: infidus, per-
muto, praedamnare;
2) sulla terzultima, se la penultima breve: clere,
maldicus, infero;
d) l'accento tonico non cade mai oltre la terzultima
sillaba (legge del trisillabismo): infidlitas, infirmitas, ecc.
NOTA. -a) Quando le enclitiche que, ve, ce, ne, pte si attaccano
ad una parola, l'accento tonico cade sempre sulla sillaba che le
precede, anche se questa sia breve: cura (nom, e voc. ), cuTaque
(nom. e voc.).
b) Quando l'enclitica que perde il suo valore copulativo (que
=el) dando origine ad una parola composta, l'accento si regola
secondo le norme generali: itdque = et ita = e cos; ma si dir:
undique = da ogni parte, iMnique = finalmente. Tale uso spesso
trascurato da noi moderni; noi diciamo pi spesso armiique invece
di armaque, come sarebhe pi preciso, secondo le sopra c i ~ a t e regolo;
CUraque (nom. e VOC. sing.) e Ourt.<Ji'6 (abJ. sing.).
ESERCIZIO l.
Si scompongano nelle loro sillabe foTmative le paTole seguenti,
e si precisi se la sillaba finale di ciascuna paTola sia aperta o
chiusa:
Venio - credere - expositus - quoque - adt.tare - nut,rix
- scripserant - Luperei - 1\lars - constitit - arbor - ambo
- patria - poena - poenitentia - coelicola - taedium - coelum
- amor - amans - praeficio - tenebrosus - infandum - tuus -
faber - praesim - corripio - discumbere - relucet - quaestio
- quantum - excurro - decidunt - lenimen - pauxillus - sex-
angulus - pedcster - tennis - tradere - discolor - Roma -
torridus - Sulmo - volucris - tenebrarum - abstinens - abs-
tinentia - contineo - continuus - pertinacia - obtinueram
- contentus - exprobro - patraverant - administrare - per-
Iucidus - collustrant - illuminari - auferunt - differt - pro-
tulit - transtulero - rettulit - antepono - perturbatum -
-IO-
respondens - perutilis - Psammetichus - scripserunt - pu-
blicus - publicatio - pulsatio - reptatio - Samnis - Samnium
- sarcinae- strigmentum - omnipotens - omnimodis - Lemnias
- trimestris - cycnus.
ESERCIZIO 2.
Si segni l'accento tonico nelle parole seguenti:
Undique - omniaque - denique - deque - suopte -
dixeruntne - celerisque - bice - huncine - hoce - itaque ( = et
ita) - itemque (avv.) - musaque (nom. e voc.) - rex - par
- plus - cor - mel - cunctaque (nom. e voc.) - suapte (abl.)
- plusve - minusve - crudelitas - feritas - pater - mater -
fulgidus - terribilis - innocentissimus - infirmissima (nom.)
- munitissimum - eripio - erogatio - errabundus - fataliter
- fatuitas - feretrum - fidicina - foedifragus - formositas -
gratulor - gubernaculum - gustavimus - herbosus - bine -
hippodromos - hirundinis - hoc - humanitas - iactans -
eademque (nom.) - identidem - ignipotens - illacrimabilis -
imaginor - imago - immobilis - impatiens - impotens - im-
puritas - intercido - libamen - lucubro - manus - mergimur
- morbus - mons - obloquor - octogiens - oculus - omissum -
omniparens - pactum - peculiariter - pecudis - pergravis -
poenaque (abl.) - praeceps - praeceptor - provoco - qui -
quies - reddidimus - reditus - sal - sagaciter - scalptum -
seges - semita - spes - telum - temere - tempestivitas - vas
- velox - veneficus - viscera - vis - vox - vultus - zephyrus
- zonula - lucifer - deditus - finitimus - magnanimitas -
- necessitas - innumerus - commodum.
-Il-
CAPO III.
QUANTIT DELLE SILLABE LATINE PER NATURA
E PER POSIZIONE
Le sillabe latine possono essere brevi o lunghe per natura
e per posizione.
A) Quantit delle sillabe per natura.
11. - Sono lunghe per natura:
l) le sillabe formate da dittonghi: Caesar, curae, poena,
taedium, coelum. (Si eccettua il dittongo di prae dinanzi a vo-
cale: prae-erat; ma dinanzi a consonante rimane lungo: prae-
mium - Cfr. 14, Nota
1
);
2) le sillabe formate da vocali derivanti da contrazione
o da un originario dittongo: tibicen (da tibiicen), mi (da mihi),
di (da dii), cogo (da coago), includo (da in e claudo), ecc ...
NOTA. - Per riconoscere la quantit delle altre sillabe brevi o
lunghe per natura, i grammatici non hanno fissato altre regole,
all'infuori delle anzidette. Ed allora bisogner ricorrere ad un buon
dizionario prosodico, quale, ad esempio, la Regia Parnassi.
Sovente la posizione dell'accento tonico fa da guida nella cono-
scenza della quantit di una sillaba. Se esso, ad esempio, cade
sulla terzultima sillaba, la penultima breve: amabilis;
d'altra parte, nelle parole plurisillabe se cade sulla penultima sil-
laba, questa lunga: conticure, terrnus.
B) Quantit delle sillabe per posizione.
12. - Una vocale di natura breve, formante sillaba, pu
trovarsi in posizione forte o debole.
'C!r. l'antica regola: Dipbtbongus longa est iu graeeis atque latlnls;
Prae rape praepositam vocali dieque praeustu!!
-!:l-
a) Si dice che una vocale in posizione forte, quando
viene a trovarsi:
1) dinanzi a due o pi consonanti: dictus, sancta;
2) dinanzi a consonante composta (x, z): gaza, exitus;
3) dinanzi a consonante finale di parola, cui segue
un'altra consonante iniziale di a:tra parola: sub monte.
NoTA. - a) Il gruppo qu consonante semplice, e per non
fa posizione: liiquor, iiqua l.
b) La Il non fa posizione, perch non considerata consonante:
inhumanus, dixit homo.
c) La i ( = j) che sta a principio di parola ed seguita da vo-
cale, consonante, e come tale, quando preceduta da altra conso-
nante, fa posizione: diuvo, sub Jove.
d) La i fra due vocali ( = j), e che suole essere resa in italiano
con gg, viene considerata consonante doppia, e. per c?nseguenza
la vocale che la precede lunga: rnior = maggwre. S1 eccettua:
biiugus, t1.,'iiugus, quadriiugus, nelle quali la prima i resta
considerandosi la i di iugum, solo in composizione, come semplice
2
b) Si dice che una vocale in poszzwne debole, quando
viene a trovarsi dinanzi a due consonanti, delle quali la prima
muta (c, p, t, g, b, d) e l'altra liquida (l, r).
13. - Una sillaba che in posi.zione forte lunga
8
Una sillaba che in posizione debole in poesia ancipite,
in prosa breve '
NOTA. - a) Per considerare ancipite una sillaha non basta che
Ja vocale sia seguita da muta e da liquida, necessario cl1e le due
consonanti formino la stessa sillaba. come avviene nP-lla parola
(non cos in ob-latum ... ), e che la vocale sin. di natura breve,
l Si ricordi che la u considerata come consonante dopo q e o e, come tale,
non fa sillaba di per s: quo-que, mentre vocale negli aggettivi in -uuu
e nei perfetti in -gui, nei qu::lrli fa siJlaba di per s: vigu-i.
21 Cfr. l'antica regola: (..)uachiingus rapitur. biiugus coniungitur illi.
J n quihus i duylli.'X non est, sed consona shnples:
8 crr. rantica regola: Vocalis Ionna est, si consona bina sequantur
'C!r. l'antica regola: Coutrahit mator, variant in carmine vates,
, si 1nutarn Jiquillamque sirnul brevis una praeiblt
- 13-
come in sapra, vol1Jcres (mentre si dir larcrum. salubris, ec!'.,
giacch la vocale di natura lunga, essendo derivate queste parole
da larre, ... );
b) La vocale a di acer lunga e rimane sempre tale: cris ...
U. - Una \'Ocale seguita immediatamente da
vocale breve, anche se sia interposta la h, che non conta:
erudio, arduus, nihil
1
ECCEZIONI. - Sono lunghe:
1) la e della terminazione ei del genitivo e dativo sin
golare della 5"' declinazione, quando preceduta da vocale:
diei, aciei (non preceduta da vocale regolarmente breve:
spei, rei);
2) l'a e l'e nel vocativo singolare dei nomi propri in
aius ed eius: Gai, Pompei;
3) l'i di fio nelle forme senza r: fiebam (ma fieri, fierem ... ,
ecc.);
4) l 'i della desinenza ius del gen. sing. dei pronomi della
za declinazione, che originariamente era lungo: illius, solius,
unius. (Nei poeti usata anche come breve, tranne in alius);
5) l'a del genitivo arcaico singolare della l"' declin.:
auliii (sta per aulae). Nei nomi greci le vocali conservano la
quantit originaria: Darius, Academia;
6) la e dell'interiezione eh eu.
NOTA. - Si ricori che il dittongo di prae seguito da vocale,
nelle parole composte, breve: praeustus, pmealtus, e che la i di
Diana ancipite.
Si ricordi, altreB, che la i ( = j) che sta a principio di parola
ed seguta. da vocale, ha. valore di consonante semplice: iugerum
(Cfr. 12, Nota, e).
.. 1 Cfr. l'antica rell'ola: breYiant, alia Latini
-14-
ESERCIZIO 3.
Applicando le regole studiate si segnino le sillabe lunghe
per natura nelle parole seguenti:
Coetus - Cumae - rosae - gaudeo - moenia - Orpheus
- aurum- curae- bubus (da bovibus)- praenosco- praesim -
praefuit - vitae - praedicatio - praedictum - praeda - prae
feci - praefulgeo - aetas - praetor - nolo (da ne(v)olo) - mo-
mentum (da movimentum) - gratis (da gratiis) - dis (da diis)
- subus (da suibus) - Clodius (da Claudius) - Clusium (da
Clausium) - mi (da mihi) - nilum (da nihilum) - copia (da
coopia) - cogo (da coago) - nil (da nihil) - nemo (da ne e l'an-
tico hemo =homo) - proles (da prooles) - cogito (da coagito)
- aequor - aequus - aest.us - aestas - aeternitas - aet.berius
- aevum - auctor - auctio - augmen - Boeotii - Caecilius
- Caecubum - caecus- caedes- coelum- Caeninenses- calum-
niae - dominae - Genuae - Graviscae - lacertae - Oenot.ria
- praenomen - praenuntius - praescribo - praeposuero -
praesidium - praedator - praedium - trocbaeus - valvae.
ESERCIZIO 4.
Dalla posmone dell'accento tonico si riconosca la quantit
della penultima sillaba delle parole seguenti:
Cleris - rapidus - c6rporis - tumidus - lfmpidus -di-
vrsus - dissolutus - distare - edacis - emendatus - excurro
- frmere- grminis- germanus- gn1vitas- gratulor- fgnifer
- fmmemor - ignarus - lucidus - laetabundus - mustla -
matrnus - natalis - opacus - putridus - rapiditas - saepfs-
sime - tnerum - uvidus - terrigena - terrificus - tet6ndi -
tssera - tim6rem - valetudo - vectigal - venficus - vennum
- venundo - verecundia - garrulitas - glomeratus - guber-
natrix - bomicfda - bumilitas - illiberalis - immutsco -
impertrritus - locupletatus - longinquitas - loqula - lutu-
-15-
lntus - memm1 Melp6mene - membranula - omnipotens
- Pand6ra - propugnavimus - receptaculum - spculum -
supplemntum - terriculum - vectabilis - vexillum - Z6pyrus.
ESERCIZIO 5.
Applicando le regole enunciate nei paragrafi 12 e 13 si segni
la quantit delle sillabe che risultano di posizione forte e di posi-
zione debole nelle parole seguenti:
Extremum - maestus - amans - quocumque - adspi-
ceres - nescius - pectora - gemitusque - ad montem - sub
Iove - infandum regina - volucres - peragro - cerebrum -
integro - explere - repletus - duplex - supra - pharetra -
formosus iuvenis - venitque - ad expositos natos - nutrix
bona - sub vesperum - dixit pater - amavit liberos - tenebrae
- acris - oblatum - oblongum - cingunt - biiugus - quadri-
iugus - triiugus - periclum - salubris - falx - falsarius -
fecundabant - fragrantiae - egregius - scripsi - sub radicibus
collis - exspectatus - dulcissimum - matribus - turbo - plau-
strum - plebs - amplexibus - dissipavit - tellus -bune- pro-
cella - edixerunt - felix - contendit - ad regem - rubens -
terrigenus - triclinium - transvolo - classicum - ad matrem
suam- fert pecunias- filius diligens- ad rivum- inter fratres
- concinunt - signa - salubritas - salubriter - lavabrum - te-
nebrosus - inclemens - inclinabilis - per montes et maria
- circiter centum - paulatim proferre.
ESERCIZIO 6.
Applicando le regole, di cui al paragrafo 14, si segni la
quantit della sillaba che rientra in dette regole, nelle parole
seguenti:
Adsiduus - excubiae - exclusio - Gai - diei - speciei -
spei - fidei- rei - fiam - fierem - unius - alterius - totius -
nulli.w.s - tuus - eheu - maior - gaudeo - nihil - nibilominus
- 16 --
- peior- veho- Arion- Iphigenia - Thalia - Machaon - noso-
comium - elegia - Cytherea - pictai - vestio - filius - fieri -
- Pompei - praeustus - repleo - praeoptare - praeessent -
praeeo - iugerum - Dianae - ullius - Zeuxis - Zoroastres -
effigiei - planitiei - nihilum - fruatur - fierent - Academia -
philosophia - praeivimus - praeisti - iugeribus - fiant -
metior - miliarium - miluus - arduus - idoneus - antiquus
- iacui- hinnio- hiems- heredium- dilatio- diluit - deleamus
- conspicuus - conscius - cognitio - furia - furialiter - gre-
mium - gruis - mortalium - viguit - exiguus - antiquo.
CAPO IV.
QUANTIT DELLE SnLABE FINALI
DEI POLISILLABI USCENTI IN VOCALE
15. - L'a finale di una parola polisillaba breve: luminri,
carmina, vitid.
ECCEZIONI. - lunga:
1) nell'ablativo singolare della 1a decl.: rosa, poeta;
2) nell'imperativo della 1a coniug.: ama, la1{dii;
3) nel vocativo dei nomi greci in as: Aenea;
4) nelle parole invariabili polisillabe: antea, contra, tri-
ginta (tranne: itd, eia, quia);
5) i nomi greci di persona uscenti in a conservano spesso
la loro quantit originaria: Andromeda, Electrii.
16. - L'e finale di una parola polisillaba breve: genere,
domine, consule.
EccEZIONI. - lunga:
l) nell'ablativo singolare della 5
8
declin.: di e, specie;
2) nell'ablativo sing. fame, da james, gen. famis, deri-
vato dall'antico fames, e, della 5a declinazione;
17-
3) nell'imperativo della 2a coniug.: mone, time;
4) negli avverbi di maniera derivati da aggettivi della
2a declinazione: docte, sancte, aegre (eccetto male, here, bene,
temere, necesse, nei quali l'e finale breve; in inferni, supern'J
l'e finale ancipite);
5) negli avverbi fere e ferme e nella interiezione: oh;
6) nei nomi derivati dal greco, nei quali in origine era
lunga, 'YJ (eta): Circe, Tempe, Andromache.
17. - L'i finale di una parola polisillaba lunga: viri,
amari, spei, dici, viginti.
EcCEZIONI. - breve:
l) in nisi, quasi;
2) nei nomi greci: Dafni, Palladi, Alexi;
ancipite:
1) in mihi, tibi, sibf, ubi, cui (usato come bisillabo), ibi.
I composti di ibi, ubi hanno l'i breve in ubinam, necubi,
sicubi, ubivis; lunga in ibidem, ubique, utrobique, alibi.
L'i di uti, sicuti, veluti lungo, ma breve in utinam, utique,
neutiquam.
18. - L'o finale di una parola polisilbba lungo: docto,
ergo, laudabo, a ~ t d i t o .
EccEZIONI. - breve:
1) in ego, duo, octo, cito, illico, modo (e nei suoi composti
dummodo, quomodo, ecc.); nell'interiezione io;
2) in alcuni bisillabi che hanno la penultima sillaba
lunga e che nello svol!!ersi dell'uso poetico h ,nno accorciato
la loro finale: imo ( = .,,.mo), ca6, lwao, sermo, virgo, nemo
1
l Nell''lSO poetico, si verifica l'accorciamento della finale nelle elencate forme
da Ovidw in poi.
2 .- E. DI MARZO, Prosodia e metrica latina.
- 18-
ancipite:
_l) n ~ i b i s ~ l l a b i _con la penultima sillaba breve: led, peto,
hOmo! veto, volo, scio, ecc.;
2) in nesciiJ (ma breve in nescio quis), persever.
NOTA. - Virgilio, Orazio e Properzio abbreviano sovente l'o
finale di Polio, dixe1o, ecc ... : Ovidio abbrevia l'o di Sulmo, di Naso
(Nasonis) ed anche dell'avverbio ergo.
19. - L'u finale di una parola polisillaba lungo: vocatU,
fructu, noctu, diii, dictii.
20. - L'y finale di una parola polisillaba breve: moljj
(erba moli).
ESERCIZIO 7.
Si segni la quantit delle sillabe finali delle parole seguenti:
Nomine - igne - nostro - fabula (nom.) - nulla (abl.) -
mihi - puero - digna (voc.) - crimine - firme - toro - ultima
(nom.) - viri - laeviora- indignata (abl.) -para (imperativo)
- Atla (voc. di Atlas) - Palla (voc. di Pallas, antis) - quadra-
ginta - contra - supra - frustra - antea - postea - sperne
(imperativo) - doce (imperativo) - misce (imperativo) - tene
(imperativo) - ita - qui a - eia - Tempe - sancte - ferme -
postridie - timide - bene - temere - male - inferne - multi -
audi - heri - Paridi - sibi - tibi - cui - ubinam - sicubi -
utique - Dido - denuo - piro - dummodo - quomodo - homo
- octo - volo - sermo - amabo - factu - senatu - cito - illico
- scio - nescio - equitatu - dictu - fructu - diu - io - Polio -
Sulmo - Naso - utinam - utique - utrobique - planitie -
effigie - die - spe - Hecube - hyperbole - Hypsipyle - celeri
- mari - calcari - vi - intepui - Sequani - agni - neutiquam -
fero - foro - fremo - Jongo - gustatu - specu - tribu - quercu
- acu - arcu - interdiu - memoratu.
-19-
CAPO V.
QUANTITA DELLE SILLABE FINALI
DEI POLISILLABI USCENTI IN CONSONANTE
21. - Le sillabe finali di parole polisillabe uscenti in
qualsiasi consonante, elle non sia s, sono brevi: exul, flu-
mn, mater, egit, tamen, ecc.
NOTA. -a) necessario che tali sillabe finali si trovino dinanzi
a parola che incominci per vocale, altrimenti diverranno lunghe
per posizione.
b) Si tenga presente che nel verso la finale m (cfr. 45, l) di-
nanzi a parola cominciante per vocale si elide: patre(m) adit e per
conseguenza si perde la sillaba per l'incontro di due vocali.
EccEZIONI. - Sono lunghe le sillabe finali:
l) in Hiber, eris, e nei composti di par (compiir, dispiir,
impiir, ecc.);
2) negli avverbi desinenti in c: illic, istic, adh uc, ecc.
(tranne donec);
3) nel genitivo plurale della l& e 2a declinaz. uscente
in um invece che in -arum od -orum: drachmum, amphorum,
deum, ecc.;
4) nella terza persona sing. dei perfetti contratti in iit
per ivit: petiit ( = petitit);
5) nelle parole derivate dal greco, terminanti nel no-
minativo sing. o nell'accus. sing. in an, en, on, in, yn: Titiin,
Aeneiin, Nioben, Anphion.
NOTA. - Sovente il poeta Virgilio nell'Eneide allunga la sil-
laba finale breve dei nomi in or, come amor, specie in arsi e cesura.
Per le sillabe terminanti in s occorrer osservare le regole
seguenti:
-20-
22. - La sillaba finale as lunga: piratas, rosas, laudas,
moneas, audiveras.
ECCEZIONI. - breve:
l) in aniis (aniitis);
2) nel nominativo sing. dei nomi greci uscenti in as,
genit. ddis o iidos: Palliis (Palliidis), lampiis (lampiidis), Ilids
(lliddis) ... ;
S) nell'accusativo plurale dei nomi greci della sa decli-
nazione: herods, Thyadiis, Areadiis.
2S. - La sillaba finale es lunga: prols, dems, dics,
audi-
ECCEZIONI. - breve:
l) nel nominativo e vocativo singolare dei nomi impari-
sillabi della sa declinaz. uscenti in es, col genitivo in itis,
etis, idis: miles (militis), seges (segetis), praeses (praesidis),
tranne: abis (abietis), aris (arietis), paris qua-
drups (quadrupedis). lunga in Cers (Cmi!Jis);
2) nella preposizione penes;
S) nella 2a persona singolare del presente indicativo di
sum, e nei suoi composti: es, abi!s, potes, ines, ecc.;
4) nei nomi greci: Arcades, Aeacides, Troades, ecc; ma
al singolare: Anchiss, Aeacids, ecc ....
24. - La sillaba finale os lunga: pueros, eos, dominos,
honos.
ECCEZIONI. - breve:
l) in compos, impos;
2) nel nominativo e nel genitivo sing. dei nomi derivati
dal greco, nei quali si mantiene l'o breve (omicron): Delos,
Pallados.
25. - La sillaba finale is breve: consulis, diffcilis, scribis,
omnis, amaveris.
-21-
ECCEZIONI. - lunga:
l) nel dativo e ablativo plurale della 1a e 2a declina-
zione: terris, dominis, agnis, e negli avverbi derivati da abla-
tivi: foris, imprimis, ecc.;
2) nell'accusativo plurale della sa declinaz. uscente in
is (per es): hostis ( = hostes ), civis ( = civ es), ecc.;
S) nella 2a persona singolare del presente indicativo
della 4a coniug.: audis, advenis ... ;
4) nella 2a persona sing. dei presenti congiuntivi uscenti
in t'm: sis (da sum, e in tutti i composti), velis, malis, nolis
(e per analogia vis, da volo);
5) nei nomi greci: Simois.
ancipite in sanguis e pulvis.
26. - La sillaba finale us breve: bonus, clarus, amamus,
penits ...
ECCEZIONI. - lunga:
l) nel nominativo della sa declinaz., con l'u tematico
lungo (u del genitivo lungo): incus (incudis), virtils (virtiltis),
tcllus ( telluris);
2) nel genitivo singolare e nel nominativo, accusativo,
vocativo plurale della 4
3
declinaz.: senatils (gen. sing.), fructils
(nom., accus., voc. plur.);
S) nei nomi derivati dal greco, uscenti originariamente
in ous: tripus (tripodis), Opfis (Opilntis); cos nei genitivi di
forma greca: Didus, Sapph s, ecc.
27. - La sillaba fin:1Je ys dei pochi nomi di origine greca
breve: Libys (gen. Libyis).
ECCEZIONI. - lunga:
in Tethys (gen. Tethyos) ed Erinnys (anche Ennys).
-22-
ESERCIZIO 8.
Si segni la quantit delle sillabe finali delle parole che seguono:
Romanis - temporibus - pater - intellexit - petiit -
acumen- tamen- caput- illud- consul - Hannibal - procul
- crater - compar - dispar - imprimis - malis - velis - nolis
- sanguis - pulvis - amaveris - vulnus - sensibus - funditus
- melius - cantus (gen.) - sensus (nom. plur.) - Amathus
(Amathuntis)- lampas- Naias- aetas- laudaveras- Arpinas
(Arpinatis) - omnes - doces - toties - duces - montes - Ar-
cades - daemones - rhetores - compos - melos - Amaryllidos
- forsitan- Iumen- nomen- Ilion- paries- praeses- servitus
- palus- comes (comitis) - hospes (hospitis) - eques (equitis)-
seges (segetis) - paries (parietis) - Ceres (Cereris) - anas -
georgicon - drachmum - deum - istic - illuc - donec - audis -
sis - adsis - sepelis - pervenis - sentis - farcis - brutus -
bubulcus - calor - triumvir - decemvir - Iuppiter - iter -
iecur - femur - acer - alacer - volucer - pedester - audax -
supplex - anceps - vigil - flumen - animai - clades - virtus
- montes - dolor - deduc - imaginis - marmor - requies -
elephas - anguis - thorax - lupos - humanitas - srctos -
adelphos - Arcados - heros - interes - praees - illos. - dicis -
amor - visus (gen. sing.) - miles (militis).
CAPO ,VI.
QUANTIT DEI MONOSILLABI
28. - I monosillabi uscenti in vocale sono lunghi: tu,
m, s, a, ecc.
ECCEZIONI. - Sono brevi:
l) le enclitiche qui!, ce, te, pti!, ne (tranne tet);
2) la forma enclitica dell'indefinito qua (nomin. singo-
lare femm. o neutro plurale).
-23-
29. - I monosillabi uscenti in consonante, sostantivi e
aggettivi, sono lunghi: sol, piir, os (oris), vr (veris).
ECCEZIONI. - Sono brevi: cor, vir, mel, fel, os (ossis), vas
(vadis).
30. - I monosillabi uscenti in consonante, ma che non
siano sostantivi o aggettivi, sono brevi: ab, per, dat, an, ecc.
EccEZIONI. - Sono lunghi:
l) criis, cur, n, non, quin, sin;
2) tutti i monosillabi uscenti in c: sic, huc, hiic, hoc,
ecc. (tranne nec, fac);
3) il pronome quis, quando sta per quibus.
II pronome hfc ancipite; hic avverbio lungo; es 2a. per-
sona sing. presente indicativo di sum breve (cfr. 23, 3);
es di edo lungo.
ESERCIZIO 9.
Si segni la quantit dei seguenti monosillabi:
Cur - ver - far - par - lar (laris) - cor - glis (gliris) -
plus - crus - sus (suis) - grus (gruis) - bos - vos - ros (roris)
- es (sum) - os (ossis) - in - an -ne -me - se - te - tu - ob
-e- a- ex- de- pte- hoc- ve- ce-fel- hac- hic (avverbio)
- quis (= quibus) -es (edo) - cras- quin- fur (furis) - sin
- non - hic (pronome) - nec - fac - lis (litis) - ius - mus -
mas (maris) - nix - strix (strigis) - nox - dens - urbs - fons -
ars - mons - mel - lac - fas - aes - grex - sol - vas (vasis) -
rex - res - spes - dat - et - abs - cis.
- 2-i-
CAPO VII.
QUANTIT DELLE SILLABE RADICALI
NELLE FORME DERIVATE E NELLE PAROLE COMPOSTE
31. - La quantit della sillaba radicale di un nome, in
linea di massima, rimane immutata nelle forme derivate e
nelle parole composte
1
:
agcr; derivati: agellus, agricultura, agricola, agrarius,
dgrestis, agripeta, ecc.;
nepos: pronepos, ecc.
EcCEZIONI. - Molte sono le eccezioni a questa regola.
Eccone alcune:
1) bos, gen. bOvis; Zar, gen. laris; sal, gen. salis; ps,
gen. pedis; rnas, gen. maris; par, gen. pans, ecc.
2) In sedeo la radicale breve, ma nel sostantivo suo
derivato sedcs lunga; cos la radicale di rego breve, ma
nel suo derivato regina lunga; in voco la radicale breve,
ma nel derivato vox, vocis diventa lunga; in lego la radicale
breve, ma nel derivato lex, lgis lunga; all'incontro, in
liicco la radicale lunga, ma nel derivato lucerna breve;
iu vado la radicale lunga, ma nel derivato vadum diventa
breve; in areo la radicale lunga, ma nel derivato arista
breve; in dico la radicale lunga, ma nei derivati dicax, male-
dicus, veridicus diventa breve, in nubo la radicale lunga,
ma nel suo derivato pronba diventa breve, ecc.
3) Accanto alle forme religio, religiosus, rifl1'quiac tro-
vansi le forme religio, religiosus, reliquiae con radicale breve;
da preferire per i primi due nomi la forma con la radicale
lunga, giacch l'arcaico red fu reso con rell, e :;i ebbero rel-
Ugio, relligiosus, ecc.
l Cfr. l'antica regola: Deri"t'ata pntrls natura m verba sequnntur
-25-
NOTA. - PreTTlesso che non si pu stabilire una norma precisa e
generica per determinare la quantit delle sillabe radicali delle
parole latine l, accenniamo qui brevemente alle principali cause
che determinano le frequenti eccezioni alla regola al Hl.
Esse vanno ricercate nelle varie trasformazioni che la sillaba radi-
cale subisce per alcune leggi della fonetica (contrazione, dittonga-
zione, posizione, pmlwngamento di compenso e organico, sposta-
mento dell'accento).
a) Talora la sillaba radicale, venendo a contatto con un'altra
vocale, anche per la caduta di qualche consonante intermedia, va
soggetta alla contrazione; ne deriva che se essa era lunga, rester
tale; ma se era breve, per la contrazione, si muter in lunga: mihi
= mi; coopia = copia.; mvolo = malo; siem = sim; coago = cago;
nivolo = ?Wlo, ecc.
b) Spesso due vocali che costituivano sillabe separate (il
che diverso dal caso precedente), si uniscono in dittongo per il
feuomeno della na-vt-jragus = nau-jragl&S; ne-ufer
neu-ter, ecc.
Talora un dittongo passa a semplice vocale, e questa sempre
di natura lunga: quaero = inquiro; aequus = moenia =
munio; Claudius = Clodius; Crausiu-m = ClUsi1-t,m, ecc.
c) Sovente la sillaba ra:licale di natura breve diventa lunga
per posizione, a causa di pii1 consonanti (o consonanti doppie)
che s'incontrano nella formazione delle parole. Esempio: la sil-
laba radicale mrl.q che breve di natura (cfr. magis), diventa lunga
per posizione in a causa dell'incontro di due consonanti
(g + n); la sillaba radicale cap, anch'essa di natura breve (cfr. capio),
diventa lunga per posizione in ciiptus per la stessa ragione (p+ t);
la sillaba radicale mor. i natura breve, (cfr. morior), diventa lunga
in mortuus (r + t), ecc.
d) Talora la sillaba radicale breve, nella formazione delle
parole, si allungata, onde compensare la perdita di qualche con-
sonante (prolungamento di compenso). Cos, la radicale cii di ciisus
risulta allungata per compensare la perdita del d della parola ca.(d)sus,
da cui deriva, mentre detta sillaba originariamente era breve
(cfr. cadere); lo stesso fenomeno si verificato nelle forme motum
1
Alcuni studiosi banno formulate delle regole per stabilire la quantit!t della
sillaba radicale degli imparisillabi della 3 declinazione. (Cfr. Roccr, Trattato i
Prosodia ... , Paravia, p. 42, 43); ma poicb esse non ci sembrano rite-
niamo ometterle, e consigliamo il discente a fare uso di buoni dizionari e della
Regia Parnassi, onde accertarsi, caso per caso, della quantit delle sillabe radicali.
brevi o lunghe per natura, come si diceva al i 11, nota.
-26-
da mo(v)tum (cfr. moveo); iutum da iu(v)fum (cfr. adiuvo); votum
da vo(v)tum (cfr. voveo); prelum (torchio) da pre(m)lum (cfr. premo),
ecc.
e) Non di rado la sillaba radicale breve risulta allungata,
nella flessione o formazione delle parole, per prolungamento organico.
(Cfr. la definizione e le regole del prolungamento organico nella
grammatica della lingua greca). Esempio: la sillaba radicale te
di tego si allungata per prolungamento organico nella voce tegula;
la sillaba radicale breve se di sero ,;i allungata in semen per lo
stesso fenomeno; la sillaba radicale re di rego si allungata in re-
g,ula, ecc.
f) Da ricordare, infine, che lo spostamento dell'accento dalla
sillaba radicale verso altre sillabe pu a volte determinare il veri-
ficarsi o meno del prolungamento organico e, per conseguenza,
modificare la quantit della. sillaba radicale. Se questa, ad esempio,
viene a perdere l'accento, perch esso si trasferito in altre sil-
labe, talora non si verifica il prolungamento organico e, conseguen-
temente, la sillaba radicale lunga pu mutarsi in breve. Esempio:
la sillaba radicale se di sedes divenuta breve in sedile, perch
l'accento si trasferito dalla sillaba radicale sulla sillaba seguente;
lo stesso fenomeno si verificato in luceo, lucrna; iicer, iicrbus;
moles, molst'US; areo, iirna, ecc.
ESERCIZIO 10.
Si segni la quantit della sillaba radicale delle parole seguenti:
Artifex - artificium - artificialis - artificiosus - augeo -
augmen - auctor - auctio - bcllum - bellator - bellatrix -
bellicosus - bellicum - luceo - lucerna - rego - regina - re-
ligio - religiosus - reliquiae - moveo - mobilis - lapis - la-
pillus - lapideus - lapidosus - lapidator - animus - magna-
nimus - pes - tripes - nepos - pronepos - avia - proavia -
mensis - bimestris - pugna - oppugnatio - oppugnator -
facio - praefectus - sedeo - cano - canor - canorus - canticus
- cantilena - cantito - cantrix - accino - accentus - concino
- concentus - locus - collocare - collocatio - locuples - lo-
cupleto - fides - fidelitas - perfidus - perfidia - infidus -
fluo - flumen - fugere - fugitivus - profugus - transfuga
- fulgeo - fulmen - opes - inops - opulentus - opimus - opi-
-27-
tulari - opus (operis) - magnopere - tantopere - os (oris) -
osculum - orare - orator - coram - pario - pactio - pagina
- parere - parentes - pars - - particeps - cor (cordis)
- discors - misericors - praccordia - cura - incuria - securus
- curro - cursus - concursus - curriculum - colo - incola -
agricola - colonia - bos - bovile - boatus - annus - perennis
- quotannis - anniversarus - annona.
CAPO VIII.
QUANTITA DEI PREFISSI
32. - I prefissi, com' noto, sono elementi sillabici che
si prepongono al tema di una parola per rafforzarne o va-
riarne il significato.
Sono prefissi le preposizioni monosillabiche e bisillabiche
ed alcune particelle, come ne, se, ni, re, ecc.
a) Circa la quantit delle preposizioni monosillabiche, si
gi detto al Capo VI trattando dei monosillabi.
b) Circa la quantit delle preposizioni bisillabiche, si ve-
dano le regole date ai Capi IV e V per le parole polisillabe
in vocale o in consonante.
c) Circa la quantit delle particelle, usate come prefissi,
si danno le regole seguenti:
1. Sono brevi: ne, n!f, re. Esempio: nefas, nefastus,
nequeo, nisi, redttco, rejert, riporta refero), ecc.
ECCEZIONI: nequam, neve, nimirum, nedum, nequitia, rfert,
importa (da res e fert).
La particella re (da red) breve davanti a muta e liquida:
recreo, repleo, ecc.
2. Sono lunghe: di, s, trii (da trans). Esempio: di-
mitto, segrego, traduco, ecc.
ECCEZIONI: dirimo, disertus.
- 2S-
NOTA. - a) Il pn5, come rilevasi dalla regola al 28,
lungo.
breve nelle forme:
proficiscor e derivati, projiteor e derivati, e derivati,
procella, p1ocul, proceres, projanus, projari, profecto, profestus,
p'l'ojugio, pronepos, propitius, protervus.
Lo stesso prefisso nei composti greci sempre breve:
prodromus, prologus, ecc.
b) La particella a (derivante dall'alfa privativa greco), e la
particella di (dal greco sono brevi: adytum, atheus, dilemma, ecc.
c) Si tenga sempre presente che la quantit di tutti i prefissi
va soggetta ai mutamenti che possono verificarsi per le regole di
posizione. Esempio: pro in composizione di avus, venendosi a tro-
vare dinanzi a vocale, diventa breve: pro-avus; ad in composizione
di facio, venendosi a trovare in posizione forte, diventa lunga:
adficio, adfectus; re b:ru "' diventa lunga per posizione forte nella
forma respicio, ecc.
ESERCIZIO 11.
Si distinguano i prefissi nelle parole seguenti e si segni la
quantit dei medesimi:
Adeo - atheus - adequitant - adhaerent - adhortor
- adigere - admisit - aduro - circumagere - circumclusi -
circumdederunt - circumtulerant - coerceo - cogitem - coegit
- collaudatio - collustrare - consors - detulerim - deftagratio
- deformis - depugnare - deligere - denuntiavit - depugnent
- depositio - divaricare - diverbium - divertere - dilemma
- edurus- educare- eduxerunt- efficiam- egredior- emanare
- expoposci - expositio - exspectatio - extimui - extrusi -
incruentus - incultus - indecorus - indemnis - indocilis -
infclix - interrumpere - intervallum - inverecundus - neco-
pinatus - nedum - nefarius - nefas - nefastus - nequam -
nequiquam - nescio - nimirum - nisi - nequitia - obduresco
- oblevi - obnoxius - percensent - periremus - perfidelis -
perfugio - permollis '- perno x - pernoxius - praelongus -
prod11cere - protuleram - profestus - profundo - profanus
- protervus - prologus - propugnatio - reclamare - reclusuru
-29-
- rccumbo - recurro - reddere - relinquo - rrmorsum- requies
- refert (da res e fert) - trado - traductio - transcribere-
transgressus - transmarinus - propitius - adytum - dimitto
- segregare - prodromus - proavus - adfectus - respicere -
disertus.
CAPO IX.
QUANTIT DELLA FLESSIONE VERBALE
A) Elementi costitutivi del verbo.
33. - Gli elementi costitutivi del verbo sono: la radicale
o tema verbale generale, il tema temporale, la desinenza personale.
l) Il tema verbale generale quella parte del verbo che
resta invariata in tutta la flessione; esso si ottiene staccando
dall'infinito presente le sillabe are nella l a coniug., ere nella
2a coniug., ere nella 3a coniug., ire nella 4a coniug.: am-are;
mon-ere; leg-ere; aud-ire.
2) Il tema temporale quella parte del verbo che assume
la determinazione del tempo; esso si ottiene aggiungendo al
tema verbale generale qualche suffisso che determina ciascun
tempo. E poich noto che tre sono i temi temporali fon-
damentali (del presente, del perfetto, del supino), accenniamo
brevemente alla formazione di questi tre temi fondamentali:
a) il tema temporale del presente si ottiene aggiun-
gendo al tema generale la vocale tematica
1
a per la prima co-
niug. (am +a); la vocale tematica e per la 2a coniug. (del+ e);
la vocale tematica i per la 4a coniug. (aud +i).
La 3a coniugazione non ha vocale tematica, ma vocali
copulative: i, e, o, tt, che uniscono il tema verbale generale
alle desinenze.
1 Alcuni grammatici chiamano dette vocali non gi tematiche, ma caratteri
stiche : tale terminologia errata, giacch la caratteristica dei tempi una sola, e
non sono tante : mentre noto che le vocali tematiche non sono che modificazioni
di nn'a primitiva. (Cf. E. DI MARZO, Grammatica Latina, Paravia, Torino, p. 139,
93 N.). Altri grammatici confondono le vocali tematiche con le copulativB.
-30-
Dal tema del presente gli altri tempi da esso d eri va ti si
formano mediante suffissi: ba per l'imperf. indicativo; bo per
il futuro indicativo della P e za coniug., ecc.
b) Il tema temporale del perfetto si forma in vari modi:
l) aggiungendo al tema generale av, ev, iv: am-av(i),
del-ev(i), aud-iv(i); oppure u o s: mon-u(i), clau(d)-s(i);
2) allungando l'ultima vocale del tema: video, vid- vid(i);
3) premettendo il raddoppiamento: curro- cucurr(i), ccc.
c) Il tema temporale del supino si forma aggiungendo
al tema verbale generale i suffissi tum o sum, preceduti dalla
vocale tema ti ca per la l a, za, 4a coniugazione: laud-a-tum,
del-e-tum, aud-i-tum.
3) Le desinenze personali che ci fanno conoscere la per-
sona che fa o subisce l'azione, sono le seguenti:
DESINENZE PERSONAU ATTIVE
Indicativo Perfetto
Imperativo
Persone
e congiuntivo indicativo Presente Futuro
s. Pers. 13 o, m i - -
za
s i-sti - t o
3a t i-t - t o
P. Pers. la mus i-mus - -
za tis i-stis te t o te
3a n t e-runt (re) - nto
DESINENZE PERSONAU PASSIVE
Impemtivo
Persone Indicativo e co,giuntivo
Presente Futuro
s. Pers.
la
r - -
2a ris (te) re t or
3a tur - t or
P. Pers. la mur - -
za.
mini mini -
3& ntur - n t or
--
-31-
Premesse queste indispensabili nozioni, passiamo ad occu-
parci intorno alla quantit della flessione verbale.
B) Quantit della sillaba radicale di un verbo.
34. - La quantit della sillaba radicale di un verbo, anche
se composto, rimane invariata in tutte le forme derivate,
eccezion fatta per i perfetti ed i supini, per i quali si danno
regole a parte: facio, perficio, t"itor, abutor.
35. - La quantit della sillaba radicale si mantiene inva-
riata in tutte le forme verbali derivanti dal medesimo tema
temporale: pono, poncbam, ponam, ponerem, ponere, ponens, po-
nendi, ponendus; posui, posuerarn, posuissem, posuerim, posuero,
posuisse; positum, positurus, positurum, positus; ecc.
36. - I perfetti ed i supini bisillabi hanno la radicale lunga,
anche se nel presente essa sia breve: vici, egi, rnotum, victum, ecc.
EccEZIONI. - Sono eccettuati i seguenti perfetti e supini
bisillabi: a) bibi, fidi, steti (sto), tuli, scidi (scindo), stiti (sisto);
b) citurn, ddtum
1
, itum, litum, quitum, rdtum, rutum, sdtum
- - ' sttum, statum, ecc.
NOTA. - I supini polisillabi hanno la penultima sillaba lunga:
laudiitum, auditum, ecc., ad eccezione dei supini in itum apparte.
nenti a verbi il cui perfetto non esce in vi, come: condo, supino
conditu1n; dorno, supino: domitum (tranne cognosco, che avendo il
perfetto in vi, ha il supino con la penultima sillaba breve: cognitum ).
37. - Nei perfetti con raddoppiamento la sillaba radi-
cale e la sillaba raddoppiata sono brevi, a meno che questa
non diventi lunga per posizione: d id ici, pupugi, cecidi, ecc.;
ma in totondi, in cucurri, ecc., la sillaba radicale lunga per
posizione forte.
EccEziONI. - Sono eccettuati:
cecidi (caedo), pepdi (pdo).
1
Ila di dare sempre breve, anche nei tranne ch" nelle forme das
e da che lunga.
-32-
C) Quantit delle sillabe interne di un verbo.
QUANTIT DELLE VOCALI TEMATICHE E COPULATIVE.
38. - Le sillabe interne di un verbo, formate dalle vocali
tematiche (a per la la; e per la 2a; i per la 4a coniug.), con-
servano la loro quantit lunga in tutta la flessione:
amare, amabam, amaveram, amiivero, amabo, ecc.; de-
lere, delbam, delveram, delvero, delrem, ecc.; audire, audi-
vero, audiveram, audivi, audivissem, ecc.
NoTA.- Soltanto in due casi le vocali ternatiche mutano la loro
quantit lunga in breve:
a) quando vengono a trovarsi dinanzi ad altra vocale: audio,
mono, delam;
b) quando sono unite a desinenza breve (per es.: la t finale
di parola dinanzi ad altra parola cominciante per vocale): amdt,
delt, audit, ecc. (amiit
39. - Le sillabe interne di un verbo, formate dalle voeali
copulative i, e, o, u (queste vocali uniscono il tema verbale
generale alla desinenza nei verbi della 3a coniug.), sono brevi:
leg-e-rem; leg-i-mus; nol-it-mus, ecc.
ECCEZIONI. - Sono lunghe:
l) nell'imperfetto indicativo: leg--bamtts;
2) quando vengono a trovarsi in posizione forte: dic-fi-nt,
dic-e-nt.
NoTA. - Nell'imperfetto indicativo della 4a coniugazione s'in-
troduce, per analogia ai verbi della 3a coniug., una vocale copu-
lativa e lunga: aud-i-e-bam.
QUANTIT DEI SUFFISSI TEMPORALI.
40. - La sillaba interna di un verbo, formata dal suffisso
temporale ba dell'imperfetto indicativo, lunga: ama-bii-mus,
audie-bii-mus.
-33-
Va da s che diventa breve, se la vocale unita a desi-
nenza breve: lauda-ba-t. (Cfr. 38, Nota, b).
41. - La sillaba interna di un verbo, formata dal suffisso
temporale i del perfetto indicativo, lunga, eccetto nella
3 persona singolare e nella Ia persona plurale: amav-i-sti;
leg-i, ecc., ma amav-i-t (cfr. 38, Nota, b), leg-i-mus.
42. - La sillaba interna di un verbo, formata dal suffisso
temporale del presente congiuntivo e dell'imperfetto con-
giuntivo, lunga: am-e-m, dele-a-m; audi-ii-tis, ecc., e cos
noli-mus; amar-e-m, deler--m, audir-e-m, ecc.
43. - La sillaba interna di un verbo, formata dal suffis11o
temporale bi del futuro semplice indicativo per la P e co-
niugazione, breve; quella formata dal suffisso temporale ii
del futuro semplice indicativo per la 3a e 4a coniug., lunga:
ama-bi-tis, mone-bi-mus; leg-e-s, audi-e-mini.
D) Quantit delle sillabe finali delle forme verbali.
44. - Per le sillabe finali di un verbo si applicano le re-
gole gi fissate per le sillabe aperte o chiuse. (Cfr. Cap. IV,
15 e seguenti; Cap. V, 21 e seguenti; Cap. VI, 28 e
seguenti).
ESERCIZIO 12.
Si segni la quantit di tutte le sillabe, delle quali si compone
ciascuna forma verbale qui sotto trascritta:
Laudabant - diximus - ducemus - moneo - moneam -
monuisse - delevi - auditurus - auditum - amatum - cogni-
tum - conditum - deletum - monitum - bibi - fidi - pot.ui -
potuisse - rutum - situm - didici - cucurri- cecidi - pendere
- pependi - nolumus - velim - dicent - audiebamus - nolimus
-34-
- paravissemus - laudabit - laudabimus - amantur - paretur
- dicito- dicitote- currens- emi- carpsi- emptum- redimo
- adimis - accensum - esum - lego - intelligo - negligo - ver-
tere - animadvertere - vinco - convinco - arguo - redarguo
- scio - nescio - venio - pervenio - invenirent - pungit - pu-
pugit - tangunt - tetigerunt - conveniunt - fallo - fefelli -
pello - pepulimus - contundo - contudi - appellem - appella-
remur - dictus - dicturus - lecturus - parcitum - tactum -
monebimus - audiebamur - legi - deleamini - simus - oppu-
gnor - conscribemur - Iaturus - diligendi - Iegeris - nomina-
beris - vocaverim - putareris - condiderimus - transeuntis
- venire - venundare.
ESERCIZIO 13.
Si segni la quantit delle sillabe componenti ciascuna parola
dei versi che seguono:
Tempus hoc laetitiae,
dies festus hodie;
omnes debent psallere,
cantilenas promere,
cum affectu pectoris,
toto gestu corporis
et scolares maxime,
qui festa colunt maxime.
(Da un canto dei Ole1 ici
Dives eram et dilectus,
inter pares praelectus
1
,
modo curvat me senectus
et aetate sum confectus.
Paupertatis fero pondus,
meus ager, meus fundus,
domus mea totus mundus
quem pererro vagabundus.
1
Da prae-leoo = ooelto primi>, prescelto.
-35-
Quondam felix et fecundus
et facetus et facundus,
quondam primus, nunc secundus,
victum quaero verecundus.
(Da un canto dei Cleri C'i r
Hector beate ca eli tum,
Qui sic amas mortalium
Salutem, ut almi filii
Cruore sancto laveris
Peccata eorum, suspice
Servi precantis spiritum,
Qui fretus unica tua
Benignitate languidos
Artus Iibenter deserit,
Ut alta caeli sidera
Petens fruatur, optime
Pater, tua praesentia (ab!.),
Et sempiterno gaudio.
(M. A. Flaminio, Carm., l. VIII).
Puella delicatior
Molli columba, pulchrior
Rosae rubentis flosculo,
Our immerentem candidis
Te saeva Parca fratribus,
Et coniugi dulcissimo
Prima inventa (abl.) sustulitT
Sic florem hiantem mollibus
Telluris almae amplexibus
Vellens procella turbinis
Leves in auras dissipat ...
(M. A. Flaminio, Carm., I. I).
-36-
CAPO X.
PUOSOIHCHE
45. - Non semp:e 1 poeti usservano scrupolosamente
nelle loro p1 !(>SE' le legg p n; SI d1dH che, Clllle Si visto, fissano
la quantit delle sillab1 compLnenti ciascuna parola, consi-
derandola isolatamente: spesso i poeti, nell'aggruppare pi
parole in venil, si so ne arrcgata la libert di far breve una
sillak lunga. l' lunga um dlaba breve.
Le prineip:l.l! lf'lnzt. ,., ntra.r:e alle leggi della prosodia,
sono:
l) L'elisi. nt (d . .J lat. no elidere = togliere via, annullare).
Se una p;rola. t.eJm na pu vocale o per m, ed immediata-
mente s1 :u t,p da un'altra parola che comincia per vocale o
pPr h, cer1: m1 n te si g1 nua un suono l'gradevole; a.d evitarlo,
si ricorre ad elidere la sillaba precedrnte, che non conta, come
si vedr in seguito, nella misura del verso, e nella lettura
non si fa sentire la vocale o la sillaba con m elisa.
ESEMPI:
Cuntwuere omnes = conticuer'omnes;
Vince animos = vinc'animos;
adeo = mult'adeo;
.M onstrum informe = monstr'informe.
2) L'iato. Quando la m o la vocale, finali di parola, non
si elidono per necessit metriche, dinanzi alla vocale o la h
con cui si inizia la parola seguente, si ha l'iato, che licenza
contraria all'elisione. La parola iato viene dal latino hiatus =
gola, apertura, in quanto nella pronunzia, a causa dell'incontro
di tale lettera o della vocale, siamo costretti a tenere la bocca
un po' pi aperta del solito.
ESEMPIO:
Spe l! t'nimica;
Et vera Il incessu.
-37-
3) La sinresi o sinezsi ( cruvodpem da cruv-odpw = prendo
insieme). Essa consiste nel considerare come una sola sillaba
due vocali che dovrebbero fare sillaba ciascuna da s:
ESEMPIO: Proinde (trisillabo) = proin-de
ostrea (trisillabo) = o-strea.
4) La diresi (aw.[fJEO't da at:x:x1piw =separo). una
licenza opposta alla precedente; consiste nel separare in due
sillabe, per necessit metriche, due vocali costituenti una sola
sillaba.
ESEMPIO: Si-lu-ae per sil-vae;
Ye-i-us per Ve-ius.
5) La sistole ( crucrw da cruv-crrnw = abbrevio). Con-
siste nel far breve una sillaba lunga, specie nella sa persona
plurale dei perfetti.
ESEMPIO: Tulerunt, invece di tulerunt;
dederunt, in vece di dederunt.
6) La diastole da atO<-O'TW =allungo). Si
ha quando si fa lunga una sillaba che di sua natura breve.
la e di es (seconda persona sing. ind. di esse)
breve; talora per diastole si fa lunga: s.
46. - Alle anzidette licenze prosodiche occorre aggiungere
le seguenti alterazioni per rnetaplasmo, nella struttura delle
parole:
l) La protesi (np60e:crt da npoTf0'Y)[Lt = metto avanti).
Consiste nell'aggiungere qualche suono a principio di parola:
ESEMPIO: gnatus = natus; edurum = durum.
2) l'aferesi (&;n.fpe:at:; da chp:xtpw =tolgo ria,
Consiste nella soppressione di qualche suono a prmCJp!O di
parola:
ESEMPIO: temno = contemno; factum-st = factum est.
-38-
3) L'epntesi da 7t-Ev--rW'Y)tJ.L =pongo in
mezzo). Consiste nell'aggiungere qualche suono nel corpo della
parola:
ESEMPIO: Alcumena per Alcmena; balineum per balneum.
4) La sincope da cruy-x67t-rw =taglio in
mezzo). Consiste nella soppressione di qualche suono nel corpo
della parola:
ESEMPIO: saecl7tm per saeculum; periclum per periculum.
5) La paragoge da 1tocp&yw =prolungo). Con-
siste nell'aggiungere qualche suono in fine di parola:
ESEMPIO: deludier per deludi.
6) L'apocope (&7to-x67t-rw =taglio dopo). Consiste nella
soppressione di qualche suono in fine di parola:
ESEMPIO: oti per otii; viden per videsne.
7) La tmesi (-rtJ.'ljcrt da -rtJ.VW =separo, stacco). Con-
siste nello staccare gli elementi formanti una parola, ponen
dovi in mezzo altre parole:
ESEMPIO: septem subiecta trioni = subiecta septentrioni;
quam rem cumque = quamcumque rem.
8) La metatesi ([LE-rif8Ecrt da = traspongo).
Consiste nella trasposizione di una parte della parola:
ESEMPIO: emt inter = interemt;
fecit are = arefecit.
PARTE SECONDA
MRTRICA
47. - La parola rnetrica
1
(grecamente (-rt;{V"YJ) da
y.-rpov =misura; in latino ars metrica o mctrvrum ratio), in
senso generico l'arte che insegna a comporre dei versi e
a collegarli tra di loro; in senso ristretto, la dottrina che
studia gli elementi costitutivi del verso a base quantitativa,
proprio delle lingue classiche', greca e latina.
CAPO I.
RITMO ARSI E TESI PIEDI
A) Ritmo.
48. - Principio informativo ed essenziale del verso latino
il ritmo (in greco pu6f1.6, cadenza, movimento uniforme; in
latino: numerus).
1
Nella compilazione della 2 e 3 parte di qnestB volume a.bbiamo oonsult&t9
le opere seguenti: LUCIANO MULLER, Metrica dei Gr.ci e il<i Romani, 2 ediz., Hoepli,
1926; FR. VOLLMER, RiJmische JJfetrick, Leipzig - Berlin, 1923; BIONE, Lt forme
metriche dei Greci e dei Romani; La mdrica dei poeti Greci t Latini, Nuov& Italia
Firenze; O. ScHROEDER, Nomendator metricus, Heidelberg, 1929; CRIST 'VIHEL
MEN, Metrik dr,r Griechen und Romer, Leipzig, 1879; SCHROEDER OTTo, Horazens
Vermasse ... , Leipzig, 1911; FR. A.UG. MEINEKK, prefaz. all'edizione di Orazio,
Ber!in, 1834; LACKMANN, In Klein. Schrift, zur Klass. Phil. , 1876; BINDI, Orazio
Flacco, 7 ediz. Napoli, Ia89; GIRI GIACOMO, Odi ed Epodi, 7" ediz., .!.l-
brighi " E'egati, 1913; RASI PIETRo, Orazio, Sandron, Palermo, 1910; P. FosSA
TARO, Manuale teorico-pratico di prosodia ed elementi di metrica latina, Napoli,
1927; M. LE,.-CHAN'riN DE GUBERNATIS, Manuale di prosodia t metrica latina,
Messina, 1934; TI101toTTI, 11fetrica latina classica e eristiana, S. E. 1., Torino; ET'rORE
STAMPINI, La metrica fH Orazio, Loescher, Torino, 1913; CLAUDIO VAIOLI, Elemtnti
di prosodia e metrica Boloi'na, Zanichelli; CARLO DEL GRANDE, Elementi
Ili prosodia e metrica l<tiina, LoJiredo, Napoli, 1923. - Abbiamo altresl consult&to
non pochi altri autori eh& qui ai
-42-
Dicesi ritmo il regolare alternarsi di suoni deboli e forti.
Nella poesia italiana il ritmo dato, come si detto a
principio del volume, dal succedersi a determinati intervalli
di sillabe accentate e disaccentate; nella poesia latina il ritmo
risulta dalla studiata e regolata successione di sillabe lunghe
e di sillabe brevi, o meglio, dall'alternarsi, secondo determi-
nate leggi, delle arsi e delle tesi.
B) Arsi e tesi.
49. - Quando pronunziamo una parola, non pronunziamo
gi tutte le sillabe di essa con la stessa tonalit, ma da prima.
eleviamo il tono della voce, poi l'abbassiamo. Pronunziando,
ad esempio, la p::trola mater, facciamo sentire l'a accentata
con una tonalit pi alta che il resto della parola. Ebbene,
l'innalzamento della voce dicesi arsi (grecamente &pcrt, da
OttpC =sollevo; in latino sublatio = innalzamento): l'abbassa-
mento della voce dicesi tesi (Stcrt, da -d6'Y)fH = depongo; in
latino positio = abbassamento).
L'arsi la sillaba lunga, su cui cade l'accento acuto (l'icttts),
e pertanto dicesi che essa in posizione forte; la tesi, al con-
trario, che costituita della rimanente parte della parola,
non essendo sottoposta all'ictus, dicesi che in posizione debole.
Arsi e tesi sono i due elementi formativi del piede, del
quale parleremo subito.
NOTA. - a) In origine due vocaboli: e tesi,
carono l'opposto di quanto si detto sopra; tesi fu la parte
'lrsi la parte debole. Scientificamente cos dovrebbe essere; n01,
per non ingenerare confusione, manteniamo la terminologia che
da tempo invalsa nella scuola.
b) Prima di passare ad altro argomento, ci sembra opportuno
l!ltabilire qui la differenza che passa tra l'accento tonico e l'ictu.r
metrico.
Ci spieghiamo con un esempio. Secondo I'accento.tor,dco
pronunziare le seguenti parole tratte da un verso _d1 T1bullo, c?s1:
horrndos primus ; mentre, secondo metr;co, l_e
parole vanno lette nel modo che segue: horrendos . .
L'ictus metrico, come si vede, interessa la quant1ta delle sil-
labe, o, per essere pi precisi, tutte le arsi; l'accento tonico, al
- 43-
contrario, segna la posa della voce sulla sillaba di ciascuna parola,
nella consueta pronunzia di questa, libera da considerazioni metriche.
O) Piedi.
50. - Dicesi piede un aggruppamento di un certo numero
di sillabe lunghe e brevi, collocate in determinati posti.
Il piede l'elemento formativo del verso, e si chiam
cos dall'abitudine che avevano gli antichi di misurare il tempo,
sollevando il piede da terra e abbassandolo a terra.
L'unit di misura del piede la sillaba breve (v) (greca-
mente y,_p6vo npw't'o = tempo primo; in latino: mom, cio:
spazio, durata).
La sillaba breve detta battuta. Una sillaba lunga equi-
vale a due battute, cio a due brevi; e per ogni sillaba lunga
si pu sciogliere in due brevi e due sillabe brevi possono essere
sostituite da una lunga (nel verso esametro dattilico, come si
vedr, la sillaba lunga dell'arsi non pu essere soluta, mentre
le due brevi della tesi possono essere sostituite dalla lunga)
(Cfr. 69).
Come la battuta detta anche misura, cos il piede
detto da alcuni studiosi anche metro ([L't'pov), perch serve
a misurare il tempo con esattezza (esempio: esametro = sei
metri o piedi). Infatti mediante la combinazione delle lunghe
con le brevi, di cui costituito il piede, possiamo calcolare
il tempo con la pi grande precisione possibile, osservando
una regolare distanza fra una percussione e un'altra, e man-
tenendo cos quel perfetto sincronismo che nella natura
del ritmo. Per l'esattezza dobbiamo, per, far notare che
piedi e metri non sempre sono termini equivalenti; difatti
l'equivalenza soltanto esiste, quando trattasi di piedi che
nel verso si misurano separatamcnte, come per esempio: il
dattilo, lo spondeo; mentre non c' alcuna equivalenza quando
trattasi di piedi che si misurano a dipodie, quali il giambo,
il trocheo; giacch l'unit di misura data, non dai singoli
piedi, ma dalle dipodie. (Cfr. 56).
NoTA. -Anche nella musica, che anticamente fu connessa con
la poesia, si ha, com' noto, una rni>mra chiamata comunemente
battuta, la quale serve a dividere il tempo, inteso in. _quell'anda.-
-H-
mento simmetrico, che viene applicato a tale arte. Come i cultori
di musica sanno, il tempo ha due sorta di battute: battute con
movimento pari e battute con movimento dispari. I movimenti
della battuta vengono regolati col piede e con la mano. I tempi
con movimento pari sono quelli nei quali la battuta divisa in
due, quattro e sei movimenti; i tempi con movimento dispari sono
quelli le cui battute si dividono in tre movimenti; e cio, due in
battere e l'altro in levare. In musica la breve (v) pu essere rap.
presentata con la croma (n. e la lunga(-) pu essere rappresen
tata con la semiminima ( ). Ci posto, nella musica, cos come
nella poesia, si verifica il rapporto di equivalenza di varie specie
di battute: infatti la semibreve ha la rlurata di tempo uguale a
due minime; la minima ha la durata di tempo uguale a due semi-
minime; la semimiuima ha la rlurata di tempo uguale a due crome;
e via dicendo.
Varie specie di piedi.
51. - I piedi che noi chiamiamo fondamentali o ritmici,
sono i sette seguenti:
l. ..!. .__ v, dattilo ( = dito), formato di una sillaba lunga
,
e di due sillabe brtvi, l'ictus sulla prima sillaba:
2) .1. v, trocheo o coreo ( = corsivo), formato_ dL &!1-
laba lunga e di una breve, con l'ictus suiia prima sillaba: arma;
3) v .1., giambJ ( = pulsante), formato di una sillaba breve
,
e di una lunga, con I'ict7ts sulla seconda sillaba: meae;
4) v v..!.' anapesto o antidattilo (=ribattuto), formato
di due sillabe brevi ed una lunga, con l'ictus sulla terza sil-
laba: elephas;
5) ..!. v v v, peone ( = peana), form::tto di una sillaba
lunga e di tre brevi, con l'ictus sulla prima sillaba: Jrnbrosiii;
6) v v..!. _
1
ionico a minore (=della Ionia), formato eli
due sillabe brevi e di due lunghe, con l'ictus sulla terza sil
laba:
7) ..!. _ v v, ionico a maiore ( = della Ionia), formatn
di due sillabe lunghe e due brevi, con l'ictus sulla prima sil
l.J ba: provincia.
- 45 --
Dall'accoppiamento di questi piedi o dalle loro trasforma-
zioni (giacch sappiamo - 50 -- che una sillaba lunga si
pu sciogliere in due brevi e due sillabe brevi si possono cam-
biare in una lunga), si originano altri piedi, che noi chiamiamo
impropri, e, precisamente, i seguenti:
l) .1. _, spondeo ( = per libazione), formato di due sii-
' labe lunghe, con l'ictus sulla prima sillaba: cliimns;
2) J., v v, tribraco ( = tre brevi), formato di tre sillabe
urevi, con l'ictus sulla prima (ma quando sostituisce il giambo
l'ictus cade &ulla seconda sillaba): mfnimiis;
3) v J., v v, proceleusmatico (=affrettato), formato di
lJ. uattro sillabe brevi con l'ictus d'ordinario sulla seconda:
animiUa. Questo piede celerissimo da solo usato raramente
in sostituzione del dattilo e dell'anapesto;
4) .1. v_, eretico(= [ballo] cretese) o anfimacro (=[due
lunghe] attorno), formato di nna breve in mezzo a due lunghe;
l'ictus sulla prima sillaba:
5) v..!._, bacchio (=[canto] bacchico), formato di una
breve e due lunghe, con l'ictus snlla seconda sillaba: avari;
6) .1. _v, antibacchio (= [crmto] bacchico inverso) for-
mato di due sillabe lunghe ed una breve, con l'ictus sulla
prima sillaba: fc mater;
7) ..!. v v_, coriambo (= coreo +giambo) formato di
due sillabe brevi in mezzo a due lunghe, con l'ictus sulla prima
sillaba: Virgo poti-tu;
8) - ..L _, molosso ( = nome di regione o di popolo), for-
mato di tre dlabe lunghe, con l'ictus sulla seconda sillaba:
divillo
'
9) v .1. v, anfibraco ( = [due brevi] attorno), formato di
una sillaba lunga in mezzo a due brevi, con l'ictus sulla se-
conda: librnti.
-46-
10) v 2 _v, antispasto (=[le brevi] in parti opposte),
formato di due sillabe lunghe in mezzo a due sillabe brevi,
con l'ictus sulla seconda sillaba: inarscit;
11) v_.!-_, epltrito (=[breve] dopo tre [lunghe]), for-
mato di una sillaba breve e di tre lunghe, con l'ictus sulla
seconda perabsurde.
E poich la sillaba breve pu cambiare di posto, si hanno
altre tre forme di questo piede: epitrito 2 (- u __ ), epitrito 3
(_ -v -), epitrito 40 (_ - - v).
NOTA. -a) Il pirrichio, formato di due sillabe brevi (v v) da
alcuni viene considerato come il pi breve piede del verso latino,
da altri non affatto considerato un piede, data la rapidit di
tale battuta.
b) In quanto al peone, quello che abbiamo segnato il peone
primo; ma si hanno il p eone secondo (v 2 v v), il peone terzo (v v ..1 v);
il peone quarto (v v v 2).
c) Come si dir pi innanzi, alcuni piedi, quali ad esempio, il
giambo, il trocheo, sono adoperati per lo pi in coppie, ed allora
possono chiamarsi anche: diambo (v- v-), ditrocheo (-v- v),
e per analogia, una coppia di spondei si dice dispondeo (- - - - ).
52. - I piedi vanno distinti secondo il tempo o balluta
e secondo il numero delle sillabe.
a) secondo il tempo i piedi sono di:
2 tempi Pirrichio uv
TTibTaco .J..,vv
3 tempi Giambo v...!
TToclleo o coreo ...!v
l
Dattilo _!v v
l
Anapesto v v....!
4 tempi ( Anfibraco v_!_v
~
Proceleusmatico 1.......1J.-.vv
Spondeo '
l
Oretico o anfimacro
_!v_
l
Bacchio ',J _!_-
6 tempi
(
A ntibacch io .....!.-v
P eone lO J..vvv
P eone 20: u _]_v v; peone 3: v v_!_ v; peone 40: vvv2
Ionico a minore
Ionico a maiore
-47-
G tempi Molosso .
7 tempi
l
Antispasto
Coriambo
Epitrito }O
20
30
40
v_!_- v
_!_uv-
u_! __
- u--
-- u-
--- \,_..1
b) Secondo il numero delle snlabe piedi sono di:
l
spondeo
2 sillabe tr_ocheo
g ~ a m b o
pinicllio
. l
3 Sillabe 1
l
4 sillabe
dattilo
anapesto
tribmco
eretico
bacchio
antibacchio
anfibraco
molo.sso
peone l
0
, 2, 3, 1 ~
ionico a minore
ionico a maiore
proceleusmatico
coriambo
antispasto
di ambo, dilrocheo, dispo n d,'tJ
epitteto 1, 2, 3o, 4o.
53. - Quando il piede completo, dicesi acatalettico; ma
se manca di una o pi sillabe, dicesi catalettico o tronco. I piedi
tronchi generalmente si trovano in fine del verso, e la sillaba
e le sillabe mancanti vengono sostituite da pausa della voce.
Non sempre il piede tronco in fine verso; talora, come nel
pentametro elegiaco (cfr. 73), pu trovarsi anche nel corpo
del verso,
-48-
54. - Dicesi piede discendente quello che comincia con
l'arsi, come il dattilo (2 v v), il trocheo (2 v), ecc ... ; dicesi
piede ascendente quello che comincia con la tesi, come il giambo
(v 2), l'ionico a minore {v v 2 -),ecc.
55. - Dicesi piede pari quello, in cui il tempo (o durata)
dell'arsi equivale al tempo (o durata) della tesi.
ESEMPIO: il dattilo (_!_v v). In questo piede l'arsi, essendo
costituita di due tempi, equivale alla tesi, che parimente
di due tempi. Lo stesso dicasi dello spondeo (_!_ -), dell'ana-
pesto {v v _!_), ecc.
Dicesi piede impari quello, in cui il tempo (o durata) del-
l'arsi non uguale al tempo (o durata) della tesi.
ESEMPIO: il giambo (v_!_), il trocheo (-L v), ecc.
56. - Dei numerosi piedi che abbiamo esaminati, alcuni
fanno metro di per s, sono, cio, delle misure ritmiche (ad
esempio: il dattilo e lo spondeo); ma altri piedi, essendo molto
brevi, come ad esempio, i giambi, i trochei - e talora anche
gli anapesti -, si uniscono insieme a due a due: la nuova
unit, ritmica si chiama dipodia (giambica, trocaica, anapestica).
Qun.ndo si uniscono tre piedi uguali si ha una tripodia
(giambica, trocaica, ecc.).
Se si uniscono quattro piedi eguali si ha una tetrapodia;
se cinque piedi eguali, si ha una pentapodia; se sei piedi eguali,
un;1 csapodia, ecc.
Qu:tndo si uniscono due piedi di tre tempi, si forma un
metro o una dipodia di sei tempi; se si uniscono due piedi
di quattro tempi, si ha una dipodia di otto tempi.
Il primo dei due piedi trochei che si uniscono in una pi
ampia unit ritmica, fa come una specie di arsi rispetto al
secondo ehe funge da tesi, e per l'ictus o arsi del primo avr
valore preponderante. Nella dipodia giambica e anapestica
il secondo piede che funge da arsi al primo, e per l'ichll
-49-
del seeondo ha valore preponderante
1
per questa ragione
che modernamente si suole segnare doppia la prima arsi della
dipodia troeaica, mentre nella dipodia giambica va segnata
doppia l'arsi del seeondo piede.
EcoJ come alcuni moderni studiosi segnano una dipodia
trocaica, una dipodia giambica e una dipodia anapestica:
a) ...!!..u...!.u;
b) v..!.v.!!_;
c) v v _L v v..!!..
57. - I metri giambici e trocaici, usati in serie continua,
generano un ritmo molto rapido. I poeti ad attenuarlo tro-
varono l'espediente di allungare una delle sillabe brevi del
metro: la. sillaba allungata che prende il posto della breve
si disse lunga irrazionale, ed il piede eos allungato (es.: _ 2 :
in eambio di v _!_), si disse piede irrazionale.
Tali piedi irrazionali, specie se trattasi di giambi e di
troehei, sono chiaramente individuabili per la posizione di-
versa, su cui l'ictus si posa.
1
Alcuni studioei di metrica latini> !Cfr. W'eil, Rlass, ecc.) eostengono che lo
percussioni forti nelle dipodie c&dt>no nel primo piede delle
dipodie.
(. - 1'. DI MAliZO. mtfr(M lnlitatJ.
TAVOI,A RIASSUNTIVA DEL PIEDE
Piedi ritmici
\
__!v v
..Lv
v ..L
t
. ..Lv v v
uv....!..-
_,__uu
dattilo
trocheo
giambo
anapesto
peone 1
ionico a minon
ionico a maioro
\
' spondeo
:Z =: v tribraco
v v v proceleusrnatieo
__t_ v_ eretico
v __t__ bacchio
antibacch' o
Piedi impropri _ coriambo
_ __t__ molosso
v __t_ v anfibraco
v ..L _ v antispasto
v..L-- epitrito 1
v v pirrichio
1
2 tempi { Pirrichio
3 tempi { Tibraco Giambo - Trocheo
. 1 Dattilo - Anapesto - Anfibmco
4 tempi 1 Procelcnsmatico -
eretico o anfimacro - BacchiO
Piedi ' Piedi distinti 5 tempi An ti bacchio - Peone l
0
2, 3",
condo iJ tempo l 4o
a minore - Ionico a ma-
G tempi iore. - Molosqo - -
eonarnbo
7 tempi 1 Epiuito 1, 2, 30, 4o
. )Bpondeo . Trocheo - Giaml1o -
l
2 sillabe Pirrichio
Dattilo - Anapesto - Tr!braco. -
3 sillabe eretico - Bacchio - Ant1bacchw
Piedi distinti se- . Anfibraco - Molosso
condoi.lnumero' Peone
1
,, 2o, 3o, 4o. Ionico a
delle Sillabe ) minore . Ionico a mai ore -
4 sillabe
. Antispasto - Ep1tnto l
0
, 2 ,
3, 4
Piedi distinti se- ) Pari: __t_ v v, ecc.
condo il posto Dispari: __t_ v, ecc.
P1ed1 m prosecu- Tetrapodia
. . . )
zione Pentapodia
E,;apodia, ecc.
-51-
C.APO II.
VERSO - CESURA - SCANSIONE E LETTURA METRICA
VERSI IN SERIE INDETERMINATA
ED IN STROFICA
.A.) Del verso.
58. - Un determinato numero di piedi (o dipodie) uguali
o diversi tra loro, governati dall'ictus e disposti sopra una
riga di scrittura, formano un'unit ritmica, che prende il
nome di membro (x(;)ov).
Quando due o pi membri sono congiunti secondo una
legge di simmetria e di eufonia rispondente a determinate
esigenze artistiche, si ha il cosiddetto periodo ritmico, cui si
d il nome di verso. (La parola verso deriva dalla voce latina
versus, da vmtere =voltare, andare a capo. In latino la parola
significa: riga, linea di scrittura, terminata la quale, bisogna
voltare, per andare a capo. Il vocabolo greco corrispondente
(ntxoc;, che vale propriamente: riga). I membri, o xwrx,
possono essere uniti nel verso in vari modi. Quando si veri-
fica la continuit melodica dei membri e tra di essi non c'
l'iato, n la sillaba ancipite, si ha la sinafia =
coninnctio); in tal caso il verso sinarteto, cio, connesHo.
59. - Secondo il genere dei piedi il verso latino pu essere
puro ed impuro.
puro quando consta di una sola specie di piedi; es.: o
dattili, o spondei, o trochei, ecc .
impuro, quando consta di piedi di genere differente.
I versi impuri possono essere: versi composti o asinarteti,
misti o logaedi.
60. Si dicono versi composti o asinarteti quelli che con-
st.ano di singoli membri puri, ma di ritmo diverso, essendo
formati di piedi di genere differente.
-52-
Ci spieghiamo con un esempio.
Supponiamo di avere una serie dattilica (genero pari);
orbene, per formare il verso occorre aggiungere una serie
giambica (genere dispari): ne deriva che i due membri (ossia
xw,i<), costituenti il verso, risultano di piedi di tempo diffe-
rente:
-.!vv, ....!.vv, v2, v_!_
Tali versi composti sono anche dett,i asinarteti (dal greco
a privativo e aJvi<p-r&Ul =congiungo), cio, sconnessi, perch
in verit i due membri che li formano rimangono distinti,
come se fossero serie ritmiche, indipendenti, ammettendosi
tra i due membri l'iato e la sillaba ancipite.
61. - Quando nello stesso membro c' mescolanza di
piedi di genere pari e di genere dispari, jJ verso che ne risulta,
si dice misto o logaedo. Esempio: dattili e trochei nel medesimo
membro o xwov: _,_v v, _,_ v, _,_v v Il ...
Tali sono il verso asclepiadeo, il saffico, l'alcaico, usati
da Orazio. Si chiamano logacdi in quanto codesta disposizione
di piedi sta fra il canto ed il rccitativo (Myo;).
NoTA. -Tali versi logaedi hanno per lo pi una combinazione
di ritmi <<1lllhici e trocaici, ossia sono metri coria.mbici,
per cui alcuni studiosi banno negato J'e,;J-
sten za dei versi l ogacJ ici.
62. - stato detto (cfr. 50) che metro uguale a piede;
c p;r, quando noi, ad esempio, diciamo esametro, vogliamo
sicrnificare un verso composto di sei metri o piedi, cio, una
quando diciamo trimctro, vogliamo significare una
tripodia: qua,ndo diciamo tetramctro, una tetrapodia, ecc.
Si badi, per, che nei metri giambici e trocaici, invece, la
parola metro, eguale ad una dipodia; quindi: trimctro.
1Jico va inteso nel senso di tre dipodie giambiche, ossia, se1
giambi (senario); trirntiro trocaico significa tre dipodie di
trochei, ossia sci trochci.
-53-
63. - Il verso dattilico, se consta di dattili; trocaico,
se consta di trochei; giambico, se di giambi; scazonte, se trat-
tasi di un trimetro giambico avente uno spondeo in fine (sca-
zonte =zoppicante: ossia, giambo zoppo); eretico, se consta
di eretici, ecc.
64. - Quando un verso, in rapporto ai piedi di cui si
compone, presenta l'ultimo piede completo, in modo da fare
apparire come se il ritmo continuasse, si dice acatalettico.
Quando, viceversa, l'ultimo p i e dc manca di qualche ele-
mento di cui dovrebbe comporsi, ossia, quando incompleto, il
verso dicesi catalettico (dal greco xa-ra!Ul =cesso, finisco). In tal
caso, se all'ultimo piede rimane una sola sillaba, il verso cata-
lettico in syllabam, (la sillaba mancante di un tempo suole essere
segnata col segno /\)
1
; se all'ultimo piede restano invece due
sillabe, il verso catalettico in dissyllabam, (si adopera lo stesso
segno con pi una lineetta 7\ se mancano due tempi).
Quando l'ultima dipodia mancante di un intero piede,
il verso detto brachicatalettico.
Talora il verso pu avere una sillaba di pi nell'ultimo
piede; tale sillaba finale, che una vocale, si amalgama, per
elisione, con la prima sillaba, anche essa vocale, del verso
seguente: d'ordinario la sillaba soprabbondanie la encli-
tica que. Tale verso detto ipermetro (da tmp e [L-rpov), cio,
che va al di l del metro; ma tale terminologia inesatta,
perch l'elisione fa rientrare il verso nella giusta misura. Un
verso ipermetro detto ipercatalcttico.
Codesti versi ipermetri sono frequenti ne1l'Encide (cfr. En.,
l. I, 448; I. II, 745; l. V, 573; l. VI, 602, ecc.). Eecone un esempio:
Omnia Mercurio similis voccmque colorem(quc)
Et crines ...
Infine dicesi verso dicatalettico, se il piede rimane incom-
pleto alla fine di ciascuno emistichio (ossia, mezza riga), di
l Quale l'origine di questo segno! noto che Aristide Quintilliano fu il
primo a chiamare ELf.tf.tOC tale segno, che in seguito s'indic con un , lettera
iniziale di e:f.tf.tOC: poi si pose sull'iniziale una piccola linea orizzontale ad indi
e.are la mancanza di d ne tempi (n: p 6o6EcrL).
-M-
cui il verso si compone: tale, per esempio, il pentametro,
che, come si dir innanzi (cfr. 73), ha due piedi incompleti;
dicesi verso tt"icatalettico, se il piede resta incompleto alla fine
di tre membri. .Alcuni studiosi chiamano procatalettico il verso
che ha un piede incompleto nella cesura (Cfr. 65, nel quale
si parla della cesura).
Non bisogna pensare che ciascuna parola del verso debba
fare piede da s; al contrario, i poeti, convinti che un verso,
formato di parole, ciascuna delle quali fa piede da s, riesca
slegato e bruttissimo, se ne sono sempre ben guardati, ed hanno
avuto l'accortezza di disporre le parole nel verso in modo che
la fine di un piede e l'inizio del piede seguente cadano possibil-
mente nella stessa parola. Si osservi, ad esempio, il verso
che segue:
' m: l l
NOTA. - l) Il verso latino, come stato detto da principio,
non tien conto del numero delle sillabe, ma solo dei tempi, e nel
computarli si deve tener presente che la sillaba lunga vale sempre
due tempi.
2) II verso latino termina sempre con parola intera.
3) La quantit della vocale finale del verso spesso contraria
alla normale misura del piede cui essa appartiene; essa consi-
derata ancipite, giacch, nella recitazione, potr essere compensata
da una pi lunga pausa della voce.
4) Quando la fine di un membro, o xwov, corrisponde alla
fine del piede, ed il membro seguente coincide con l'inizio di altro
piede, tra i membri si ha dieresi; se, al _contrario i due
s'incontrano nello stesso piede, tra una sillaba e l altra d1 detto
piede, si ha un taglio, cio, la cesnra '
B) Cesura - Dieresi.
65. -Non possibile pronunziare di un solo fiato un vers.o
di una certa lunghezza, per necessario, durante la rem-
----
1 Negli schemi metrici che seguiranno, da p. 57 poi, per la. ce
sura dalla dieresi, indicheremo la prima con una_ sola la
con due lineette verticali. Non si confondano gli schemt metr"c' con_ gli r1
portati dei scanditi; giacch In questi ultimi una lineetta vertiCale d1stmgue
n piede, la doppia linea verticale distingue la cesura.
-55-
tazione, fare qualche pausa ritmica al posto stabilito. Tale
pausa che divide il piede in due parti, dicesi cesura (caesura,
taglio: da caedere, tagliare), vale a dire, spezzatura o taglio
del piede.
La cesura pu essere maschile e femminile.
maschile quando si verifica dopo l'arsi del piede, ossia
dopo un tempo forte:
l l li Troiae qui primus ab oris
femminile quando si verifica dopo la tesi del piede, ossia
dopo la sillaba che trovasi in posizione debole:
l / jj l cum frondesque dolique
Quando la cesura non taglia il piede in due parti, ma cade
alla fine di esso, si ha la dieresi.
ESEMPIO:
j l l /1 ile ca pella e
In questo esametro virgiliano la cesura cade alla fine del
quarto piede, ed detta dieresi bucolica. (Cfr. 71, d).
Tanto la cesura che la dieresi dividono il verso in parti,
che sono delle serie ritmiche, alle quali, come si detto, si
d il nome di membri. (Cfr. 58).
C) Scansione e lettura metrica.
66. - Scdndere o scandire un verso significa distinguerlo,
sezionarlo nei suoi piedi costitutivi. Da notare che l'espres-
sione latina: << scandere versus )) fu usata dagli antichi gram-
matici, nel senso di dividere i versi nei loro piedi, come sa-
lendo (scandere = salire, montare) per i gradi della loro misura.
Per leggere metricamente un verso bisogna fare risaltare
le arsi di ciascun piede di cui il verso si compone, facendone
sentire la cesura o la dieresi; e per ottenere ci occorre accen-
tare fortemente con la voce le sillabe sulle quali cadono le
-56-
usi, e fare una pausa prolungata della voce al posto dove
s'incontrano cesura e dieresi. Diamo un esempio:
Qu:s l j Il l Il l
Codesto verso va letto come se esso fosse scritto su due
righe, calcando la voce sulle sillabe accentate:
Quis fuit h6rrend6s
prirm(s qui pr6tulit nses?
In tal modo, nella lettura, rimangono staccati i due membri
dell'esametro, divisi da cesura semiquinaria. (Cfr. 71, a).
D) Versi in serie indeterminata ed in composi-
strofca.
67. - Un verso pu usars1 m serie indeterminata, quale,
ad es., l'esametro (cfr. l'Eneide di Virgilio, il De Rerum Na-
tura di Lucrezio, le di Ovidio, ecc.), ed allora
dicesi sciolto o continuato.
La composizione poetica, nella quale ripetuto uno stesso
genere di versi, in serie indeterminata, come nei nostri ende-
casillabi sciolti, dicesi monastica (f1.6voc; =solo e a't"(xoc; = verso).
68. - Due o pi versi della stessa specie metrica o di
1 peci e differente, disposti e raggruppati in pi ampia unit
ritmica, ripetuta a piacimento, formano un sistema.
Il sistema distico (da lc;, due volte e a't"(xoc;, verso) se
consta di due versi; tristico, se consta di tre versi; tetmstico,
l:le consta di quattro versi. Il sistema distico, tristico, tetra-
stico chiamato anche strofa La strofa, dunque,
un sistema metrico ripetuto a piacimento, una o pi volte;
ci va inteso nei riguardi soltanto della poesia latina, giacch
presso i Greci, come noto, nella lirica dorica e nei canti
corali della tragedia, le strofe di numero pari (ad esempio:
la seconda, la quarta, ecc.) sono dette antistrofe.
NoTA. - Tra i sistf'mi distici sono assai noti il distico elegiaco
l'epodo. Il distico degiaco consta di due versi: un esametro (cfr. 69)
e un pentametro (cfr. 73). Fu detto elegiaco, perch fu usato molto
-57-
nella elegia, la quale, se nella sua origine presso i Greci fu un com-
ponimento di contenuto indeterminato e vario, fini poi per diven-
tare un canto tenero e soave, come appare dai poeti elegiaci latini
Catullo, Tibullo, Ovidio e Properzio.
L'aggruppamento di due versi disuguali dal punto di vista
metrico, generalmente uno lungo ed uno breve, formano l'epodo.
Sono famosi gli epodi del poeta Orazio. In verit Orazio chiam
codesti componimenti poetici col nome di giambi; il nome di epodo
fu loro dato dai grammatici posteriori.
VI.:RSO
Tavola riassuntiva del periodo ritmico o verso.
Secondo la composizione
dei piedi ..
Secondo il numero degli
identici piedi in prost>-
cuzione ...
Secondo la specie dei piedi
Secondo l'ultimo piede
(del verso)
( puro o semplice
) composto o agi.
l
impuro _narteto
misto o logaedo
l
l
dimetro, trimetro, tetrame.
tro, pentarnetro, esametro
dattilico, eretico, giambic
trocaico, scazonte, ecc.
acatalettico,
catalettico in svllaham, in
lis!!vllab!lm, "
ipercatalett.ico o ipermetro,
dicatalettico, tricatalettico,
procatalettico.
CAPO III.
VARIE SPECIE DI METRI METRI DATTILICI
I metri dattilici comprendono: l'esametro duttilico, il pen-
tamctro elegiaco, I' adonio, l'archilocheo, l' alcrnanio.
A) Esametro dattilico.
69. L'esametro (dal greco sei e fl.hpov, misura)
un verso di sei piedi, detto dattilico, perch risulta di dattili
consecutivi.
-58-
Questo metro fu usato dapprima da Omero (e da Esiodo)
nella poesia epica, e perci fu detto: versus eroicus; fu anche
usato dalla Pizia nei responsi, e fu detto: versus pythius. In
tempi posteriori fu usato con molta fortuna nella poesia di-
dattica e nella bucolica, ed in seguito nella satirica, e persino
nella drammatica. Fu usato felicemente da non pochi poeti
latini, ora da solo, in serie indeterminata, ora in accoppia-
mento con altri metri, ed in particolare con il pentametro,
di cui parleremo pi sotto a proposito del distico elegiaco.
Lo schema dell'esametro puro il seguente:
_! vv' _! uv' _! uv' _l v v ' _!. vv ' _! vv
Ma poich due sillabe brevi, come abbiamo accennato
nel 50, equivalgono quantitativamente ad una lunga, ed
una sillaba lunga equivale a due sillabe brevi, questo verso
ammette che si sostituisca una sillaba lunga a due sillabe
brevi, ma non ammette il contrario: non ammette, cio, che
l'arsi lunga venga soluta in due brevi; ne consegue che il
dattilo si pu sostituire con lo spondeo. Tale sostituzione
che si verifica in tutti i piedi, tranne che nel quinto, voluta
da ragioni di variet e di armonia, in quanto l'esametro dat-
tilico puro, usato ininterrottamente, riuscirebbe monotono.
L'ultimo piede dell'esametro sempre di due sillabe; e siccome
generalmente gli antichi poeti non tenevano conto della quan-
tit dell'ultima sillaba del verso, da tale usanza consegue che
il sesto piede pu essere un trocheo (_t_ v) o uno spondeo (_t__);
alcuni studiosi moderni sostengono, peraltro, che l'ultimo
piede dell'esametro dattilico sia un dattilo catalettico in dis-
syllabam e non affatto un trocheo o spondeo; come che sia,
bene ricordare che alla fine del verso non ammessa l'eli-
sione o l'apostrofo.
Lo schema completo dell'esametro il seguente:
__! vv ' _L uv ' _! vv l _L vv ' _l vu , _L v
70. - Si detto che il quinto piede generalmente un
dattilo; talvolta anche il quinto piede pu essere uno spondeo,
,, l
-59-
ma in questo caso nel quarto piede suole esserci un dattilo:
codesto esametro dicesi spondaico, e termina, il pi delle volte,
con un quadrisillabo o con un trisillabo.
Ecco lo schema dell'esametro spondaico:
J.. uv ' _l vv ' _L ~ ' _L v v , _L - ' _L v
Raramente l'esametro spondaico manca del dattilo nel
quarto piede: ce ne offre degli esemplari Virgilio, il quale,
mosso da intendimenti artistici, volendo riprodurre l'armonia
imitativa, us lo spondeo non solo nel quinto, ma anche nel
quarto piede.
Eccone un esempio:
A t li l vJs ocre l Js ln l tJ du l cilnt ar l gknto
71. - L'esametro dattilico ha quattro cesure: la semi-
quinaria o pentemimera, la semisettenaria o eftemimera, la
trocaica, la bucolica.
a) La cesura semiquinaria o pentemimera quella che
cade dopo il quinto mezzo piede, ossia, dopo l'arsi o sillaba
lunga del terzo piede:
Essa assai frequente, perch divide l'esametro in due
parti che, pur distinte armonicamente tra di loro, conser-
vano speciale cadenza. Si badi che nel contare i mezzi piedi
occorre tener presente che due sillabe brevi, nelle quali
stata sciolta una sillaba lunga, fanno mezzo piede.
ESEMPI:
' l ' l. Il ' ' '- Ltibitiir et ptil lnt ti l misso l sangnln' vnae
, l ' l, , , ,
Felix qui pot1'i it Il re l rum co l gnosc'r' l caustis.
b) La cesura semisettenaria o eftemirnera quella che
cade dopo il settimo mezzo piede, ossia, dopo l'arsi del quarto
piede:
J \..tV 1 J VV' _!uv' J ! =-::: ' _l uv '
-60-
ESEMPIO:
Urbem l qurfm di l cant Ilo l mdm, Il Meli l b""ie, pu l
Questa cesura. semisettenaria, essendo un po' lontana,
comunemente suole essere preceduta da un'altra cesura. se-
condaria, detta semiternaria o tritemimera, che cade dopo
l'arsi del secondo piede:
_..! vv ' .J_ l , _! vv ' _! l ::::::;:; ' _! vv ' _L
ESEMPI:
_!_ r
Astni te l nent Il cae l zkste 80 llilm Il
r r
for l ma(que de l iJ,um
_!_ r
Infan l dum
Il
r r
1
r r
re 1 gina iu 1 bes Il reno vare do ltorem.
c) La cesura trocaica quella che cade dopo la prima
sillaba breve del terzo piede, che sar necessariamente un
dattilo. detta del terzo trocheo, perch cadendo nel mezzo
della tesi del terzo piede, si forma in tal modo un trocheo:
_! vv ' _! ' _!.. v l v ' _L ' _! vv ' _!
ESEMPIO:
virbii: li ve l nit N ii l talis ad [ ariis
d) La cesura bucolica, cos detta, perch usata dai poeti
bucolici greci, cade alla fine del quarto piede. chiamata
anche dieresi bucolica, perch coincide con la fine di un piede:
vale a dire, il quarto piede termina con parola completa:
ESE\IPIO:
' r
!te me 1 ae 1 dtim te 1 1ix pect'ts, Il fte ca 1 pkua:e
NoTA. -La sospensione della. voce, voluta. dalla cesura., spesso
fa. s che non si verifichi la sinalefe (cio l'elisione di vocale o dit.
-61-
tongo dinanzi ad altra vocale), e che si ammetta l'iato, quando
capiti immediatamente dopo la eesura. Esempio:
Quid struitf aut qua spefinimica in gente moratur r
1
Alcuni suggerimenti
per ben comporre degli esametri latini.
72. - Perch un esametro riesca metricamente perfetto,
occorre badare principalmente alle sospensioni nel mezzo
del verso, ossia alle cesure; alla proporzione dei dattili e degli
spondei nei primi quattro piedi; agli ultimi due piedi finali
che chiudono il verso; alla legatura dei piedi ed alla variet
delle parole nei riguardi delle sillabe onde risultano formate.
Diciamo qualche cosa su ciascuno dei punti suddetti.
l) Sebbene la cesura semiquinaria sia la pi frequente,
perch, come si detto (cfr. 71, a), divide l'esametro in
due parti distinte ed armoniche, tuttavia, per motivi di va-
riet, gradita all'orecchio, occorre far uso, negli esametri in
l Il Carducci, avendo perfezionato l tentativi di L. Battista Albertl, del Dati,
di Claudio Tolomel, e l'antico metodo del Chiabrera, del Rolli e del Fantoni, ripro
dusse nella poesia italiana metri e sistemi greci e latini, servendosi di metri ac
centuativi; raggiunse lo scopo per mezzo di speciali accorgimenti, quali, ad esempio,
facendo corrispondere alle arsi le sillabe accentate, e alle tesi le sillabe disaccentato
o atone, servendosi di speciali cesure, ecc.; in tal modo riuscl ad ottenere dei metri
italiani riproducenti un ritmo in certo qual modo simile a quello del corrispondente
metro latino. Riprodusse l'esametro latino in vari modi, e cio:
l) con un settenario pimw, seguito da un novenario:
Sognai, placide cose Il del miei novelli anni sognai ;
2) con un piano, seguito da un ottonario:
.Miste le bionde spighe Il strappa. anche i grappoli ve n! i :
3) con un senario piano, seguito da. un nnvenario:
E !"ombra. dell'ala. il che gelida. gelida. avanza ;
() con un quinario piano, r-eguito da. un novenario, distinti da cesura:
lnvecchian iv! K ne l'ombra l superstiti al rombo :
6) con un quinario piano Reguito da un decasillabo, dlstlnti da cesura:
E molli d'auree U Kinestre al paravano l colli.
-62-
serie, anche della cesura semisettenaria e delle altre sospen-
sioni, giacch una sequela di esametri aventi la sola cesura
semiquinaria, finirebbe col generare monotonia.
2) Per quanto riguarda l'uso dei dattili e degli spondei
nei primi quattro piedi, bisogna che ci sia, dal punto di vista
della ricercatezza, una giudiziosa variet, tenendo presente che
la poesia latina, come non comporta il largo uso di dattili
nello stesso esametro (sono piuttosto rari presso i poeti dell'et
classica gli esametri composti di piedi tutti dattili, e sono
tollerati soltanto per motivi di armonia imitativa, giacch
quanto pi numerosi sono i dattili, tanto pi agitato risulta
il ritmo), cos non ama eccessivamente gli esametri formati
con piedi, tutti spondei:tanto vero che questi ultimi esemplari
sono piuttosto di scarso numero e sono stati ammessi dai
poeti, in massima parte, per motivi artistici, specie se si vuole
esprimere calma e solennit, giacch quanto pi numerosi
sono gli spondei, tanto pi lento risulta il ritmo (cfr. Virgilio,
Eneide: l. II, v. 251, 256; l. III, v. 538; l. V, v. 351, 559; l. VIII,
v. 552, ecc.) 1.
3) Per chiudere bene un esametro, occorre fare uso,
dal punto di vista della ricercatezza, di un bisillabo finale,
preceduto da un polisillabo, e questo, a sua volta, preceduto,
possibilmente da un monosillabo o da un bisillabo; ad es.:
Caelo nitidissimo alto>> (Ovidio); << in contraria versos
(Ovidio).
Quando l'esametro finisce con un trisillabo, e questo
preceduto da una parola lunga, i piedi risultano legati, come
nell'ovidiano: lacrimosa minzstri )),
Le chiuse monosillabiche, frequenti nella poesia arcaica,
come quella nella quale l'esametro in formazione metrica, non
aveva raggiunto il pieno sviluppo, non mancano nella poesia
classica; ma tali chiuse monosillabiche sono, in massima
1
Cfr. la prefazione al vol. II dell'Eneide, con note d! e Rlll:ctfnl,
riveduta da h. Ramorino, Zanlcbelll, 1922.
-63 -
parte, ad effetto, cio, mirano al raggiungimento di una fi.
nalit artistica, come, ad esempio, il famoso esametro vir-
giliano: ... procumbit lwmi bos ))' nel quale il monosillabo
finale d la sensazione della caduta d eli 'animale. J_,e chiuse
con due monosillabi, dci quali il primo costituisce l'arsi del
sesto piede (cfr. il verso 370 delle Georgiche: At Boreae de
parte trucis cum fulminat, et cum >>),sono ammesse raramente dai
poeti dell'et classica, mentre nella poesia arcaica sono frequenti.
Gli esametri che terminano con parola assai lunga, in
modo che questa formi gli ultimi piedi del nrso, non man-
cano nella poesia classica; ma tali chiuse, frequenti nella
poesia arcaica, mirano manifestamente al conseguimento di
finalit artistiche e sono da considerare, in massima parte,
chiuse ad effetto; come l'oraziano: Divisit mediurn fortis-
sima Tyndaridarum >> (Satire, l. I, v. 100). Il pentasillabo
finale mira, manifestamente, al raggiungimcnto di un deter-
minato effetto. Gli esametri che terminano con forme del
verbo esse, specie con la 3
11
persona sing. del presente indica-
tivo, sono frequentiss:mi nella poesia arcaica, ma di tali esem-
plari non scarseggia, in verit, neanche la poesia classica.
Tali chiuse riescono alquanto sgradite all'orecchio, e per,
dal punto di vista della ricercatezza, sono da evitare.
4) I piedi costituenti l'esametro bene siano, il pi
possibile, legati fra di loro: un esametro, e in generale un
qualsiasi verso, che risultasse composto di parole, formanti
ciascuna di esse un piede a s, riuscirebbe sgraditissimo, per
non dire, orribile. Parimenti brutto riesce il verso composto
di monosillabi o di bisillabi.
Si conclude affermando che la giudiziosa variet di parole,
formate di una o di pi sillabe, come serve ai fini della lega-
tura dei piedi, cos riesce atta alla formazione di versi metri-
camente buoni.
Ricordiamo, da ultimo, che la legge d'eufonia non ammette
il ritorno troppo frequente in uno stesso verso, della mede-
sima lettera, come, ad esempio, l'enniano: O Ti te tute Tati
tibi tanta tyrartne tulisti)) (Ann., 113).
-64-
B) Pentametro elegiaco.
73. - Pentarnetro (dal greco 7tvTE:, cinque, e [J.'-r O'l,
misura) significa: di cinque misure o piedi "i in realt questo
verso consta non di cinque, ma di sei piedi, giacch esso non
che un esametro dattilico dicatalettico (due volte catalettico),
cio, con due piedi, il terzo e l'ultimo, catalettici in syllabarn
1
Risulta composto di due emistichi; nel primo ci sono due
dattili, sostituibili con due spandei, e una sillaba lunga, la
quale l'arsi del terzo piede catalettico (in essa cade la ce-
sura"); il secondo emistichio composto di una dipodia dat-
tilica, non sostituibile, ed una sillaba ancipite. Ordinaria-
mente tra la fine del primo emistichio e l'inizio del secondo
non sono ammessi n l'iato n l'elisione.
Lo schema del pentametro elegiaco il seguente:
_!.vv' ..!..'-'v' _!'Il ...!...v.._,, _!_vu, ':!!..
Eccone degli esempi:
_! , , , , , ,
l mits dd l insi l gnis 1/ urbfs ab l arte vi l ros
Scribre l tknta l bam 1/ vkrbd soiZhta rno l dis
Questo metro non fu mai usato da solo, ma in aggruppa-
mento con l'esametro dattilico nel distico elegiaco. Esso fu
usato da Callino, da Archiloco e da molti altri fra i lirici greci,
e non trascurato, certamente, dai poeti elegiaci latini, Catullo,
Tibullo, Properzio ed Ovidio.
l Si diede a questo verso il nome di pentametro, perch anticamente si pens
che l due mezzi piedi, il 3 e il G costituissero un solo piede, che con l quattro rl
mancnti. formava nn verso di cinque piedi. Questa opinione oggi appare falsa,
giacch i due piedi cato.lettici sono da considerare come due piedi veri e propr l
e alle loro tesi mancanti, si supplisce con due pause nella lettura.
J La cesura del pentametro, coincidendo sempre con la fine del piede, pro
p mmente una dieresi.
-65-
Il pentametro che ha lo spondeo nel secondo piede riesce
armonioso e ben accetto, come il tibulliano:
O) Adonio.
74. - Pare che il nome di questo metro derivi dal ritor-
nello (;) -r?iv usato nei cantici destinati ad Adone.
Consta di una dipodia dattilica catalettica in dissyllabam
2
Orazio l'usa come chiusura del sistema saffico minore
8
,
SOHE111A:
.1 vv, _!v
ESEMPIO:
, ,
Trruit l urbm '
D) Archilocheo.
75. - Questo metro che alcuni chiamano trimetro archi-
locheo, ebbe nome dal poeta greco Archiloco di Paro, fiorito
nella 2a met del sec. VII a. Or., creatore della poesia giam-
bica ed introduttore del distico elegiaco nell'epigramma.
1
Il Carducci riprodusse il pentametro nella poesia italiana nei modi seguenti:
a) con due seilenari piani:
Volano ucce.li strani Il per il purpureo cielo :
b) con un quinario piano, seguito da un senario sdrucciolo:
Gli arbusti lieti il di lor rame giovani :
c) con un senario piano, seguito da un 8'1ttnario piano:
Filtra con la pioggia Il per rossa stanche. Io tremo :
) con un sdrucciolo, seg-uito da un settenario piano:
Ccr;lo pnrpureo Il nunzio di primavera .
2
Alcuni studio! sostengono che questo metro sia logaedico. formato, cio,
di una <Upo<tia dalti/olrocaica. Il Weil d'altra parte nella sua nuova teoria, ri-
pudia tutti i metri logaedici, che riduce in dimetri, trimetri e tetrametri coriam
bici, eliminando i dattili.
3
Lo t;tampini affaccia l'ipotesi che il sistema saffico minore sia tristico e so
>petta che questo metro che in Orazio chiude la strofe saffica minore, appartenga
al terzo verso di detto sistema.
t li Carducci riprodusse nella poesia italiana questo metro con un quinario
ldano: A ve .:\i aria .
5. - E. DI _i\1 -\.HZO, Pro.sodia e rnetrica latina.
-66-
Consta di un trimetro dattilico catalettico in syllabam (tre dattili
di cui l'ultimo catalettico in syllabam). '
SCHEMA:
_l vu , ....1 vu , ~ A
ESEMPIO;
, l , . l ,
Li ber ii t H ippoly tfim
E) Alcmanio.
76. - Fu cos chiamato dal poeta greco AJcmane, .:be
fior nella 2a met del secolo VII (650) a. Or.
Consta di un tetrametro dattilico catalettico in dissyllabam:
esso uguale agli ultimi quattro piedi dell'esametro e per
fu detto eroico acefalo. '
II 3 dattilo, d'ordinario, puro; rarissimamente ammette
la sostituzione spondaica. Orazio l'us non da solo ma in
. '
accoppiamento con altri metri, cio, con l'esametro dattilico
nel sistema alcmanio,,(nel dodicesimo epodo) e nella Ja 7a ~
2sa ode dl pri{o liro dei carmi. ' '
SCHEMA:
_! vv ' _L uv ' _!_ vv ' ....! :; 1\
ESEMPIO:
_l v , ,
.A 11t EphC l silm bima 1 risve Co 1 rinthi.
ESERCIZIO 14.
Si scompongano nei loro piedi costitutivi i seguenti esametri,
segnandone le diverse cesure e leggendo metricamente ciascun
verso.
Talia iactanti stridens Aquilone procella
velum adversa ferit, fluctusque ad sidera tollit.
Franguntur remi; tum prora avertit et undis
dat latus; insequitur cumulo praeruptus aquae mons.
(Virg. En., l. l, 102 e seg).
-67-
Interea magno misceri murmure pontum
emissamque biemem sensit Neptunus et imis
stagna refusa vadis graviter commotus, et alto
prospiciens, summa placidum caput extulit unda.
(Virg., En., l. l, 123 e seg.).
Regia Solis erat sublimibus alta columnis,
clara micante auro flammasque imitante pyropo,
cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,
argenti bifores radiabant lumine valvae.
(Ov., Metam01josi, l. II, v. l e seg.).
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
Sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.
Poena metusque aberant, nec verba minacia fixo
Aere legebantur, nec supplex turba timebat
Iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.
N ondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem,
Montibus in liquidas pinus descenderat undas,
Nullaque mortales praeter sua litora norant.
Nondum praecipites cingebant oppida fossae;
Non tuba directi, non aeris cornua flexi,
Non galeae, non ensis erant: sine militis usu
Mollia securae peragebant otia gentes.
(Ovidio, Metamorfosi, l. I, vv. 89-100).
Atque ait: < O toto quaesitae virginis orbe
Et frugum genetrix, immensos siste labores,
Neve tibi fidae violenta irascere terrae!
Terra nibil meruit, patuitque invita rapinae.
Nec sum pro patria supplex: bue bospita veni,
Pisa mihi patria est, et ab Elide ducimus ortus.
Sicaniam peregrina colo; sed gratior omni
Haec mihi terra solo est: hos nunc Arethusa penates,
Hanc ha beo sedem, quam tu, mitissima, serva ... n.
(Ovidio, Metamorfosi, l. V, vv. 489-497).
-68-
Ultima restabat; quam toto corpore mater,
Tota veste tegens: << U naro minimamque relinque!
De multis minimam posco , clamavit, et unam .
Dumque rogat, pro qua rogat, occidit. Orba resedit
Exanimes inter natos natasque virumque,
Diriguitque malis: nullos movet aura capillos,
In vultu color est sine sanguine, lumina maestis
Stant immota genis, nihil est in imagine vivum.
Ipsa quoque interius cum duro lingua palato
Congelat, et venae desistunt posse moveri;
N cc flecti cervi x n cc bracchi a reddere motus
Nec pes ire potest: intra quoque viscera saxum est.
(Ovidio, Metamorfosi, l. VI, vv. 298-309).
ESERCIZIO 15.
Si scompongano nei loro piedi costitutivi i seguenti penta
metri, distinguendone i due emistichi, segnandone la cesura,
e leggendo metricamente ciascun verso:
l\Iaius erat nostris viribus illud onus.
Quotque aderant vates, rebar adesse deos.
Nomine sub nostro fabula nulla fuit.
Abstulerat decies praemia victor equus.
Ipsa multa tuli non leviora fuga.
Tristia, quo possum, carmine fata levo.
Sic tamen absumo decipioque diem.
Protinus ut moriar, non ero, terra, tuus.
(Ovidio, Trist., l. IV).
Et teneat culti iugera multa soli.
Martia cui somnos classica pulsa fugent.
Duro meus adsiduo luceat igne focus.
Rusticus et facili grandia poma manu.
Praebeat et pieno pinguia musta lacu.
-69-
Seu vetus in trivio florida serta lapis.
Libatum agricolae ponitur ante deo.
Spicca, quae templi pendeat ante fores.
Terreat ut saeva falce Priapus aves.
Custodes, fertis munera vestra, Lares.
Nunc agna exigui est hostia parva soli.
Clamet io, messes et bona vina date.
Nec semper longae deditus esse viae.
Arboris ad rivos praetereuntis aquae.
(Tibullo, Elegie, I).
ESERCIZIO 16.
Si scompongano nei loro piedi costituti t'i i distici seguenti,
segnando le diverse cesure di ciascun verso, e leggendo i versi
metricamente:
Quam bene Saturno vivebant rege, priusquam
. ' Tellus in longas est patefacta v1as.
Nondum caeruleas pinus contempserat undas,
Effusum ventis praebueratque sinum,
N ec vagus ignotis repetens compendia terris
Presserat cxterna navita merce ratem.
Illo non validus subiit iuga tempore taurus,
Non domito frenos ore momordit equus,
Non domus ulla fores habuit, non fixus in :...61'18,
Qui regeret certis finibus arva, lapis;
Ipsae mella dabant quercus, ultroque ferebant
Obvia seCLuis ubera Iactis oves.
Non acies, nor1 ira fuit, non bella, nec enscm
Immiti sauus duxerat arte faber.
Nunc Iove sub domino caedes et vulnera semper,
Nunc mare, nunc leti mille repente viae.
(Ti bullo, Elegie, l. I, 3, v v. 35-50).
-70-
Luctus erat, falsaeque patres in cnmme caedis,
Haesissetque animis forsitan illa fides:
Sed Proculus Longa veniebat Iulius Alba,
Lunaque fulgebat, nec facis usus erat,
Cum subito motu saepes tremuere sinistrae:
Rettulit ille gradus, horrueruntque comae.
Pulcher et humano maior trabeaque decorus
Romulus in media visus adesse via
Et dixisse simul Pro h i be lugere Quirites,
Neo violent lacrimis numina nostra suis:
Tura ferant placentque novnm pia turba Quirinum,
Et patrias artes militiamque colant .
Iussit et in tenues oculis evanuit auras;
Convocat hic populos iussaque verba refert.
Tempia deo fiunt: collis quoque dictus ab ilio est,
Et referunt certi sacra paterna dies.
(Ovidio, Fasti, II, vv. 497-512).
Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus?
Carmine currentes ille tenebat aquas.
Saepe sequens agnam lnpus est hac voce retentus,
Saepe avidum fugiens restitit agna lupum.
Saepe canes leporesque umbra cubuere sub una,
Et stetit in saxo }'roxima cerva leae.
Et sine lite loquax cum Palladis alite cornix
Sedit, et accipitri iuncta columba fuit.
Cynthia saepe tuis fertur, vocalis Arion,
Tamquam fraternis obstupuisse modis.
Nomen Arionium Siculas impleverat urbes,
Captaque erat lyricis Ausonis ora sonis.
(Ovidio, Fasti, II, vv. 83-94),
-71-
Et gelidus fons est: et nulla salubrior unda:
Et molli circum gramine terra viret:
Et ramis arcent soles frondentibus alni:
Et levis in nullo gratior aura loco est:
Et medio Titan nunc ardentissimus axe est:
Exustusque gravi sidere fervet ager.
(A. Navagerio, Lusus, vv. 1-6).
Sci te puer, mellite puer, nate uni ce, dormi;
Claude, tenelle, oculos, conde, tenelle, genas.
Ipse so por: Non condis, ai t, non claudis ocellos? n
En cubat ante tuos Luscula
1
lassa pedes.
Languidulos, bene habet, conditque et claudit ocellos
Lucius, et roseo est fusus in ore sopor.
Aura, veni, foveasque meum placidissima natum.
An strepitant frondesT Tam levis aura venit;
Scite puer, mellite puer, nate unice, dormi;
Aura favet flatu, mater amata sinu.
(G. Pontano, De Am,_ Con., n. V).
CAPO IV.
METRI GIAMBICI
I metri giambici comprendono: il senario giambico o tri-
metro giambico, il trimetro giambico catalettico, il trimetro giam-
bico ipponatteo, il dimetro giambico ipercatalettico.
A) Senario giambico (o trimetro giambico).
77. - Il senario giambico (versus senarius) pu essere
puro ed impuro.
l Il nome della c a ~ n e t t a .
-72-
SEN ARIO GIAMBICO PURO.
Consta di sei giambi. E poich nella serie dei giambi l'unit
di misura la dipodia (come si detto al 56) che occorre
far sentire nella scansione, ne consegue che i sei piedi giambi
vengono aggruppati in tre misure (tripodia giambica acata-
lettica), ed per questo che il suddetto metro prende il nome
di trimetro ('rpl[Le-rpov) giambico acatalettico t.
Eccone lo schema:
v!_, v!!_, v/.!..,
,
v-"
Questo verso ammette la cesura semiquinaria o pente-
mimera, cio, dopo il quinto mezzo piede (ossia, dopo la breve
del terzo giambo):
ESEMPIO:
, " , , , ,
Phiiselus il/ te l quem rid J tis, hospites
L'ultima sillaba pu essere anche breve, come in questo
altro esempio:
, " , " l ,
ait fisJse l nadum celerr'imus
NOTA. - ammessa, sebbene meno spesso, la cesura semisette.
naria, cio, dopo il settimo mezzo piede (ossia, dopo la breve del
quarto piede):
,
v.!_u!!...., v.!._vl!!_, -v.!...v'::!
SENARIO GIAMBICO JMPUIW.
78. - Il senario giambico puro usato dai poeti non con
eccessiva frequenza; assai pi frequenti sono gli altri schemi
1
Alcuni studiosi distinguono per altro li senario giambico dal trimetro giam-
bico; considerano quest'ultimo come un verso composto di tre metri, ed il senario
che sostengono esser derivato daJ come un verso che va misurato non in
rapporto ai metri, ma bensl ai piedi di cui si compone, ciascuno dei quali conserva
l a sua posizione !orte.
l
-73-
da esso derivati, e che hanno dato or1gme al senario giam-
bico impuro. Gli che il versus senarius risulta fra i pi mo-
bili versi della poesia latina, per il semplice fatto che in tutti
i suoi piedi giambi, eccetto l'ultimo, una sillaba breve pu
essere sostituita da una lunga irrazionale (cfr. 57), ed una
lunga, anche irrazionale, pu essere sciolta successivamente
in due brevi: ne deriva variet e mobilit schematica. Codesto
senario giambico che noi chiamiamo impnro, fu usato, come
noto, dai poeti tragici e comici, specie nella poesia recitativa,
e da Orazio negli Epodi; fu usato anche nelle favole di Fedro.
In forza di detta sostituzione, in questo verso impuro, oltre
al giambo, sono ammessi altri piedi, considerati come aventi
la medesima quantit del giambo (ma non hanno la stessa
quantit!), e cio:
l) v ..1., giambo puro;
2) _ ..t, giambo con la lunga irrazionale;
3) v, giambo con la lunga della posizione forte
sciolta in due brevi (v vv; sistema tribraco);
4) _ giambo con la lunga di posizione forte sciolta
in due brevi, e con la breve di posizione debole allungata
irrazionalmente (: vv; sistema dattilo);
5) v v ..1., giambo con la breve di posizione debole allun-
gata irrazionalmente e la irrazionale di poi sciolta in due
brevi (vv -i sistema anapesto);
6) v v .v v, giambo con la breve di posizione debole
allungata irrazionalmente e le due sillabe lunghe sciolte in
qtLtttro brevi sistema proceleusrnatico).
Riepilogando: al posto del giambo possiamo trovare i se-
guenti piedi:
1
, spondeo, con l'ictns nella 2a sillaba,
\ = : v tribraco, con l'ictus nella za sillaba,
'--' .!.. , _ .v v dattilo, con l'ictus nella za sillaba,
l v v .!.. anapesto, con l'ictus nella 3a sillaba,
\ u ._, .v v proceleusmatico, con l'ictus nella 3a sillaba.
-74-
Lo schema del senario giambico impuro pu, dunque, sin-
tetizzarsi come segue:
A A A ...!-.. ...!-..
v..__
~
yv
~ ,
v v v v v v '=!.'-:!_ v_,
'=!.'-:!_ v
~
=
'
.__....
' = '
.__....
'
La cesura la pentemimera, cio, dopo la posizione debole
del 5 piede.
ScHEMI DI SENARIO GIAMBICO IMPURO USATI DA FEDRO.
79. - Il senario giambico nei suoi svariati schemi fu lar-
gamente usato dal favolista Fedro, il quale, se modific varia-
mente i primi cinque piedi, conserv quasi sempre il giambo
nel sesto piede.
Elenchiamo gli schemi pi frequentemente usati da questo
poeta, cominciando dallo schema del senario puro.
l) Schema: puro
v.!... v!!_
,
,
'
v-'-- v- v.!...
v'='
2) Schema: tribraco
,
, ,
n
vvv v...!..,v t
,
v'='
v-,
"
'-'-
3) Schema: spondaico
, , ,
_!!
,
,
v"='
4) Schema: anapestico
vu...J.., ~ ~ , ~ J . , ~ . ! ! . . , vv..lt
5) Schema: dattilico
- .Lv v ~
v-, -
6) Schema: proceleusmatico
\...v,J.; v
NOTA. - a) Non si confonda questo specchietto con l'altro di
cui al 78; occorre por mente alle varie sostituzioni relative alle
-75-
aedi; cosl, per es., Fedro suole introdurre il tribraco nella 2a, 3
e 4" sede; lo spondeo nelle prime 5 sedi; l'anapesto nella l a e 5'
sede (il Poeta non tollera due anapesti di seguito); il dattilo in-
trodotto nelle prime 3 sedi; il proceleusmatico per lo pi in l a sede
(generalmente il piede consta di due parole, delle quali, una costi-
tuisce l'arsi del piede e l'altra parola la tesi); talora il proceleu-
smatico trovasi anche nella 3"' e nella 5 sede.
b) Le varie sostituzioni usate da Fedro, son sottoposte gene-
ralmente alle leggi seguenti:
l. il giambo trovasi sempre, come si detto, nella sesta sede;
e poich l'ultima sillaba del verso ancipite, si pu avere il pir-
richio (v JJ) invece del giambo;
2) il giambo pu trovarsi in tutte le sedi, ma pi di sovente
nelle sedi pari (2"' e 4");
3. le varie sostituzioni si verificano con pi frequenza, nelle
prime quattro sedi, nelle quali, oltre al giambo, si possono trovare
il tribraco, lo spondeo, l'anapesto, il dattilo;
4. nella quinta sede si incontrano lo spondeo e l'anapesto;
di rado il dattilo, rarissimamente il proceleusmatico, mai il tribraco.
In quanto alla cesura, Fedro ammette generalmente quella del
senario puro, cio, la pentemimera; talora usa anche la eftemimera.
Esempio di scansione:
-, ,
, , , ,
.Aes6pus auc l t6r guam miiteri l iim ripprit,
, , , , , ,
Hiinc ego poli l vi Il versibus l sniirls
l " , , , "
Duplex libil l li Il doll est quod l risum mclvt
, , , " , ,
Et guod pruden l ti IJ titiim con l slli6 mont.
B) T1imetro giambico irnpuro catalettico.
80. - Questo metro fu usato da Archiloco, famoso giam-
bografo greco. Consta di tre dipodie giambiche, l'ultima delle
quali catalettica. Si tenga presente, per, che il secondo piede
della terza dipodia mancante della prima sillaba, la quale
viene sostituita da una pausa di tempo. In compenso di tale
mancanza, la penultima sillaba del verso, che la seconda
del quinto giambo si considera come equivalente a tre tempi,
anzich a due tempi. Codesto prolungamento si suole indicare
-76-
col segno L. (il puntino serve ad indicare la mancanza della
sillaba). Nelle sedi dispari il giambo pu essere sostituito dallo
spondeo; ma il quinto piede di rado ammette tale sostituzione.
Questo verso ammette la cesura pentemimera. Orazio l'usa
in accoppiamento con l'archilocheo maggiore.
SCHE:IiA:
" 'd.
ESEMPIO:
, , , ,
Triihunt que sic l ciis l mii chinae l
0) Trimetro giambico ipponatteo.
81. - Il trimetro giambico ipponatteo, detto anche verso
coliambo o scazonte, composto di cinque giambi ed uno spon-
deo all'ultimo piede del verso. Lo spondeo, facendo variare
il regolare ritmo, genera quasi un urto improvviso, cos da
sembrare che il verso zoppichi; da ci deriva il nome di sr;a-
zonte, dato a questo metro, cio, zoppicante; ovvero coliambo,
cio, giambo zoppo (cfr. 63).
Nel primo e terzo piede invece del giambo pu trovarsi
Io spondeo: talora le arsi dei primi quattro piedi possono
sciogliersi in due sillabe brevi. La cesura la semiquinaria
o pentemimera, come nel giambo puro.
Eccone lo schema completo:
ESEMPIO:
r " l l "
v_!_t
Hom(o) kst vena lstus l Jt dtcdx l et Jrbanus
Misir Cat-az Ile 1 1 inipthe.
D) Dimetro giambico ipercatalettico.
82. - Questo metro ebbe il nome da Alceo di Mitilene,
che visse nella 2
8
met del secolo VII e all'inizio del secolo VI
a. Cr. formato di quattro giambi, pi una sillaba finale (spondeo
-7-
nelle sedi impari). detto anche alcaico enneasillabo: fu usato
da Orazio quale terzo verso della strofe alcaica.
SCHEMA:
ESE:'tiPIO:
Silv;e l liib6 l rantks l getil. l que
NoTA. -Secondo altri l'enneasillabo alcaico sarebbe una tetra-
podia trocaica con lo spondeo irrazionale alla seconda sede e con
anacrusi
1
a principio, secondo il seguente schema:
ESERCIZIO 17.
Si scompongano nei loro piedi costitutivi i seguenti senari
giambici puri, segnandone le cesure, e leggendo metricamente
ciascun verso:
Phaselus ille, quem videtis, hospites,
Ait fuisse navium celerrimus,
Neque ullius natantis impetum trabis
Nequisse praeterire, sive palmulis
Opus foret volare sive linteo.
Et hoc negat minacis Adriatici
Negare litus insulasve Cycladas
Rhodumque nobilem horridamque Thraciam
Propontida trucemve Ponticum sinum,
Ubi iste post phaselus antea fuit
Cornata silva: nam Cytorio in iugo
Loquente saepe sibilum edidit coma.
Amastri Pontica et Cytore buxifer,
Tibi haec fuisse et esse cognitissima
Ait phaselus: ultima ex origine
Tuo stetisse dicit in ca.cumine,
Tuo imbuisse palmulas in aequore,
Et inde tot per impotentia freta
1
L'anacrusi una. sillaba lunga fuori battuta e che dii. inizio a.! verso.
-78-
Herum tulisse, laeva sive dextera
Vocaret aura, sive utrumque Iuppiter
Simul secundus incidisset in pedem;
Neque ulla vota litoralibus deis
Sibi esse facta, curo veniret a marei ( = mari)
Novissime hunc ad usque limpidum lacum.
Sed haec prius fuere: nunc recondita
Senet quiete seque dedicat tibi,
Gemelle Castor et gemelle Castoris.
(Catullo, IV).
Quid est, Catulle1 quid moraris emoriT
Sella in curuli struma Nonius sedet,
Per consulatum peierat Vatinius:
Quid est, Catulle? quid moraris emoriY
(Catullo, LII ).
ESERCIZIO 18.
Si scompongano nei loro piedi costitutivi i seguenti senari
giambici impuri, segnandone le cesure, e leggendo metricamente
ciascun verso:
Ad rivum eundem lupus et agnus venerant
Si ti com pulsi; superior sta ba t lupus
Longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
Latro incitatus iurgii causam intulit.
Cur, inquit, turbulentam fecisti mihi
Aquam bibenti? Laniger contra timens:
Qui possum, quaeso, facere, quod quereris, lupe!
A te decurrit ad meos haustus liquor.
Repulsus ille veritatis viribus:
Ante hos sex menses male, ait, dixisti mibi.
Respondit agnus: Equidem natus non eram.
Pater hercle tuus, ille inquit, male dixit mibi.
Atque ita correptum Iacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula,
Qui fictis causis innocentes opprimunt.
(Fedro, Favole, l. l, l).
-79-
Peras imposuit Iuppiter nobis duas:
Propriis repletam vitiis post tergum dedit
Alienis ante pectus suspendit gravem. '
Hac re videre nostra mala non possumus;
Alii simul delinquunt, censores sumus.
(Fedro, Favolll, l. 4, IO).
Nunc, nequis erret vestrum, paucis in viam
Deducam, si quidem operam dare promittitis ...
Primum mihi Plautus Luxuriae indidit:
Turo hanc mihi gnatam esse voluit Inopiam.
(Plauto, Trinummus, Prolog.).
ESERCIZIO 19.
Si scompongano nei loro piedi costitutivi i seguenti trimetri
giambici_ ipponattei, segnandone le cesure, e leggendo metrica-
mente ctascun verso:
O Funde noster seu Sabine seu Tiburs
'
Fui libenter in tua suburbana
Villa, malamque pectore exspui tussim,
Non immerenti quam mihi meus venter,
Duro sumptuosas appeto, dedit, cenas.
Nam, Sestianus dum volo esse conviva,
Orationem in Antium petitorem
Plenam veneni et pestilentiae Iegi.
Hic me gravedo frigida et frequens tussis
Quassavit usque duro in tuum sinum fugi,
Et me recuravi otioque et urtica.
Quare refectus maximas tibi grates
Ago, meum quod non es ulta peccatum.
Nec deprecor iam, si nefaria scripta
Sesti recepso, quin gravedinem et tussim
Non mihi, sed ipsi Sesti o ferat frigus,
Qui tunc v oca t me, cum malum librnm legi.
(Catullo, XLIV).
-80-
Egnatius, quod candidos habet dentes,
Henidet usque quaque: sei ( = si) ad rei ventum est
Subsellium
1
, cum orator excitat ftetum,
Hcnidet ille: si ad pii rogum fili
Lugetur, orba cum ftet unicum mater,
Henidet ille: quicquid est, ubicumque est,
Quodcumque agit, renidet: bune habct morbum,
N eque elegantem, ut arbitror, n eque urbanum.
Quare monendum te est mihi, bone Egnati.
Si urbanus esses aut Sabinus aut Tibnrs,
Aut parcus Umber aut obesus Etruscus,
Aut Lanuvinus ater atque dentatus,
Aut Transpadanus, ut meos quoque attingam,
Aut quilubet, qui puriter lavit dentes,
Tamen renidere usque quaque te nollem:
Nam risu inepto res ineptior nulla est ...
(Catullo, XXXIX).
c.Aro v.
Jl E T R I T R O C A I C I
I metri trocaici comprendono: il dimetro trocaico catalet-
tico e il verso itifallico.
A) Dimeho trocaico catalettico.
83. - Consta di una tetrapodia trocaica catalettica in syl-
labam, vale a dire: tre t.rocbei ed una sillaba finale. Questo
metro fu usato da Orazio una sola volta, nell'ode 18 del se-
condo libro, in accoppiamento col trimetro giambico catalettico,
nel sistema ipponatteo. Ammette nelle sedi pari lo spondeo,
ma Orazio non usa tale licenza.
1
Se travasi presso lo scanno d! un reQ,
' l
-81-
SCHEMA:
ESEMPIO:
..! ,
At jfds et J Ingeni
B) llifallico.
84. - Questo metro fu cos chiamato, perch in esso erano
composti i cantici destinati alle processioni falliche. Consta
di una tripodia trocaica acatalettica.
SCHEMA:
~ usato in asinarteto, preceduto da un tetrametro dattilico,
dando origine all'archilocheo maggiore (cfr. 96).
CAPO VI.
METRI IJOGAEDICI t
I metri logaedici comprendono: il gliconeo secondo, il fera-
crateo secondo, il priapeo, l'asclepiadeo minore, l'asclepiadeo
maggiore, il saffico minore, il saffico maggiore, l'alcaico ende-
casillr'tbo, l'alcaico decasillabo, l'aristofaneo, il faleceo.
A) Gliconeo secondo.
85. - Ebbe il nome o dal comico greco Leucone, o, se-
condo altri, dal greco Glicone, che ne sarebbe stato l'inven-
tore (cfr. Efestionc).
Modernamente si sostiene che la struttura di questo verso
consista in una tetrapodia logaedica catalettica in syllabam con
spondeo o trocheo in prima sede e dattilo alla seconda (ovvero:
l Noi non seguiamo la teoria del Weil, il quale, come si accennato, ripudia
tutti l versi logaedlcl che riduce a. dimetri, trimetri e tetrametri coriamhicl.
6. - E. DJ MARZO, Prosodia e metrica latina.
- 82-
uno spondeo o trocheo base, un dattilo ed una dipodia trocaica
catalettica in syllabam).
Nella prima sede raramente travasi il trocheo.
Orazio l'usa qu,]e primo verso del sistema asclepiadeo
terzo, e quale quarto verso dt-1 sistema asclepiadeo secondo:
presso i Greci Io usarono Saffo e Anacreonte.
SCHEMA:
ESEMPIO:
, , , '
Miles l t duce 1 gesse l rit
B) Ferecrateo (o Ferecrazio) secondo.
86. - Derivato dal gliconeo, a questo eguale, senza
l'ultima sillaba; consta di una tripodia logaedica acatalettica
con spondeo o trocheo in prima sede e dattilo alla seconda; (e
precisamente: uno spondeo o trocheo base, un dattilo, un
trocheo o spondeo). Orazio l'usa in composizione con gliconei
ed asclepiadei.
SCHEMA:
ESEMPIO:
Grato l sub l Jntro
O) Priapeo.
87. - Ebbe il nome, secondo Mario Vittorino, dal fatto
che in tal metro si cantavano le lodi in onore di Priapo. Consta
di due membri, e precisamente, di un gliconeo secondo e di
un ferecrateo secondo, collegati insieme e divisi allo stesso
tempo dalla cesura, che spessissimo anche dieresi. Fu usato
da Catullo.
SCHEMA:
_!_v, -.!v v, _L v'
-v _,
Il _l u'
..!.uv, _J-..J
ESEMPIO:
..!.
,
__!_
eu l pis
, ,
'
o Co IZOniii, qua e
Il
ponte ZUder long o
-83-
D) Asclepiadeo minore.
88. - Fu cos chiamato dal poeta greco Asclepiade di
Samo, che fiori nell'et ellenistica e fu inventore dei due metri
asclepiadei, il minore ed il maggiore. Questo verso composto
di due parti, divise nettamente dalla cesura che, in generale,
anche dieresi; la prima parte la base di un ferecrateo se-
condo (tripodia dattilico-trocaica catalettica in syllabam con
spondeo in prima sede e dattilo in seconda sede); la seconda
parte una tripodia logaedica (un dattilo, seguito da due trochei,
di cui l'ultimo catalettico in syllabam). La cesura, che dieresi,
cade fra le parti componenti, cio, dopo la sesta sillaba. Orazio
us questo verso in composizione monastica, ripetuto in serie
indeterminata; oppure accoppiato con altri versi, nei sistemi
degli asclepiadei 1o, 2o, so.
SCHEMA:
, Il _!uv, _l v,
ESEMPIO:
M l nhs iita l via Il l rtgi l b 1is.
E) Asclepiadeo maggiore.
89. - Differisce dal precedente metro per l'inserzione di
una dipodia dattilica catalettica in syllabam dopo il terzo piede
dell'asclepiadeo minore.
La cesura che del pari dieresi (salvo qualche eccezione),
cade dopo la sesta sillaba; talvolta se ne trova un'altra, dopo
la decima sillaba.
SCHEMA:
.....!. _ , _! v , _!. 1\ , Il _! uv , _! l\ , !1 ....1 v v , _!_ u , 1\
ESEMPJO:
, _!_ , ' , , , ,
Tu ne l quaesie l ris 1\ scir ne l fiis l\ qum mihi l qum ti l bi.
-84-
F) Saffico minore.
90. - Ebbe il nome dalla poetessa Sa:ffo di 1\:litilene, che
vissuta tra la fine del VII sec. e l'inizio del VI secolo a. Cr.,
fu concittadina e contemporanea di Alceo.
Questo verso una pentapodia dattilico-trocaica acatalet-
tica, con il dattilo nella terza sede e lo spondeo nella seconda
(e precisamente: due trochei, il secondo dei quali sostituito
dallo spondeo; un dattilo c due trochei finali). Saffo trascur
la cesura; Orazio non segu una regola determinata, us la
semiquinaria e qualche volta la trocaica, dopo la 6a. sillaba;
adoper assai spesso questo verso, nelle odi, in accoppia-
mento con l'adonio, nel sistema del saffico minore.
SCHEMA:
v ' _l - ' _! l v v ' _l v ' ...!... v
ESEMPIO:
z:rm sa l tL: tr l ris nivis l atque l dlrac
G) Saffico maggime.
91. - l'ampliamento del precedente metro per l'inser-
zione dopo i primi du.e piedi del rnedesirno di una dipodia dat-
tilica catalettica t"n syllabarn. Orazio fu solito far cadere la
cesura, che anche dieresi, il pi delle volte, dopo la terza
arsi ed us una cesura stabile, che anche dieresi, dopo la
dipodia dattilica inserita: us questo verso in accoppiamento
con l'aristofaneo nel sistema del saffico maggiore.
_.!v, _!_, _!_
Il
v v, _!.,
Il
...!..v v, _!v, _!_v
ESEMPIO:
TJ de 1 Js o l rJ,
Il
s.ifba l rin
Il
,
l
, ,
ciir prope res a 1 mando.
H) Alcaico endecasillabo.
92. - Fu cos ehiamato da Alceo di lVIitilene, nobile poeta,
che visse nella 2a met del sec. VII e l'inizio del sec. VI a. Cr.
-85-
Questo metro diviso in due parti da cesura (dieresi) stabile:
la prima consta di tre giambi di cui l'ultimo catalettico in syl-
labam, con la sostituzione della lunga alla breve nel primo e terzo
piede; la seconda di una tripodia dattilico-trocaica catalettica
in syllabam. Orazio us questo metro quale primo e secondo
verso della strofe alcaica.
SCHEMA:
v_!' v . ....!.,
ESK\IPIO:
Vidls l ut alj la Il st nire l candi l dam.
NOTA. - L'alcaico enneasillabo, essendo un metro giambico,
stato elencato al 82: esso non che il dimetTo giambico iper-
catalettico.
l) Alcaico decasillabo.
93. - Consta di una tetrapodia dattilico-trocaica acata-
lettica (e precisamente: due dattili e due trochei); chiude,
quale quarto verso, la strofe alcaica.
SCHEMA:
_..!.vv, _!.v'V, _!.v, _lv
Flilmina l cbnslite l rlnt a l cflto.
L) Aristofaneo.
94. - Fu cos chiamato dal poeta Aristofane. Consta
di una tripodia dattilico-trocaica acatalettica, col dattilo nella
prima sede (e precisamente: un dattilo e due trochei). il
primo verso del sistema saffico maggiore.
SCHEMA:
ESEl\IPIO:
Lidia, J dic per j Jmnis.
-86-
M) Faleco o Endecasillabo.
95. Il faleceo, detto anche endecasillabo perch ri
sulta di undici sillabe, una pentapodia dattilico-trocaica, con
il dattilo nella seconda sede e con la sostituzione dello spondeo
o del giambo al primo trocheo.
Con altre parole lo si pu anche definire cos: il faleceo
un verso di cinque piedi, il secondo dei quali un dattilo e gli
altri quattro trochei; al primo trocheo si pu sostituire lo spondeo
o il giambo.
Questo verso che fu largamente usato da Valeria Catu 1 ,
tutto proprio della poesia piana e delicata. Esso non h.1.
una cesura fissa, ma per lo pi la cesura cade dopo l'arsi del
terzo piede (cesura tritemimera); anche la si trova dopo l'arsi
del secondo e del quarto piede.
Eccone lo schema completo:
..!.lv , , l __ , -VV,- v, _tu, ..!v
ESEMPIO:
PJsser l dkzici l de l me l Ife pu l Jzzae
Qulm plls l ill(a) ocu llis l su l is a l mabtit.
ESERCIZIO 20.
Si scompongano nei loro piedi costitutivi i seguenti versi
falecei, segnandone la cesura, e leggendo metricamente ciascun
verso:
Quoi dono lepidum novum libellum
Arida modo pumice expolitum?
Corneli, tibi: namque tu solebas
meas esse aliquid putare nugas ...
Lugete, o Veneres Cupidinesque,
Et quantum est hominum venustiorum.
(Catullo, I).
-87-
Passer mortuus est meae puellae,
Passer, deliciae meae puellae,
Quem plus illa oculis suis amabat:
Nam mellitus erat suamque norat
Ipsam tam bene quam puella matrem ...
Furi, villula nostra non ad Austri
Flatus opposita est neque ad Favoni
(Catullo, II I).
Nec saevi Boreae aut Apheliotae (=levante),
Verum ad milia quindecim et ducentos.
O ventum horribilem atque pestilentem!
(Catullo, XXVI).
Hesterno, Licini, die otiosi
Multum lusimus in meis tabellis,
Ut convenerat esse delicatos.
Scribens versiculos uterque nostrum
Ludebat numero modo hoc modo illoc,
Reddens mutua
1
per iocum atque vinum.
Atque illinc abii tuo lepore
Incensus, Licini, facetiisque,
Ut nec me miserum cibus iuvaret,
Nec somnus tegeret quiete ocellos,
Sed toto indomitus furore lecto
Versarer, cupiens videre lucem,
Ut tecum loquerer, simulque ut essem.
At defessa labore membra postquam
Semimortua lectulo iacebant.,
Hoc \ iocunde, tibi poema feci,
Ex quo perspiceres meum dolorem.
Nunc audax cave sis, precesque nostras,
Oramus, cave despuas, ocelle,
l Sott. carmina. Redere mataa ha il significato di alterni& canert, a botta
e risposta.
2 Hoc ... poema = questa poesia.
-88-
Ne poenas Nemesis reposcat a te.
Est vehemens dea: laedere hanc caveto.
Risi nescio quem modo e corona,
Qui, cum mirifice Vatiniana
(Catullo, L).
Meus crimina Calvos ( = Calvus) explicasset,
.Admirans ait haec manusque tollens,
<<Dii magni, salaputium disertum!, t.
(Catullo, Llll).
C.APO VII.
METRI ASINARTETI
I metri asinarteti pi usati sono: l'archilocheo maggiore,
il giamblego, J'elegiambo.
A) Archilocheo maggiore.
96. - Si chiam cos da .Archiloco di Paro. Consta di
una tetrapodia dattilica acatalettica, che ha la cesura semi-
quinaria ed il quarto dattilo puro, seguita dal verso itifallico
(cfr. 84) (tripodia trocaica acatalettica). Dieresi fra le parti
componenti. Orazio non l'usa mai solo, ma in accoppiamento
di altri versi, nel sistema dell'archilocheo 4o.
SCHEMA:
...1 vv, _!. vv, ....1. ........,,_,., ....!. '-' ..._,.. Il _! ......... ...!. v, ....!.. v
ESEMPIO:
s61rrtur l Jcris h l ims l gra 1 t a vfc Il t'Jris Jt Fa l v6ni.
1
Senso. Quanta que1to nanetto
-89-
B) Giamhlego.
97. - Consta di due parti distinte, quasi si trattasse di
due versi differenti, e cio, di un dimetro giambico acatalettico
a ritmo ascendente con l'ultima sillaba spesso ancipite quale
finale di verso e l'iato tra essa e la sillaba del verso seguente
(ma Orazio evita sempre l'iato), e di un trimetro dattilico cata-
lettico in syllabam a ritmo discendente, che non ammette la
sostituzione dello spondeo al dattilo. Cesura (dieresi) fra le
parti componenti. Orazio l'usa in accoppiamento con altri
metri nel sistema dell'archilocheo secondo.
SCHEMA:
,
.._,_t, v!!.., .._,.__!,
ESEMPIO:
, , ,
Nivs 1 que de 1 ducunt
" , , ,
lovm; Il nunc mare l nunc slu l ae.
C) Elegiambo.
98. - il giambelego invertito; consta, cio, di 1m tri-
metro dattilico catalettico in syllabam, seguito da nn dimetro
giambico acatalettico.
Questo verso ammette nella sa arsi la sillaba breve e l'iato
fra le due unit componenti. Cesura (dieresi) fra le parti com-
ponenti. Orazio usa questo verso in accoppiamento con altri
metri nel sistema dell'archilocheo terzo nell'epodo XI.
SCHEMA:
...lv v, Il
ESEMPIO:
v_!' v.!!.,.
"
Scribre l vlrsicu !Z6s Il ambi re plr l cussJm l gravi.
-90-
CAPO VIII.
METRI IONICI
Furono detti ionici, perch in uso tra i poeti della Ionia
(specie Anacreonte), nei canti simposiaci ed eroici: tali metri
sono: l'ionico a minore o anacreontica, il galliambo anaclomeno,
il sotadeo.
A) Ionico a minore.
99. - Intorno alla composizione di questo metro gli stu
diosi dissentono tra di loro; alcuni, infatti, sostengono che
esso sia un tetrametro di ionici a minore; altri un decametro
di ionici a minore, ecc.
Sappiamo che presso i Greci il verso ionico comprendeva
dodici tempi primi, cio, una dipodia di ionici a minore; o
al pi, diciotto tempi primi (Alceo e Alcmane), cio, una
tripodia di ionici a minore, secondo i seguenti schemi:
SCHEMA 2:
Ora., presso i poeti latini, Orazio costrusse questo verso
nientemeno che con dieci piedi di ionici a minore (cfr. l. III,
ode 12), secondo il seguente schema:
Un verso cosi lungo non entra in una sola riga, e per
gli studiosi furono concordi nello spezzettarlo, ma non si
accordano affatto nel determinarne le parti. (Cfr. 123).
-!H-
B) Galliambo anaclomeno.
100. - Fu detto galliambo dai Galli, sacerdoti di Cibele,
che adoperavano questo metro nei loro canti. La parola ana-
clomeno (grecamente &vll(xlfLevov), deriva da anclasi (inver-
sione =battuta a contrattempo), ad indicare la variazione
del ritmo che si ba allora quando in un piede si sostituisce
la breve alla lunga e la lunga alla breve. Questo verso una
tetrapodia di ionici a minore catalettica con anclasi, cio, con
interversione ritmica.
Lo schema fondamentale costituito dalla prosecuzione
di quattro ionici a minore, dei quali l'ultimo catalettico:
. _ ~ v _ ! _ _ , vv_!_, '-'v_!__, uv_!/\
Ma per I'anclasi si ba una grande variet scbematica di
questo metro. Il poeta latino Catullo l'us nel carme LXIII;
nel detto carme ci sono almeno tredici schemi differenti, dei
quali il pi usato il seguente:
SCHEMA:
uv-lv .. _u_!_t uv2.v uvv'=!
ESEMPIO:
, , ,
Siiper iilta l vectus Attis Il ce
1
eri ra l te maria
C) Soladeo.
101. - Questo metro ebbe il nome da Sotade, poeta del
III sec. a. Or. un tetrametro di ionici a maiore, senza an-
clasi, con l'ultimo piede catalettico.
SCHEMA:
ESEMPIO:
,
-v ocalia
, ,
quaedam mrhn l rdnt consnd l quacdm.
--
l
2
:;;
-
.,
"'
;:: 3
....
.,
4
5
l
6
c;
7
;.;
E3
.,
'Ei,
8
;::
....
.,
9
l
lO
_])
... "'
..
E-<
11
l
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PRINCI
METRO SCHEMA.
Esametro
- - - -
. . _!..vv, _..!.. vv, _!.vu, _!_vv,
-
_!v v, 2v
Pentametro
- -
l
. .
_]_ vv' _!vv, _L -l..vv,
_!_v v, ':li.
l
Adonio
-
_!v v' _Lv
Archilocheo . ...Lv v, -lv v, ':li./\
Alcmanlo
- -
1\ . .....!uv, _!uv, _!v v'
Trimetro giambico puro
vi..!, acat. (senario) v_!_, v.!!., v.!!.., v2,
"
Trimetro giambico i m-
puro catalettico .
-:;_!.v!!.,
l ' "
- "
V -V-,
Trlmetro giambico lp
ponatteo
--'-
,
l , ,
.
vvv, vvv, V \...IV 1 VVVt
v_!'
Dimetro giamb. fperca
talettico (cfr. alcaico
enneasilla.bo)
- -
v_!' v_!'
v_!, \...l_!'
Dimetro trocaico ca t a-
letti co .
.'!_v, .Jv, !!.... \.J,
-
l Hifallico
. . .J..v, ...!v'
.lv
PALI METRI E LORO STRUTTURA
STRUTTURA
Esapodia dattilica con sostituzioni spondaiche in tutti i piedi,
tranne il quinto. Cesura semiquinaria o semisettenaria o troca.ica,
ecc.
Esapodia dattilica dica.talettica con sostituzioni sponda.iche nel l o
emistichio. Cesura tra i due emistichi.
Dipodia dattilica catalettica in dissyllabam.
Trimetro dattilico catai. in syllabam (t.re daUili, di cui l'ultimo
catai. in syllabam).
Tetrametro dattilico catai. in dissyllabam, con sostituzioni spon-
daicbe in tutti i piedi, eccetto il terzo.
Tripodia giambica acat., con cesura semiquinaria.
Tripodia giambica catai. con sostituzioni spondaiche al giambo nel
1 e 3 piede, raramente nel 5 piede. Cesura semiquinaria.
Cinque giambi +uno spondeo finale (sesto piede). Nel 1 e 3 piede
invece del giambo pu trovarsi lo spondeo, le arsi dei primi 4
piedi possono scio g) iersi in 2 sillabe brevi.
Quattro giambi + una sillaba finale (spondeo nelle sedi impari).
Secondo altri un dimetro trocaico aeat. con anacrusi a principio
e spondeo irrazionale nella 2a sede: _ , __1 v, ..! _ , __1 v, __1
Tetrapodia trocaica catai. in syllabam (tre trocbei ed una sillaba
finale).
Tripodia trocaica acatalettica .
Segue
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PRINCI
METRO SCHEMA
-------1------------------l------------------------
12 Gliconeo secondo
13 Ferecrateo (o Ferecra-
zio) secondo ..1. v , ..1. v v, ..1. v
14 Priapeo ....!.v, _!vv, _!.v,
.J..vv, _.!.V
15 Asclepiadeo minore ..1. _, ..1. v v, ..1. 1\. [[ ..1. v v,
..l v, ..Ji 1\
16 Asclepiadeo magg. ..1. _ , ..1. v v , ..1. A ., Il ..1. v v ,
- l'
....!./\,.1i....!vv,
17 Samco minore ..1. v , ..1. _ , _l l __, ...- , ..1. v , ..1. v
18 Saffico maggiore ..1. v ..1.-, ..1. Il v v, ..1. 1\ ., il
Jvv, _!v, _!v
19 Alcaico endecasillabo :; ..1., v ..1., :; 1\, [[..1. v v, ..1. v, ..1. 1\
20
21
enneaslllabo
decasillabo
22 Aristofaneo (o Ferecra-
Cfr. N. 9
...!..uv, _!uv, Jv, .-lv
zlo primo) ..1. u v , ..1. u , ..1. u
23 Faleceo o endecasillabo --1! '=< , 1 v v , . .1 \ v , ..1. v, ..1. v
PALI METRI E LORO STRUTTURA
STRUTTURA
Tetrapodia logaedica catai. in syllabam con spondeo o trocheo in
l
3
sede e dattilo alla 2
3
sede (ovvero: spondeo o trocheo base,
un dattilo e una dipodia trocaica catai. in syllabam). Raramente
trovasi il trocheo in l" sede.
Tripodia logaedica acatal. con spondeo o trocheo in l" sede e dattilo
in 2" sede (uno spondeo o trocheo base, un dattilo, un trocheo
o spondeo).
Consta di due membri: gliconeo secondo + ferecrateo, divisi da
cesura che spesso dieresi. Cfr. N. 12 e N. 13 .
Tripodia dattilico-trocaica cat. in syll. con spondeo in ]& sede e
dattilo in 2
3
sede + una tripodia logaedica (un dattilo e due
trochei di cui l'ultimo catai. in syll. ). Cesura (dieresi) fra le parti
componenti.
Uguale al precedente + una dipodia dattilica catai. in sylZ. inserita
dopo il 3 piede dell'asclepiadeo minore. Cesura (dieresi) dopo
la 6" sillaba e talora altra cesura (dieresi) dopo la 10
3
sillaba.
Pentapodia dattilico-trocaica acatal. con dattilo in 3'" e lo spondeo
in 2" sede. Cesura semiquinaria; talora trocaica, dopo la 6" sillaba.
Uguale al precedente +una dipodia dattilica ca t. in syll. inserita dopo
il 2 piede del saffico minore. Cesura (dieresi) dopo la 3" arsi e ce-
sura stabile, che anche dieresi, dopo la dipodia dattilica inserita.
Tre giambi di cui l'ultimo catai. in syll., con la sostituzione della
lunga alla breve nel primo e terzo piede + tripodia dattilico-tro-
caica catai. in 1yll. Cesura (dieresi) fra le parti componenti.
Cfr. il N. 9.
Tetrapodia dattilico-trocaica a.catal. (due dattili e due trochei).
Tripodia dattilico-trocaica a.ca.tal. con dattilo in I sede (un dattilo
e due trochei).
Pentapodia dattilico-trocaica. con dattilo in 2 sede e la sostituzione
dello spondeo o del giambo al l
0
trocheo. Cesura dopo l'arsi del
3 piede.
Segue TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PRINCI
METRO SCHE:\IA
---------------------------- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
-.;
=
o
....
"C
-
~
24 Archilocheo maggiore . _t vv, _t vv,:! l , _t v v, li
J.v,2v,....!u
25 Giamblego
v!!.,
,
Il
v......!.' v.,!' v'::!,
.J.uv, ..!.. V V l ~
1\
26 Elegiambo 2 v v' Juv,
~ l \
,
Il
~ ,
V ..l.' v!!..,
w.J.' v'd.
27 Ionico a minore uv..!.-, uv-L-. vv-L-,
vuJ-, v v_!-, vvJ._,
uv......!-. vv_!_, vv...l.-,
uv..!.-
28 Galliambo anaclomeno uv-1- . uv_!-, vv.J..-,
vu_! 1\
29 Sotadeo . . . . . . ...1.-vu, ..1.-vu, ....l-uv,
_t 'd. 1\
PALI METRI E LORO STRUTTURA
STRUTTURA
Tetrapodia dattilica acat. con cesura semiquinaria ed il quarto
dattilo puro +il verso itifallico. (Cfr. N. Il). Dieresi fra le parti
componenti.
Dimetro giambico acat. + trimetro dattilico catai. in syll. Cesura
(dieresi) fra le parti componenti.
Trimetro dattilico catai. in syll. + dimetro giambico acat. Cesura
(dieresi) fra le parti. il giamblego invertito.
Dieci piedi di ionici a minore.
Tetrapodia di ionici a minore catai. con anclasi (- interversione
ritmica).
Tetrametro di ionici a maiore, senza anclasi, con l'ultimo piede
catai.
f. - E. DI :M.lazo, .l'to1odiG e metrica /alina.
P ARTE TER-ZA
METRICA ORAZIANA
CAPO I.
NOZIONI PUELUHNARI
102. - Le forme metriche usate dal poeta. Orazio
1
sono
state variamente elencate ed enunciate dagli studiosi di me-
trica: noi sulle orme di Ettore Stampini (cfr. E. 8TAMPINI
1
La metrica di Orazio, Loescher, 1913), le classificheremo in:
composizioni monastiche, sistemi distici e tetrastici, composi-
zioni ipermetriche.
Per quanto riguarda la spiegazione di composzzwni mona-
stiche e di sistemi, si vedano i paragrafi 67 e 68.
NOTA.
l 03. - Si tenga presente che gli studiosi di metrica oraziana
dissentono nello stabilire se le odi di Orazio siano formate tutte
di strofe tetrastiche: il l\Ieineke, il Lackmann, il Cri'st, il Rasi, ecc.,
ne ammettono per tutte la composizione strofica tetra.stica; mentre
altri, ad es. il Giri, lo Stampini, il Bindi, ecc., sono di parere con-
trario.
Ai discenti che nei loro testi trovino le odi oraziane, tutte, in
composizione strofica. tetrastica, facciamo sapere che la strofa
tetrastica pu essere di quattro tipi:
a) tutti e quattro versi uguali (fJ.Tpov [J.av6xw-ov). Es.: l'ascle
piadeo maggiore e minore che noi consideriamo in composizione
monostica in serie indeterminata;
b) i primi tre versi uguali, l'ultimo differente (fJ.Tpov ll!xwov).
Es.: la strofa sa.ffica minore;
1
In tutto 19; alcuni autori di metrica oraziana. ne elencano 20 (Cfr. Giri, Rasi,
ecc.). Ci dipeso dal fatto che, essendo stata adottata una trattazione, nella quale
i metri delle odi vengono distinti dai metri degli epodi, uno stesso sistema, e pre
elsamente l'alcmanio, ripetuto due volte, ricorrendo esso tanto nelle odi quanto
negli epodi (Odi 7 e 28 del libro I ed Epodo 12).
-102-
c) i due primi versi uguali, gli altri differenti fra loro e dai
primi (flhpov pfzw.ov). Es.: la strofa alcaica;
d) il primo verso uguale al terzo e il secondo al quarto (doppio
distico; fJ.'t'po' S!zwov ). Es.: il sa(Jico maggiore che noi consideriamo
in composizione semplicemente distica e non di doppio distico.
104. TAVOLA DELLE
l
l Trimetri giambici in serie indeterminata
A) Composizioni
2
'
Asclepiadei minori in serie indeterminata
1\'lonostiche g: Asclepiadei maggiori in serie indeterminata
\
B) Sistemi ..
Sistemi
Distici
Sistemi
Tetrastici
4. Sistema Epodico o giambico
5. Sistema Alcmanio
6. Archilocheo l o
7. Archilocheo 2o
8. Archilocheo go
9. Archilocheo 4
IO.
li.
12.
13.
l 14.
\ 15.
l 16.
' l 7.
\ 18.
Pitiambico ]o
Pitiambico 2o
Ipponatteo ..
Asclepiadeo minore go .
Saffico maggiore
Strofa Alcaica
Saffica m in ore
Asclepiadea l"'
Asclepiadea 2a
l
O l Ipermetro ' 19. Periodi decametrici di i onici a minori
lpermetnche 1 j
- Iog-
Prima d'iniziare partitamente lo studio delle forme me-
triche usate da Orazio, ci sembra utile premettere la seguente
tavola schematica delle medesime, onde facilitarne l'appren-
dimento.
FORME METRICHE USATE DA ORAZIO
Epodo 17.
Odi, I, l; III, go; IV, S.
Odi, I, 11, 18; IV, IO.
- Epodo l, 2, g, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IO.
- Odi, I, 7, 28; Epodo 12.
-Odi, IV, 7.
- Epodo Jg.
- Epodo l l.
-Odi, I, 4.
- Epodo 14, 15.
- Epodo 16.
Odi, Il, 18.
Odi, I, g, 1g, 19, g6; III, 9, 15, 19, 24, 25, 28; IV, l, 3.
Odi, I, 8.
Odi, I, 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, g4, g5, 37; II, l, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
14, 15, 17, 19, 20; III, l, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 21, 23, 26, 29; IV, 4,
9, 14, 15.
-Odi, I, 2, 10, 12, 20, 22, 25, 30, 32, 38; II, 2, 4, 6, 8, IO, 16; III, 8,
Il, 14, 18, 20, 22, 27; IV, 2, 6, l l, e il Carmen Saeculare.
Odi, I, 6, 15, 24, 33; II, 12; III, lO, 16; IV, 5, 12.
Odi, I, 5, 14, 21, 2g; III, 7, 13; IV, 1g.
- Odi, III, 12.
-104-
CAPO II.
COlUPOSIZIONI lUONOSTICHE
I.
Trimetri giambici
(in composizione monastica).
105. - Orazio ripete in serie indeterminata il trimetro
giambico, di cui si parlato al 78, e che, come sappiamo,
consta di tre dipodie giambiche impure acatalettiche. Nel primo
piede di ciascuna delle tre dipodie ammessa la lunga irra-
zionale; inoltre pure ammesso, in certe sedi, Io scioglimento
di una lunga (anche irrazionale) in due brevi; in tal modo
il giambo o lo spondeo possono cambiarsi in anapesto, in
tribraco (con l'ictus sulla prima breve rappresentante la lunga),
in dattilo (con l'ictus parimente sulla prima breve), e talora
in proceleusmatico. La cesura la semiquinaria; talvolta tro-
vasi la semisettenaria in unione con la semiquinaria o con
la dieresi dopo il 2o giambo.
SCHEMI VARI:
v...!_' v !!... " l ...!_' v.!.. .,
"
u-!.., v"=!
"
'-1-JI
v.!....., v!!.-,
-, l - ..
v -.l,v
'
'-'' --- .
v!!_,
uu
v.!_,
,
V-,
, " , ,
v ..vu. . v , , '--' .. v -- ........ , ecc.
Orazio us questo metro in composizione monostica una
volta sola, nell'epodo 17.
105-
ESERCIZIO 21.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedt che cornpon
gono i versi seguenti:
Iam iam efficaci do manus scientia,
supplex et ro regna pr Proserpina,
per et Dianae non movenda numina,
per atque libros carminum valentium,
refixa caelo devocare sidera,
Canidia, parco vocibus tandem sacris
citumque retro solve, solve turbinem!
Movit nepotem Telephus Nereium,
in qnem superbus ordinarat agmina
Mysorum et in quem tela acuta torscrat.
Unxere matres lliae addictum feris
alitibus atque canibus homicidam Hectorem,
postquam relictis moenibus rex procidit
heu! pervicacis ad pedes .Achillei.
Saetosa duris exuere pellibus
laboriosi remiges Ulixei
volente Circa membra: tunc mens et sonus
relapsus atque notus in vultus honor.
Dedi satis supcrque poenarum tibi,
amata nautis multum et institoribus.
Fugit iuventas et verecundus color
reliquit ossa pelle amicta lurida,
tuis capillus albus est odoribus,
nullum a labore me reclinat otium;
urget diem nox et dies noctem, neque
levare tenta spiritu praecordia.
Ergo negatum vincor ut credam miser,
Sabella pectus increpare carmina
caputque Marsa dissilire nenia.
Q,uid amplius o mare et terra, ardeo,
quantum neque atro delibutus Hercules
N essi cruore nec Sicana fervida
-106-
virens in Aetna fiamma; tu, donec cinis
iniuriosis aridus ventis ferar,
cales venenis officina Colchicis.
Quae finis aut quod me manet stipendium 1
Effare: iussas cum fide poenas luam,
paratus expiare, seu poposceris
centum iuvencos, sive mendaci lyra
voles sonari. Tu pudica, tu proba
perambulabis astra sidus aureum!. ..
(Orazio, Epodo 17, vv. 1-41).
II.
Asclepiadei minori
(in composizione monastica).
106. - Orazio ripete in serie indeterminata l'asclepiadeo
minore che, come abbiamo visto al paragrafo 88, consta di
due parti divise dalla cesura, che generalmente anche die-
resi: la prima una tripodia dattilico-trocaica catalettica in
syllabam con spondeo in prima sede e dattilo in seconda sede:
la seconda una tripodia logaedica, e precisamente un dattilo,
seguito da due trochei, di cui l'ultimo catalettico in syllabam.
Il ritmo di questo verso, secondo gli studiosi, si avvicina a
quello del pentametro elegiaco (cfr. Rasi).
SCHEMA:
--' ' 1\ Il J., " - , - v '-' ' -- v ' - .' \
Orazio us questo metro in composizione monastica nelle
Odi, I, l; III, 30; IV, 8.
ESERCIZIO 22.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compongono
i 1:ersi seguenti:
Macenas atavis dite rgibus,
o et praesidium et dulce decus meum.
-107-
sunt quos curriculo pulverem Olympicum
collegisse iuvat, metaque fervidis
evitata rotis palmaque nobilis
terrarum dominos evehit ad deos:
bune, si mobilium turba Quiritium
certat tergeminis tollere honoribus,
illum, si proprio condidit horreo
quicquid de Libycis verritur areis.
Gaudentem patrios findere sarculo
agros Attalicis condicionibus
numquam demoveas, ut trabe Cypria
Myrtoum pavidus nauta secet mare.
Luctantem Icariis fluctibus Africum
mercator metuens, otium et oppidi
laudat rura sui; mox reficit rates
quassas, indocilis pauperiem pati.
Est qui nec veteris pocula Massici
nec partem solido demere de die
spernit, nunc viridi membra sub arbuto
stratus, nunc ad aquae lene caput sacrae.
(Garm. I, l, vv. 1-22).
xegi monumntum are pernnius
rgalique situ Pyramidum altius,
quod non imber edax, non Aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam: usqne ego postera
crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cnm tacita virgine pontifex.
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex bumili potens
prjnceps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos. Sume superbiam
-108-
quaesitam meritis et mihi Delphica
lauro cinge volens, Melpomene, comam .
(Orazio, Cmm. III, 30, vv. 116).
III.
Asclepiadei maggiori
(in composizione monastica).
107. - Orazio ripete in serie indeterminata l'asclepiadeo
maggiore che, come sappiamo dal paragrafo 89, uguale al-
l'asclepiadeo minore, con in pi una dipodia dattilica catalet-
tica in syllabam, inserita dopo il terzo piede dell'asclepiadeo
minore. La cesura, che del pari dieresi, cade dopo la sesta
sillaba; talvolta, oltre alla predetta, se ne trova un'altra dopo
la decima sillaba.
SCHEMA:
Questo metro ricorre nel l. I, 11, 18; I. IV, 10 dei Carm.
ESERCIZIO 23.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seguenti:
Tu ne quasieris, scire nefas, qum mihi, qum tibi
finem di dederint, Leucono, nc Babyl6ni6s
temptaris numeros. Ut melius, quicquid eri t, pat!
Seu plures hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum, sapias: vina Iiques et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.
(Orazio, Carm. I, 11, vv. 18).
1
Il Carducci riprodusse nella poesia italiana questo verso per mezzo dell'ende
rasi/labo ldrucciolo:
lieto sorgesse nel mattin del popoli
-109-
Nullam, Vare, sacra vite prius sveris arborm
circa mite solum Tiburis t monia Catili;
siccis omnia nam dura deus proposuit, neque
mordaces aliter diffugiunt sollecitudines.
Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat7
Quis non te potius, Bacche pater, teque, deccns Venus!
Ac nequis modici transil!at munera Liberi,
Centaurea monet cum Lapithis rixa super mero
debellata, monet Sithoniis non levis Euhim,
cum fas atque nefas exiguo fine libidinum
discernunt avidi. Non ego te, candide Bassarcu,
invitum quatiam nec variis obsita frondibus
sub divum rapiam. Saeva tene cum Berecyntio
cornu tympana, quae subsequitur caecus amor sui
et tollens vacuum plus nimio gloria verticem,
arcanique fides prodiga, perlucidior vitro.
(Orazio, Carm. I, 18, vv. J.J6).
CAPO III.
SISTEMI DISTICI
IV.
Sistema epodico.
(sistema giambico).
108. - Questo sistema distico consta di due versi, dei
quali:
a) il primo trimetro giambico impu1'o acatalettico (cfr 78
e 105);
b) il secondo dimetro giambico impuro acatalettico in
forma epodica (due dipodie giambiche acatalettiche impure).
Questo verso non ammette la sostituzione di due sillabe brevi
alla lunga, ma soltanto pu allungare irrazionalmente la sil-
laba, breve del primo piede di ciascuna dipodia.
-IlO-
Cesura semiquinaria generalmente, poche volte la semi
settenaria.
SCHEMA:
v.!.....:.,
\....' = 1 ...!___'
v.!..:., v!!_,, v [ _!_,
,
v!!_,,.._,..!...., v'::!.
"
In questo sistema il Poeta compose i primi 10 epodi che
chiam giambi.
ESERCIZIO 24.
Si continui a segnare le percussioni forti delle dipodie giam
biche che compongono i versi seguenti:
Ibis Liburnis inter alta navium,
amice, pr6pugnacula,
paratus omne Caesaris periculum
subire, Maecenas, tuo:
quid nos, quibus te vita si superstite
iucunda, si contra, gravisT
Utrumne iussi persequemur otium
non dulce, ni tecum simul,
an bune laborem mente latud, decet
qua ferre non molles viros!
Feremus. Et te vel per Alpium iuga
inhospitalem et Caucasum,
vel Occidentis usque ad ultimum sinum
forti sequemur pectore.
Roges, tuum labore quid iuvem meo,
imbellis ac firmus parumT
- 111-
Comes, minore sum futurus in metu,
qui maior absentes habet,
ut assidens implumibus pullis avis
serpentium allapsus timet
magis relictis, non, ut adsit, auxili
latura plus praesentibus.
(Orazio, Epodo l, vv. 1-22).
Quo, quo scelsti ruitis? aut cnr dexteris
aptantur nses conditi?
Parumne campis atque Neptuno super
fusum est Latini sanguinisT
N o n ut superbas invidae Carthaginis
Romanus arces ureret,
intactus aut Britannus ut descenderet
Sacra catenatus via,
sed ut secundum vota Parthorurn sua
urbs haec periret dextera.
Neque hic lupis mos nec fuit leonibus,
umquam, nisi in dispar feris.
Furorne caecus an rapit vis acrior
an culpa? Responsum date!
Tacent, et ora pallor albus inficit,
mentesque perculsae stupent ...
1
(Orazio, Epodo 7, vv. 1-16).
1
Il Carducci (nelle Odi barbare) riproduce sistema cosi: Il primo
con un entlecasillabo sdrucciolo, ed il secondo verso con un settenario sdrucciolo:
Dimmi: percb sotto Il fiammante
gemiti
man<:J.!i Il mare la gi l q n al. canti, o LI dia,
tra lnr quel pini cantano! .
(CARDUCCI, Ruit Rora),
- ll2-
V.
Sistema alcmanio
(sistema dattilico puro).
109. Questo sistema distico consta di due versi, dei
quali:
a) il primo un esametro dattilico (cfr 69): esapodia
dattilica con sostituzioni spondaiche in tutti i piedi, eccetto
il quinto; cesura semiquinara, meno comune la settenaria.,
rara la trocaica;
b) il secondo un tetrametro dattilico catalettico in dis-
syllabam (verso alcmanio, detto anche eroico acefalo; cfr. 76).
Eccezionalmente il 3 dattilo ammette la sostituzione spon-
daica.
ScHEMA:
-v
Orazio us questo sistema in Carm., l. I, 7, 28, e nell'epodo 12.
ESERCIZIO 25.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seguenti:
LaUdabunt alii claram Rhodon aut J\lytilnen
aut Ephes6n bimarisve Corinthi
moenia vel Baccho Thebas vel Apolline Delphos
insignes aut Thessala Tempe.
Sunt quibus unum opus est, intactae Palladis urbem
carmine perpetuo celebrare et
undique decerptam fronti praeponere olivam.
Plurimus in Iunonis honorem
-113-
aptum dicet equis Argos ditesque
Me nec tam patiens Lacedaemon
nec tam Larisae percussit campns opimae,
quam domus Albuneae resonantis
et praeceps Anio ac Tiburni lueus et uda
mobilibus pomaria rivis.
Albus ut obscuro deterget nubila caelo
saepe Notus neque parturit imbres
perpetuo, sic tu sapiens finire memento
tristitiam vitaeque labores
molli, Plance, mero, seu te fulgentia signis
castra tenent seu densa tenebit
Tiburis umbra tui. Teucer Salamina
cum fugeret, tamen uda Lyaeo
tempora populea fertur vinxisse corona,
sic tristes affatus amicos: ...
1
(Orazio, Carrn. I, 7, vv. 1-24).
VI.
Sistema archilocheo primo
(sistema dattilico puro).
110. - Questo sistema distico consta di due versi, dei
quali:
a) il primo un esametro dattilico (cfr. 69): esapodia
dattilica con sostituzioni spondaiche in tutti i piedi eccetto
il 5; cesura semiquinaria, ecc.;
1
Il Carducci riprodusse questo sistema nella poesia italiana usando un esa-
metro (cfr. 71, nota) per primo verso, e per secondo un nouenario piano:
Salve, o pia. Courmayeur, che l'ultimo riso d'Italia.
al pi del gigante de l'Alpi
:echi soave l Te, datrice di posa. e di canti,
lo reco nel verso d'Italia. .
(CARDUCCI, Courma!ltur),
- E. DI MARZO, Prosoia e metrica latina.
- ll4-
b) il secondo un trimetro dattilico catalettico in
labam (3 dattili, di cui l'ultimo catalettico in syll.). il venw
archilocheo. (Cfr 75).
SCIIEMA:
2... vw' ...!._uv,
urazio us tale sistema in Carm., l. IV, 7.
ESERCIZIO 28.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedt che Mmpon-
gono i versi seguenti:
Diffugre nivs, redeunt iam gramina campis
arboribusque coma' ;
mutat terra vices et decresccntia ripas
flumina praetereunt;
Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet
ducere nuda choros.
Immortalia ne speres, monet annus et almum
quae rapit bora diem.
Frigora mitescunt Zephyris, ver proterit aestas
interitura, simul
pomifer autumnus fruges effuderit, et mox
bruma recurrit iners.
Damna tamen celeres reparant eaelestia lunae:
nos ubi decidimus,
quo pius Aeneas, quo Tullus dives et Ancus,
pulvis et umbra sumus.
Qnis scit an adiiciant hodiernae crastina summae
tempora di superi T
Cuncta manus avidas fugient heredis, amico
quae dederis animo.
-115-
Cum seme! occideris et de te splendida Minos
fecerit arbtra,
non, Torquate, genus, non te facundia, non te
restituet pietas;
infernis neque enim tenebris Diana pudicum
liberat Hippolytum,
nec Lethaea valet Thcseus abrumpcre caro
vincula Pirithoo.
(Orazio, Carm. IV, 7, vv. 1-28).
VII.
Sistema archilocheo secondo
(sistema giambico-dati'ilico).
111. - Questo sistema distico consta di due versi, dei
quali:
a) il primo un esametro dattilico (cfr 69); esapodia
dattilica con sostituzioni spondaiche in tutti i piedi, eccetto
il quinto; cesura semiquinaria, ecc.;
b) il secondo un giamblego (cfr. 97). Tale verso consta,
come si detto, di due parti: un dimetro giambico acatalettico
a ritmo ascendente con l'ultima sillaba ancipite quale finale
di metro e l'iato tra essa e la sillaba del piede seguente (ma
Orazio evita sempre lo iato); la seconda un trimetro datti-
lico catalettico in syllabam a ritmo discendente, e non am-
mette quasi mai la sostituzione dello spondeo al dattilo. Ce-
sura (dieresi) tra le parti componenti. Non essendovi la con-
tinuit ritmica fra i membri, questo verso appartiene agli
asinarteti.
SCHEMA:
_l uv'
,1-
.....!. uv . ..lv v, .Jv
- - " Il , ,, ' v
V-, v-, v_, v_, ..lvv,
Orazio usa tale sistema nell'epodo 13.
-!Hl-
ESERClZIO 27.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seguenti:
H6rrida tmpestas caelum contn\xit, et imbres
nivesque dducunt Iovm; mine mare, nunc silua
Threicio Aquilone sonant. Rapiamus, amici,
occasionem de die, dumque virent genua
et decet, obducta solvatur fronte senectus.
Tu vina Torquato move consule pressa meo.
Cetera mitte loqui: deus haec fortasse benigna
reducet in sedem vice. Nunc et Achaemenio
perfundi nardo iuvat et fide Cyllenea
levare diris pectora sollicitudinibus,
nobilis ut grandi cecinit Centaurus alumno:
Invicte mortalis dea nate puer Thetide,
te manet Assaraci tellus, quam frigida parvi
findunt Scamandri flumina, lubricus et Simois,
unde tibi reditum certo subtemine Parcae
rupere, nec mater domum caerula te revehet.
Illi omne malum vino cantuque levato,
deformts aegrimoniae dulcibus alloquiis .
(Orazio, Epodo l 3, v v. l. l 8 ),
VIII.
Sistema archilocheo terzo
(sistema giambico-dattilico).
112. - Questo sistema distico consta di due versi, dei
quali:
a) il primo un trimetro giambico acatalettico impuro
(tripodia giambica impura; non ammette la soluzione delle
lunghe; cfr. 78 e 105);
- 117-
b) il secondo un elegiambo (giambelego invertito, cfr. 98).
(Trimetro dattilico catalettico in syllabam +dimetro giambico
acatalettico). Il verso elegiambo ammette nella terza arsi la
sillaba breve e l'iato fra le due met di cui composto. Ce-
sura (dieresi) tra le parti componenti.
SCHEMA:
v_!. v !!__ " = l __!_ ' v !!_ ,. "-' _! '
,
u'=!.
_!_ I...J '-' , _L ..._, 4!. l\ ,, Il : _! , u !!... ,.
Orazio us tale sistema nell'epodo 11.
ESERCIZIO 28.
v..!'
,
v'=!.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seguenti:
Petti, nihil me sicut antea iuvat
scribere vrsicul6s amore prcussum gravi,
amore, qui me praeter omnis expetit
mollibus in pueris aut in puellis urere.
Hic tertius December, ex quo destiti
Inachia furere, silvis honorem decutit.
Heu me! per urbem - nam pudet tanti mali -
fabula quanta fui! Conviviorum et paenitet,
in quis amantem languor et silentium
arguit et latere petitus imo spiritus.
((Contrane lucrum nil valere candidum
pauperis querebar adplorans tibi,
simul calentis inverecundus deus
fervidiore mero arcana promorat loco.
(c Quodsi meis inaestuet praecordiis
libera bilis, ut haec ingrata ventis dividat
fomenta, vulnus nil malum levantia,
desinet imparibus certare summotus pudor .
-118-
Ubi haec severus te palam laudaveram,
iussus abire domum ferebar incerto pede
ad non amicos heu! mihi postes et heu!
limina dura, quibus lumbos et infregi latus.
Nunc gloriantis quamlibet mulierculam
vincere mollitia amor Lycisci me tenet;
unde expedire non amicorum queant
libera consilia nec contumeliae graves,
sed alius ardor aut puellae candidae
aut teretis pueri longam renodantis comam
1
(Orazio, Epodo Il, vv. l-28).
IX.
Sistema archilocheo quarto
(sistema logaedico-giambico ).
113. - Questo sistema distico consta di due versi, dei
quali:
a) il primo un archilocheo maggiore (cfr. 96) (tetrapodia
dattilica acatalettica che ha la cesura semiquinaria ed il quarto
dattilo puro + il verso itifallico, cio: tripodia trocaica acata-
lettica. Dieresi fra le parti componenti);
b) il secondo un trimetro giambico impuro catalettico
(cfr. 80) (tripodia giambica impura catalettica; nelle sedi
dispari il giambo pu essere sostituito dallo Cesura
semiquinaria).
l 11 Carducci riprodusse nella poeia italiana questo sistema cosi: il primo
verso con un endecasillabo srucciolo; il secondo con ue versi selt<nari accoppiati,
dei quali l'ultimo sdrucciolo:
c Ob, al bel mar di Trieste, ai poggi, agll animi
Volate col nuovo anno, anticbi versi italici:
rai del sol cbe San Petronio imporpora
volate di San Gimto sovra l romani ruderi .
(CARDUCCI, Saluto italico),
-119-
SCHEMA:
...!.uv,
....!\:=;:;,...!.uv,, 11....!....1, .!v, ..!.v
- -, - .,
v ...1. , v .!!.. ,, u ..! , v !!.... ,, v L ':::!..
Orazio us questo sistema in Carmina, l. I, 4.
ESERCIZIO 29.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon
gono i versi seguenti:
S6lvitur acris hims grata vice vris t Fav6ni,
trahuntque siccas machina carinas,
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni,
nec prata canis albicant pruinis.
Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Vulcanus ardens visit officinas.
Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut fiore, terrae quam ferunt solutae,
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agna sive malit haedo.
Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turres. O beate Sesti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam:
iam te premet nox fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia; quo simul mearis,
non regna vini sortiere talis
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis et mox virgines tepebunt.
(Orazio, Oarrn. l, 4, vv. 1-20).
- 120-
x.
Sistema pitiambico primo
(sistema giambico-dattilico).
114. Questo sistema distico consta di due versi, dei
qual!:
a) il primo un esametro dattilico, che, come sappiamo
(cfr. 69), fu anche detto verso pitico da nuOwc;. Esso una
esapodia dattilica con sostituzioni spondaiche in tutti i piedi,
eccetto il 5o, Cesura semiquinaria, ecc.;
b) il secondo un dimetro giambico impuro acatalettico
(due dzpodie giambiche impure acatalettiche). Nel primo piede
di ogni dipodia la breve pu essere sostituita dalla lunga
irrazionale. Cesura semiquinaria.
-, "
v!!_, v_.!, v':::::
Orazio us questo sistema negli epodi 14, 15.
ESERCIZIO 30.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compm,.
gono i versi seguenti :
l\16llis inrtia cur tantam diffuderit imis
oblivi6nem sensibus,
pocula Lethaeos ut si ducentia somnos
arente fauce traxerim,
candide :Maecenas, occidis saepe rogando:
deus, deus nam me vetat
/
- 121-
inceptos, olim promissum carmen, iambos
ad umbilicum adducere.
Non aliter Samio dicunt arsisse Bathyllo
A.nacreonta Teium,
qui persaepe cava testudiue flevit amorem
non elaboratum ad pedem.
Ureris ipse miser: quodsi non pulchrior ignis
accendit obsessam Ilion,
gaude sorte tua; me libertina, nec uno
contenta, Phryne macerat.
(Epodo 14, vv. 1-16).
N6x erat t cael6 fulgbat luna serno
inter min6ra sidera,
cum tu magnorum numen Jaesura deorum,
in verba iurabas mea,
artius atque hedera procera astringitur ilex;
lentis adhaerens bracchiis,
dum pecori lupus et nautis infestus Orion
turbaret hibernum mare
intonsosque agitaret A.pollinis aura capillos,
fore hunc amorem mutuum.
O dolitura mea multum virtute Neaera!
Nam siquid in Fiacco viri est,
non feret assiduas potiori te dare noctes,
et quaeret iratus parem.
Nec semel offensae cedet constantia formae,
si certus intrarit dolor.
Et tu, quicumque es felicior atque meo nunc
superbus incedis malo,
sis pecore et multa dives tellure licebit
tibique Pactolus fluat,
-122-
nec te Pythagorae fa1lant arcana renati,
formaque vincas Nirea,
heu heu! translatos alio maerebis amores:
ast ego vicissim risero
1
115.
quali:
(Orazio, Epodo 15, vv. 1-24).
XI.
Sistema pitiambico secondo
(sistema giambico-dattilico).
Questo sistema distico consta di due versi, dei
a) il primo un esametro dattilico (cfr. 69): esapodia
dattilica, con sostituzioni spondaicbe in tutti i piedi, eccetto
il 5. Cesura semiquinaria, ecc.;
b) il secondo un trimetro giambico acatalettico puro
(tripodia giambica acatalettica pura, con cesura semiquinaria).
(Cfr. 77). usato in forma pura in tutto l'epodo 16o.
,
v ...1. ' v !!_ " v l ..! ......, !!_ '' v ..! ' v ~
Orazio us questo sistema nell'epodo 16.
1
Il Cnrducci riprodusse questo sistema cosi: li primo verso con un esamflro
(cfr. 71, nota), il secondo con un sellenario sdrucciolo:
Ecco: la verde Sirmio nel lucido lago sorride,
fiore de le penisole.
Il sol la guarda e vezzeggia: somiglia d'intorno Il Benaco
una gran tazza argentea,
cui placido olivo per gli orli nitidi corre
misto a l'eterno lauro .
(CARDUCCI, Sirmiont),
..
q.
J
-123-
ESERCIZIO 31.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon
gono i versi seguenti:
,
Altera 1am teritur bellis civflibus atas,
suis et fpsa Roma vfribus ruit.
Quam neque finitimi valnerunt perdere l\brsi,
minacis aut Etrusca Porsenae manus,
aemula nec virtus Capuae, nec Spartacus acer
novisque rebus infidelis Allobrox,
nec fera caerulea domuit Germania pube
parentibusque abominatus Hannibal,
impia perdemus devoti sanguinis aetas,
ferisque rursus occupabitur solum.
Barbarus heu! Cineres insistet victor et Urbem
eques sonante verberabit ungula,
quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini,
nefas videre! dissipabit insolens.
Forte, quid expediat, communiter aut meior pars
malis carere quaeritis laboribus:
nulla sit hac potior sententia: Phocaeorum
velut profugit exsecrata civitas
agros atque Lares patrios, habitandaque fana
apris reliquit et rapacibus lupis,
ire, pedes quocumque ferent, quocumque per undas
Notus vocabit aut protervus Africus.
Sic placetT an melius quis babet suadere? Secunda
ratem occupare quid moramur alite?
Sed iuremus in haec: < Simul imis saxa renarint
vadis levata, ne redire sit nefas;
neu conversa domum pigeat dare lintea, quando
Padus Matina laverit cacumina,
-124-
in mare seu celsus procurrerit Appenninus
novaque monstra iunxerit libidine
mirus amor, iuvet ut tigres subsidere cervis,
adulteretur et columba miluo,
credula nec ravos timeant armenta Ieones,
ametque salsa Ievis hircus aequora ))
1
(Ora.zio, Epa:la 16, vv. 1-34).
XII.
Sistema ipponatteo
(sistema giambico-trocaico ).
116. - Questo sistema distico consta di due versi, dei quali:
a) il primo un dimetro trocaico catalettico in syllabam
(dutJ dipodie trocaiche catalettiche in syllabam) (cfr. 83). Orazio
usa una sola volta tale metro, precisamente in questo sistema
ipponatteo, lasciando immutato il secondo trocheo della prima
dipodia;
b) il secondo un trimetro giambico impuro catalettico
(tripodia giambica impura catalettica). Nelle sedi dispari il
giambo pu essere sostituito dallo spondeo. Cesura semi-
quinaria (cfr. 80).
SCHEMA:
.!!_u, .!_u, !!_v, l! 1\
v.!_, v_!_ ,, / _!_. v!!_,, :=L
Or&zio us questo sistema in Carmina, l. 18.
1
Il Cnrducci riproduce questo sistema cosi: il primo verso con un
:cir, ! 71, nota), il secondo con un en-Jecasillabo sdrucciolo:
Io d'Italia dal cuor tra impeti d'inni balzai
quando l'Alpi di barbari snebbiarono
o sul popnleo Po p 'l verde paese i carrocci
tutte le trombe reduci suonavano .
(CARDUCCI, Le Due Torri).
-125-
ESERCIZIO 32.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon
g ono i versi seguenti:
Non ebur neque aureum
mea renidet in domo lacunar,
non trabes Hymettiae
premunt columnas ultima recisas
Africa, neque Attali
ignotus heres regiam occupavi,
nec Laconicas mihi
trahunt honestae purpuras clientae.
At fides et ingeni
benigna vena est, pauperemque dives
mc petit: nihil supra
deos lacesso nec potentem amicum
largiora flagito,
satis beatus unicis Sabinis.
Truditur dies die,
novaeque pergunt interire Lunae:
tu secanda marmora
locas sub ipsum funus et sepulchri
immemor struis domos,
marisque Bais obstrepentis urges
1mmmovere Iitora,
parum locuples continente ripa.
Quid, quod usque proximos
revellis agri terminos et ultra
limites clientium
salis Pellitur paternos
in sinu ferens deos
et uxor et vir sordidosque natos.
Nulla certior tamen
rapacis Orci fine destinata
-126-
aula divitem mauet
erum. Quid ultra tendisT Aequa tellus
pauperi recluditur
regumque pueris, nec satelles Orci
callidum Promethea
revexit auro captus. Hic superbum
Tantalum atque Tantali
genus coercet, hic levare functum
pauperem laboribus
vocatus atque non vocatus audit.
(Orazio, Oarm,ina, Il, 18, vv. l 40).
XIII.
Sistema asclepiadeo minore terzo
(sistema logaedico).
117. - Questo sistema distico consta di due versi, dei quali:
a) il primo un gliconeo secondo (tetrapodia logaedica
catalettica in syllabam, con spondeo o trocheo in prima sede
e dattilo in seconda sede), (ovvero: spondeo o trocheo base,
un dattilo e una dipodia trocaica catalettica in syllabam).
Raramente trovasi il trocheo in P. sede. (Cfr. 85);
b) il secondo un asclepiadeo minore (tripodia dattilico-
trocaica catalettica in syllabam, con spondeo in prima sede e
dattilo in seconda sede + tripodia logaedica (un dattilo e due
trochei, di cui l'ultimo catalettico in syllabam). Cesura (die-
resi) fra le parti componenti. (Cfr. 88).
SCHEMA:
....!..v, .!....uv, ..!... v' ~ 1\
.!...!\,Il -'-.uu, .!...u, ~ / \
,
--
_!_uv,
Orazio us questo sistema in: Carmina, l. I, 3, 13, 19,
36; III, 9, 15, 19, 24, 25, 28; IV, l, 3.
-127-
ESERCIZIO 33.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon
gono i versi seguenti:
Sic te diva potns Cyprf
sic fratrs Helena, lucida sidera,
ventorumque regat pater
obstrictis aliis praeter Iapyga
navis, quae tibi creditum
debes Vergilium: finibus Atticis
reddas incolumem, precor,
et serves animae dimidium meae.
Illi robur et aes triplex
circa pectus erat, qui fragilem truci
commisit pelago ratem
primus, nec timuit praecipitem .Africum
decertantem .Aquilonibus
nec tristes Hyadas nec rabiem N o ti,
quo non arbiter Hadriae
maior, tollere seu ponere vult frE>ta.
Quem mortis timuit gradum,
qui siccis oculis monstra natantia,
qui vidit mare turbidum et
infames scopulos .Acroceraunia 1
Nequicquam deus abscidit
prudens Oceano dissociabili
terras, si tamen impiae
non tangenda rates transiliunt vada .
Audax omnia perpeti
gens humana ruit per vetitum nehs:
audax Iapeti genus
ignem fraude mala gentibus intulit.
- 128-
Post ignem aetheria domo
subductum macies et nova febrium
terris incubuit cohors,
semotique prius tarda necessitas
leti corripit gradum.
Expertns vacuum Daedalus aera
pinnis non homini datis;
perrupit Acheronta Herculeus Jabor.
Nil mortalibus ardui est;
caelum ipsum petimus stultitia, neque
per nostrum patimur scelus
iracunda lovero ponere fulmina.
(Orazio, Carm., l, 3, vv. 1-40).
XIV.
Sistema sartlco maggiore
(sistema logaedico).
118. - Questo sistema distico consta di due ver11i, dei
quali:
a) il primo un aristofaneo (tripodia dattilico-trocaica
acatalettica, col dattilo in prima sede; ovvero: un dattilo e
due trochei) (Cfr. 94);
b) il secondo un saffico maggiore (efr. 91). Questo
verso l'ampliamento del saffico minore (pentapodia datti-
lico-trocaica acatalettica; cfr. 90), per l'inserzione dopo i
primi due piedi del minore di una dipodia dattilica catalettica
in syllabam. Il saffico maggiore ha due cesure: la prima cesura
(dieresi) dopo la 5n sillaba, la seconda che stabile, oltre
che dieresi, dopo la dipodia dattilica inserita, vale a dire
dopo 1'8 sillaba..
- 129-
Lvu, .!_v, !_v
!_ v , __!_ _ _ , _!_ Il v v , ..!.. 1\ , , ! l _!__ ..._, v , ..!.. u , !_
Orazio us codesto sistema in: Carmina, l. I, 8.
ESERCIZIO 34.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seg,uenti:
Lydia, dic, per 6mnes
t de6s or6, Sybarin cur propers amando
perdere; cur apricum
oderit campum, patiens pulveris atque solis;
cur neque militares
inter aequales equitet, Gallica nec lupatis
ternperet ora frenis.
Cur timet ftavum Tiberim tangere? Cur olivum
sanguine viperino
cautius vitat, neque iarn livida gestat armis
bracchia, saepe disco,
saepe trans finem iaculo nobilis expedito!
Quid latet, ut marinae
filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troiae
funera, ne virilis
cultus in caedem et Lycias proriperet catervasY
(Orazio, Oarm. I, 8, vv. 1-18).
9, - E. DT M.n<zo, Prosodia m'irica tatma.
- 1'30 --
CAPO IV.
SISTEMI TETRASTICI
xv.
Sistema alcaico
(strofa tetrastica alcaica).
119. - II sistema alcaico che trionf nella melica greca,
fu il preferito da Orazio.
Questa atrofa. tetrastica (!Lhpov -rp(xwov) consta di quattro
versi, dei quali:
a) i primi due sono alcaici (tre giambi, di etti
l'ultimo catalettico in syllabam, con la sostituzione della lunga alla
breve nel primo e terzo piede + tripodia dattilico-troeaica cata-
lettica in syllabctm. Cesura stabile, che anche dieresi, fra
le parti componenti). (Cfr. 92);
b) il terzo un enneasillabo alcaico (quattro giambi +
una sillaba finale; spondeo nelle sedi impari) (Cfr. 82);
c) il quarto un decasillabo alcaico (tetrapodia dattilico-
trocaica acatalettica; ossia, due dattili e due trochei). (Cfr. 93).
SCHEMA:
v_!_,
-
l\
Il
A v !_v v, !_v. !...
- -
l\
l!
A v!.._, v_!_, u
,
.!_v.
-'-
'
-v v.
u_!_,
-- -
l\ v_!_. v_!_
v-'- v
Orazio us codesta. l'!trofa alcaica in 3 7 odi I 9 16 17
. ' ' ' '
26, 27, 29, 31, 34, 35, 37; II, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17,
19, 20; I. III, 1-6, 17, 21, 23, 26, 29; I. IV, 4, 9, H, 15.
-131-
ESERCIZIO 35.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che cmnpon-
gono i versi seguenti:
Nunc st bibndum, nuuc pede libero
pulsanda tllus, nunc Saliaribus
ornare pulvinar deorum
tmpus erat dapibus, sodales.
Antehac ncfas depromere Caecubum
cellis avitis, dum Capitolio
regina dementes ruinas,
funus et imperio parabat
contaminato cum grege turpium
morbo virorum, quidlibet impotens
sperare fortunaque dulci
ebria. Sed minuit furorem
vix una sospes navis ab ignibus,
mentemque lymphatam l\Iareotico
redegit in veros timores
Caesar, ab Italia volantcm
remis adurgens, accipiter veut
molles columbas aut leporem citl13
venator in campis nivalis
Haemoniae, daret ut catenis
fatale monstrum. Quae generosius
perire quaerens nec muliebriter
expavit ensem nec latentes
classe cita reparavit oras ...
(Orazio, Oarm., I, 37, vv. l-24).
Vids ut alta stt nive candidum
Soracte nc iam sustineant onus
-132-
silva Iab6rants geluque
ftumina c6nstiterint acuto.
Dissolve frigus ligna super foco
large reponens atque benignius
deprome quadrimum Sabina,
o Thaliarche, merum diota.
Permitte divis cetera, qui simul
stravere ventos aequore fervido
deproeliantes, nec cupressi
nec veteres agitantur orni.
Quid sit futurum cras, fuge quaerere et,
quero Fors dierum cumque dabit, lucro
appone nec dulces amores
sperne, puer, neque tu choreas,
donec virenti canities abest
morosa. Nunc et campus et areae
lenesque sub noctem susurri
composita repetantur bora, ... 1.
(Orazio, Oarm., I, 9, vv. l 20).
1
La strofa. alcaica stata riprodotta da poeti moderniClMl: J'endf>caslllabo
alcaico con due quinari, piano il primo e sdrucciolo l'altro; l'enneasillabo con un
novenario; il de<>"-illabo alcaico con un decasillabo portmte l'accento o sulla sesta
o sulla settima ou .. >ba, oppure con due quinari piani accoppiati. Diamo un esempio
del D'Annunzio:
Alcaica strofe, canora, vigile,
che vai fremendo su l'ali rosee
de l'aura vagante tra gl'itali
verdi lauri e mirteti, salute! .
Un esempio del Carducci:
Te redemito l di fior purpurei
aprii te vide l su 'l colle emergere
da 'l solco di Romolo torva
riguardante su i selvaggi piani:
te dopo tanta l forza di secoli
apri1e irraggia, l sub11me, massima,
e Il sole e l'Italia. saluta
te, Flora di nostra. gente, o Roma .
!CARDUCCI, Nell'annuale t/la Fondmicne di Rom,;a).
-133-
XVI.
Sistema saffico minore
(strofa tetrastica saffica minore).
120. - Ettore Stampini
1
sospetta che questa strofe sa-
rebbe tristica, basandosi sul frammento greco di una lirica
della poetessa Saffo, dal quale risulta che l'ultima parola
del terzo verso (parola semplice, non composta) trovasi spez-
zata in due parti, la seconda delle quali continua in un verso
successivo: tale spezzatura proverebbe l'inesistenza del quarto
verso; e per potrebbesi conchiudere che originariamente co-
desta strofe sarebbe stata tristica, e che col tempo sarebbe
divenuta tetrastica, essendo stato spezzato in due il terzo
verso che risultava alquanto lungo.
Noi, seguendo l'antico uso, anche per non creare dispa-
rit, includiamo fra le tetrastiche questa strofa di tipo abtCOV
che, se non ha l'energia dell'alcaica, permeata di grazia
e di delicatezza.
Essa consta di quattro versi, dei quali:
a) il primo, il secondo ed il terzo sono M(fici minori ,
(pentapodia dattilico-trocaica acatalettica, con dattilo in terza
sede e lo spondeo in seconda sede; oppure: un trocheo, uno
spondeo, un dattilo e due trochei finali. Cesura semiquinaria
{cfr 90), e qualche volta trocaica, dopo la 6a sillaba);
b) l'ultimo un adonio (dipodia dattilica catalettica in
dis.syllabam) (cfr. 74).
1
ETTORE 11/etriGa oraziana, Loescher, Torino, 1913, p. 4 9.
2
Lo etesso Stampini sostien(l ')be il verso sa.lllco minore abbia ritmo i"iaw
bico. !Cfr. op. cit., p. 50).
-134-
ScHEMA:
-
...!.v,
!_
- .
!_
v u
!_
v !_u
-
.!....v !_
-
'
-'-- u u .
!_
u .
!_u
-'--v . -'-- - .
!_
vu
'
!_
v . -'-- v
!_
u v
!_
'-'
Codesto sistema lirico stato applicato ben 26 volte, e
precisamente, in Carm.: I, 2, 10, 12, 20, 22, 25, 30, 32, 38;
I. II, 2, 4, 6, 8, 10, 16; I. III, 8, 11, 14, 18, 20, 22, 27: l. IV,
2, 6, 11, e nel Carmen Saeculare.
ESERCIZlO 36.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seg1tenti:
Phobe silvarumque potns Diana,
Iucidum caeli decus, 6 colndi
smper t cult.i, date qua precamur
tmpore sacro,
quo Sibyllini monuere versus
virgines leetas puerosque casto11
dis, quihus septem placuere colles,
dicere carmen.
Alme sol, curru nitido diem qui
promis et celas aliusque et idem
nasccris, possis nihil urbe Roma
visere maiua!
-135-
Rite maturos aperire partus
Ienis, Ilithyia, tuere matres,
sive tu Lucina probas vocari
seu Genitalis.
Diva, producas subolem patrumque
prosperes decreta super iugandis
feminis prolisque novae feraci
Jege marita,
certus undenos deciens per annos
orbis ut cantus referatque Judos
ter die claro totiensque grata
nocte frequentes ...
(Orazio, Carmen Saeculare, TV. 1-U).
Mrcurf, facunde nep6s Atlantis,
quf fer6s cultus hominum recntum
voce formasti eatus t dec6rae
m6re palstrae,
Te canaro, magni Iovis et deorum
nuntium curvaeque Jyrae parentem,
callidum, quicquid placuit, iocoso
condere furto.
Te, boves olim nisi reddidisses
per dolum amotas, puerum minaci
voce dum terret, viduus pharetra
risit Apollo.
Quin et Atridas duce te superbos
Ilio dives Priamus relicto
Thessalosque ignes et iniqua Troiae
castra fefellit.
- 136-
Tu pias laetis animas reponis
sedibus virgaque levem coerces
Aurea turbam, superis deorum
gratus et imis 1.
(Orazio, Carni., I, IO, vv. l-20).
XVII.
Sistema asclepiadeo primo
tetrastica asclepiadea 1").
121. - Questo sistema tetrastico ([Lhpov alx:wov) consta.
di quattro versi, dei quali:
a) i primi tre sono asclepiadei minori (tripodia dattilico-
trocaica catalettica in syllabam con spondeo in prima sede e
dattilo in seconda sede + tripodia logaedica; cio: un dattilo,
seguito da due trochei, di cui l'ultimo catalettico in syllabam.
Cesura, che dieresi, tra le parti componenti). (Cfr. 88).
1
La strofe sa.fflca. minore sta.ta. resa. dal Carducci cosi: i primi tre versi con
tre endecasillabi piani, aventi una cesura. dopo la. quinta. sillaba., e privi di accento
sulla. seconda. sillaba; il quarto ver30 con un piano. Eccone un esempio:
Una di flauti lenta melodia
passa. invisibil fra la terra e il cielo:
spiriti forse che ruron, che sono
e che saranno.
Un oblio lene de la. faticosa
vita., un pensos:J . aspirar quiete,
una. soave volont di pianto
J'anime invade.
Taccion le fiere e gli uomini e Je cose,
roseo 'l tramonto ne l'azzurro sfuma,
mormoran gli alti vertici ondeggianti:
A ve .Maria. .
(C&RDUCCI, La chiesa di Polenta),
' '
! l
-137-
b) il quarto un gliconeo secondo (tetrapodia logaedica
catalettica in syllabam, con spondeo o trocheo in prima sede
e dattilo in seconda sede). (Cfr. 85).
SCHEMA:
' '
.!..A,
Il
_!_v v, .!_v, -!d .
"-.
-'--''-'
'
.!_'-''-'t .!..A
Il
.!.. .!_v, A
- - '
'-"''-'.
,
_!_ '-' '-' ' .!.. /\
Il
..!.. v v, _.!_ ._.'
--
'
,
.:...v. -v, -v v,
Riscontriamo applicata questa strofe nove volte, e pre
cisamente: in Carm.: l. I, 6, 15, 24, 33; I. II, 12; I. III, 10,
16; 1. IV, 5, 12.
ESERCIZIO 37.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seguenti:
Scriberis Vario f6rtis et h6stium
victor Maonii carminis alit,
quam rem cumque fer6x navibus aut equis
miles t duce gsserit.
Nos, Agrippa, neque haec dicere nec gravem
Pelidae stomachum cedere nescii,
nec cursus duplicis per mare Uli:xei,
nec saevam Pelopis domum
conamur, tenues grandia, dum pudor
imbellisque lyrae Musa potens vetat
laudes egregii Caesaris et tuas
culpa deterere ingeni.
- 138-
Quis Martem tunica tectum adamantina
digne aut pulvere Troico
nigrum Merionen aut ope Palladis
Tydiden superis paremY 1.
(Orazio, Oarm., I, 6, vv. 1-16).
XVIII.
Sistema asclepiadeo secondo
(strofa tetrastica asclepiadea 2).
122. Questo sistema tetrastico ([L"rpov -rp[xwov) consta
di quattro versi, dei quali:
a) i primi due sono asclepiadei minori (cfr. il sistema
precedente e il 88);
b) il terzo un feracrateo secondo (tripodia logaedica aca-
talettica con spondeo o trocheo in prima sede e dattilo in se-
conda sede). (Cfr. 86);
l Il Carducci ci ha reso questa strofe cosi: i primi tre versi con tre endecasillabi
1druccio/i o tre coppie di quinari sdruccioli; il quarto con un settenario drucciolo.
Fccone un esempio, in cui i primi tre versi sono formati da 3 coppie di quinari
druccioli:
Sorgono e in agili l file dilungano.
gl'immani ed ardui l steli marmorei,
e ne la tenebra l sacra somigliano
di giganti un esercito
t be guerra mediti l con l'invisibile:
le areate salgono l chete, si slanciano
quindi a voi rapido, l poi si abbracciano
prone per l'alto e pendule
(CARDUCCI, In una chiesa yot;cn).
Ecco un altro esempio, In cui i prim i 3 versi sono formati da tre endecasillabi
sdruccioli:
Tu parli; e, de la voce a la molle aura
lenta cedendo, si abbandona l'anima
del tuo parlar su l'onde carezzevoli,
e a strane piaghe naviga .
!CARDUCCI, Fantasia!,
- 139-
c) il quarto un gliconeo secondo (cfr. il sistema prece-
dente e il 85). Come si vede, codesta strofe differisce dalla
precedente solo nel terzo verso.
_!_, 2vv, _L .. Il _!vv, ..tu,
-'- _ ..!. v v 2 1\ . Il .! v v , ..!. v , -1< 1\
J..v. _!_vv, ...!..v
2v ....!vv, ...!...v, ...J!I\
Ricorre in Carm.: l. I, 5, 14, 21, 23; l. III, 7, 13: l. IV, 13.
ESERCIZIO 38.
Si continui ad accentare tutte le arsi dei piedi che compon-
gono i versi seguenti:
,
O fons Bandusia, splndidi6r vitr6,
dulci digne mer6 n6n sine fl6ribus,
cras donaberis hado,
cui frons turgida c6rnibus
primis et venerem et proelia destinat
frustra: nam gclidos inficiet tibi
rubro sanguine rivos
lascivi suboles gregis.
Te flagrantis atrox bora Caniculae
nescit tangere, tu frigus amabile
fessis vomere tauris
praebes et pecori vago.
Fies nobilium tu quoque fontium,
me dicente cavis impositam ilicem
saxis, unde loquaces
lymphae desiliunt tuae.
(Orazio, Oarm., III, 13, vv. 1-16).
- 140-
,
O navis, refernt in mare t novi
'
fluctus! O quid a g i s ~ F6rtiter 6ccupa
p6rtum. Nonne vids, ut
nudum rmigi6 latus
et malus celeri saucius Africo
antemnaeque gemant, ac sine funibus
vix durare carinae
possint imperiosius
aequor? Non tibi sunt integra lintea,
non Di, quos iterum pressa voces malo.
Quamvis Pontica pinus,
silvae filia nobilis,
iactes et genus et nomen inutile,
nil pictis timidus navita puppibus
fidit. Tu, nisi ventis
debes ludibrium, cave.
Nuper sollicitum quae mihi taedium,
nunc desiderium curaque non levis,
interfusa nitentes
vites aequora Cycladas
1
(Orazio, Carm., I, 14, vv. 120).
l Questa strofe resa dal Carducci cosl: i primi due versi eono riprodotti con
due coppie di quinari sdruccioli: il terzo verso riprodotto con un settenario piano;
il Quarto con un settenario sdrucciolo.
Eccone un esempio:
Sotto l'olimpico l riso de l'aera
la terra palpita: l ogn'onda accendesi
e trepida risalta.
i fu1gidi amor turgida
1
(CARDUCCI, Su l'Adda},
.l
t
-141-
CAPO V.
COMPOSIZIONI IPERlUE'rRICHE
XIX.
Periodi decametrici di ionici a minore.
123. - L'ode 12
8
del III libro consta di quattro periodi
metrici aventi dieci piedi di ionici a minore (v v _L-) ciascuno.
da sapere che presso i Greci il x6lov ionico poteva
comprendere dodici tempi primi (due dipodie di ionici a mi-
nore), o, tutt'al pi, diciotto tempi primi (tre dipodie di
ionici a minore); ora, se il periodo ionico sar costituito da
dieci piedi di ionici a minore, esso oltrepasser la misura
ordinaria e sar, naturalmente, ipermetro. (Cfr. E. Stam-
pini, op. c., p. 60).
Se si ammette che Orazio avrebbe composto la suddetta
ode, con versi comprendenti, nientemeno, che dieci piedi di
ionici a minore, ne risulter un verso dal seguente schema:
\,.,.1 \.-/ _!... - ' v v_..!_ - . v v_!._ - ' v v!.._ - ,.
'
v \.J --
, ' , , l
v \,...,1 - - '' v v - - ' u v - - ,, v v- - ' \.......< v - -
Un verso cos lungo non pu entrare in una sola riga: e
per gli studiosi di metrica, se sono stati concordi nel divi-
dere codesti versi (o meglio: periodi metrici) in parti, non
si accordano affatto nello stabilirne le parti e nell'aggrup-
p.ule in strofe. Alcuni hanno propugnato la trascrizione di-
stica, altri la tristica, ed altri ancora la tetrastica. Messa da
parte la trascrizione distica, gli studiosi moderni si sono fer-
mati alla trascrizione su tre righe, in modo che la prima e
la seconda riga contengano quattro piedi di ionici a minore,
- 142-
la terza, due piedi di ionici a minore, secondo Io schema se
guente:
Altri studiosi accettano, si, la trascrizione su tre righe,
m:1 sostengono una diversa distribuzione di piedi su ciascuna
riga, e precisamente ammettono che la prima riga comprenda
quattro piedi ionici a minore; la seconda e la terza riga, tre
piedi ionici a minore ciascuna, secondo questo altro schema:
Vi sono infine alcuni insign studiosi che sostengono la
trascrizione tetrastiea (cfr. Laehmann, Meineke, ecc.), la
quale, secondo noi, la preferibile, sia per ragioni di analogia,
sia per ragioni basate sulla tradizione pervenutaci dai Greci,
i quali, come si diceva di sopra, solevano aggruppare gli io-
nici a minori in membri di due, o al massimo, di tre piedi.
Facciamo notare, d'altro canto, che tutte le divisioni sono
rese possibili dal fatto ehe Orazio fa coincidere la fine di una
parola con la fine del piede. Anche per la trascrizione tetra-
stica c' disparit di opinioni circa la distribuzione dei piedi
nelle quattro righe.
Riportiamo soltanto i due schemi seguenti:
ScHEMA .A.
}O
verso: vu.....!
-
'
v v __!
-
2 v v ...l.
-
'
'-' '-'
__!
-
3D
v v __!
-
'
v v __!
-
'
vvJ
-
40
v v l
-
'
V '<....l-L-
'
v v -.l-
. 1
-143-
I primi due versi comprendono due piedi ionici a minore;
il terzo e il quarto, tre piedi di ionici a minore.
Trascriviamo, secondo questo schema, la prima strofe della
suddetta ode:
1!-Iiserarurnst nequ(e) arnon
dare ludurn neque d11lci
mala vino laver(e) aut exanimari
metuntes patrua verbera Unguae.
(Orazio, Oarm., III, 12, vv. l 4)
ScHE!\fA B.
}O
verso: v v _1
-
'
v v _1
-
20 v v _1
-
'
v v _1
-
so
v v _!
-
'
'-' v ~
-
'
'-' v _1
-
'
v '-'
_l
40 v v .!
-
'
'-' '-'
__!
-
Il primo, secondo e quarto verso comprendono due piedi
di ionici a minore, il terzo verso, quattro piedi di ionici a
minore.
Trascriviamo, secondo questo schema, la prima strofa della
suddetta ode:
Miserarurnst nequ(e) amor.
dare ludttm neque dulci
mala vino laver(e) aut exanimari metuntes
patrtta rerbera linguae.
(Orazio, Carm., III, 12, vv. 1-4).
124.
Nu
mero
2
3
4
Esempi
Iam iam efficaci do manus
[scientia,
Macenas atavfs dite rgibus
Nullam, V are, sacra vite prius
(sveris arborm
Quo, quo scelsti ruitis aut
[cur dAsterfs
aptantur nses conditi!
TAVOLA RIASSUNTIVA
Classificazione
metrica
del Carmi
Epodo 17
Odi. I, 1; III, 30;
IV, g_
Odi, I, 11, 18; lV,
10.
l
Epodo l, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10.
A) Composizioni
Metro
Trimetro giam-
bico acataletl.
Asell'piadeo
minore
AselPpiadeo
maggiore
B) Sistemi
Sistema Epodieo
DELLA METRICA ORAZIANA
Formazione
Trimetro ginn-
bleo hnpuro u-
t'atalett. (in se-
rie indetermina-
ta)
Schema
- " -t " u_!_,v-,,v _!..,v_,,
- "
v__L,
A!lciPpladeo mi- ..L _ , ..! v v ..! 1\ , Il
nore (in serie in-
determinata) i ..! v v , ..! v , '-k 1\
Asclepiadeo,..!- ..! v v ..! 1\" il
maggiore (in l -
serie inetermi- ! _L v v, _L i\ , \ [ _L v v ,
nata)
distici
1 verso: trhne-
tro gianibico
impuro acatal.
2 verso: dimetro
giambieo im-
puro aeatal.
-
v _L'
-
v _L'
-
\,.l _L,
v.!!_,
,
v'='
v!!_
,
_L
'
\....)_,,
"
"
..!, v
""'
Struttura dei versi
Trimeho giambleo impuro acat.
Tr<' dipodw Nel pl'imo
piede di ciascuna di p odia am
messa la lunga irrazionale; inoltre
pure ammesso, in certe sedi, lo
scioglimento di una lunga (anche
irrazionale) In due brevi; in tal
modo il giambo o lo spondt'o pos-
sono mutarsi in ft.napesto, iu t.ri-
braco e In dattilo (gli ultimi due
con l'ictns sulJa prima breve, che
rappresenta la lunga), e talora in
proceleusmatico. La cesura la
semiquinaria. Talora trovMi la
semisettenaria in unione con la
semlquinaria o con la dieresi dopo
Il 2 giambo.
A!leleplalleo minore. Consta di due
psrti:
a) una tripodia dattllico-tro-
caica catai. in svllabam, con spon-
deo in prima sede e dattilo In 2
aede;
b) una tripodia logaedlca (cio:
un dattilo seguito da due trochei,
di cui l'ultimo catai. in svllabam).
che dieresi, tra le parti
componenti.
Asclepiadeo maggiore: uguale al
precedente, con In pi una dipodla
dattilica catai. in svllabam inse-
rita dopo il terzo piede.
che dieresi, dopo la 6 sillaba;
talora dopo la 10 sillaba travasi
una seconda cesura (dieresi).
Trlmetro giambico Impuro aca-
talettico. Come al N. l.
Dimetro giambico impuro aea-
taletlico: due dipodie giambiche
impure acatalettiche. Nel primo
piede di ogni dipodia la breve pu
essere sostituita dalla lunga irra-
zionale. Cesura eemiquinaria.
Segue
Nu
Esempi
mero
--
5 Laudabunt alii claram Rhodon
[aut l\iytilnen
aut Ephes6n bimarisve Co-
[rinthi
6 Diffugre nivs, redeunt iam
[gramina campis
arboribusque coma;
7 H orrida. tmpestas coelum
[contraxit, et imbres
nivesque dducunt Iovm;
nunc mare, nunc silua
8 Petti, nihil me sicut antea
[iuvat
scribere vrsicul6s amore pr-
(cussum gravi,
'
T A. VOLA. RIASSUNTIVA.
B) Sistemi
Classificazione
l
metrica Metro
dei Carmi
i
Odi, I, 7, 28. SistenJa
Epodo 12. Alcmanlo
Odi, IV, 7, Archilocheo
prhno
Epodo 13. Archilocheo
secondo
Epodo 11. Archilocheo
terzo
DELLA. METRICA. ORA.ZIA.NA.
distici
Formazione
l verso: tosame-
tro dattilico
2 verso: tetra-
ml'tro dattilico
eatal. 111 di
a;yllabam
1 verso:
tro dattilico
Schema
_!uv, 2vv,
2vv,
....!.vv, 2uv,
_L vv' 2uv,
..L.vv, -Lvv, ..Lv
2 verso: trime- 2 v v , _t_ v v , ':k 1\
tro dattll. ca-
tal. iD 11yllabam
1 verso: esame-
tro dattilico
2 verso: glam-
blego
_! vv , _!. vv '
J.vv, _t_vv, _!v
- - ,
v_!, v!!_, v ....L' l l
1 verso: trlme- :; .J., v.!!_,, /....!,
tro giambico _
"
v-"
" acatal. impuro v ..L , v
2 verso:
eleglambo
_Lv'-'' -.Lv v,":!:!. 1\ "]j
- - ,
v-L, v!!...., v...!, v':::::
Struttura. del versi
Esametro dattilleo: esapodia dat
tilica con sostituzione dello spon
deo al dattilo in tutti i piedi, ec
cetto il 5. Cesura semiquinaria;
meno comune la settenaria; talora
la troeaica.
Tetrametro dattilico ( Il verso
alcmanio -cfr. 7!i), formato di
una tetrapodia dattilica catai. In
dissvllabam, detto anche eroico
acefalo. Eccezionalmente il 3
dattilo ammette la sostituzione
sponda.ica.
Eaametro dattilico: come al N. 5
(verso primo).
Trimdro dattll. cat. in S)'l (Tre
dattili, di cui l'ultimo catai. in
svll.). - Il verso archilocheo
(cfr. S 75).
Esametro dattilico: come al N. 5
(verso primo).
Giamblego: dimetro giambico
acatalettico + trimetro dattilico
catalettico In svllabam. Cesura
(dieresi) fra le parti componenti.
Trimetro giambico acat. Impu-
ro: cfr. il N. 1. Non scioglie in
brevi che la lunga della l" dipodia
del verso 2 7.
Elegiambo: uguale al giamblego
invertito, cio: trimetro dattilico
ca.t. in svllabam + dimetro ltam-
blco acatalettico. N ella s arsi
talora c' la sillaba. breve e l'lato.
Cesura (dieresi) tra le parti com-
ponenti.
Segue T A. VOLA. RIA.SSUNTIV A.
B) Sistemi
Classificazione
Nu-
Esempi metrica Metro
mero
dei Carmi
9 S6lvitur acris hims grata vice
Odi, I, 4. Archilocheo
[vris t Fav6ni,
quarto
trahuntque siccM machina
[carinas,
IO M6llis inrtia cur tantam dif- Epodo 14, 15. Pitiamblco
[fuderit imis
prhno
oblivi6nem sensibus,
,
Il Altera iam teritur bellis civi-
Epodo 16. Pitiamblco
[libus atas,
secondo
suis et ipsa l ~ orna viri bus
[ruit.
12 Non ebur neque aureum
Odi, II, 18, lpponatteo
mea renidet in dom6lacunar,
13 Sic te diva potns Cypri
Odi, I, 3, 13,19, 36;
Asel('piadro
sic fratrs Helena, lucida
III, 9, 15, 19, 24, Inioore terzo
(sidera,
25, 28;
IV, l, 3.
"
DELLA. METRICA. ORAZIANA
distici
Formazione
l verso: archi-
locheo magg,
Schema
_l vv,
_!vv,
J.v
2 verso: trlme- -
tro gia1nbico v_!.' v!!...." v l_.!.' v!!....,
ln1puro catai.
l
0
verso: rsarne-
tro dattilico
- ,
v L ~
_!.uv,
_! vv'
_!.v
2 verso: dirne- - - "
tro giambico v ...! ' v !!.. " v f .2. , v "':::::!
impuro acata-
lettico
l" verso: esame-
tro dattilico
2 verso: trlme-
tro giambico
acataJ, puro
_!. vv t _!. VVt
...J.\-/Vt _!uv, ...J.v
"'-'..2' v ~ .. vJ ' "
_,v_,,
,
Struttura dei versi
Archilocheo maggiore: tetrapodia
dattilica acatal. (con cesura seml-
quinaria ed il quarto dattilo puro)
+ il verso itifallieo (tripodia tro-
caica acatal.). Dieresi tra le parti
componenti.
Trlmetro giambico Impuro ca t.:
tripodia giambica Impura catai.
Nelle sedl dispari il giambo pu
essere sostituito dallo spondeo.
Cesura semlquinaria (cfr. 80).
Esametro dattilico: come al N. 5
(verso primo).
Dimetro giambico Impuro aca-
tal.: come al N. 4 (verso secondo).
Esametro dattilico: come al N. 5
(verso primo).
Trimetro giambico acat. puro:
tripodia. giambica acatal. pura,
con cesura semiquinaria. Non am-
mette la sostituzione delle lunghe
alle brevi e non scioglie In brevi
le sillabe lunghe ed usato In
forma pura in tutto l'epodo 16.
1 verso: dime-
tro trocaico ca t.
In syll.
"
-V> _!v,
,
-v
~ 1\ Dimetro trocaico cat. in syll.:
due dipodie trocaiche catai. in
svllabam.
,
V-''
2 verso: trirne- : ~ ,
tro giambico
impuro catai.
- ,
l' verso; glico-
neo secondo
v L ~
Trimetro giambico Impuro ca-
tal. come al N. 9 (verso secondo).
Glieoneo secondo: tetrapodia lo-
gaedica catai. in syllabam, con
spondeo o t.rocheo in P sede e
dattilo in 2 sede; ovvero: uno
spondeo o trocheo base, un dat-
tilo e una dipodia trocaica cata-
lettica in syll. Raramente trovasi
usato il trocheo in P sede.
2 Terso: asde-
piadeo Jnioore
_t_, _!.vv, ....1.1\,
-l.VV! _f_vJ ~ / \
Il Asclepiadeo minore: Come al N 2.
Segue
Nn-
mero
14
)5
16
Esempi
Lydia., dic, per omnis
t ~ deos oro, Syba.rfn cur pro-
(pers amando
Vids ut iUta. stt nive candi-
[dum
Soracte nc ia.m sustineimt
[o nus
Rilva. la.bora.nts geluque
flumina. constiterint acUto.
Mrcurf, facunde n epos AtHm-
[tis,
qui feros cultus bominum re-
[entum
voce formasti ca.tus t de-
[cora.e
more jJalstrae,
TAVOLA RIASSUNTIVA
B) Sistemi
Classificazione
metrica
dei Carmi
Odi, I, 8.
Metro
Saffico maggiore
C) Sistemi
Odi, I, 9, 16, 17, (Strofa)
26, 27, 2!), 31, 34, (iJ.'I"p0\1
Alcaica
-.p(xw-
35, 37; 0\1)
II, l, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 14, 15, 17, 19,
20;
III, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
17. 21, 23, 26, 29;
IV, 4, 9, 14, 15.
Odi, I, 2, 10, 12,
20, 22, 25, 30, 32,
38;
II, 2, 4, 6, 8,10,16;
III, 8, 11, 14, 18,
20, 22, 27;
IV, 2, 6, 11 e Car-
men Saeculare
(Strofa) Safflca
minore
(iJ.'I"pov lxwov)
DELLA METRICA ORAZIANA
distici
Formazione Schema
1 verso: arislo- 2 v v, ......!... v, 2 v
fa neo
2 verso: saJfico
naggiore
Tetrastici
l verso: alcaico
endecasillabo
_!v, _i_,_!. 1/ uv,
....! 1\ ,. Il ..1. v v, ..1. v,
...!.v
~ 2, v ..1., ~ 1\, !l_! v v,
J v ...!./\
2 verso: alcaico - -1\ Il
v_!., v-..!, v ' ......!... v\ ../)
endecasillabo
3 verso: alcaico ;,::; ...!. ,
enneasillabo
4 verso: alcaico
de(asillabo
I verso: safJico
minore
2 verso: saflico
...!.v
...l.. v,
_L v'
v...!., v_!.,
_!..v v,
_!-' ...!.
l
-
...!.v
nlinore Come il precedente.
3 verso: salfico
minore
4. verso: adonio
Come Il precedente.
v _t,
v v,
Struttura del versi
Aristofaneo: tripodi a dattllico-tro-
caica acatalettica, con dattilo in
1 sede; (un dattilo e due trochei).
Salfico maggiore: uguale al sar-
flco minore, di cui al N. 16, + una
dipodia dattilica catai. in s11llabam
inserita dopo Il 2 piede del sat-
llco miuore. Cesura (dieresi) dopo
la 3 arsi, e cesura stabile, che
dieresi, dopo la dlpodla dattilica
Inserita, cio: dopo 1'8 sillaba.
Alcaico endeeasillabo: tre giambi
di cui l'ultimo catai. in SIJll. con la
sostituzione della lunga alla breve
nel primo e terzo piede+ tripodia
dattilico-trocaica catai. iu S!ll-
labam. Cesura stabile (dieresi) fra
le parti componenti.
Aleaieo endeea!!lllabo: come Il pre-
cedente.
Alcaico ennea!!illabo: quattro
giambi + una sillaba finale; spon-
deo nelle sedi impari.
Alcaico deeasillabo: tetrapodia
dattilico-trocaica acatalett. (due
dattili e due trochei) .
Safflco minore: pentapodia datti-
Iico-trocaica acatalettica, con dat-
tilo in 3 sede e lo spondeo nella
2 sede, oppure: un trocheo, uno
spondeo, un dattilo e due trochei
finali. Cesura semiquinaria; talora
trocaica dopo la 6 sillaba.
Adonio: dipodia dattilica catai. In
di!lllabam.
Segue
Nu
mero
17
18
19
Esempi
Scrfberfs Vario fortis et ho-
[f'tium,
victor :Maonii carminis alit,
quiim rem cumque ferox nii-
[vibus aut equis
mi! es t duce gsserit.
,
O refernt fn mare t
, [novi
fluctus! O qui d agis t Fortiter
[occupa
portum. Nonne vids, ut
nudum rmigio latus
Miserarumst nequ(e) amOri
dare ludum neque dulci
mala vino laver(e}, aut exa-
[nimari
metuntes patrua verbera
[linguae.
Miser3.rumst nequ(e) amOri
dare ludum neque dulci
mala vino laver(e) aut exa-
[nimiiri metuntes
patrua verbera lfnguae.
TAVOLA RIASSUNTIVA
Classificazione
metrica
dei Carmi
Odi, I, 6, 15, 24,
33;
II, 12;
III, 10, 16;
IV, 5, 12.
Odi, I, 5, 14, 21,
23;
III, 7, 13;
IV, 13,
Odi, III, 12.
C) Sistemi
1\fetro
(Strofa) Ascle-
piadea prima
([L't"pov l)(xooov)
(Strofa)
pia dca
{[L't"pov
ov)
A scie-
seconda
't"p[xoo-
D) Composizioni
Periodi decame-
lrlci di tonici a
1ninore
DELLA lUETRICA ORAZIANA
Tetrastici
Formazione
1 verso: ascle-
piadeo minore
z verso: ascll!-
pladeo minore
3 verso:
pladeo minore
4 verso: glico-
neo secondo
1 verso: ascle-
piadeo n1inorc
2 verso: ascle-
piadeo minore
3 verso: lerarre-
teo secondo
Schema
2 1\ Il
__,_ 1\ Il
2 1\ Il
JJI\
Struttura dei versi
Asclepiadeo n1inore: come al N. 2.
_.!v, _2. v v, ..!... v, '.:k 1\ Gliconeo secondo: con1e al N. 13
(verso primo).
2 1\ , Il Asclepiadeo min.: come al N. 2.
:k(\
_!. 1\ ' l!
:kl\
_!v
Ferecrateo secondo: tripodla lo-
ll'aedica acatalettica con spondeo
o trocheo In 1 sede e dattilo In
2 sede.
4
8
verso: glico-
2
v, _.!v v, ...!.. v, 1\
neo !!econdo
Gliconeo secondo: come al N. 13
(verso primo).
ipermetriche
1 verso: dlpodla
di lonlci a mi-
nore
2 verso: Idem
3 verso: tripodi a
di lonicl a mi-
nore
4. verso: Idem
1 verso: dipodia
di ionicl a mi-
nore
2 verso: Idem
3 verso: tetra-
podio di !onici
a minore
4. verso: dlpodia
di lonlcl a mi-
nore
v v_!_, v v_!.-, v v-L-
v v_!_, v v_!_, v v_!-
SCHEMA B.
vv...l-tvv...l.-
Nola. - Le trascrizioni di questi
periodi decametrici di !onici a. mi-
nore sono varie e tutte le divisioni
sono possibili, perch l singoli piedi
dell'ode coincidono quasi sempre
con la fine della parola. Preferiamo
la trascrizione tetrastica, della quale
diamo due schemi:
A) La. prima e la. seconda. riga
comprendono due piedi di !onici a
minore; la terza e la quarta., tre piedi
di !onici a minore.
B) La prima, seconda. e quarta
riga comprendono due piedi di !onici
a minore; la terza riga, quattro piedi
di !onici a minore. Per il resto con
fronta. 123.
INDICE
P.tEFAZIONE ...... Ptl]. Tll
PARTE I
P ROSO DIA
CAPO I. - Poesia accentuativa e quantitativa . . . . . rag. 3
l. Prosodia.- 2. Poesia accentuativa.- 3. Versi
accentuativi italiani Jemplici e composti. - 4. Poesia
quantitativa. - 5. Cenni sull'origine della poesia
quantitativa e accentuativa
CAPO II. - Nozioni preliminari intorno alla sillaba latina
e alla sua quantit . . . . . . . . . . 6
6. La sillaba latina. - 7. Divisione delle sillabe
latine nel corpo della parola. - 8. Sillabe aperte e
chiuse.- 9. Quantit delle sillabe latine.- l O. Rap.
porto fra l'accento tonico e la quantit delle sillabe.
l, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CAPO III. - Quantit delle sillabe latine per natura e per
posizione . . . . . . . . . . . . . . . . Il
11. Quantit delle sillabe per natura.- 12. Quan.
tit delle sillabe per posizione. - 13-14. Regole
sulla quantit delle sillabe in posizione forte ed in
posizione debole e intorno alla vocale seguita da altra
vocale.
Esercizio 3, 4, 15, 6. . . . . . . . . . . . . . 14
CAPO I V. -Quantit delle sillabe finali dei polisillabi uscenti
in vocale (sillabe aperte) . . l G
15. Quantit della vocale a, finale di polisillabi. -
16. Quantit della vocale e finale di polisillabi. -
-156-
17. Quantit della vocale i, finale di poli;:tillabi -
I R. Quantit della vocale o, finale di polisillabi. -
19. Quantit della vocale u, finale di polisillabi. -
20. Quantit della y, finale di polisillabi.
Esercizio 7 . . . . . . . . . . . . . . . Paf!. 19
CAPO V. - Quantit delle sillabe finali dei pollsillabi uscenti
in consonante (sillabe chiuse) . . . . . . . 18
21. Regola generale sulla quantit delle sillabe
finali di polisillabi uscenti in qualsiasi consonante
che non sia s. - 22. Quantit della sillaba finale as:
- 23. Quantit della sillaba finale es. - 24. Quan-
tit della sillaba finale os. - 25. Quantit della sil-
laba finale is. - 26. Quantit della sillaba finale us.
- 27. Quantit della sillaba finale ys.
Esercizio 8 . . . . . . . . 22
C.uo VI. - Quantit dei monosillabi
28. Quantit dei monosillabi uscenti in vocale.
- 29. Quantit dei monosillabi uscenti in conso-
nante sostantivi e aggettivi. - 30. Quantit dei
monosillabi uscenti in consonanti che non siano so-
f>tantivi o aggettivi.
Esercizio 9 . . . .
CAPO VII. - Quantit delle sillabe radicali nelle forme
derivate e nelle parole composte . . . .
31. Regola generale.
Esercizio 10 . . . . . . .
CAPO VIII. - Quantit dei prefissi .
32. Regole generali
Esercizio 11 . . . . . . . .
CAPO IX. -Quantit della flessione -verbale
33. Elementi costitutivi del verbo. - 34. Quan
tit della sillaba radicale di un verbo: regola gene
rale. - 35. Quantit deol.la sillaba radicale in tutte
le forme verbali derivanti dal medesimo tema tem-
porale. - 36. Quantit dei perfetti e dei supini
bisillabi. - 37. Quantit dei perfetti con raddop-
piamento. - 38. Quantit delle sillabe interne
di un verbo, formate dalle vocali tematiche. -
39. Quantit delle sillabe interne di un verbo,
formate dalle vocali copulative. - 40. Quantit
22
23
24
26
27
28
29
- 157-
delle sillabe interne di un verbo formate dal suf-
fisso temporale ba dell'imp. ind.- 41. Quantit della.
sillaba interna di un verbo, formata dal suffisso tempo-
rale i del perfetto indicativo. - 42. Quantit della
sillaba interna di un verbo, formata dal suffisso tem-
porale del presente congiuntivo e dell'imperfetto con-
giuntivo. - 43. Quantit della sillaba interna di
un verbo, formata dal suffisso temporale bi del fu-
turo semplice indicativo (l e II coniug.), dal suffisso
temporale e del futuro semplice ind. (III e IV co-
niugazione). - 44. Richiamo alla quantit delle
sillabe finali delle forme verbali.
Esercizio 12, 13 . . . . . . . . ...
CAFO X. -Licenze prosodiclle . . . . . ..
45. Elisione, iato, sineresi, dieresi, sistole, dia-
stole. - 46. Alterazioni per metaplasmo: protesi,
aferesi, epentesi, sincope, paragoge, apocope, tmeRi,
metatesi.
PARTE II
METRICA
CAPO I. - Ritmo - Arsi e tesi Piedi .
47. Definir,ione. - 48. Ritmo. - 49. Arsi e
tesi. - 50. Piedi. - 51. Piedi fondamentali o ritmici
e piedi derivati o impropri. - 52. Piedi distinti
secondo il tempo e secondo il numero delle sillabe.
- 53. Piedi acatalettici e tronchi. - 54. Piedi di-
scendenti e ascendenti. - 55. Piedi pari ed impari. -
56. Piedi in serie: dipodia, tripodia, tetrapodia.,
pentapodia, esapodia, ecc. - 57. Piede irrazionale.
Tavola riassuntiva del piede
CAPO II. - Verso - Cesura - Scansione e lettura metrica -
Versi in serie indeterminata ed in composizione strofica
58. Membro, periodo ritmico, verso. - 59. Verso
puro ed impuro. - 60. Versi composti o asinarteti. -
61. Versi misti o logaedi. - 62. Chiarimento sul
significato di metro nei versi giambici e trocaici. -
63. Distinzione di versi secondo la specie dei
piedi componenti. - 64. Versi completi ed incom
Pag.
33
36
50
51
-158-
pleti e ipermetri; chiarimeuti sulla disposizione della
parola per formare i piedi del verso. - 65. Cesura.
maschile e femminile - Dieresi. - 66. Scansione
del verso e lettura metrica. - 67. Versi in serie
indeterminata ed in composizione strofica. - 68.
Sistemi: distico, tristico, tetra.stico.
Tavola riassuntiva del periodo ritmico o verso Pag. 57
CAPO III. - Varie specie di metri - Metri dattilici . . . 57
69. Esametro dattilico. - 70. Esametro s pon.
daico. - 71. Cesure dell'esametro dattilico. -
72. Alcuni suggerimenti per ben comporre degli
e ~ a m e t r i lati n i. - 73. Pentametro elegiaco. -
74. Adonio. - 75. Archilocheo. - 76. Alcmanio.
Esercizio 14, 15, 16 . . . . . . . . . . . . . .
CAPO IV. - lUetri giambici
77. Senario giambico puro. - 78. Senario giam-
bico impuro. - 79. Schemi di senario giambico im-
puro usati da li'edro. - 80. Trimetro giambico im-
puro catalettico. - 81. Trimetro giambico ippo-
natteo. - 82. Dimetro giambico ipercatalettico.
Esercizio 17, 18, 19 . . . . . . .
CAPO V. - Metri trocaici . . . . . . .
83. Dimb.:o trocaico catalettico. - 8-!. Verso
itifallico.
CAPO VI. - Metri logaedici . .
85. Gliconeo secondo. - 86. Ferecrazio se-
condo. - 87. Priapeo. - 88. Asclepiadeo minore.
- 89. Asclepiadeo maggiore. - 90. Saffico minore.
- 91. Saffico maggiore. - 92. Alcaico endecasil-
labo. - 93. Alcaico decasillabo. - 94. Aristofaneo.
- 95. li'aleceo.
Esercizio 20 . . . .
CAPO VII. - l\letri asinarteti
96. Archilocheo maggiore. - 97. Giambelego. -
98. Elegiambo.
CAPO VIII. - Metri ioniri
99. Ionico a minore. - 100. GalliamiJo anaclo-
meno. - 101. Sotadeo.
66
71
77
80
81
86
88
90
Tavola riassuntiva dei principali metri . 92
- 159
PARTE III
METRICA ORAZIANA
CAPO I. - Nozioni preliminari . . . . . . . . . Pag.
l 02. Classificazione dei carmi oraziani. - l 03. Vari
tipi di strofe tetrastiche. - 104. Tavola schematica
delle forme metriche usate da Orazio.
CAPO II. - Composizioni monosti('l!e . . . . . . . . .
105. Trimetri giambici in composizione mono-
siica.
Esercizio 21 . . . . . . .
106. Asclepiadei minori in composizione mono-
stica.
Esercizio 22 . . . . .
107. Asclepiadei maggiori in composizione mo-
nostica.
Esercizio 23 .
CAPO III. - Sistemi distici
108. Sistema epodico (sistema giambico).
Esercizio 24 . . . . . .
109. Sistema alcmanio (sistema dattilico puro).
l!Jsercizio 2.5 . .
110. Sistema arcliilocheo primo (sistema dat-
tilico puro).
Rse1cizio 26
111. Sistema archilocheo secondo (sistema
giambico Hiattllieo).
Escrf'izio 27 .
112. Sistema archilocheo terzo (sistema giam-
bico-dattilico).
Esercizio 28 . .
113. Sistema archilocheo quarto (sistema lo-
gaedico-giambico ).
Esercizio 29 .
101
104
105
106
108
109
110
112
114
116
117
119
-160-
114. Sistema piliambico primo (sistema giam-
oico-dattilico ).
Esercizio 30 . Pag. 120
115. Sistema. pitia.mbico secondo (sistema giam-
bico- dattilico).
Esercizio 31 . . . .
116. Sistema ipponatteo (sistema gia.mbico-
trocaico).
Esercizio 32 . . . . . . .
li 7. Sistema asclepiadeo minore terzo (sistema
loga.edico ).
Esercizio 33 . .
118. Sistema saffico maggiore (sistema logae-
dico).
Bsercizio 34 . .
CAPO IV. - Sistemi tetrastici
119. Sistema alcaico (strofa tetra!>tica alcaica).
Esercizio 35 .
l 20. Sistema saffico minore (strofa tetrastica
saffico minore).
Esercizio 36 .
121. Sistema asclepiadeo primo (strofa tetrastica
asclepadea 1 a).
Esercizio 37 .
l 22. Sistema asclepiadeo secondo (strofa tetra-
etica asclepiadea 2 ).
Esercizio -38
CAPO V. - Composizioni ipermetriche .
lndiet
l 23. Periodi decametrici di ionici a minore.
l 24. Tavola riassuntiva della metrica ora2iana.
123
125
127
129
130
131
134
137
139
141
144
155
Potrebbero piacerti anche
- Dialogoi Percorsi Di Lessico GrecoDocumento52 pagineDialogoi Percorsi Di Lessico Grecosdreca100% (5)
- Szemerényi, Introduzione Alla Linguistica IndoeuropeaDocumento373 pagineSzemerényi, Introduzione Alla Linguistica IndoeuropeaHansOrberg1234Nessuna valutazione finora
- Grammatica Della Lingua Geroglifica Egiziana Di Base.Documento35 pagineGrammatica Della Lingua Geroglifica Egiziana Di Base.Elena100% (2)
- Guida alla traduzione del testo latinoDa EverandGuida alla traduzione del testo latinoNessuna valutazione finora
- Pisani - Grammatica Latina Storica e ComparativaDocumento322 paginePisani - Grammatica Latina Storica e Comparativajuliusevola88100% (14)
- Giorgio Pasquali - Filologia e Storia-Le Monnier (1971) PDFDocumento106 pagineGiorgio Pasquali - Filologia e Storia-Le Monnier (1971) PDFAdriano Aprigliano100% (1)
- LatinoDocumento68 pagineLatinoAntonio Imperi100% (2)
- Analisi LogicaDocumento16 pagineAnalisi LogicalorrisNessuna valutazione finora
- Studio Critico Della Lingua LatinaDocumento415 pagineStudio Critico Della Lingua Latinaבנ מיכאל בנ מיכאל100% (1)
- Epigrafia Cristiana Di MarucciDocumento592 pagineEpigrafia Cristiana Di MarucciFrancesco Patruno100% (6)
- Manuale Di Filologia ClassicaDocumento386 pagineManuale Di Filologia Classicasalliaci83% (6)
- Il Vocabolario Del Romanesco ContemporaneoDocumento18 pagineIl Vocabolario Del Romanesco Contemporaneobombonera12Nessuna valutazione finora
- Sintassi Greca 1Documento2 pagineSintassi Greca 1lely19770% (1)
- Appunti Di Grammatica EbraicaDocumento67 pagineAppunti Di Grammatica EbraicaPiero MancusoNessuna valutazione finora
- DonizettiDocumento2 pagineDonizettiAmoreViolaNessuna valutazione finora
- L Ottocento - Filosofia (64): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 65Da EverandL Ottocento - Filosofia (64): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 65Nessuna valutazione finora
- Lessico RomanoDocumento103 pagineLessico Romanolucapennazzi101Nessuna valutazione finora
- Liceo Classico de Adda Prima Lezione Di Greco AnticoDocumento39 pagineLiceo Classico de Adda Prima Lezione Di Greco AnticoHarold Rodriguez Echeverry100% (1)
- Conte. LatinoDocumento76 pagineConte. LatinoValentinaNessuna valutazione finora
- Paleografia Latina 1Documento8 paginePaleografia Latina 1Mattia Moretti100% (1)
- Ripetizione LatinoDocumento15 pagineRipetizione LatinoMartina FedericoNessuna valutazione finora
- Sistema Verbale LatinoDocumento17 pagineSistema Verbale LatinoAlessandro ValentiniNessuna valutazione finora
- Metodo Golfera - Guida Alla Memorizzazione Dei Verbi GreciDocumento23 pagineMetodo Golfera - Guida Alla Memorizzazione Dei Verbi GreciGianni Golfera ladro100% (3)
- Latino ArcaicoDocumento6 pagineLatino ArcaicopronaturaalNessuna valutazione finora
- Classi Verbali Del Greco AnticoDocumento6 pagineClassi Verbali Del Greco AnticoRaffaele Morelli100% (1)
- (Alfonso Traina) L'Alfabeto e La Pronunzia Del LatinoDocumento109 pagine(Alfonso Traina) L'Alfabeto e La Pronunzia Del LatinoKarl Vaneigem100% (1)
- Lessico LatinoDocumento930 pagineLessico LatinoEraldo Forti100% (3)
- Di Marzo 1946 Prosodia e Metrica Latina PDFDocumento84 pagineDi Marzo 1946 Prosodia e Metrica Latina PDFcavuscula100% (1)
- Dizionario Latino-Italiano Sec - Georges, Karl Ernst, 1806-1895 - 664 PDFDocumento1.464 pagineDizionario Latino-Italiano Sec - Georges, Karl Ernst, 1806-1895 - 664 PDFsebarm86100% (1)
- Monopoli Regolamento PDFDocumento4 pagineMonopoli Regolamento PDFgiovanni67% (3)
- Profilo Storico Della Letteratura TardolatinaDocumento335 pagineProfilo Storico Della Letteratura TardolatinaSettemontiErma1Nessuna valutazione finora
- Lista Di Paradigmi in Greco AnticoDocumento61 pagineLista Di Paradigmi in Greco AnticoDaniel Prieto DonosoNessuna valutazione finora
- P. Magnanini-Nava - Grammatica Di Aramaico Biblico - Book - 2005Documento168 pagineP. Magnanini-Nava - Grammatica Di Aramaico Biblico - Book - 2005Jose ColonNessuna valutazione finora
- Appunti Di LatinoDocumento16 pagineAppunti Di Latinoearthshine784_200534Nessuna valutazione finora
- Fondamenti Di Grammatica Storica e Dialettologia GrecaDocumento29 pagineFondamenti Di Grammatica Storica e Dialettologia GrecaC. Sessini100% (1)
- Il Latino nella secondaria di primo grado: Atti del Seminario per Docenti della Scuola secondaria Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di PadovaDa EverandIl Latino nella secondaria di primo grado: Atti del Seminario per Docenti della Scuola secondaria Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di PadovaNessuna valutazione finora
- Metrica Poetica ItalianaDocumento44 pagineMetrica Poetica ItalianaCabascarica100% (1)
- Tantucci PDFDocumento1 paginaTantucci PDFEzio0% (1)
- Bausi-Martelli MetricaDocumento4 pagineBausi-Martelli MetricaGiulia CardilloNessuna valutazione finora
- LATINO - Tavole Verbi Attivi e PassiviDocumento9 pagineLATINO - Tavole Verbi Attivi e PassivilevredNessuna valutazione finora
- Lineamenti Di Lingua D'oilDocumento21 pagineLineamenti Di Lingua D'oilValentina BaroneNessuna valutazione finora
- Regole MetricaDocumento14 pagineRegole MetricaAndyRollock100% (2)
- Sistema Verbale Greco AnticoDocumento21 pagineSistema Verbale Greco Anticomascio2001it1347100% (1)
- Storia e Storie Lingua Greca 2014Documento265 pagineStoria e Storie Lingua Greca 2014HelenNessuna valutazione finora
- La Pronuncia "Neutra, Internazionale" Del Latino ClassicoDocumento11 pagineLa Pronuncia "Neutra, Internazionale" Del Latino ClassicoSandra RamosNessuna valutazione finora
- 81 EBR Gli Accenti EbraiciDocumento4 pagine81 EBR Gli Accenti Ebraicilezione27Nessuna valutazione finora
- Fonetica Storica FormentinDocumento16 pagineFonetica Storica FormentinJulio JuanNessuna valutazione finora
- La Fabbrica Delle ParoleDocumento8 pagineLa Fabbrica Delle ParoleMonica CellaNessuna valutazione finora
- Le Origini Della Letteratura LatinaDocumento24 pagineLe Origini Della Letteratura LatinaAnonymous Kmu8VENessuna valutazione finora
- Epigrafia Greca Nell'Italia RomanaDocumento10 pagineEpigrafia Greca Nell'Italia RomanaGiuseppe DelfinoNessuna valutazione finora
- Momigliano Latino 377Documento43 pagineMomigliano Latino 377Italiano UATxNessuna valutazione finora
- Alfabeto Greco e LatinoDocumento8 pagineAlfabeto Greco e LatinoEdoardo BonaNessuna valutazione finora
- Paradigmi Latini Lessicali PDFDocumento10 pagineParadigmi Latini Lessicali PDFVXNessuna valutazione finora
- Aperte PaleografiaDocumento41 pagineAperte PaleografiaenricaNessuna valutazione finora
- La Lirica ItalianaDocumento68 pagineLa Lirica ItalianaSaraiNessuna valutazione finora
- Introduzione Oratoria, Retorica, Atticismo e AsianesimoDocumento2 pagineIntroduzione Oratoria, Retorica, Atticismo e AsianesimoDiego DeplanoNessuna valutazione finora
- Il Vocabolario Del Dialetto Napolitano Di Emmanuele Rocco. Studio Ed Edizione Critica Della Parte Inedita F-ZDocumento1.481 pagineIl Vocabolario Del Dialetto Napolitano Di Emmanuele Rocco. Studio Ed Edizione Critica Della Parte Inedita F-ZBruno SerraNessuna valutazione finora
- Principi di catalogazione e rappresentazione delle entità bibliograficheDa EverandPrincipi di catalogazione e rappresentazione delle entità bibliograficheNessuna valutazione finora
- Nozioni Metrica CardilloDocumento30 pagineNozioni Metrica CardillonagornykarabatNessuna valutazione finora
- Elementi Di MetricaDocumento10 pagineElementi Di MetricaRiccardo MuccardoNessuna valutazione finora
- La MetricaDocumento15 pagineLa MetricaFABIOLA BASELICENessuna valutazione finora
- Scrocchiazeppi - WikipediaDocumento2 pagineScrocchiazeppi - Wikipediakiko462Nessuna valutazione finora
- Ebook - Libri PianoforteDocumento14 pagineEbook - Libri PianofortePatrick Guarneri De Ornelas0% (1)
- Legrand - Residenziali e TerziarioDocumento150 pagineLegrand - Residenziali e TerziarioIonescu Silvian IonutNessuna valutazione finora
- Pesto Alla GenoveseDocumento2 paginePesto Alla GenoveseDaniele GallesioNessuna valutazione finora
- Tunisian SummitDocumento8 pagineTunisian SummitCherbiti Mohammed AmineNessuna valutazione finora
- Repertorio Di Base Di Verbi LatiniDocumento5 pagineRepertorio Di Base Di Verbi LatiniFrancesco CONIDINessuna valutazione finora
- Cavalleria Rusticana TesinaDocumento11 pagineCavalleria Rusticana TesinaCecilia X. CaiNessuna valutazione finora
- Appunti Hard Rock e Pink FloydDocumento5 pagineAppunti Hard Rock e Pink Floydgero.ciulla5372Nessuna valutazione finora
- Alfonso Gatto - Poesie in Versi - Il Piacere Di Scrivere e Pubblicare Online PDFDocumento9 pagineAlfonso Gatto - Poesie in Versi - Il Piacere Di Scrivere e Pubblicare Online PDFJoshua WatsonNessuna valutazione finora