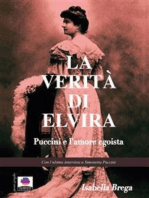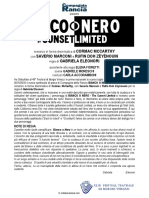Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
ERNA
Caricato da
Cristina Ventrucci0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2 visualizzazioni2 pagineRecensione teatrale
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoRecensione teatrale
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2 visualizzazioni2 pagineERNA
Caricato da
Cristina VentrucciRecensione teatrale
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 2
È cresciuta artisticamente tra i moti del teatro danza europeo più folle e critico –
Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre e Alain Platel – sviluppatosi
particolarmente in area belga. Ma Erna Omarsdottir non è belga bensì islandese, come
Bjork, con la quale ha pure collaborato, ed è quello stesso nord incandescente che si
sprigiona nella frizione tra lei e la scena. Un ribollire terraqueo, uno svaporare
vorticoso di essenze misteriose, aliti irrequieti e sorridenti che ci schiaffeggiano, ci
fanno il solletico, ci scrollano come a metà di un sogno trattenendoci in veglia dentro
quegli stessi onirici nodi. E si mette in moto una certa disordinata idea di libertà,
intima e carica di ormoni, slabbrata e acrobatica.
La tecnica, che pure è radicata nel suo corpo piccolo, atletico e sapiente, si mette da
parte, si rende invisibile grazie a tentativi di volo tra soma e voce che si svolgono in
un’idea di innocenza, e in accordo con altre musiche, suoni e respiri. La Omarsdottir
si pone alla danza in una elementare nudità, esposta, dichiarando ogni fragilità al
punto da usare i crolli come forza, e depistando i cliché.
Ciò che vediamo, assistendo ai suoi spettacoli – con particolare riferimento a due
produzioni realizzate in collaborazione col compositore Jóhann Jóhannsson,
collaboratore a sua volta di musicisti quali Marc Almond, Barry Adamson e Pan
Sonic – è qualcosa che ci riguarda per forza di cose, perché ha un’origine veritiera,
perché non si nasconde dietro paraventi o pedanterie, perché proprio grazie a questo si
mostra in tutta la sua forza politica e ribelle. Qualcosa che ci ricorda la nascita del
teatro come ciò che si esaurisce in un gesto e ne crea subito un altro.
Sotto la tecnica c’è lei
Un canto ipnotico, sembra in loop, lei deve essere da qualche parte, ma non si vede.
La scena ha l’aspetto disordinato di un luogo di prove, quasi vuoto, sulla destra una
postazione musicale e una pila di cavi elettrici. A luci ancora accese in sala, entra in
scena il musicista, sposta i cavi, sotto c’è lei. L’uomo siede alla tastiera (una carcassa
di clavicembalo dentro la quale sono innestati a vista un computer e un organo
elettronico Hammond B3, quasi come una ventraglia) e viene il buio.
Sussulti, contrazioni, espressioni epilettiche del corpo e del viso, così comincia la vita
scenica di Erna Omarsdottir in IBM 1401 - A user’s manual. Se l’idea è quella di un
manuale per l’uso, come suggeriscono sia il titolo che la voce diffusa a un certo punto
da un altoparlante, le istruzioni sono scritte in una lingua mai ascoltata prima, eppure
comprensibile a tutti. Si tratta di un fanciullesco catalogo di espressioni che la
Omarsdottir compone, con le musiche dal vivo di Jóhannsson, attraverso ginnastiche
facciali e fisiche, a tradurre emozioni e provocazioni: ora è una bambinaccia
irriverente, ora una ragazza disperata, poi una seduttrice, una rana, una pulzella
indemoniata che annega nel suo rapimento fisico, forse una santa dai capelli biondi
che si trasforma in figura da fumetto – può ricordare agli appassionati del genere certi
mostriciattoli ghermandiani abitati da grezza allucinazione – e cade a terra come in
morte apparente, o in stand by, per essere presto riattivata dal semplice tocco del
musicista. IBM 1401 si ispira alla storia del primo computer che arrivò in Islanda nel
1964: gli operatori insegnarono alla macchina a ‘cantare’ dotandola di un’abilità
umana. Tra musiche qua e là struggenti e animosità grottesca, sclerosi e improvvisi
blocchi, seguiamo l’azione di una sonnambula che ci appare sempre in bilico su un
crepaccio. Nella felicità infantile di un gioco continuo e autoreferenziale, si coglie il
sospetto di uno splendore dello stato autistico. E ogni tanto si tocca il sesso, ogni tanto
il movimento rallenta, preludendo a un nuovo accadimento. È una figura femminile
come identità multipla, come azzardo e istinto, come atto precritico, che sviscera
immagini e stati aldilà della ragione, in un legame continuo con l’infanzia,
quell’infanzia che sola ci impartisce istruzioni per trovare connessioni, codici di vita e
voci.
Dentro il canto c’è lei.
Immagini di un’adolescenza assassina, il suono elettrico di chitarre che scorticano i
corpi attraverso riverberi e amplificazioni, un’idea del caos cosmico e di una
primavera burrascosa. In The mysteries of love, l’altro spettacolo creato col musicista
Jóhannsson, la Omarsdottir si sdoppia in un parto gemellare dalla memoria anche un
po’ horror, ed entra in scena mano nella mano con Margret Sara Gudjonsdottir. Sono
candide streghe, sono farfalle, sono bambole stuprate, imbellettate e sbavate, lolite in
rosso e rosa che aprono e consumano capitoli sull’adolescenza, sul femminile,
sull’eros. Le due, in scena con il musicista, compongono una partitura che cavalca la
dismisura dell’invasamento amoroso, che provoca i “crampi dell’angoscia” per dirla
con Lea Melandri, e scaturisce dall’incontenibile pressione emotiva dell’adolescenza,
col vento che da dentro muove i capelli. “Dire niente o dire troppo, niente vie di
mezzo” sembra essere il patto amoroso della loro esistenza, portata senza veli su volti
conturbanti. Non addomesticate, emancipate per loro stessa natura, orfane
d’innocenza, dotate di tenerezza e avvinghiate l’una all’altra come senza confini,
eseguono dieci pezzi fisico-vocali, dimensione nella quale Erna cerca la via per
abitare le verità indicibili. La voce cerca una fusione col corpo attraverso una canto un
po’ punk, ma nel quale trovano spazio anche mugugni e versi segreti di due
adolescenti apparentemente frontali e disarmate, ma anche guerriere, forse amazzoni
còlte in tutta la loro forza e vulnerabilità.
Potrebbero piacerti anche
- Analisi Azucena TrovatoreDocumento3 pagineAnalisi Azucena TrovatoreDavideMaruiMedasNessuna valutazione finora
- NOTE REGIA Coefore - Eumenidi Daniele SalvoDocumento2 pagineNOTE REGIA Coefore - Eumenidi Daniele SalvoSilvia ArosioNessuna valutazione finora
- Irrlicht - SchulzeDocumento5 pagineIrrlicht - SchulzeJackNessuna valutazione finora
- Festino Della Sera Del Giovedì Grasso - BanchieriDocumento4 pagineFestino Della Sera Del Giovedì Grasso - BanchieriGiacomo CornonNessuna valutazione finora
- LisztDocumento3 pagineLisztMarta SaulleNessuna valutazione finora
- Il TuonoDocumento5 pagineIl TuonoGiorgio ButtittaNessuna valutazione finora
- Tuono AnalisiDocumento3 pagineTuono AnalisiElisa Parise100% (2)
- Stagione Teatrale Teatro Guglielmi22Documento13 pagineStagione Teatrale Teatro Guglielmi22Gianni BelléNessuna valutazione finora
- Divina Commedia - PressBook 2020Documento7 pagineDivina Commedia - PressBook 2020SilviaarosioteatroNessuna valutazione finora
- Lucia Di LammermoorDocumento3 pagineLucia Di LammermoorGaia AmmaturoNessuna valutazione finora
- Testi Pascoli e D'AnnunzioDocumento3 pagineTesti Pascoli e D'Annunziofederica0505Nessuna valutazione finora
- Binomio d’amore: Musica e poesia sulle corde della vitaDa EverandBinomio d’amore: Musica e poesia sulle corde della vitaNessuna valutazione finora
- Histoire Vs PierrotDocumento15 pagineHistoire Vs PierrotIan SirbuNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO Principali Poesie Di PascoliDocumento2 pagineRIASSUNTO Principali Poesie Di PascoliFab ioNessuna valutazione finora
- Storia Del 900Documento26 pagineStoria Del 900Francesco RonzioNessuna valutazione finora
- Breve Storia Opera LiricaDocumento6 pagineBreve Storia Opera LiricabesciamellaNessuna valutazione finora
- Sintesi Introduzione Opera Italiana Di BianconiDocumento4 pagineSintesi Introduzione Opera Italiana Di BianconiAlvise MazzucatoNessuna valutazione finora
- Fiabe incendiarie Cuentos incendiarios Зажигательные сказки Incendiary TalesDa EverandFiabe incendiarie Cuentos incendiarios Зажигательные сказки Incendiary TalesNessuna valutazione finora
- Il TuonoDocumento5 pagineIl TuonogiaiselNessuna valutazione finora
- Fausto Romitelli Il Corpo ElettricoDocumento86 pagineFausto Romitelli Il Corpo ElettricopaolutusNessuna valutazione finora
- DONATELLA MELINI Flauto MagicoDocumento130 pagineDONATELLA MELINI Flauto MagicoLalalallalaNessuna valutazione finora
- Tesina Metodologia AlessandriniDocumento20 pagineTesina Metodologia Alessandrinip4r4n01d-4ndr01dNessuna valutazione finora
- Il Mito Di Arianna e Il Melodramma BaroccoDocumento6 pagineIl Mito Di Arianna e Il Melodramma BaroccoValeria La GrottaNessuna valutazione finora
- Flauto MagicoDocumento130 pagineFlauto MagicoLalalallalaNessuna valutazione finora
- Enciclopedia Della Musica TraviataDocumento2 pagineEnciclopedia Della Musica TraviataEszter SzegediNessuna valutazione finora
- Romanticismo in MusicaDocumento37 pagineRomanticismo in MusicaPatty GiacaloneNessuna valutazione finora
- NUDO Comunicato StampaDocumento1 paginaNUDO Comunicato StampaSilvia ArosioNessuna valutazione finora
- AVANGUARDIE STORICHE 2Documento19 pagineAVANGUARDIE STORICHE 2Francesca StuaniNessuna valutazione finora
- Alessandro MartinisiDocumento6 pagineAlessandro MartinisiEsonet.orgNessuna valutazione finora
- Foscolo Le Grazie Il Velo 10-13Documento5 pagineFoscolo Le Grazie Il Velo 10-13smataloneNessuna valutazione finora
- Presentazione Concerto StabelloDocumento4 paginePresentazione Concerto StabelloMattia SonzogniNessuna valutazione finora
- LA MUSICA FDocumento7 pagineLA MUSICA FFrancesca D'AdamoNessuna valutazione finora
- BIANCO O NERO The Sunset Limited - Comunicato Stampaott15 PDFDocumento4 pagineBIANCO O NERO The Sunset Limited - Comunicato Stampaott15 PDFSilvia ArosioNessuna valutazione finora
- Antonio Ghislanzoni - Il-Violino-A-Corde-UmaneDocumento24 pagineAntonio Ghislanzoni - Il-Violino-A-Corde-Umanetrash trashNessuna valutazione finora
- IlBallo Delle Ingrate Tra Monteverdi e BergmanDocumento2 pagineIlBallo Delle Ingrate Tra Monteverdi e BergmanmarynewNessuna valutazione finora
- 05 - Produzioni Coproduzioni RipreseDocumento16 pagine05 - Produzioni Coproduzioni RipreseClaudia GrohovazNessuna valutazione finora
- Lettura Della Traviata 2013 PDFDocumento103 pagineLettura Della Traviata 2013 PDFnefandoinfingardo100% (3)
- Vinicio Capossela TourDocumento7 pagineVinicio Capossela TourSimona Mazza DueNessuna valutazione finora
- Così Fan TutteDocumento5 pagineCosì Fan TutteDomenico CameraNessuna valutazione finora
- Il Collezionista Di Emozioni Di Stanislao LiberatoreDocumento40 pagineIl Collezionista Di Emozioni Di Stanislao LiberatoreFilippo SchiaviNessuna valutazione finora
- Latture 5 Laura MarchigDocumento80 pagineLatture 5 Laura MarchigAnna CastellariNessuna valutazione finora
- Scheda Dettagliata - Romeo e Giulietta Ama e Cambia Il MondoDocumento27 pagineScheda Dettagliata - Romeo e Giulietta Ama e Cambia Il Mondovistasulpalco0% (1)
- Cosi Fan Tutte-MozartDocumento22 pagineCosi Fan Tutte-MozartGiacomo CornonNessuna valutazione finora
- Die Glueckliche Hand LocandinaDocumento5 pagineDie Glueckliche Hand LocandinaAurora StamerraNessuna valutazione finora
- Mozart, Leopold - MusetteDocumento1 paginaMozart, Leopold - MusetteLiliana SilvaNessuna valutazione finora
- SchonbergDocumento7 pagineSchonbergjhon drinkwaterNessuna valutazione finora
- Bach Minuet in G Major BWV Anh. 114Documento1 paginaBach Minuet in G Major BWV Anh. 114F e w z e yNessuna valutazione finora
- CoroDocumento4 pagineCoroSusanaRoblesCisternaNessuna valutazione finora
- Yann Tiersen La Valse Des MonstresDocumento3 pagineYann Tiersen La Valse Des MonstresEleni KefalidouNessuna valutazione finora
- O Dolce Vita MiaDocumento2 pagineO Dolce Vita MiaAntonio ArnofiNessuna valutazione finora
- Italianoopera pp16 33Documento18 pagineItalianoopera pp16 33arturocalleNessuna valutazione finora
- BRANODocumento3 pagineBRANOShila CapezzutoNessuna valutazione finora
- Tutti Insieme AppassionatamenteDocumento3 pagineTutti Insieme AppassionatamenteGiovanni NorritoNessuna valutazione finora
- Ave Maria: LentoDocumento3 pagineAve Maria: LentoPasqualeNessuna valutazione finora
- Introduzione e Variazioni Sull'Arie Di Malbroug (Fernando Sor) Rev. ChiesaDocumento8 pagineIntroduzione e Variazioni Sull'Arie Di Malbroug (Fernando Sor) Rev. ChiesaCiccillo RussoNessuna valutazione finora
- Catalogo FaniaDocumento12 pagineCatalogo FaniaCARLOS ROCHEL100% (2)
- Trattati e MetodiDocumento5 pagineTrattati e MetodideboraNessuna valutazione finora
- Cant Help Falling in Love - PIANO PDFDocumento4 pagineCant Help Falling in Love - PIANO PDFSamuelNessuna valutazione finora
- THE EDGE SOUND (Ita)Documento11 pagineTHE EDGE SOUND (Ita)Giangregorio SuraceNessuna valutazione finora
- Musicologia Estratto Dal DEUMMDocumento5 pagineMusicologia Estratto Dal DEUMMAnonymous YrSzLyNessuna valutazione finora
- Langgaard OggiDocumento2 pagineLanggaard OggiTrappola AcusticaNessuna valutazione finora
- La Poesia Della Provvida SventuraDocumento2 pagineLa Poesia Della Provvida SventuraCesareMarinacciNessuna valutazione finora
- SCHEDA Il Combattimento Di Tancredi e ClorindaDocumento2 pagineSCHEDA Il Combattimento Di Tancredi e ClorindaMikhaelDejanNessuna valutazione finora
- Tu Che Di Gel Sei CintaDocumento4 pagineTu Che Di Gel Sei Cintacoat av88% (8)
- Tablatura Vengo Solterito HuaynoDocumento1 paginaTablatura Vengo Solterito HuaynoImpresiones SolerNessuna valutazione finora
- A2 Attiva Lessico ProfessioniDocumento4 pagineA2 Attiva Lessico ProfessioniLingua Italiana100% (2)
- SCALE AND ARPEGGIO-Classical - GuitarDocumento1 paginaSCALE AND ARPEGGIO-Classical - Guitarvincent berameNessuna valutazione finora
- Otello - LibrettoDocumento36 pagineOtello - LibrettoAndreaNessuna valutazione finora
- Storia Del Jazz 1Documento17 pagineStoria Del Jazz 1Fausto Chinaski VillaNessuna valutazione finora
- Brunetta - S. IngoDocumento18 pagineBrunetta - S. Ingodario la macchia100% (3)
- Pavane For Guitar and Clarinet PDFDocumento4 paginePavane For Guitar and Clarinet PDFismailakmuradovNessuna valutazione finora
- La Cumparsita. Tango PDFDocumento5 pagineLa Cumparsita. Tango PDFNatalia Zofia Ruszkowska100% (1)
- Appunti PropedeuticoDocumento8 pagineAppunti PropedeuticoChiara MartinelliNessuna valutazione finora
- LazioinCoro Ott Nov 18 PDFDocumento32 pagineLazioinCoro Ott Nov 18 PDFnadiuccia63Nessuna valutazione finora