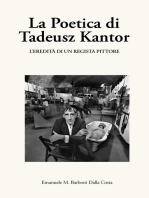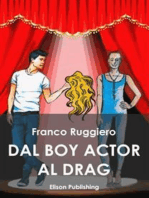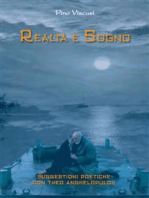Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Ripensare Il Novecento Teatrale
Caricato da
Martina CuomoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Ripensare Il Novecento Teatrale
Caricato da
Martina CuomoCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|11124565
Ripensare Il Novecento Teatrale
Storia del teatro e dello spettacolo (Università di Bologna)
StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
1. IL PROCESSO CREATIVO NEL TEATRO CONTEMPORANEO.
Se esiste un dato sul quale concordano gli studi teatrali (“Nuova Teatrologia” = studio continentale e in
particolare Italiano; “Performance Studies” = studio di area anglosassone e americana) oggi, questo è la
centralità del processo, dei processi rispetto al prodotto. L’oggetto specifico degli studi teatrali non è più
il testo o lo spettacolo in sé, quanto il teatro nella sua interezza, complesso dei processi produttivi che lo
compongono.E’ stato il fondatore dei Performance Studies, Victor Turner, a chiarire che la “svolta post-
moderna” negli studi scientifici e sociali-antropologici ha garantito maggiore attenzione al processo e
alle qualità processuali. Tutto ciò che interessa il processo creativo lo ritroviamo a monte di uno
spettacolo teatrale: dall’adattamento del testo al lavoro degli attori, le prove etc. Eugenio Barba lanciò
contro gli studiosi di teatro l’accusa di avere una visione da spettatore, parziale, imprigionati in quel
“etnocentrismo teatrale” che relegava l’importanza dello spettacolo al suo risultato finale, al prodotto.
La comprensione storica del teatro è spesso bloccata e resa superficiale –dice Barba- dal trascurare la
logica del processo creativo ma, oggi, questi pregiudizi e sottovalutazioni sono via via in fase di
superamento. Difficile non citare, in questo senso, Grotowski: il regista polacco, durante il periodo
stalinista e di censura degli spettacoli ammette l’importanza delle prove. “Là accadeva qualcosa fra un
essere umano e un altro. Nel teatro abbiamo un anello visibile –lo spettacolo- e un altro quasi invisibile
–le prove-.” Le prove sono per Grotowski un terreno in cui, l’attore, riscopre se stesso, le sue capacità e
le possibilità di superare i propri limiti. Parlando di prove, non è sbagliato ricordare che è proprio il
novecento –con l’avvento della regia- l’età d’oro del processo creativo. Mirella Schino scrive che, con il
termine “regia” ci si riferisce “ad un nuovo modo di fare e di pensare il teatro, che implica, da una parte,
una presenza creatrice dominante e maieutica e, dall’altra, unità e coerenza tra le diverse componenti
della messinscena”. Il regista come collante, come supervisore (almeno quando non “despota”) un aiuto
nel passaggio dello spettacolo da “contenitore” a “opera”. Le prove –che proprio per questo si
allungano- servono dunque a consentire questo passaggio, garantendo allo stesso tempo unità e
coerenza fra tutti gli elementi compositivi dello spettacolo. I padri fondatori della regia vedevano lo
spettacolo come un’opera d’arte in sé, basato su un testo drammatico e cioè ponendosi come messa in
scena di questo. La scelta del testo è dunque il primo passo nel processo creativo, da sempre
emarginato e segmentato in più parti da assegnare in base al sistema dei ruoli. Solo dalla metà dell’800
circa si videro le prime importanti battaglie contro il vecchio sistema del teatro delle parti e dei ruoli,
grazie anche ad una drammaturgia che, con Strindberg, Ibsen, Cechov, si allontanò dai personaggi tipici
dei secoli precedenti. E’ certamente evidente che l’arrivo della regia portò con sé –sostanzialmente- due
modi di lavorare: la regia demiurgica (despota) e la regia maieutica. Lasciamo la parola a Stanislavskij:
“Nel periodo in cui il regista era un despota egli costruiva tutto il progetto dello spettacolo, indicava lo
schema generale delle parti, prendendo in considerazione naturalmente gli attori e mostrava loro tutta
la ‘faccenda’. Io stesso fino a pochi anni fa seguivo questo metodo di allestire i drammi. Ma ora sono
giunto alla convinzione che il lavoro creativo del regista deve procedere all’unisono con quello degli
attori e non precorrerlo né reprimerlo. Egli deve agevolare la creatività degli attori, sorvegliarla e
integrarla, vigilando…” Anche Brecht –che passò dalla demiurgica alla maieutica- dice la sua,
sostenendo che una lunga durata delle prove, per un regista maiuetico, è imprescindibile, data la
difficoltà nel conciliare così tanti fattori con così tanti “collaboratori-attori”. Anche quando non si
condivideva l’esigenza stanislavskiana di un lavoro sui sentimenti e sulla memoria emotiva dell’attore
per metterlo in condizione di creatività, cioè di poter vivere e non soltanto di recitare, il creare regia
insieme agli attori presupponeva la dilatazione dei tempi. L’affermarsi di un’idea di una pratica
maiuetica della regia ha contribuito inevitabilmente ad assegnare ulteriore importanza ai processi
creativi. Ma c’è un altro fenomeno che incide profondamente sui processi produttivi e, cioè,
l’allontanamento dal testocentrismo per l’avvicinamento ad un metodo di lavoro scenocentrico. Ancora
Eugenio Barba ci offre un’interessante speculazione in tal senso, distinguendo due metodi lavorativi:
quello per il testo e quello con il testo. Lavorare per il testo significa assumere l’opera letteraria come
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
valore principale dello spettacolo. Attori, regia, organizzazione dello spazio, musica e disegno di luci si
impegnano a far emergere la qualità dello scritto. Lavorare con il testo vuol dire scegliere uno o più
scritti, non per mettersi al loro servizio, ma per estrarre la sostanza che alimenti e esalti lo spettacolo in
sè, la scena. La matrice del teatro scenocentrico è quanto mai più inaspettata, poiché le prime
“speculazioni di metodo” vengono proprio dal maestro russo, tanto legato al testo. Stanislavskij
sperimenta il “metodo delle azioni fisiche” portando ad una delle più grandi svolte teatrali del XX
secolo. Non si parte più dai sentimenti, dalla memoria emotiva, dalle reviviscenze ma
dall’improvvisazione, dai movimenti. Agli attori non era neppure consentito proferire parole che
fossero del testo: lo scopo di questo metodo era quello di liberare quelle reviviscenze, quelle
sensazioni, dai movimenti che agli attori si chiedeva di trovare. Soltanto completata questa fase, l’attore
poteva ritornare al testo. Stanislavskij dava ragione ai suoi allievi circa l’inaffidabilità delle emozioni
come punto di partenza, prediligendo l’azione fisica, decisamente più solida. D’altro canto, egli è
convinto che la reviviscenza possa venire attuata automaticamente dalla giusta azione fisica, che,
conseguenzialmente, ne provoca una “interiore”. Si badi con incredibile attenzione che cambia soltanto
il punto di partenza, nient’altro: l’interiorità, infatti, resta il fulcro del personaggio e lo scopo da
raggiungere di tutto il nuovo metodo. E’ così che possiamo riparlare di Grotowski, affermando
l’importanza del metodo delle azioni fisiche che ebbe per il maestro polacco. Il suo erede, Thomas
Richards, ci ribadisce però che tra il lavoro di Grotowski e quello del maestro russo c’è una sostanziale
differenza: “Stanislavskij ha centrato la sua ricerca sullo sviluppo di un personaggio all’interno di una
storia e nelle circostanze raccontate dal testo teatrale. L’attore si domanda: qual è la linea logica di
azioni fisiche che farei se mi trovassi nelle circostanze di questo personaggio? Nel lavoro di Grotowski,
invece, gli attori non cercavano mai i personaggi. Cieslak –attore protagonista ne ‘Il principe costante’-
non aveva mai lavorato sul personaggio della tragedia di Calderon ma solo su ricordi personali connessi
a un importante evento della sua vita.” Parliamo dunque di un intenso staccamento dal personaggio.
Grotowski parte dal metodo stanislavskiano pur rielaborandolo a proprio modo: se nel metodo del
maestro russo il fine era il personaggio e l’interiorità un mezzo, Grotowski inverte il tutto. E’ l’interiorità
dell’attore il fine, poiché il personaggio risulta essere soltanto un mezzo per raggiungere quella
consapevolezza di sé e quasi offrirla in “sacrificio”. E’ facile intuire, dunque, che l’emancipazione
dell’attore dal personaggio va di pari passo con la definitiva fuoriuscita dal testocentrismo. Se Il principe
costante rappresenta l’emancipazione dell’attore dal personaggio, “Apocalypsis cum figuris”, ultimo
spettacolo di Grotowski, passa alla storia come il tentativo di superamento della rappresentazione.
Flaszen, consigliere letterario del Teatr Laboratorium, ci spiega come Apocalypsis cum figuris sia stato
creato dagli attori, sotto la guida del regista, usando il metodo dell’improvvisazione. Il testo, a seconda
delle necessità, veniva improvvisato nel corso delle prove per poi giungere, in fase finale,
all’individuazione del materiale verbale adeguato e indispensabile che andasse a sostituire le battute
provvisorie trovate precedentemente dagli attori. I tre lunghi anni del lunghissimo processo creativo
dello spettacolo furono un estenuante corpo a corpo fra la “troupe” e la forma spettacolo e i suoi limiti
di rappresentazione (oltre che con le edizioni precedenti). Questo scontro, questa voglia di spingersi
sempre al di là non terminò neppure col primo debutto del 1969, tant’è vero che dopo Apocalypsis non
ci furono altri e nuovi spettacoli del maestro polacco, se non altre due versioni dell’ultimo. Interessanti
paiono le parole di Grotwoski sulla “genesi” di Apocalypsis, scritte nella postfazione al primo libro di
Richards: “Cerchiamo qualcosa di cui abbiamo solo un’idea iniziale, una certa concezione. Se cerchiamo
con intensità e coscienziosamente, forse non troviamo proprio quello, ma potrà apparire qualcos’altro
che può dare una direzione diversa a tutto il lavoro.” Non è un caso infatti che, durante i tre anni di
lavoro, quest’ultimo abbia cambiato più volte rotta, passando dapprima dal poema di Slowacki e poi dai
Vangeli, cadendo inevitabilmente in una serie di cose viste e riviste. Si decide dunque, in questo
momento, di mettere da parte i riferimenti letterari per dedicarsi al piano dell’improvvisazione degli
attori: “Non era un montaggio di testi. Era qualcosa a cui arrivammo durante le prove, attraverso lampi
di rivelazione e improvvisazioni.” Ancora una volta intuiamo l’importanza delle prove, dell’esperienza
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
che l’attore vive sulla propria pelle, tangendo il territorio, i movimenti, la propria interiorità: un flusso di
cose e umanità alle quali Grotowski dava assoluta priorità, pur quando nascevano conflitti tra i processi
creativi dei propri colleghi (“una rappresentazione dell’umanità”). Il modo in cui Apocalypsis era nato, in
bilico fra spettacolo e suo superamento lo caratterizzò per tutti e dieci gli anni di vita che ebbe,
cambiando molte volte (almeno tre volte ufficiali). Non è certo un caso che le trasformazioni andavano
tutte nella direzione di una progressiva “presa di distanza dalla dimensione estetica e teatrale”:
dall’eliminazione delle panche per il pubblico sino alla rinuncia da parte degli attori ad ogni
connotazione legata al costume. Passiamo ora al processo creativo dell’Odin Teatret (di Barba) che così
si suddivide in 3 parti: il lavoro individuale del regista, che sceglie temi; il lavoro individuale degli attori
che elaborano –sotto l’egida del regista, ma anche autonomamente- i materiali utili alla
rappresentazione; le prove vere e proprie, collettive. A queste tre fasi ne succede quella finale,
consistente nella rielaborazione, da parte di Eugenio Barba, di tutto il materiale ottenuto dalle fasi
precedenti: una sorta di assemblaggio che potrebbe pure distruggere tutto il lavoro precedente
dell’attore (e del regista stesso che sceglie i temi). Come abbiamo già sottolineato, dunque, il processo
creativo novecentesco diviene qualcosa di più: non è più semplicemente fine alle sorti dello spettacolo
bensì muta in un’esperienza non soltanto artistica ma anche umana. Siamo alle prove-non-del-tutto-
per-lo-spettacolo di cui parlava Grotowski, qualcosa che già l’ultimo Stanislavskij aveva intravisto
lavorando a “Tartufo”, quando non si preoccupava di andare in scena. E’ quanto accade, insomma,
nell’ultima fase della ricerca post-teatrale di Grotowski: l’Arte come veicolo. Nell’Arte come veicolo
infatti ricompaiono delle opere performative, le Azioni, che somigliano a degli spettacoli pur non
essendoli. Queste performance nascono per produrre degli effetti in chi le esegue, nei performer e non
in chi le guarderà. Concludendo, c’è da dire che oggi più che di crisi o superamento della regia possiamo
parlare di una crisi riguardante prettamente la figura del regista stesso. Ci troviamo di fronte a un
fenomeno di cessione di “sovranità” da parte del regista in favore dell’attore o, ancora, assistiamo alla
proposta di un “team di regia” o, addirittura, di un regista a rotazione. Il processo creativo nel “teatro
senza il regista” (o “post-registico”) si impone come un qualcosa di non definibile a priori, non
pianificabile, anche a causa del ruolo che in esso può giocare l’improvvisazione.
2. L’OPERA D’ARTE TOTALE.
Tra il ‘700 e ‘800 non abbiamo teatro che non si sia confrontato con le teorizzazioni di Wagner
sull’”opera d’arte totale”. Già durante il periodo Romantico le arti si andavano sovrapponendo e molte
furono le critiche –ricordiamo quella di Nice o di Adorno- nei confronti dell’opera d’arte totale che
consisteva, per l’appunto, nell’unione di più arti. Quanto detto da Wagner possiamo dire essere il punto
di partenza per la nascita della regia: si potrebbe ammettere, infatti, che il primo teorico e fondatore
della regia sia proprio Adolphe Appia. Lo scenografo svizzero partì proprio dal lavoro del compositore
tedesco, intitolando il primo libro sulla questione “La messa in scena del dramma Wagneriano” ma la
regia teatrale nasce, in particolare, con il volume “La musica e la messa in scena”. Dunque, la prima
teoresi discende direttamente da Wagner, o, per meglio dire, contro Wagner. Secondo Appia se, da una
parte, il dramma wagneriano risulta essere un qualcosa che va al di là di ogni forma semplice e banale,
che punta ad esprimere l’essenza –grazie all’ausilio della musica e della poesia- d’altro canto, c’è pure
da dire che a livello di rappresentazione il tutto cade in un realismo esagerato. Si badi dunque la
contraddizione: simbolismo-realismo. In “Richard Wagner e la messa in scena”, Appia riassume bene la
questione: “Egli pretendeva che la sua musica trovasse sulla scena una realizzazione. Ciò che egli aveva
detto più che a sufficienza al nostro orecchio, voleva offrirlo letteralmente ai nostri occhi. Ed è così che
seppelliva la sua opera.” E dunque si intuisce ancor meglio come nasce la contraddizione simbolismo-
realismo. Appia punta, però, più sulla questione dell’attore, messo da Wagner al centro della sua
visione teatrale nonostante poi, nel momento di dover definire gli altri fattori inanimati della scena, il
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
compositore non si confronta con l’attore ma, piuttosto, ritorna nuovamente al testo. Piccola differenza
per Appia il quale sostiene che, in principio, c’è la musica e sotto di essa l’attore (alla quale si adatta
anche nelle movenze), definendo dunque una gerarchia di mezzi al servizio della musica che, ad ogni
modo –e qui v’è la differenza- tiene ben presente le necessità del dramma. Wagner sostiene –
contraddicendosi- che l’errore nel genere d’arte dell’opera consiste nel fare del mezzo d’espressione (la
musica) lo scopo, e al contrario, nel fare dello scopo dell’espressione (il dramma) il mezzo. Wagner dice,
ma non rispetta. Dunque, nella poetica di Wagner troviamo da un lato il Wort-Tondrama che deve
essere messa in scena seguendo le modalità rigidamente fissate dalla musica, dall’altro c’è l’attore, nel
sistema di Appia, che funge da intermediario fra il dramma e lo spettacolo, fra opera e scena,
occupando un posto molto alto nella gerarchia di Appia, pur se subordinato alla musica. Ma da dove
viene all’attore questa capacità mediatrice? Ebbene, secondo Appia l’attore, in quanto uomo, ha in sé il
principio della musica che è pure alla base dell’opera del poeta musicista. Certamente non è discutibile
l’idea che l’uomo sia perfettamente conciliabile con la musica ma, d’altro canto, l’attore finisce poi per
acquisire una tale autonomia, nel rapporto uomo-musica, da farsi creatore svincolato dalla stessa
musica. Nell’opera wagneriana è presente sempre un gioco di compromessi fra musica e attore: Appia,
che pure crea una gerarchia di mezzi li fa sottostare, ad ogni modo, alla necessità del dramma; Wagner,
invece, nonostante sostenga il contrario, non concepisce l’idea di dover sacrificare un po’ della sua
potenza musicale che, per di più, come già detto, non trovava una giusta esteriorizzazione. In La musica
e la messa in scena, Appia intuisce la necessità di una “ginnastica musicale” che servisse da
intermediaria tra l’attore e la musica. Quello che è importante sottolineare è la trasformazione radicale
della teoresi di Appia: partito dal dramma wagneriano, arriva a immaginare un nuovo Wort-Tondrama,
senza Wagner, dove assume incredibile centralità il corpo dell’attore-danzatore. Passando infine
dall’esperienza della Ritmica dalcroziana (educazione musicale che collega ritmica e movimenti)
definisce una volta e per tutte la centralità unica del corpo umano o del “corpo collettivo”. Si passa,
dunque, dall’opera d’arte totale all’opera d’arte vivente, un evento teatrale basato sulla relazione fisico-
corporea fra attore e spettatore. Possiamo sostenere, ad ogni modo, che queste due linee estetiche
discendano dallo stesso Wagner e che, addirittura, la linea estetica teatrale legata alla corporeità si
definirà maggiormente in quel teatro chiamato “povero” da Grotowski o, ancora, con Peter Brook,
Mejerchol’d, Artaud, con l’Odin Teatret di Barba o ancora con il Living Theatre. Cosa interessante risulta
un alto fenomeno e, cioè, quello di registi che passano dal teatro totale a quello povero, dalla regia
demiurgica a quella maieutica: accade a Stanislavskij, a Mejerchol’d, a Artaud, Brecht, Grotowski, Peter
Brook etc. Il lavoro di Wagner, pure se con qualche difetto e contraddizione, è certo che ispirò tra i più
importanti registi del ‘900. Parlando di Craig possiamo dire che, seppur il concetto di teatro totale del
regista inglese sia profondamente diverso da quello wagneriano, perché basato su elementi linguistici –
e non sulle arti- e perché riguarda il teatro come linguaggio specifico in sé, e non come linguaggio dei
linguaggi, è abbastanza evidente come il teatro di Craig sia stato modellato riprendendo quello
wagneriano. O ancora, parlando di Mejerchol’d, possiamo affermare che l’inventore della bio-meccanica
si sia ispirato ancora una volta a Wagner: se quest’ultimo esprimeva “l’inesprimibile” con la musica, con
l’orchestra, Mejerchol’d invece sfruttava il corpo e la gestualità non accordata alle parole. Un altro
incredibile contributo di Wagner è quello di aver reso il cantante lirico un vero e proprio attore
drammatico: ha costretto i propri colleghi innanzi tutto a farsi personaggi, attori, prima che cantanti. Il
Gesamtkunstwerk è chiaro si sia diffuso prevalentemente in Germania, ma pure dove si sentiva
maggiormente l’influenza delle avanguardie storiche si ottennero risultati poi non troppo differenti.
Fuchs, per esempio, ricordato tra i padri fondatori della regia con Appia e Craig, era per un teatro
“corale orgiastico”, dionisiaco, che favorisse il coinvolgimento fisico degli spettatori, travolti dal
movimento degli attori; ed era pure avverso al teatro totale poiché diceva che il teatro “è un arte di per
sé. Il dramma è possibile senza parola e senza suono, senza scenografia e senza costumi, semplicemente
come movimento ritmico del corpo.” Due anni dopo cambiò idea, ripensando il teatro wagneriano –
improvvisamente come il suo- come un’unione delle singole energie sotto l’idea generale dell’accadere
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
drammatico. Anche Erwin Piscator (amante della tecnica più estrema che schiaccia attore e spettatore),
diversamente influenzato dai teatranti della Germania, voleva creare una comunità politica così come
Wagner voleva crearne una mistica: qui si rivela la somiglianza tra i due e, cioè, la volontà di conservare
l’idea che il teatro sia quasi un posto sacro. E ancora, pure Schlemmer e Moholy-Nagy, studenti della
Bauhaus, risentono delle teorie wagneriane, tanto da far asserire Schlemmer così: “Quasi nessun altro
campo artistico è così polivalente come quello scenico; quasi nessun altro comprende tanti elementi in
sé, ragione per cui nacque il concetto dell’opera d’arte totale.” Ciò che accade nel ‘900, insomma, non è
lo scomparire della “totalità” ma, piuttosto, il suo riformularsi in maniere differenti. Si fa avanti, nel
‘900, pure l’idea che il teatro più completo sia quello più povero e, non a caso, Decroux –inventore della
Ritmica dalcroziana- sostiene proprio questo quando risponde a Baty e alle sue accuse che lo ritraggono
come il “distruttore” della parola. Non siamo lontani dalla teoresi di Grotowski sul teatro povero: qui
non si lavora più sullo spettacolo quanto sull’attore, il quale dovrebbe essere in grado di dar vita in
scena, in relazione con lo spettatore, a un “atto totale”, da “uomo totale”. Lo stesso sostiene Artaud
quando parla dell’attore come un “atleta del cuore”, capace di agire efficacemente, quasi magicamente,
sullo spettatore attraverso il completo dominio dei propri mezzi espressivi. In altri termini, l’opposizione
più significativa del 1900 non è quella del teatro totale vs teatro povero, ma, piuttosto, teatro totale vs
attore totale. Ritornando al teatro totale di Wagner e concludendo, dobbiamo ammettere che le
modalità di unione fra le diverse arti non sono del tutto chiare. Wagner si dichiara assolutamente
contrario alla confusione delle diverse arti, in cui cioè ciascuna rinuncia al proprio specifico per
prevalere sulle altre e, anzi al contrario, dice che il dramma mira ad attuare una comunità di tutte le arti.
Giusto e preciso appare quanto detto da Paolo Bolpagni: “…l’unità delle arti del teatro dell’arte totale
riemerge negli anni sessanta e settanta del Novecento, quando esplode il fenomeno della intermedialità
e, sotto le insegne dadaisteggianti…” Nulla di più vero: così come nell’800 (circa) le arti vengono ad
unirsi verticalmente, in una scala gerarchia ideata da Appia, pure nel ‘900 le arti si accostano
orizzontalmente, senza alcuna differenza di importanza. Non è forse un caso che la regia, tutto sommato
tesa all’unità degli elementi scenici, inizi a delinearsi proprio quando viene a galla l’idea di un teatro
totale, comprendente più arti.
3. REGIA E POST-REGIA.
Ad oggi, nonostante molti siano i libri sulla regia teatrale editi negli ultimi anni, si può parlare di un
“vuoto”, una carenza di approfondimenti che comparino la regia contemporanea a quella novecentesca:
Julian Beck, Judith Malina, Grotowski, Brook, Barba etc. Probabilmente, delle eccezioni sono i libri di
Mirella Schino: “La nascita della regia teatrale” o “Alchimisti della scena. Teatri laboratorio del
Novecento europeo”; o ancora, quelli di Annalisa Sacchi: “Il posto del re. Estetiche della regia teatrale
nel modernismo e nel contemporaneo”. A Eugenio Barba gli si deve riconoscere lo sforzo teorico (post-
novecentesco) più importante. Ricordo in particolare il libro intitolato “Bruciare la casa. Origini di un
regista”. Questo libro, in realtà narrativo-autobiografico, si può comunque leggere come un vero e
proprio trattato di regia. Ma perché i registi di oggi non teorizzano la propria “disciplina”? Ebbene,
questo rifiuto parte da lontano, almeno in Italia, già dagli esponenti più importanti della prima
generazione del Nuovo teatro italiano e, cioè, con Carmelo Bene e Leo de Berardinis. Sia Bene che Leo
hanno scritto parecchio, ma mai approfondendo in maniera adeguata la questione della regia e del
regista. Bene parla della “scrittura di scena” che alla fine diventa “di-scrittura scenica”, sostanzialmente
sull’irrappresentabilità e sulla non-rappresentazione. Leo invece sintetizza –“in Teatro e
sperimentazione”- la distinzione fra spettacolo ed evento teatrale. A questo punto, che il silenzio in
questione abbia a che fare con una diffidenza e un rifiuto nei confronti della pratica registica diventa più
che un sospetto. Questa mancanza di una teorizzazione registica che, come già detto, nasce sin dal
Nuovo Teatro Italiano, riguarda soprattutto l’allontanamento proprio dai due termini “regia” e “regista”.
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
Cesare Ronconi, rispondendo di mala voglia a una domanda sul ruolo del regista oggi, risponde: “La
regia è un nomignolo che rimanda a un re. Io ritengono di essere servitore di un processo creativo
meraviglioso e vitale”. Giorgio Barberio Corset, invece: “Ma poi cosa vuol dire dirigere? Non si dirige
nulla, ci si lascia dirigere.” Si capisce bene, dunque, che dichiarazioni del genere –facilmente trovabili-
indicano un rifiuto di quella pratica registica demiurgica che, probabilmente, le garantiva anche una
certa importanza. E’ interessante osservare, come, del resto, anche nel trattato di Barba il lavoro
registico venga teorizzato interamente in termini di “drammaturgia” e montaggio” (i termini “regia” o
“regista” ricorrono pochissimo), cioè come un lavoro che si muove sui tre principali livelli di
organizzazione dello spettacolo: il livello della drammaturgia organica o dinamica; il livello della
drammaturgia narrativa; il livello della drammaturgia evocativa. A parte Appia, Craig e Mejerchol’d,
l’unico e importante contributo teorico sulla regia è stato scritto da un regista cinematografico:
Ejzenstejn. Stiamo parlando, in effetti, di un superamento della regia, fenomeno in auge oramai da circa
due decenni. La questione è chiaramente legata alla figura dell’attore: la regia diventa qualcosa di
omogeneo al lavoro dell’attore, quasi al suo servizio e, non così rari sono i casi in cui il regista cessa la
propria “sovranità” nelle mani dei performer. Chiaramente le ragioni trovabili sono molteplici, come,
per esempio, l’imporsi dell’idea di un “collettivo artistico” senza distinzioni fisse di ruoli. Ma anche
laddove non si arrivi al team di regia o al regista “a rotazione” l’accento è sempre più spesso posto su di
una figura che faccia dell’apertura, della collaborazione, della mediazione, le caratteristiche maggiori
del proprio ruolo. In Italia, chi ha meglio e da maggior tempo assorbito questo “metodo lavorativo” è
senz’ombra di dubbio il Teatro delle Albe di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Si badi, inoltre,
che un’altra motivazione della perdita della centralità del ruolo del regista la si può tranquillamente
trovare in quella concezione che vede il processo creativo dello spettacolo come un qualcosa di
assolutamente unico, non prevedibile o programmabile a priori, anche a causa del ruolo che in esso può
avere l’improvvisazione. Ad ogni modo, se fino ad ora abbiamo parlato di un “teatro-senza-regista”,
possiamo affermare pure l’esistenza di un teatro che si oppone al precedente. Si tratta, in altri termini,
del rilancio della figura del regista demiurgo o despota. Romeo Castellucci a più riprese ha dichiarato il
suo scetticismo verso la creazione collettiva, insistendo sulla solitudine dell’artista come condizione in
un’epoca dove “la solitudine è l’altra faccia dell’individualismo”. Cosa accomuna queste due linee
registiche post-novecentesche? Certamente il superamento del testocentrismo e pure l’importanza che
si attribuisce al processo creativo. Su entrambi questi due versanti della regia contemporanea
assistiamo ad un’adozione di quella che è stata chiamata la “svolta performativa”, consistente nella
decostruzione/destrutturazione della messa in scena, facendola conseguenzialmente deragliare dai suoi
binari classici di rappresentazione (unità e coerenza scenica). Come decostruire la classica messa in
scena? Tramite i “segni teatrali postdrammatici”: simultaneità, frammentarietà, discontinuità,
ripetizione, incompiutezza, sospensione del senso, corporalità etc. Secondo Mirella Schino questa
novità consentì il “passaggio dello spettacolo da ‘contenitore’ a ‘opera’”. Ad oggi, invece, lo spettacolo
teatrale non è semplicemente un’”opera” ma neppure un mero ‘contenitore’. Piuttosto, lo spettacolo
oggi è un’“opera-contenitore” dove il criterio dell’unità e coerenza scenica viene messo in discussione.
Per “opere-contenitori” si intende dunque lo spettacolo dove gli elementi scenici non sono più fusi
(paratatticamente), gli uni subordinati agli altri bensì, sono accostati ipotatticamente nella loro relativa
autonomia-indipendenza e nella loro eterogeneità performativa. In questo senso, risulta essere
importante l’ultimo spettacolo di Leo de Berardinis “Come una rivista. Da Eschilo a…”. Il titolo allude
proprio al suo modo di lavorare: la creazione “a rivista”, a numeri, da montare in seguito. Non è un caso,
poi, che Ejzenstejn abbia dato importanti contributi pure alla teorizzazione del montaggio
cinematografico, oltre che alla regia. In un intervento dei nostri maggiori registi, Federico Tiezzi, ha
avanzato una distinzione fra “registi” e “costruttori”: “Nel caso dei ‘costruttori’ esiste un legame molto
forte con la performance, e non si può parlare di ‘regia’ come la intendevano Reinhardt o Craig. Sono
assemblaggi performativi di materiali disparati su tema. Mi pare, oggi, prevalere la tendenza alla
‘costruzione’ e quindi una perdita (tecnica) della pratica registica.” L’opera-contenitore è proprio
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
questo: l’assemblaggio performativo di materiali disparati su tema. Concludendo, di recente è stata
avanzata l’ipotesi di ripensare la regia come la risultante del lavoro e dell’interazione di tre diverse
scritture: la drammatica, la scenica (già conosciute) e quella performativa. L’ipotesi è che la scrittura
performativa possa operare come fattore destrutturante della scena (e delle altre due scritture).
4. BRECHT, AUTORE E REGISTA.
Il volume “Brecht regista. Memorie dal Berliner Ensemble” composto da Meldolesi e Laura Olivi,
ricostruisce la storia di Brecht, regista e autore, e della sua compagnia: i Berliner Ensemble. Sono gli
anni faticosi del dopoguerra, che videro fra l’altro la crescita progressiva della tensione fra Est-Ovest
(guerra fredda). Per quanto riguarda il teatro si tratta di un periodo di faticoso intermezzo fra la stagione
dei padri fondatori (tutti morti meno Craig) e quella ancora di là da venire del nuovo teatro, con gli
autori dell’assurdo e il Living Theatre, Brook, Grotowski etc. E’ sostanzialmente grazie alla tournée
parigina del 1954 che l’Occidente scopre la eccezionale realtà dei Berliner Ensemble e il valore di Brecht
come regista. Roland Barthes così ricorda lo spettacolo in Francia: “…tra il Berliner e gli altri teatri ho
percepito una differenza non di grado, ma di natura. Alcuni di quelli che l’hanno visto allora hanno
avuto la rivelazione di un sistema nuovo, che rendeva drasticamente superato tutto il nostro teatro.
Quella novità non aveva nulla di provocatorio e non attingeva al solito repertorio dell’avanguardia. Era
invece, in un certo senso, una rivoluzione sottile. Quel teatro intelligente, politico, un teatro
divertente…” Che Brecht dovesse essere considerato un grande regista, forse il più grande di quel
dopoguerra, fu opinione condivisa da molti. La figura di Brecht e quella della sua compagnia, arrivò a
livelli incredibili, tanto da schiacciare il Brecht regista in favore del Brecht drammaturgo e teorico. Lo
studio delle modalità registiche dell’ultimo Brecht è stato affrontato principalmente in Inghilterra e negli
Stati Uniti, aree teatrali poco influenzate dall’incredibile fortuna del Brecht teorico e drammaturgo. Non
è un caso che nella maggior parte dei libri sulla regia novecentesca, usciti negli ultimi anni in Italia, lo
spazio riservato al Brecht regista è quasi sempre molto scarso. Come spiega Meldolesi la fortuna del
Brecht regista la si ritrova nel vero e proprio trasnfert creativo: Brecht smette di scrivere drammi per
dedicarsi all’attività registica. Secondo Meldolesi il lavoro registico di Brecht si rifà fortemente al mondo
inconfondibile di fare poesia dell’ultimo Brecht. Meldolesi fornisce inoltre un triplice contributo: agli
studi sui rapporto fra l’artista e il potere stalinista, agli studi brechtiani mediante la valorizzazione del
lavoro registico e agli studi sul teatro del Novecento e sulla regia teatrale. Riguardo al primo contributo
del critico in questione, possiamo affermare che Meldolesi abbia affrontato il rapporto in esame con
assoluta imparzialità. Per salvare il suo lavoro e quello dei Berliner, ma anche semplicemente per quieto
vivere, Brecht venne spesso a compromessi: accettò di fare poche dichiarazioni pubbliche in favore del
regime. Ad ogni modo, Brecht restò sempre un marxista e comunista, visto che non c’era un’altra
alternativa per rispondere all’aggressività imperialistica degli USA. Passando al secondo contributo di
Meldolesi, possiamo affermare che, secondo il critico a cui ci riferiamo, Brecht dovesse essere inserito
nel pantheon dei gradi registi del secolo, almeno per 4 motivi. Il primo motivo riguarda il Berliner
Ensemble, una realtà teatrale importante e ben finanziata; osserva Meldolesi: “Era un teatro di grandi
numeri…” Il teatro dei Berliner era un’istituzione culturale, un teatro dedicato alla fama di Brecht. Al suo
interno, tra l’altro, Brecht riuscì a scavarsi un laboratorio di ricerca e sperimentazione, ponendosi come
“cerniera” fra i primi teatro-studio/Atelier della prima metà del ‘900 e i veri e propri teatro-laboratori
della seconda metà del ‘900. I Berliner, dunque, si ponevano al centro fra il “vecchio” e il “nuovo”: se da
una parte erano vicini ai futuri laboratori teatrali –per la coincidenza fra sperimentazione e spettacolo
nello stesso teatro- d’altro canto non vi erano neppure così vicini, poiché, nonostante avessero pure
anticipato qualche dinamica del lavoro di gruppo, continuavano ad agire nel rispetto delle “leggi
classiche” teatrali. Per quanto riguarda, invece, il rapporto con i primi atelier, basta dire che, se questi
agivano in favore di uno studio e una sperimentazione pedagogica sull’uomo, Brecht credeva che il
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
teatro fosse, in sé e per sé, un luogo elaborativo, un luogo sociale, utile al cambiamento della società. Il
secondo motivo per il quale –secondo Meldolesi- Brecht dovrebbe entrare tra i miglior registi del ‘900,
riguarda la ricostruzione dei passaggi attraverso i quali Brecht bruciò le tappe di un vero e proprio
apprendistato registico, passando da un tipo di regia demiurgica a quella maieutica. Per l’esattezza,
questa fase è successiva alla creazione del Berliner Ensemble. Ricordiamo in particolare il “Cerchio di
gesso del Caucaso” (1954), spettacolo dove, per la prima volta, si manifesta il Brecht “poeta-regista”,
terzo motivo per il quale dovrebbe essere considerato tra i migliori. L’ipotesi avanzata da Meldolesi è
appunto che, nel momento in cui Brecht si trasforma di fatto da drammaturgo a regista, egli prenda a
sentire la pratica registica affine alla sua poesia, facendo così un uso “poetico” dei mezzi teatrali, e non
più tecnico. Si badi, però, che il teatro di Brecht non è certo accostabile alle modalità tradizionali del
teatro di poesia: la sua idea era quella di creare tramite suggestioni, era quella di modellare –
sperimentando durante le prove- lo spettacolo dal suo interno; Brecht, in un certo qual dire, adattò il
processo creativo della poesia a quello spettacolare, non cadendo nella contraddizione del teatro di
poesia, a metà fra l’appartenenza teatrale e la derivazione letteraria. Un altro motivo per ritenere il
poeta-regista uno dei migliori è il suo approccio, dapprima ad una teoresi sistematica (con il “Breviario
di estetica teatrale”) e poi ad una teoresi registica più frammentaria (con “La dialettica del teatro”). Da
questi due libri e, di conseguenza, da teorie in contrasto fra loro, sarebbe nato -se ne avesse avuto il
tempo- il nuovo impianto di pensiero del Brecht degli anni ’50. Tuttavia, nonostante l’artista non sia
riuscito a compiere il passaggio dal teatro epico a quello dialettico, pare interessante il pregiudizio sul
sistema di Stanislavskij, nonostante poi, dopo il lavoro pratico con i Berliner, egli capisca che
semplicemente i due maestri avevano punti di vista differenti: Stanislavskij vedeva il testo dell’autore dal
punto di vista dell’attore, mentre Brecht vedeva l’attore a partire dalle esigenze dell’autore e del testo.
5. ARTAUD.
Artaud è stato, ed è ancora, uno degli uomini di teatro del Novecento più citati, più imitati e ovviamente
più fraintesi. Naturalmente esistono alcuni concetti che hanno fatto le spese più di altri con
banalizzazioni e, in primis è ovvio, quello della crudeltà. Allora bisogna cominciare col dire che sia il
concetto di crudeltà, sia quello della violenza, sono lontani da quella sfera dove vige l’eccesso sregolato,
lo scatenamento incontrollato e la violenza fisica senza pretesto, con tanto di sangue, spesso sfera dove
i due concetti sono stati ricondotti erroneamente. In realtà, Artaud cercò sin dall’inizio di allontanarsi da
banalizzazioni del genere, spiegando che, per lui, il teatro della crudeltà è crudele innanzitutto per sé
stesso regista, poiché dedito a un teatro difficile, crudele, estremamente tecnico. Ciò che è crudele non
è tanto l’uomo, quanto la realtà: “Noi non siamo liberi. E il cielo può sempre cadere sulla nostra testa.
Insegnarci questo è il primo scopo del teatro.” Per lui crudeltà vuol dire sostanzialmente un uso crudele
dei linguaggi scenici. Abbiamo dunque due accezioni del termine ma, come si può insegnare all’uomo
quanto la realtà sia crudele? Ebbene, per Artaud solo tramite un teatro estremamente difficile, che vada
oltre la mera rappresentazione, è possibile insegnare all’umanità la crudeltà della realtà. Possiamo
dividere il lavoro di Artaud in due fasi così chiamate: La messa in scena e la metafisica (anni ’30) e
forsennare il supporto (anni ’40). Partendo dalla seconda “formula”, e cioè dal periodo post-manicomio,
possiamo affermare che questa espressione (“forsennare il supporto”) rispecchia per bene le intenzioni
del regista. Artaud perseguita con determinazione la volontà di stravolgere a più livelli i supporti
utilizzati, che sia il corpo, la voce, la lingua etc. La volontà di questa operazione nasce a sua volta dal
desiderio di superare la mera rappresentazione e, si badi, risulti essere uno dei più coraggiosi tentativi
di superamento della rappresentazione. Artaud parla di un “vero teatro” che si oppone al teatro-
spettacolo perché riesce a forzare i limiti della convenzione finzionale, aspirando a porsi in termini di
azione reale, diretta, efficace e non più come azione rappresentata-rappresentativa. Parliamo ora dello
scritto compreso ne “Il teatro e il suo doppio” intitolato “La messa in scena e la metafisica”, espressione
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
con la quale indichiamo la prima fase di Artaud negli anni ’30. Si parte da un dipinto primitivo del
fiammingo Luca di Leida (“Le figlie di Loth”) che, per Artaud non è soltanto una rappresentazione ma
anche e soprattutto una realtà efficace, in grado di far sentire i suoi effetti ogni volta sullo spettatore del
quadro. Si direbbe che il pittore sia a conoscenza di certi segreti dell’armonia lineare, e dei mezzi per far
sì che essa agisca direttamente ed efficacemente sul cervello. E questo è quello che vuol far pure il
regista: far un uso estremo dei linguaggi spettacolari e aggiunge che questo equivale a “farne la
metafisica”. Ma cosa vuol dire “fare la metafisica dei mezzi” o “trarne le estreme conseguenze poetiche
dei mezzi”? Vuol dire, come ci spiega in La messa in scena e la metafisica, forzare gli usi dei mezzi
espressivi, servendosene cioè non più in funzione della rappresentazione ma andando oltre e,
primariamente, agire direttamente sullo spettatore. Artaud spiega: “Fare la metafisica del linguaggio
articolato significa indurlo ad esprimere ciò che di solito non esprime; significa servirsene in modo
nuovo, eccezionale e inusitato, significa restituirgli le sue possibilità di scuotimento fisico […] restituendo
loro il potere originario di sconvolgere e di manifestare effettivamente qualcosa, significa ribellarsi al
linguaggio, significa infine considerare il linguaggio sotto forma di Incantazione.” Si nota dunque la
continuità fra l’Artaud degli anni ’30 e quello degli anni ’40: l’obiettivo è pur sempre quello di superare
la mera rappresentazione per raggiungere il “vero teatro”. Nonostante le due fasi possano sembrare
totalmente conciliabili, possiamo ritrovare, in realtà, una differenza. Se nella fase degli anni ’30 si voleva
ottenere un superamento della rappresentazione, andando poi ad agire efficacemente sullo spettatore,
nella seconda fase, con il forsennamento del corpo (supporto) si sposta l’attenzione proprio sull’attore
che ne beneficerà. Il decondizionamento psico-fisico dell’attore –che era effettivamente l’obiettivo-
viene ben rappresentato da due immagini nel finale di “Pour en finir avec le jugement de dieu”: il corpo
senz’organi e il danzare alla rovescia. Tuttavia, pur nello spostamento dell’accento dallo spettatore al
performer, un altro elemento di continuità fra i due decenni è la funzione terapeutica-rigenerativa
assegnata da Artaud sin dall’inizio. Si va, dunque, da un teatro “per rifare la vita” a un teatro “per rifarsi
la vita”: il corpo senz’organi simboleggia proprio la libertà raggiunta e lo svincolamento persino dal
proprio corpo, così come il danzare al rovescio indica la capacità di reimparare. Artaud ci ha lasciato
innumerevoli disegni e il più importante risulta essere “La projection du vèritable corps”. Secondo
Caterina Pecchioli: “il corpo vecchio e indifeso sulla sinistra corrisponde a quello di Artaud: grazie alla
violenza inflittagli dai soldati, sprigiona una forza da cui si ricompone un corpo nuovo, il corpo “esploso”
di destra. Nel disegno in questione, la crudeltà, in forma di soldati che lanciano fiamme, agisce sul corpo
di sinistra, che è il vero corpo di Artaud, quello rinchiuso per nove anni in manicomio e di cui egli non si
sentiva più padrone. Il corpo di destra in posizione obliqua, quindi dinamica, sembra essersi liberato,
come “una trottola”, dal corpo imploso, ammanettato, ‘statico, sottoposto alla legge di gravità’ e
bloccato.” Uno degli ultimi testi scritti da Artaud, ripropone un’immagine apparentemente violenta,
parlando di un “teatro di sangue”. Ma in realtà, ancora una volta, così non è: per Artuad, sin dall’inizio, il
sangue simboleggiò la vita, come un simbolo del suo vitale, energico fluire. Nel teatro di sangue non c’è
violenza, niente eccessi cruenti: il teatro di sangue è il teatro del “guadagno”, tanto per l’attore quanto
per lo spettatore; è il teatro che, superando la recita e la finzione, muove in direzione di un agire
efficace e ri-generativo. “…un teatro di sangue, un teatro che ad ogni rappresentazione avrà fatto
guadagnare corporalmente qualcosa tanto a colui che recita quanto a colui che vede recitare, del resto
non si recita, si agisce. Il teatro in realtà è la genesi della creazione. Questo si farà.”
6. L’AFRICA DI PETER BROOK.
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
Nel parlare delle esperienze contemporanee, dagli inizi del Novecento, di superamento dell’attore e
della recitazione tradizionale, si tende a privilegiare la “via asiatica” e, cioè, quell’attore che trascende
dalla tradizione occidentale grazie a una padronanza arrivata proprio tramite la tecnica, la disciplina e
l’artificialità. Spesso questa via asiatica ha portato a non vedere un’altra sua equivalente: quella
africana, basata sull’organicità e la fluidità, piuttosto che sulla tecnica e sull’artificiosità. Se il lavoro
dell’attore eurasiano è legato al nome di Eugenio Barba, quello dell’attore eurafricano è legato al nome
di Peter Brook. Una data fondamentale, quasi uno spartiacque a proposito del rapporto Africa-teatro è il
1972/1973, cioè l’epoca del primo viaggio di Brook nell’Africa occidentale. Spinto dall’insoddisfazione
del nostro teatro, e da quello Orientale, Brook sceglie di avventurarsi nel Continente nero, riscoprendo
la profonda e complessa spiritualità dell’Africa. Spiritualità legata alle pratiche performative del corpo,
della voce e del movimento. Insomma, per Brook l’Africa diventa, assieme a Shakespeare, l’altro punto
di riferimento che condizionerà interamente il suo lavoro, a partire da “Timon of Athens” (1974) o “La
tragédie d’Hamlet” (2002). C’è bisogno di dire che, se la letteratura, la danza, il cinema, la musica e le
arti visive erano già a conoscenza delle “potenzialità” dell’Africa, il teatro, al contrario, è stata l’ultima
arte a scoprire il continente nero. Ricordiamo almeno la passione per l’Africa di Pasolini, condivisa col
suo amico Moravia: precisamente, in Marocco, il regista-poeta girò “Edipo Re”. Riguardo alla danza, tre
sono i nomi di capitale importanza per la Black dance: Katherine Dunham, Pearl Primus e Alvin Ailey.
Come ogni storia che si rispetti, anche quella della via africana ha la sua preistoria. Ricordiamo la
spedizione Dakar-Gibuti: la prima missione antropologica organizzata dalla Francia, diretta da Marcel
Griaule. Viaggio che, venticinque anni dopo, scaturì un libro sulla possessione e i suoi aspetti teatrali
(“La possessione e i suoi aspetti teatrali tra gli Etiopio di Gondar”). Antefatti antecedenti agli anni ’70
sono i film di Jean Rouch, maestro Francese e tra i padri fondatori della Nouvelle Vague: in particolare
“Les Maitres fous”, film dedicato alle cerimonie di possessione. Infine, ci sono pure da ricordare le
ricerche condotte in Polonia negli anni ’60 da Grotowski, nel libro “Per un teatro povero”, studiando più
in particolare –un decennio dopo- i fenomeni della trance e della possessione in relazione ai rituali del
Vudù africano. Ma perché Brook decise di esplorare la via Africana? Ebbene, sono molteplici gli incontri
che lo portarono a questa scelta, partendo da quello con il suo primo attore africano: Bowens, grazie al
quale mise a fuoco, per la prima volta, “la via della recitazione invisibile e trasparente”. Il secondo
motivo che lo condusse in Africa fu l’amicizia con lo scrittore, poeta ed etnologo Hampaté Ba,
conosciuto agli inizi degli anni ’70, quasi una guida nella via Africana. Terzo motivo: la scoperta a Londra,
sempre agli inizi del ’70, di Athol Fugard, uomo di teatro sud-africano (attore, scrittore e regista) e dei
suoi due co-autori Kani e Ntshona che lo colpirono per la loro incredibile capacità d’improvvisazione. Un
altro incontro, sempre nella capitale Inglese –nell’80- con Mtwa e Ngema, che lo impressionarono per la
loro “recitazione inventiva”. L’ultimo e certamente tra i più essenziali collaborati di Brook è Sotigui
Kouyaté, principale “reincarnazione” di quell’attore eurafricano che si andava riscoprendo. La via
africana di Brook ha due facce: quella visibile e quella invisibile che, nel tempo, diverrà sempre più
importante. Parlare di quest’Africa “invisibile” vale a dire parlare di una visione dell’uomo, della cultura
e del teatro che oscilla fra molteplicità e universalità. Peter Brook, proprio sulla molteplicità costruisce
una teoria e, cioè, quella della rainbow theory. Secondo questa teoria, ogni essere umano ha in sé le
componenti (i colori) di tutte le culture; con le parole del regista “ogni cultura esprime una parte
differente del nostro atlante interiore: la verità umana è globale. Ciascuno di noi ha una parte d’Africano
all’intero di se stesso.” La rainbow theory spinge, quindi, verso il riconoscimento di un’unità profonda di
tutti gli esseri umani, spinge verso l’universalità: “L’essere umano non contiene unicamente le sue radici
nazionali e regionali, c’è nella sua vita un territorio comune all’intera umanità.” Per Brook, uno dei
compiti del teatro, se non il compito per eccellenza, è quello di svelare e far riscoprire all’individuo
questa “terra comune”. Avvicinandoci di più alla questione dell’attore, possiamo affermare che ciò che
differenzia l’attore eurafricano, da quello tradizionale e da quello eurasiano, è la fluidità, è l’organicità
naturale (cioè non costruita attraverso il training) ed è l’oralità dello story-tellere, del griot (il va-e-vieni
fra narratore e attore). Insomma, parliamo, sostanzialmente, del non-jeu, della non-recitazione: un
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
esserci realmente invece di un far-finta. Come già accennato, due sono i nomi di capitale importanza in
questo rapporto Africa-Brook: Bowens e soprattutto Kouyaté. Parlando del primo, Malick Bowens,
possiamo iniziare dicendo che quest’ultimo rifiutò coscientemente la sua “africanità” che, ad ogni
modo, rimase nel suo corpo-mente, pronta ad aiutarlo come attore. Brook, che conobbe l’attore grazie a
Grotowski, ci parla di Bowens in una pagina della sua autobiografia intitolata “I fili del tempo”: “Un
giorno improvvisammo sulla cecità. Una serie di tentativi poco convincenti […] Quando toccò a Malick
Bowens, l’attore originario del Mali, sembrava che non facesse alcuno sforzo e a un tratto, con
semplicità, davanti a noi apparve un cieco. Allo stesso tempo, l’impressione di naturalezza in questo
caso non era accidentale né lui era in uno stato di trance, come un medium. Malick sapeva quello che
faceva […] L’antica ed estremamente complessa civiltà che lo nutre è inscritta nel suo corpo, in tutta la
sua interezza e, quando lui “impersona”, “diventa” in modo indivisibile.” L’africanità di Bowens sta nella
sua capacità di pensare con il corpo, di aver coscienza dell’istante; soprattutto sta nel suo rapporto con
la terra, che ormai gli attori occidentali non hanno più. Con Kouyatè siamo difronte a un caso simile
eppure diverso, perché quest’ultimo non ha mai rifiutato la sua cultura d’origine. Appena sbarcato
dall’aereo, l’attore si diresse in teatro e gli misero in mano un foglietto con una scena del Mahabharata:
“Sotigui è entrato istantaneamente in questo testo sconosciuto, lontano, che veniva da un’altra epoca e
da un’altra cultura e ha semplicemente recitato con una naturalezza assoluta. Ecco la porta d’ingresso
che cercavamo per il Mahabharata.” Egli diventa per Brook il modello dell’attore ideale: “Egli è un buon
attore, ma guardandolo non abbiamo l’impressione che si tratti di un’arte, perché, nel vero artista, l’arte
è presente in una maniera raffinata, ma questa arte scompare. In Sotigui c’è una verità, egli sa che
abbandonando tutte le false esteriorità la verità appare.” Secondo Rosaria Ruffini, Kouyaté non è un
attore che recita –proprio come Bowens- bensì è un attore che racconta il suo personaggio. La sua
recitazione è caratterizzata dalla mancanza di artificialità, di una costruzione teorica e tutto ciò porta ad
una recitazione naturale, vera. Ora, poniamoci una domanda: davvero l’attore eurasiano e quello
eurafricano sono radicalmente diversi? O si tratta piuttosto di due modi differenti di recitazione per
raggiungere lo stesso obiettivo? Prendendo il caso di Yoshi Oida (formatosi nel teatro No e Kabuki)
sembra più conforme la seconda ipotesi, tant’è vero che quest’ultimo fu uno dei pochi a non subire
“shock” nel famoso viaggio del ‘72/’73, proprio perché riscoprì un’affinità tra la sua cultura e quella
Africana. E poi, è soprattutto la rainbow theory di Brook a far preferire l’ipotesi di una
complementarietà piuttosto che quella di una differenza invarcabile. Pare interessante, ora, il caso di
Thomas Richards, allievo ed erede di Grotowski dal qual fu sottoposto a un apprendistato durissimo
durante il quale il maestro polacco cercò di eliminare le convinzioni di un giovane attore newyorchese,
in favore di quella fluidità che percepì in Thomas. Leggiamo le parole di Richards: “Mia madre è bianca,
mio padre è nero. Benché la mia pelle sia di colore più chiaro, nella mia corporeità c’è qualcosa della
linea di mio padre, la linea africana. Questa linea africana del corpo, legata alla fluidità del movimento,
alla sua continuità di movimento, al flusso della vitalità attraverso il movimento era rimasta in gran
misura bloccata, non ancora scoperta. Grotowski cominciò a cercare di sbloccarla attraverso il lavoro
pratico…” Concludendo, e tornando alla pagina di Brook su Bowens, possiamo continuare dicendo che
“…coloro che avevano una cultura tradizionale alle spalle, riuscivano a trovare la stessa immediatezza.
Non vi è costruzione, analisi, “metodo”: corpo, mente e anima parlano all’unisono. Un vecchio attore
indiano mi spiegò non vi era alcunché di artificiale in ciò che faceva, si limitava a ‘recitare la vita’.” Per
Brook, in realtà, la via africana e la via asiatica all’acting, per dire la via della fluidità e dell’immediatezza,
non sono incompatibili con quelle della precisione e della tecnica; sono piuttosto metodi differenti per
raggiungere quella spontaneità e quella immediatezza per ottenere una ‘recitazione di vita’, un
superamento, un’organicità e quanto mai più credibilità.
7. GROTOWSKI.
Il libro “J. Grotowski, testi” è un’antologia che comprende –grazie allo sforzo congiunto di Fondazione
Pontedera e del Workcenter of Jerzy Grotowsky and Thomas Richards- molte opere di Grotowski. In questo
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
capitolo ci si sofferma sul primo volume “La possibilità del teatro”, comprendente tutti i testi più noti di
Grotowski, più un cospicuo numero di inediti. Fra i testi mancanti spiccano il leggendario corso tenuto
all’Università di Roma “La Sapienza” e le lezioni al Collège de France di Parigi, bruscamente interrotte dalle
condizioni di salute del maestro. Molto meno accettabile risulta essere la “scomparsa” del libro “Per un
teatro povero” pubblicato per la prima volta in inglese, per iniziativa di Eugenio Barba, con la prefazione di
Peter Brook. Il libro in questione, fortunatamente, non è stato del tutto eliminato poiché alcuni dei testi che
lo componevano si sono salvati, nonostante, però, proprio quelli curati da Barba e da Flaszen, la celeberrima
intervista “Il Nuovo Testamento del teatro”, le due raccolte di esercizi “Allenamento dell’attore” e i materiali
sugli spettacoli Akropolis, Dr. Faust e Il Principe Costante, sono andati perduti. Il primo volume La possibilità
del teatro ci presenta un Grotowski giovane, il quale studia teatro alla Scuola di Stato di Cracovia e non c’è
dubbio, che ci offri pure quel Grotowski impegnato da leader nelle organizzazioni giovanili rivoluzionarie.
L’adolescenza del polacco, però, ci viene dapprima fornita da altri due testi fondamentali: Jerzy Grotowski e
il suo laboratorio. Dagli spettacoli a L’Arte come veicolo di Zbigniev Osinski; e Grotowski e Compagny.
Sorgenti e variazioni di Flaszen. Nel primo volume de “J. Grotowski, testi” si smantella l’idea che il Grotowski
giovane fosse un “inesperto provincialotto”, idea, tra l’altro, confermata pure da Barba. Nulla di più
sbagliato, poiché il maestro polacco sin dagli anni ’50 viaggia moltissimo, dall’Est all’Ovest, scrivendo
interessanti reportage nonostante, durante il periodo stalinista, fosse ben difficile ottenere un passaporto.
Sempre nel primo volume, si smantella l’idea di un Grotowski non-scrittore: ancora una volta, un’idea
sbagliata. Certamente, in piena carriera, dopo la fama mondiale, si avvarrà di trascrittori, ma è vero che
Grotowski, al contrario di quanto si dica, abbia scritto, e molto. Addirittura, i due suoi collaboratori più
stretti, Osinksi e Flaszen, parlano di una precoce passione per la letteratura e, in particolar mondo, per la
poesia, vincendo a soli 13 anni un concorso di declamazione poetica. Ora, che tipo di scrittore era Grotowski
negli anni cinquanta? Secondo Flaszen “aveva la penna pesante e bramosa di esprimere tutto in una volta,
compreso il senso ultimo della vita e del cosmo” ed è vero, ma ragionandoci su, possiamo affermare che si
prospetti un profilo di un giovanissimo saggista e teorico di notevole spessore filosofico. Grotowski puntava
ai contenuti e non alle forme, per lui vizi delle avanguardie e le osservazioni di Flaszen sulla ricerca sul senso
del vita (solitudine, morte etc.) sono fondamentali. Passiamo ora al Grotowski politico: secondo Karol
Modzelewski, il maestro polacco non era adatto alla lotta politica seppur certamente un rivoluzionario.
Tuttavia gli interventi politici del ’57 evidenziano una notevole abilità tattica e strategica. Lo stesso
Modzelewski ci porta a ricordare un aneddoto: “C’era il pericolo che il potere li considerasse
un’organizzazione illegale. Al fine di evitarlo Grotowski creò il Centro Politico della Sinistra Accademica e
Operaia che riuniva coloro che erano confluiti e coloro che si erano rifiutati”. Certo, la trovata non funzionò e
tutto precipitò ma si badi al forte spirito rivoluzionario di un pur sempre giovane studente. Passando a ciò
che più ci interessa, c’è da notare come Grotowski, appena 21enne, già padroneggiava il lavoro e il sistema
artistico-pedagogico di Stanislavskij, arrivando poi a definire il proprio e, cioè, quello delle Azioni fisiche. Nel
primo volume di cui si parla, oltre a ciò di cui abbiamo parlato in precedenza, si fa riferimento alla religiosità
laica di Grotowski o, per meglio dire, alla sua visione filosofica a-religiosa, forse atea, ostile alle religioni
storiche, soprattutto al cattolicesimo e allo stesso clero. Leggiamo le parole dello stesso Grotowski: “Coloro
che si occupano di arte non possono mantenere una posizione indifferente rispetto al fatto che il mito della
‘vita ultraterrena’ diventa ormai imponente al cospetto dell’orrore della morte e dei problemi del giorno
d’oggi. I problemi di una nuova etica, di nuove risposte laiche alle domande sempre attuali sul senso della
vita, sul rapporto consono con la questione della morte, impongono agli artisti del tempo il peso di una seria
responsabilità.” E dunque, bene si capisce che per il maestro polacco, uno dei compiti dell’artista è proprio
quello di mostrare nuove vie di “fuga”, per lui laiche. E ancora: “l’umanesimo sicuramente ha inizio con il
rispetto per la solitudine altrui. Ma si realizza per l’appunto rompendo la solitudine umana, quella solitudine
che è l’anticamera della morte. Secondo la mia personale, profonda convinzione, l’uomo si libera dalla
solitudine e dalla morte, se supera la meschinità del suo fragile ‘io’. Tramite la società, tramite la
partecipazione creativa alla realtà umana, l’uomo in un certo senso si radica nella realtà universale,
nell’unità della natura.” Per lui, dunque, la speranza è questa; la via di fuga alla morte e alla solitudine
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
risiede nel collettivo, nell’umanità della natura. Una sorta di anticipazione dell’atto totale, dell’arte come
veicolo. Nel primo volume del libro che trattiamo, si delinea pure l’idea che quel Teatro povero che
rappresenta l’apice del lavoro di Grotowski sia, in realtà, la concretizzazione e lo sviluppo di idee che già
caratterizzavano il lavoro del polacco. Vediamo quali sono questi elementi essenziali: la concezione del
teatro come un “dialogo” fra spettacolo e spettatore, che rapidamente si precisa come contatto diretto,
immediato, “dal vivo”, psicofisico, tra artefici e fruitori; l’importanza sempre crescente dell’attore; l’utilizzo
del testo non come “trama” bensì come “tema” e “base”; le forti ambizioni filosofiche del teatro (la
solitudine, la morte) che offrono all’uomo la già ricordata “opportunità d’immortalità” raggiungibile tramite
la consapevolezza, tramite la collettività; e, per concludere, la proposta –estetica- di una forma grottesca e
seria. Concludendo, c’è da dire che dopo il ’59 gli interventi scritti di Grotowski cominciano a diradarsi
vistosamente, per poi arrivare nel ’65 con un definitiva scomparsa del Grotowski scrittore. Da allora si
tratterà perlopiù di trascrizioni di interventi orali. Sia chiaro, però, che il passaggio dalla scrittura all’oralità
non significò affatto una rinuncia all’ambizione teorica e alla propensione filosofica. Si trattò, più
semplicemente, di tradurre quella teoria in un lavoro più pratico, di ricerca, di azione: la pratica come teoria
in atto.
8. MAUD ROBART, L’ALLIEVA-MAESTRA. LA COLLABORAZIONE CON GROTOWSKI.
Per Grotowski, prima di parlare del canto rituale, prima di parlare di questa tradizione antica, bisogna
riscoprire la differenza fra melodia e le qualità vibratorie. Questo perché, specie nel nostro paese, si è
persa quella concezione di canto, per l’appunto, più ritualistica, legata agli impulsi e all’improvvisazione.
Se ora la melodia è intesa come una successione di note ben prestabilite dove andare a svilupparne le
capacità vibratorie, il canto della tradizione è, invece, canto-corpo, un impulso, un azione, è
improvvisazione. Questo Grotowski lo spiega bene in uno scritto intitolato “Dalla compagnia teatrale
all’arte come veicolo”. Sebbene non venga mai menzionata, questo testo resta una delle introduzioni più
acute alla collaborazione di Grotowski con Maud Robart e, essenzialmente, resta una descrizione del
lavoro della Robart sui canti tradizionali haitiani e sulle tecniche performative ad essi associate. Il testo
viene pubblicato nel 1993, data in cui finisce una collaborazione durata per un quindicennio: una
collaborazione, per Grotowski, importantissima, poiché, avvicinandosi all’allieva-maestra, il regista
polacco conobbe non soltanto una cantante ma pure i canti vibratori e le danze ritualistiche che
entrarono a far parte in maniera decisiva nel lavoro di Grotowski. La Robart prese parte a tutte e tre le
fasi che scandirono la ricerca del regista: il Teatro delle fonti, il Dramma oggettivo e l’Arte come veicolo
(precedentemente “Arti Rituali”). Maud Robart certamente cambiò le sorti del lavoro di Grotowski,
nonostante, però, negli elenchi dei collaboratori di Grotowski (Cieslak, Zmyslowski, Richards, Eugenio
Barba) ella non appaia. La Robart fu al tempo stesso allieva e maestra, poiché si formò a teatro e,
specificamente col metodo delle azioni fisiche di Stanislavskij e con gli esercizi plastici del Teatr
Laboratorium di Grotowski; fu in un certo qual dire “maestra”, poiché permise a Grotowski di sviluppare
tutta una pratica incentrata proprio sulle tradizioni rituali del vudù. Come si sa, Grotowski è sempre
stato piuttosto laconico quando si è trattato di entrare nei dettagli individuali delle sue collaborazioni
più importanti. Si pensi a “Per un teatro povero” dove non appare neppure il nome di Cieslak,
collaboratore essenziale per gli anni settanta e per questo tipo di teatro “povero” (ne parlerà soltanto
dopo la morte dell’attore). In realtà, l’unica vera eccezione a questo rigido silenzio è stato il caso di
Thomas Richards, suo ultimo collaboratore. Dalle interviste della Maud capiamo bene, come, questa,
non si sia mai posta come una semplice allieva, affermando ad ogni modo, quanto abbia ricevuto dal
lavoro e dalle ricerche di Grotowski. Riportiamo le parole della Maud: “Più di dieci anni di cooperazione
attiva con lui mi hanno apportato delle conoscenze pratiche sugli elementi dell’arte dell’attore e sui
modi d’approccio per svilupparli. Con Grotowski l’oggetto della ricerca teatrale era l’uomo in se stesso
attraverso l’arte dell’attore. E’ stato interessante e utile per me poter confrontare le tecniche
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
performative tradizionali con sistemi di riferimento moderni, quali il metodo di Stanislavskij e le tecniche
di organicità elaborate da Grotowski.” La collaborazione fra il regista polacco e Maud Robart appare
interessante perché ella la descrive come “una relazione interiore di indipendenza con lui”, quasi fossero
collegati e spinti dalla stessa volontà, però allo stesso tempo indipendenti gli uni dagli altri. La Robart
guidò uno dei due corsi al Workcenter e, cioè, quello dei canti, del testo, delle azioni fisiche e degli
esercizi plastici e fisici, mentre l’altro –diretto da Thomas Richards- puntava verso l’Arte come veicolo.
Vediamo come tutto iniziò: “Quando ho lasciato Haiti ho sentito il bisogno di un esercizio semplice che
condensasse alcuni elementi essenziali delle esperienze che avevo conosciuto nel mio paese. L’ho
praticato inizialmente sola, come un esercizio personale. Poi l’ho introdotto nel gruppo affidato alla mia
direzione quando lavoravo nel Workcenter of Jerzy Grotowski. Ho potuto così verificare che la pratica di
questo esercizio che avevo elaborato per me era trasmissibile.” Soltanto due sono i testi “di” Grotowski
che violano la riservatezza e l’anonimato: il primo è la trascrizione di un seminario torinese, fatta da
Gabriele Vacis, e il secondo è la lettera di “presentazione” del Workcenter all’indomani dell’esclusione
della Maud. Il corso dell’haitiana, che formava i giovani attori sulla base di nozioni ritualistiche correlate
al movimento, al testo, alla parola e ai suoni, aveva, in ogni caso, un approccio ai materiali dell’altro
corso: la performing art. Vediamo più nel dettaglio la vicenda: “Grotowski voleva che la persona che si
sarebbe occupata del rituale partisse dagli esercizi plastici. Per fare questo ha dovuto diventare allievo
di se stesso. Perché è vero che quegli esercizi sono stati creati da lui, ma è vero che sono passati
trent’anni da allora. Per fortuna, quando il lavoro ha preso direzioni diverse, hanno pensato di registrare
gli esercizi. Esiste Un film, in cui si possono vedere tutti in sequenza. Nel momento in cui dovevano
iniziare il lavoro a Pontedera, Grotowski ha chiesto a Maud di guardare il film. Lo si guardava, si
annotavano dettagli e poi per alcune ore si provavano gli esercizi. Dopo qualche mese Grotowski è
tornato a vedere cos’era successo. Gli esercizi erano eseguiti perfettamente. Solo che erano morti. Solo
che là dove dovevano apparire le associazioni, quello che appariva era invece la ‘frenesia’, come
un’ansia del nulla che rendeva inutile l’esattezza dell’esecuzione. Allora ha detto: ‘Maud, ascolta, in
apparenza è tutto come nel film, ma manca una cosa essenziale. Non ti dirò cosa. Scoprilo.’ Dopo tre
giorni lo sapeva già.” Tuttavia questa collaborazione non è una storia a lieto fine. L’ipotesi è che il
processo di distacco di Maud Robart dal Workcenter fosse iniziato molto prima dell’effettiva esclusione.
Le ragioni che portarono Grotowski a scegliere il gruppo di Richards appaiono evidenti: davanti
all’impossibilità di continuare a tenere in vita entrambi i poli, costretto a sacrificarne uno, egli non può
che preferire quello dell’Arte come veicolo. Quando si delinea, però, il polo dell’Arte come veicolo,
portando con sé la conseguente iniziale e progressiva crisi del corso della Maud? Attorno al 1988/89 con
Thomas Richards che da allievo diviene maestro. Ma quanto fu importante il corso dell’Haitiana per il
Workcenter e per lo stesso Richards? Parecchio. Thomas Richards, che conobbe i canti haitiani grazie a
Maud Robart, si distanziò notevolmente –una volta nel area dell’Arte come veicolo- dallo stesso
apprendistato fatto con la Robart. “Quando ho sentito i canti di Haiti, i canti tradizionali, è stato come
sentire la voce di mia nonna, che non ho mai sentito cantare. E durante quelle due settimane, quando
sentivo quei canti, era come… come se toccassero qualcosa in me che non era mai stato toccato fino ad
allora.” Si capisce bene, dunque, la funzione del corso della Maud per Richards: riattivare le sue
memorie “ancestrali”. “La sola persona da cui ho imparato l’azione interiore è Grotowski, e questo mi
sembra fondamentale. Ho imparato vari canti dai due praticanti di Haiti ma l’azione interiore non l’ho
imparata da loro.”
9. IN CERCA DI UN ATTORE “POPOLARE” E “NUOVO”. GERARDO GUERRIERI NELLA SCENA ITALIANA
DEL SECONDO NOVECENTO.
Esistono molte e buonissime ragioni per parlare di Gerardo Guerrieri, una figura chiave della scena
teatrale del nostro paese tra gli anni quaranta e gli anni ottanta del secolo scorso. Il problema dell’attore
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
ha avuto un ruolo non secondario nella sua lunga fuoriuscita dalla regia negli anni cinquanta. Per
esempio, è di Guerrieri l’idea del bisogno di una indagine pluridisciplinare sul fatto teatrale che
mettesse a collaborare fianco a fianco umanisti e scienziati. Per non parlare dei due “cantieri” su
Stanislavskij e Duse che lo impegnarono per tutta la vita. Che il problema della scena italiana fosse
principalmente di dare vita a un attore nello stesso tempo popolare e nuovo e che per far questo ci
fosse bisogno di una scuola è una consapevolezza che pone Guerrieri. E infatti il nostro è stato un paese
che ha avuto attori popolari ma tradizionali, abbastanza refrattari al nuovo e alla ricerca. Le proposte al
riguardo, comunque, non sono mancate e quelle più interessanti sono venute dagli esponenti attori-
artisti a partire dagli anni sessanta: Bene, Cecchi, Fo, Leo, Eduardo… Leggiamo una considerazione di
Diego Fabbri: “…fu per noi quasi un personaggio magico: insegnò a ognuno qualcosa di importante sia
che rivelasse un testo ignoto, o analizzasse Stanislavskij, o si applicasse in certe regie in cui lo spettacolo
anziché essere preordinato si ‘faceva’ e prendeva compiutezza attraverso un progressivo lavoro con gli
attori, o desse un ritmo di dialogo nuovo a certe rare traduzioni. Ci insegnò come guardare e come
accostarsi al teatro.” Fabbri ci conferma che Guerrieri a vent’anni o poco più era già un maestro. Gli
sviluppi successivi della sua carriera possono essere letti anche come un più o meno volontario
recedere da una posizione di preminenza e visibilità assoluta, che forse non aveva cercato e che
andando avanti gli diventò faticoso sostenere, a tal punto da abbandonare la regia per dedicarsi alla
teoria. Tuttavia quello di Guerrieri con gli attori fin dall’inizio fu un rapporto difficile, poiché il regista
richiedeva un’idea di recitazione nuova, umana, non più fatta di sola tecnica o improvvisazione: “…a un
teatro nel quale crediamo, che non esiste nella battuta o nel gesto improvvisato, ma nella battuta
poetica, nel gesto mosso da un impegno non recitativo ma umano.” Ma qual era questo modo? “La
nostra predilezione andava ai toni bassi e freddi, a un accento sospeso e rapido, alla necessità di non
espandere i movimenti ma di trattenerli, alle lunghe pause di una recitazione sensibilissima a ogni
variazione. Ogni attore finì così per recitare per conto suo.” E da qui si evince la conoscenza del metodo
di Stanislavskij. Nel ’46, come critico dell’”Unità”, Guerrieri si lascia andare un’osservazione che vuole
essere autocritica e, cioè, che applicare ai grandi testi dell’antichità il linguaggio e i gesti della tradizione
psicologica-realistica per renderli più comprensibili è un errore. Come già accennato, però, Guerrieri
ben presto avrebbe abbandonato la carriera registica: alcuni credono per questioni caratteriali, altri per
la progressiva disillusione che la regia potesse salvare tutto, dare un significato a tutto. Ad ogni modo,
gli inediti degli anni cinquanta, raccolta da Geraci (Pagine di teatro) rivelano, probabilmente, la reale
motivazione del distacco dalla regia e, cioè, la sua difficoltà a lavorare con degli attori che,
effettivamente, deludevano la sua intenzione di creare una nuova recitazione popolare e poetica.
Scrivendo per “la Repubblica” uno splendido articolo in morte di Luchino Visconti, Guerrieri parla del
“regista conte” ma è come se parlasse anche di sé e della sua assoluta incapacità di porsi come un vero
regista, se questo non poteva non porsi come un “burattinaio”. Insomma, Visconti –per Guerrieri- fu un
ottimo regista e ciò che lui non avrebbe mai voluto diventare. Dalle Pagine di teatro si evince che la
volontà di Guerrieri era quella di ottenere un teatro che, in un certo qual dire, andasse oltre il ruolo di
feticcio-burattinaio, attore-regista, in favore di un teatro nuovo, potremmo dire “collaborativo” oltre che
poetico, forse incomprensibile a molti. Guerrieri: “Non so più parlare con Luchino, come non so più
parlare con gli uomini di teatro. Cose che non mi interessano: ora mi interessano cose diverse. Sono un
pesce fuor d’acqua: lo sono sempre stato. Mi interessa cosa? La filosofia: che? Capire. Io odiavo il teatro
perché odiavo il conformismo, odiavo il piegarsi alla ‘media’ in cui consiste il teatro e avrei voluto fare
del teatro un campo di combattimento. Ma invece: il piacere, il bisogno di piacere mi ha domato, a poco
a poco, portandomi al conformismo della regia, dei costumi, delle cose che piacciono, delle scenografie,
dell’occhio cioè, e non del pensiero.” Un teatro che va oltre, un teatro nuovo e non mediocremente
inteso alla maniera tradizionale; il teatro del pensiero. Guerrieri cadeva inesorabilmente nel fascino
della persona, dell’attore; era attratto dalla vitalità e dal fascino dell’umanità, piuttosto che da quella dei
personaggi. Guerrieri voleva palesare il conflitto interiore dentro ogni persona/personaggio, voleva un
teatro quanto mai più vero, certamente di derivazione stanislavskiana. Era interessato più a guardare la
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
vita, anziché gonfiare artisticamente dei personaggi, i drammi dei personaggi, come faceva Visconti da
buon regista inteso comunemente. “Ma che volevo scoprire io? Le leggi dell’anima? O che? Che volevo
dal teatro? –e poi aggiunge- Ho pochi rapporti con gli attori, con i quali non sono mai riuscito a parlare
in modo decisivo, a guidarli.” E dunque, tra le tante motivazioni, c’è anche una concreta incapacità
“direttoriale”, probabilmente mossa proprio dalla delusione, dall’insoddisfazione e dal fatto che nessuno
lo capisse realmente. Guerrieri ha affermato che aveva bisogno di contenuti nuovi, aveva bisogno di
confrontarsi col nuovo, di ricercarlo al di fuori del teatro convenzionale. Giunge, abbandonando la regia,
ad essere studioso dell’attore. Il suo debutto, folgorante nel campo della teoresi, si inaugura con la
preparazione di due voci per l’Enciclopedia dello spettacolo: Stati Uniti d’America e, soprattutto, Attore.
Interessandosi e ispirandosi indirettamente, come già detto, alla Duse e rispecchiandosi addirittura in
Stanislavaskij (“la storia di un paziente autoanalisi, ma dell’autoanalisi di una presa di coscienza di se
stesso nel proprio mestiere” e dunque parla di sé oltre che del Russo), Guerrieri sperimenta con gli attori
non-attori del Living un nuovo strumento d’indagine critica: l’intervista, di cui presto diventerà
l’autentico maestro. Si badi, certo, una tipologia d’intervista lontana da quella aggressiva dei giornalisti.
Potremmo ritenere Gerardo come un uomo incredibilmente curioso, spinto alla più acuta sapienza e dal
gusto per l’interdisciplinarità, tanto da spingerlo in progetti scientifici centrati sulla rivoluzione biologica,
fra una collaborazione che vede uniti uomini di scienza e uomini di teatro. Opera, purtroppo, mai
compiuta però appena visibile ne “Tutto il mondo è attore” del ’73. Se da un lato, Gerardo, lavorò
sull’interdisciplinarità, oltre che sull’attore, fra ’74 e ’81, il mancato regista ritornò a studiare e a
ricercare quell’attore nuovo a metà fra il popolare e la ricerca, constatando che non restava –ancora-
che scegliere fra un popolare non nuovo e un nuovo non popolare. Se il Teatro Club (suo e della moglie)
rappresentava il meglio della ricerca internazionale, il decennio successivo non ebbe la stessa fortuna.
Guerrieri non aveva nessun entusiasmo nel guardare l’amato Living Theatre, o Grotowski, o ancora
l’Odin Teatret di Barba e, passando alla scena Italiana, non aveva interesse neppure per Cecchi o Fo.
Non che Gerardo non apprezzasse il valore di Carmelo Bene attore (il Bene regista non era bene visto da
Guerrieri) o di Leo e Perla che gli strapparono le osservazioni più interessanti, oltre che un saggio; tutto
sommato, però, nel panorama più generale, il critico rimase deluso. Forse soltanto Peter Brook lo
soddisfò un po’, ma neanche più di tanto. Ronconi, qualche anno dopo, dice la sua riguardo alla “non-
interpretazione” che non stava per nulla simpatica a Guerrieri: “Un’altra difficoltà sta nello stato
generale della regia italiana d’oggi. Sviluppatasi nella direzione della ‘non-interpretazione’, essa non ha
permesso lo svilupparsi del ‘regista-interprete- beffeggiato dal nuovo teatro, che si è abituato a
costruire, a partire da terminati testi, grandi macchine sceniche, anziché interpretarli.” Guerrieri,
sfortunatamente, rimase insoddisfatto dagli attori del tempo e, magari, se solo fosse vissuto poco più,
sarebbe rimasto stupito dal già conosciuto e futuro magistero del Leo de Berardinis, o dal Teatro delle
Albe di Martinelli e Montanari.
10. DARIO FO ATTORE EURASIANO.
Ogni volta che tentiamo di fare i conti criticamente con Fo e di situarlo nella mappa del Nuovo Teatro
Italiano, letteralmente non sappiamo dove metterlo. Che il Fo performer sia del tutto estraneo
all’attore-interprete, alla filiera dell’attore-artista, che inizia con la Duse e finisce con Bene-Cecchi-De
Berardinis, è del tutto ovvio. Dario Fo non è neppure quello che potremmo chiamare “attore-comico”
alla maniera di Eduardo e Totò: è piuttosto uno dei casi di “contaminazione comico-borghese”. Fo è
estraneo a quel teatro di regia che si va affermando con l’avvento delle nuove neoavanguardie e non
per ragioni ideologiche-politiche (che lo condizionarono però dal ‘67/68 nella realizzazione di “Mistero
Buffo” o “Morte accidentale di un anarchico”). Gerardo Guccini ci racconta un piccolo episodio: Fo arrivò
all’Odin Teatret di Eugenio Barba e gli attori mostrarono gli esercizi del loro training quotidiano. Attori
come Carmelo Bene e compagni risero di quegli esercizi a differenza di Fo che, ritrovandosi in un’aria di
famiglia, dimostrò interesse per quel training basato sulla sperimentazione delle tecniche fisico-vocali,
fondamentale per la loro improvvisazione. Perché questo feeling fra gli attori dell’Odin e Fo? Ebbene, c’è
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
da dire che Fo in primis risulta essere –almeno dopo il ’68- un attore estremamente tecnico: tecnica
trasmessagli dal grande mimo francese Jacques Lecoq negli anni cinquanta che lo fece entrare, in un
modo o nell’altro, in rapporto con la tradizione del nuovo francese e, cioè, con Jacques Copeau. Oltre a
Lecoq, che permise a Fo di ritrovare un equilibrio nella messa in scena e nell’utilizzo degli strumenti
espressivi, un altro importante incontro, secondo De Palma, fu quello con Dasté. C’è da citare pure
Decroux perché da lui prende compiutezza l’idea che l’attore possa essere drammaturgo e regista di se
stesso. Dario Fo, dunque, appartiene alla filiera dei registi-pedagoghi del novecento: si pensi a
Stanislavskij, Mejerchol’d, Grotowski o Barba, tutti registi che puntavano verso una drammaturgia
d’attore intesa come invenzione e montaggio di azioni fisiche e vocali. Queste tecniche, e vale a dire
l’utilizzo sapiente del corpo e della voce, hanno come bersaglio l’attenzione dello spettatore.
L’importanza di Fo, in tal senso, si conferma per la sua presenza in “La canoa di carta” e “L’arte segreta
dell’attore”, libri che lo citano di continuo accanto ai maestri orientali di No, Kabuki, Kathakali: insomma
accanto a coloro che facevano dello studio e della teorizzazione della pre-espressività la loro forza. Per
Fo c’è, allora, prima lo studio dei propri mezzi espressivi: non è un attore-non-interprete. Fo è un
“maestro dello sguardo” e non solo: è “padrone dello sguardo”. Dario è esperto nell’utilizzo del proprio
sguardo ma è anche padrone dello sguardo dello spettatore, poiché è capace, grazie all’esuberanza
delle frasi gestuali, di manipolare gli occhi di chi lo guarda. Persino Grotowski osserva: “Uno dei
problemi essenziali del mestiere dello spettatore, cioè del regista che guarda è quello di avere la
capacità di guidare l’attenzione; la propria e anche quella degli altri spettatori che arriveranno.
L’itinerario dell’attenzione dello spettatore appartiene al nostro mestiere.” E Fo aggiunge: “Nell’eseguire
La fame dello zanni io mi creo un ampio spazio intorno, consentendo allo spettatore una visione
completa del mio corpo – corpo che però, a un certo punto, viene come dimenticato, in quanto
irrigidisco volutamente la parte bassa, e induco così il pubblico a usare un primo piano ravvicinato verso
il solo volto…” Si capisce bene, dunque, quanto sia importante guidare lo spettatore tramite l’utilizzo
abile dei mezzi espressivi. Questo perché, secondo Grotowski e Fo, lo spettatore ha nel cranio una
“macchina da presa invisibile” che riprende sempre. Questo argomento, spiegato nel Manuale minimo
dell’attore di Fo, viene ripreso da Barba che vede il lavoro drammaturgico dell’attore costituto da
“dettagli, impulsi e controimpulsi dai quali dipende la precisione, e quindi la qualità della sua presenza”.
Si parla dunque, tutto sommato, di un attore al servizio dello spettatore. Concludendo, leggiamo quanto
dice Barba su quella che lui chiama “la drammaturgia del microscopio”: “Dario Fo spiega come la forza
del movimento dell’attore risulti dalla ‘sintesi’, dalla concentrazione in un piccolo spazio di un’azione che
impiega grande energia e dalla riproduzione dei soli elementi essenziali di un’azione, eliminando quelli
ritenuti accessorio”. Questa “sintesi” permette a Fo di governare la scena e lo spettatore, manovrato
dall’attore stesso che enfatizza o elimina certe parti della sua recitazione.
11. ELOGIO DI CARLO CECCHI, ATTORE CONTRO.
Chiunque voglia tentare un approccio complessivo al lavoro artistico di Carlo Cecchi, attore e regista
teatrale straordinario ma anche notevole interprete cinematografico e televisivo, si trova di fronte
un’impresa complessa. Anche limitandosi al solo contributo teatrale, si tratta di confrontarsi con un
repertorio che va da Shakespeare alla farsa dialettale napoletana, da Molière a Buchner, da Brecht a
Pirandello, Beckett etc. Carlo Cecchi fu un attore/regista estraneo alla realtà del nostro paese e al teatro
di regia degli anni ’60. Per Cecchi il teatro italiano “nega in fondo se stesso, perché se neghi, impedisci
agli attori di essere attori, neghi la possibilità stessa del teatro. Ero un attore che, certo di essere un
attore, si è trovato dentro un teatro, che era il teatro dei primi anni sessanta che negava la certezza del
mio essere attore”. Carlo Cecchi, per farla bene, è dunque avverso a quel teatro che ha come
protagonista la figura del regista che “in realtà aveva l’unica funzione di mettere la camicia di forza al
corpo e all’anima dell’attore”. In tal senso risultano interessanti gli apprendistati con il Living Theatre e
con Eduardo De Filippo. Quanto al primo c’è da dire che, il Living, gli insegnò il valore della
partecipazione collettiva, l’importanza del gesto, dei ritmi vocali, dinamici e sonori e gli insegò pure il
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
senso dello spazio. A De Filippo si deve, invece, il riconoscimento del ruolo e della preminenza
dell’attore e l’apprezzamento della contaminazione comica da cui deriva pure il ricorso del dialetto. Il
dialetto di Cecchi non si limita a quello napoletano (ci sono anche altre inflessioni) ma va ben oltre,
arrivando pure alla tradizione partenopea con Scarpetta e soprattutto Petito, di cui mette in scena “Le
statue movibili” e “’A morte dint’o lietto ‘e don Felice”. Il centro della questione risiede nell’esigenza di
forgiarsi strumenti e modi recitativi alternativi alla pseudotradizione dell’attore italiano del teatro di
regia che si avvale di quella che, Meldolesi, ha definito “antilingua”. Cecchi spiega come il corpo della
lingua italiana non sia adatto al teatro; la lingua italiana ha un corpo adatto al canto, ma non al teatro
senza canto e da qui: “Io non recito in napoletano, recito in italiano; è il mio corpo che non è italiano,
non è in lingua italiana; il mio corpo ha poco a che fare con la lingua italiana e ha più a che fare con la
lingua napoletana, con il corpo della lingua napoletana…”. Cecchi, tra l’altro, si definisce come un attore
comico che avrebbe voluto essere un attore tragico. Il Cecchi in scena, infatti, è un attore che alterna il
comico al tragico. Un grottesco non troppo lontano, in fondo, da quello di Pirandello e Mejerchol’d,
consistente nella sfasatura tra gesto e parola. La recitazione di Cecchi è infatti caratterizzata da bruschi
mutamenti di ritmo, accelerazioni e arresti improvvisi, silenzi meravigliosamente scanditi; una
recitazione fatta di spezzature, sprezzature e dissonanze. Probabilmente, causa il periodo, il debutto
sessantottesco con “Prova del Woyzeck” ci rivela che il lavoro di Cecchi è assolutamente caratterizzato
da una forte scommessa politica. Lo stesso ricorso ai dialetti era funzionale anche a un discorso politico.
Cecchi dice: “Quegli spettacoli nascevano dall’idea di un teatro che, in qualche modo, contribuisse alla
trasformazione del mondo… Esisteva una nuova tensione molto intensa verso il pubblico, una tensione
politica. Mi sono formato in tempi in cui si pensava che il teatro fosse necessario non solo per noi che lo
facevamo ma anche per chi veniva a vederlo. Poi, dalla fine degli anni ’70, ho attraversato anni di
grande solitudine, dove la mia necessità di attore e regista di comunicare con qualcuno, che è il
pubblico, mi sembrava quasi perduta.” Era un teatro che voleva cambiare il mondo, eppure, da un certo
punto in poi non lo fu più. Questa tensione, però, non scomparve del tutto ma semplicemente si
riconvertì: dal ’70 in poi si volle cambiare il teatro in sé, le sue funzioni fondamentali, attore anzitutto.
Importante è la descrizione di Garboli su Carlo Cecchi capocomico: “Cecchi è essenzialmente un
capocomico. Ciò che fa il carisma di un attore, non è un overdose di talento; è il sospetto di una
disappartenenza al teatro, la misteriosa capacità, da parte di un attore, di trascendere il teatro proprio
nel momento in cui egli ne è il testimone assoluto. Se per l’attore/suddito il teatro è una totalità, per
l’attore/capo è una totalità che non da più gioia… non si è più attori perché si ama il teatro; si è attori,
grandi attori, perché lo si odia.” Parliamo del rifiuto dell’attore o meglio del fare l’attore nel momento in
cui semmai attori lo si è. Questo rifiuto parte anzitutto dall’idea dell’impossibilità della
rappresentazione. Riferendosi a Bene (e probabilmente anche a se stesso), Cecchi dice: “…il grande
attore tragico è una parodia del grande attore tragico. La tecnica, ‘l’Arte’ del Grande Attore non serve
più per rappresentare un personaggio ma per agire la parodia di questa rappresentazione; alla fine, la
sua impossibilità. Il ‘personaggio’ viene fatto a pezzi secondo le tecniche che erano servire alla sua
‘costruzione’, in scena rimane il corpo di un attore che agisce questo conflitto…” Insomma, Cecchi e Bene
criticano quell’attore che, nel tentativo di raccontare un personaggio o una storia, tramite le tecniche
servite alla loro costruzione, ne fanno una parodia nell’epoca dell’impossibilità della rappresentazione.
Armando Petrini offre la soluzione: “Un teatro autentico oggi non può che frequentare nel paradosso
estremo: dire l’impossibilità di dire, recitare l’impossibilità di recitare” e non nasconderlo. Concludendo,
Carlo Cecchi –che pure si potrebbe definire un maestro- è un testimone, poiché molto si deve alla sua
coscienza critica e avversa a quel teatro “sempreuguale”. Se il teatro di regia è stato il suo bersaglio
principale (perché nega l’attore e quindi il teatro stesso), in realtà lo sguardo di testimone critico non ha
risparmiato niente e nessuno: Cecchi fu avverso alle traduzioni, spesso orribili; fu avverso alle tournées;
critico nei confronti delle sovvenzioni, al (falso) teatro politico; era contro le inutili scuole volute dai
politici, ce l’aveva con la “categoria fasulla della ricerca” intesa come professione astratta e burocratica,
non pratica e avverso ai “comici progressisti”. Un altro problema che Cecchi mette in risalto è la
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
mancanza, nella nostra cultura teatrale, di una tradizione e di scuole e, per fortuna, è a lui e a
personaggi come de Berardinis che si deve il magistero contro l’antilingua e il teatro sempreuguale,
“travestito” sempre in maniera differenti dai registi.
12. L’ERESIA DEL TEATRO DELLE ALBE.
Introduciamo il Teatro delle Albe parlando di un breve testo intitolato “Teatro politttttttico”, letto in un
convegno da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, fondatori –quattro anni prima- del Teatro delle
Albe a Ravenna. Il Teatro politttttttico oggi figura quasi all’inizio del loro volume “Primavera eretica”.
Quello che leggono è un testo all’apparenza scherzoso e irriverente, nel miglior stile dei manifesti delle
avanguardie storiche. La prima considerazione che c’è da fare è quella sul forte legame che lega teoria e
pratica: Martinelli e Montanari, infatti, hanno scritto molti libri-teatro, piuttosto che semplici libri sul
teatro. La seconda considerazione va fatta non per quello che fanno ma per come sono: questo teatro
non è un mero contenitore di spettacoli bensì un ambiente dove la cultura e l’arte diventano un modo di
vivere, di state insieme e fare comunità, dove i libri non sono meno importanti degli spettacoli stessi. Il
teatro politttttttico –con 7 “T”- “è un oggetto sacro… L’etimologia del termine è illuminante: ‘dalle molte
piegature’. E’ l’errore di un tipografo impazzito. E’ una licenza poetica. E’ pensare che ‘la poeticità è una
battaglia disperata’. E’ umor nero.” Così e in altri modi, Martinelli e Montanari definiscono il teatro
politttttttico, quello che diverrà il loro grido di battaglia, il loro “logo”. L’ultimo testo, invece, è intitolato
“Farsi luogo” e contenente la matura dichiarazione poetica del maestro. Essa non teme di esprimere
apertamente la propria indignazione o di prendere posizioni polemiche. E’ uno scritto che esalta il
talento di Martinelli per l’oratoria civile, fra passione e indignazione, in una visione al tempo stesso
umile e altissima dell’artigianato teatrale. Un testo che critica il “mercato e lo scandalo”: l’artista
moderno che cede onnipotenza al mercato. Farsi prodotto sempre e comunque ad ogni prezzo. E anche
lo scandalo va bene, anzi, è merce ricercata per il mercato. Martinelli è pure “contro la nostalgia del bei
tempi andati”: nostalgia all’ingrosso; un alibi per starsene a poltrire, Ogni epoca è buona per rivoltarsi.
In Farsi luogo la critica è rivolta pure al “regista famoso” che tratta i suoi compagni da lavoro come scarti
e pezze da piedi. “Sei un somarello, un reuccio da niente: non è luogo per tiranni e imperatori il teatro, è
il luogo della dignità di tutti. E’ il luogo della regale, aristocratica, democrazia di tutti.” Martinelli critica
persino la “trappola” che è il teatro “sociale”. Per il fondatore del Teatro delle Albe, tutto il teatro è
“sociale”, perché nasce proprio nella società. Il teatro sociale non deve limitarsi le proprie potenzialità
perché, appunto, “sociale”: il teatro, anzi, prende vita solo attraverso quell’accanimento, quel magma in
cui spendere i giorni e le notti, quella scommessa crudele con se stessi, quel rigore, quella tensione
impavida verso la bellezza. Un’altra cosa di cui Martinelli ha un’incredibile considerazione è il dialogo, il
“rivolgersi”. Occorre pensare allo spettatore come a colui al quale ci rivolgiamo. Se non c’è vero dialogo
con la platea, spesso è perché già prima non è esistito dialogo tra coloro che calcano la scena. E ancora
Martinelli ci spiega il teatro-comunità che intende: “Nel farsi luogo non ci sono né padri né madri, ci si
inventa, ogni giorno, come compagni: il tuo prossimo, il tuo compagno, colui con cui dividere ila pane. Si
cresce e si invecchia tutti a bottega, nella palestra del lavoro quotidiano. Drammaturgia della scena,
drammaturgia della vita.” Il maestro delle Albe elogia pure la bellezza e “parlo di quella Bellezza che
non è patinatura. La Bellezza che non si atteggia a ‘grande’, che non si mette in posa. La Bellezza che
zoppica. La Bellezza cui non interessa l’estetica, che non è affare di salotti. La Bellezza che non è un
affare. La Bellezza che tutto ama, anche il brutto.” E ancora, continuando l’analisi del testo, Martinelli ci
spiega l’importanza del “mestiere dello spettatore” e del bisogno di coltivarlo come un co-autore
indispensabile. Quello che intende il maestro, è inoltre un luogo dove coltivare il proprio malessere, la
propria dissidenza, trasformandola in azioni quotidiane e creatrici. Un luogo dove ribellarsi, ma non
spaccando vetrine. Da quando esiste il teatro è stato oggetto constante di avversione, denigrazione e
vere e proprie condanne, più di qualsiasi altra arte. Questo argomento è stato oggetto di un convegno
denominatosi “La haine du theatre” svoltosi nel 2015 a Bologna. Il primo aspetto: se mettiamo a
confronto, in questa disputa, gli interventi dei detrattori del teatro e quelli dei difensori, dobbiamo
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
ammettere che molto spesso il livello teorico e la qualità letteraria dei primi è superiore. Questo è tanto
vero e così frequentemente ci sorprendiamo a imparare molti più dagli scritti di coloro che lo odiano il
teatro, invece che da quelli che lo difendono. Un esempio è il “Traité de la Comédie” (1667) di Pierre
Nicole, che resta forse insuperato nell’acutissima analisi delle ragioni che vede il teatro come un
qualcosa di pericoloso-peccaminoso-seducente e, si badi, non per questioni di contenuti, ma perché
basato su un metodo comunicativo che si regge sulla seduzione del corpo e della relazione in presenza
fra attori e spettatori. Il secondo aspetto da sottolineare: da un certo momento in poi, tra XIX e XX
secolo, la polemica antiteatrale muta, diventando a volte un momento indispensabile per ripensare il
teatro in forme nuove. Sotto questa prospettiva appare importante il contributo di Rousseau del 1758
“Lettre à d’Alembert sur les spectacles”. Questo testo-documento, da un lato attesa il punto d’arrivo
della diatriba ma, d’altro canto, ne riapre pure una nuova: detestare, allontanarsi da un certo tipo di
teatro per poter proporre e cercare di realizzare un altro teatro, un teatro radicalmente diverso. Il che
vuol dire che si può odiare e amare il teatro. La Duse sostiene: “Per salvare il teatro bisogna distruggere
il teatro. Gli attori e le attrici devono tutti morire di peste… Essi rendono l’arte impossibile.” Artaud
invece: “E adesso dirò qualcosa che forse stupirà qualcuno. Io sono il nemico del teatro. Lo sono sempre
stato. Quanto amo il teatro, altrettanto io sono, proprio per questa ragione, il suo nemico.” Forse parlare
di odio per gli affondi polemici del Farsi luogo è eccessivo. Però, tuttavia, anche Martinelli ha sentito il
bisogno di esternare il suo rifiuto, il suo profondo disaccordo rispetto a certi tipi di comportamenti e di
scelte teatrali, per poter così dare più forza alla proposta del Teatro delle Albe. Detto ciò, è ora
necessario comparare Farsi luogo con un altro testo di Massimiliano Civica e Attilo Scarpellini: “La
fortezza vuota. Discorso sulla perdita di senso del teatro”. L’intervento di Civica e Scarpellini prende le
mosse dal decreto ministeriale del 1 Luglio del 2014 (che ha istituito fra l’altro i Teatri Nazionali). Si
ragiona su chi ci guadagna e chi ci perde e, la prevedibile conclusione è che a rimetterci sono le piccole
e medio-piccole realtà del teatro di ricerca e sperimentazione. La prima considerazione dei due è sul
termine “commerciale”: da parametro economico è diventato categoria estetica. “La ‘poetica
commerciale’ è oggi lo stile da adottare”. Un’altra argomentazione di Civica e Scarpellini è sulla
dislocazione del “potere” della scena: “A ‘fare’ il teatro italiano bastano i diretto dei gradi Teatri.
Esercitano questa prerogativa decidendo quali spettacoli produrre, quali mettere in abbonamento e
quali far circuitare e scambiare”. Il direttore prende dunque il potere assoluto, mentre, artisti e
spettatori diventano “due categorie ininfluenti”; per non parlare dei critici i quali non possono far altro
che stare al gioco. Muller dichiarò nel ’93: “E’ un fatto ormai acclarato che nessuno sa più a cosa serva il
teatro” e Ronconi in una delle sue ultime interviste: “Il teatro ha bisogno della società, ma forse la
società non ha più bisogno del teatro.” Di tanto teatro che si fa oggi, e questo è certo, potremmo farne a
meno e, Martinelli e Civica-Scarpellini certamente concordano. Ebbene, però, quello che accomuna
maggiormente i due testi in questione, è proprio lo scrivere di un teatro inteso come un bisogno
profondo e forse ineliminabile dell’essere umano e della società. E così concludono Civica-Scarpellini:
“L’estetica commerciale è un cadavere. Per evitare che il morto magi il vivo, gli artisti non possono far
altro che sottrarsi al suo abbraccio e rifiutare senza rancore qualunque compromesso, con il sistema
teatrale vigente. Non si tratta più, infatti, di combattere una battaglia contro il sistema o per il suo
rinnovamento, ma di abbandonarlo all’agonia amministrativa nella quale si dibatte. Dal momento che
siamo già poveri, sarà bene disporsi per un periodo a trasformare la povertà in una nuova virtù
produttiva e in una potenza di creazione che non possiamo definire nuova poiché essa ha caratterizzato
le grandi riprese storiche del teatro d’arte.” Concludendo, veniamo ora a precisare l’”asinità” del Teatro
delle Albe. Ermanna Montanari racconta: “L’asinità è diventata l’emblema del nostro fare poetico, il
nostro modo di concepire la vita e il teatro. Complice in questa assunzione è stato Meldolesi che, anni
prima, mi aveva assegnato la tesi di laurea sui Dialoghi filosofi di Giordano Bruno, dove l’asinità
rappresenta il desiderio di conoscenza, l’apertura all’altro, alla infinita varietà del mondo.” Solo gli asini
possono essere un “possibile” pubblico per il teatro, oggi.
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
13. ROMEO CASTELLUCCI.
L’Attività teatrale di Romeo Castellucci inizia nel 1981 con la fondazione della Socìetas Raffaello Sanzio
insieme alla sorella Claudia Castellucci e a Chiara Guidi. Questo gruppo si impone come uno dei più
originali e innovativi del nostro paese, caratterizzato da un linguaggio scenico che –facendo ricorso ad
un miscuglio delle arti visive con la musica, il cinema, la danza, la poesia, la filosofia, la scienza e la
religione- poggiava su fondamenti diversi da quelli testocentrici, ancora dominanti nel nostro teatro
occidentale. E’ negli anni novanta che, questo “teatro iconoclasta”, raggiunge la sua piena maturità
espressiva grazie ad un ciclo che li porta a confrontarsi con i gradi classici occidentali: da Eschilo a
Shakespeare. L’attività artistica di Castellucci nel nuovo millennio si apre con un imponente progetto
internazionale (“Tragedia Endogonidia”) dedicato ad un riflessione sulla tragedia oggi: 11 spettacoli,
chiamati Episodi, debuttano in 9 città dalle quali prendono il nome. Nel 2006, invece, troviamo da un
lato “Hey girl!” e dall’altro “Divina Commedia. Inferno, Purgatorio, Paradiso” del 2008. Negli ultimi anni
l’attività registica di Romeo si è mossa su due piani: una dedicata al volto umano e l’altra al teatro lirico.
Fin dall’inizio, Romeo Castellucci ha affiancato al suo lavoro di regista un’importante e sistematica
attività di scrittura e di riflessione teorica, come, per esempio “Il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio”.
La Socìetas di Castellucci ha contribuito notevolmente a cambiare profondamente il modo di pensare e
di fare teatro e, compito del convegno internazionale “La quinta parete. Nel teatro di Romeo
Castellucci” è stato proprio quello di indagare più nel dettaglio in cosa consistesse questo contributo.
Collocare il gruppo di Castellucci in una delle categorie teatrali (teatro di regia/teatro d’attore, teatro di
parola/teatro di gesto, rappresentazione/performance etc.) è impossibile, proprio perché un ciclo
teatrale come la Tragedia Endogonidia sembra fatto apposta per mettere in crisi queste etichette.
Quello che Romeo Castellucci cerca –a differenza di alcune erronee interpretazioni che vedono il suo
teatro fatto di eccessi, provocazioni e misteri shockanti- è l’estetica e, cioè, la sensazione. Il regista
lavora sulla materia, intesa come realtà e lo fa in maniera oggettiva. “Il mio lavoro è di tipo oggettivo e
riposa sul corpo dell’attore. La materia è l’ultima realtà. E’ la realtà finale che ha come estremi il respiro
del neo-nato e la carne del cadavere. […] Trovo che l’unica funzione immediatamente social del teatro
sia innanzitutto nell’architettura che lo contiene, che comporta ogni volta, come effetto di rimando,
l’instaurarsi di una comunità istantanea tra sconosciuti che condividono una sorta di ‘eucarestia’
estetica della sensazione, la quale può sussistere solo a patto di una vacuità del contenuto etico
dell’opera stessa. Insomma: è l’estetica che produce l’etica. E’ l’estetica –disciplina dello spirito e delle
viscere- ce si sospinge tutti quanti, attori e spettatori, in un teatro”. Romeo Castellucci si definisce un
“cacciatore di forme” e, non a caso, critica quelle forme, quelle performance estreme che tutto fanno,
meno che inseguire i modelli classici della disciplina della rappresentazione occidentale (la tradizione
Greca) che hanno imposto al futuro una coscienza della forma. E’ dunque la tradizione Greca e le
tragedie a questa legata “sono gli unici che mi commuovono perché questo è il confine in cui sono nato”.
Non è un caso che la sua Orestea è considerata il più bello spettacolo del regista. Quello di Romeo
Castellucci è un teatro di sensazioni, un teatro elementale (che si muove cioè su questioni che stanno
sulla “superficie” della realtà/materia; un teatro che sfrutta gli elementi basilari del teatro stesso) ed è
un teatro che offre allo spettatore la possibilità di essere scandalizzato, toccato, emozionato. E’ un
teatro che invia una sfida: diventare spettatori responsabili, cioè responsabili dell’atto di guardare,
responsabili nel scegliere tra le migliaia di informazioni e immagini che ci sommergono
quotidianamente; sta a noi decidere se essere spettatori responsabili o persone comuni.
14. ARMANDO PUNZO E LA COMPAGNIA DELLA FORTEZA: OLTRE IL TEATRO CARCERE.
Numerose sono le pubblicazioni dedicate negli ultimi anni al Teatro Carcere, ma è grazie a Meldolesi che
il teatro in carcere ha potuto ricevere una prima, adeguata teorizzazione e storicizzazione. Formule
come “immaginazione contro emarginazione” o “teatro del costringimento” hanno consentito alle
esperienza del teatro recluso di uscire dal ghetto di una pratica concepita per i suoi eventuali risultati
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
riabilitativi o terapeutici piuttosto che per il suo valore artistico, per la sua originalità estetica. Si tratta di
un giudizio duro a morire che può trovare una giustificazione in molte proposte di livello scadente,
nonostante molti siano gli spettacoli –specie quelli della Compagnia della Fortezza di Punzo- di successo.
Citiamo anche il lavoro del Tam Teatromusica di Padova o la Compagnia del Pratello di Paolo Billi a
Bologna. La vera grande rivoluzione teatrale del XX secolo non è stata esclusivamente estetica ma pure
etica: il teatro lascia l’orizzonte tradizionale del divertimento e dell’evasione per diventare anche un
luogo in cui dare voce a esigenze e a bisogni. Beninteso, senza con ciò negare il divertimento e il gioco o
l’arte in sé ma, anzi, grazie ad essa. Nello stesso tempo, un’altra seconda rivoluzione del novecento
teatrale, è la riscoperta del teatro come incontro con l’altro, viaggio verso l’altro per riferirsi alle sue
zono d’ombra, insomma, a “quella parte di noi che vive in esilio”. Se sono queste le verte, grandi novità
del ‘900, allora il Teatro Carcere è teatro novecentesco per eccellenza. Si insite continuamente su
quanto bene il teatro faccia al recluso ma molto meno si riflette, invece, su quanto loro facciano bene al
teatro e ai teatranti di professione, aiutandoli a reinventare un teatro essenziale, primario e inteso come
gioco-festa-rito collettivo, da un lato, e come lavoro su di sé dall’altro. E’ da questo versante del lavoro
teatrale contemporaneo che vengono spesso, oggi, le maggiori e più originali innovazioni. Specie l’attore
sociale non ci ricorda soltanto l’incredibile incisività socio-antropologico delle tecniche teatrali, ma si fa
anche alfiere di provocatorie proposte di nuove forme di arte e di nuove forme di bellezza. L’utilità
sociale è direttamente proporzionale alla qualità artistica, e dunque all’efficacia estetica: terapeuticità,
gioco e originalità estetica tutto insieme. Gli strumenti del teatro risultano tanto più efficacie, in ambito
socio-pedagogico-terapeutico, quanto più alta è la qualità artistica dello spettacolo. Lo stesso Armando
Punzo è il nemico più radicale della considerazione socio-pedagogica del Teatro Carcere, dimostrando di
fatto il primato dell’artistico sul sociologico. Egli ha dimostrato anche e soprattutto che l’impossibile può
diventare possibile, che possiamo riuscire ad evadere da quel carcere che è innanzitutto dentro di noi. Il
chiodo fisso di Volterra, al di là di questo, era dar vita a Volterra, un teatro stabile in carcere. Punzo
afferma: “Il teatro in carcere non è nato per rendere il carcere meno carcere. Il teatro non rede il carcere
più umano, come si intende comunemente, né più sopportabile per il detenuto, non crea più vicinanza
tra l’interno e l’esterno. Perché qui non si tratta di entrare in carcere per smantellare il carcere: queste
sono idiozie pure che non hanno prodotto nulla”. E poi continua parlando del teatro educativo-
terapeutico: “E’ evidente, allora, che il teatro funziona anche come educazione, terapia, sebbene si tratti
di risultati ottenuti indirettamente… C’è una grande differenza fra l’utilizzare il teatro come mezzo
affinché i detenuti capiscano, crescano si liberiano, e l’affrontare il teatro come un prova, per poi
scoprire di essersi liberati… Il teatro è un lavoro su di sé, ma il fine è il prodotto, lo spettacolo…”
Insomma, è chiaro come Punzo abbia certo a cuore il valore terapeutico –indiretto- del teatro, ma lo
spettacolo in sé ha la priorità. Punzo voleva trasformare il carcera da Istituto di Pena in Istituto di
Cultura: “ho guardato alle potenzialità degli esseri umani. Il carcere mi interessa perché dimostra che gli
esseri umani possono avere evoluzione che ad alcuni sembrano improbabili, impossibili.” Punzo cercava
gente che non avesse nulla a che fare con la cultura e il teatro, gente con la quale fare teatro ripartendo
da zero. Ebbene, citiamo “Santo Genet commediante e martire” spettacolo che promette un “incontro”
con Shakespeare e non solo. Quando il sipario si apre, vediamo una moltitudine di oggetti e figure
umane apparentemente disordinate, mentre un Punzo scurovestito rimane per alcuni minuti sui gradini
del proscenio con in mano una caraffa e un calice. Oggetti e personaggi sono capitati lì “dopo la
tempesta”, trattenuti nell’isola-scena come in un limbo, mentre il tempo scorre come la sabbia che un
attore in proscenio lascia cadere a lungo con entrambi le mani, così come l’uomo vestito in scuro lascia
cadere gli oggetti metallici. Desdemona ha in mano un fazzoletto e lo avanza, tendendo il braccio;
l’attore-regista glielo ruba, sempre con aria dubbiosa; intanto un Riccardo III, perplesso, va avanti e
indietro sul lato sinistro del palco. Calibano urla la propria rabbia impotente e Giulio Cesare, con il
mantello insanguinato, risale la platea (continuamente percorsa dagli attori) per montare in scena. Al
centro una statua verosimilmente di Otello. E’ il bianco a dominare la scena, conferendo alle figure un
aspetto statuario, quasi fantasmatici, plasmati della stessa materia dei sogni. Intanto è il regista-
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
demiurgo a dar loro voce, letteralmente: avvicinandosi ad ognuno di loro, come per abbracciarli o
sussurragli all’orecchio, permette loro di parlare tramite il suo microfono. E lo spettacolo continua: due
giovani esibiscono in giro un enorme libro attorno al collo (riferimento ai tanti libri nell’opera
shakesperiana o alla biblioteca di Prospero). Ma gli uomini-libro sono due come i libri che Goldoni evoca
nelle sue prefazioni: quello del Mondo e quello del teatro, come dire della Vita (o Natura) e dell’Arte. Un
continuare di riferimenti: una delle due fanciulle, ora vestita in nero e accanto a un Giulio Cesare che si
pugnala in loop, reitera a lungo lo stesso gesto del bere da una coppa (quella avvelenata del finale di
Amleto?). E poi, delle scale vengono innalzate e utilizzate (gli attori salgono) per recitare dei monologhi.
Il finale: sul grande letto al centro, l’uomo in scuro strappa delle pagine (di un copione?) mentre una
delle due giovani, quella che prima brindava, cade in crescendo a una crisi di pianto. L’uomo scuro
abbandona la scena e scende in platea, allontanandosi e dando la mano al bambino che poco prima
aveva fatto rotolare fin sotto al palco un globo. Un spettacolo che, pur intrinseco di riferimenti –non
soltanto shakesperiani- punta al cuore della rappresentazione. E, infatti, per Punzo c’è bisogno di un
“attore in rivolta”, pensante: “che disarticola il linguaggio. Non dà corso alla storia, al gesto che si rifà
alla vita, non la ripete, cerca di spegnerla in se stesso… cambiare se stessi per cambiare il mondo,
eliminare se stessi, quello che sappiamo non essere noi stessi, ma il noi stessi sociale.” Ed è pure con la
bellezza, pur se amara, che ci viene offerta la sola, piccola e precaria possibilità di riavvicinarci al vero e
dunque a noi stessi. E’ sempre possibile che si dia vera vita nella falsa, ovvero libertà nella costrizione,
bellezza nello squallore. Per valorizzare questo teatro della “vita”, che permette il lavoro su di sé,
riportiamo le parole di Pitozzi in appendice del saggio di Rokem, “Filosofi e uomini di scena. Pensare la
performance”: “è necessario adottare una condotta, iscriversi in un’andatura: è necessario in altre
parole fare della filosofia, così come del teatro, un esercizio spirituale –un’arte di vivere-… La filosofia,
come il teatro, appare così una pratica del pensiero per rifare la vita.” Naturalmente la formula “rifare la
vita” appartiene com’è notto ad Artaud e, insomma, si tratta finalmente di cominciare a riconoscere il
potenziale filosofico implicito nell’agire teatrale. Un altro importante contributo lo dà pure Antonio
Attisani nel volume “Teatro Akripolis. Testimonianze ricerca azioni”. Attisani propone i restituire una
centralità nel processo educativo del teatro, richiamando Aristotele e la sua visione teatrale, almeno per
quanto riguarda la questione della catarsi. Secondo recenti interpretazioni della Poetica, la catarsi non
alluderebbe a una funzione terapeutica-psicologica, ma riguarda il suo ruolo nel portare a compimento
un processo formativo del giovane e poi dell’adulto iniziato con le musiche e con la specifica catarsi che
esse provocano. E la stessa cosa viene sostenuta da Donini: “la tragedia indirettamente completa la
formazione anche morale dell’uomo: ma non perché direttamente insegni a essere buoni proponendo
esempi o perché predichi una qualsiasi morale; semplicemente giova a formare l’intelligenza pratica che
mette l’uomo in grado di risolvere da sé i problemi che la vita impone di affrontare.” La filosofia
contemporanea è abbastanza disinteressata al teatro e la conferma ci viene da un libro di Sloterdijk
intitolato “Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica”, nel quale, nonostante ci si riferisca all’uomo
come un qualcuno che si esercita, che fa esercizi, ani che è esercizio, “un esercizio verso l’alto”,
mediante il quale l’individuo si migliora, Sloterdijk riesce nella non facile impresa di non citare neppure
una volta Grotowski o il teatro in generale.
15. LEO DE BERARDINIS: LA COMMEDIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA.
La Commedia dell’Arte contemporanea costituisce un mondo a volte litigioso. L’esistenza della
Commedia dell’Arte contemporanea è certo innegabile, ma è pure vero che i rapporti fra Commedia
dell’Arte contemporanea e quella antica sono molto controversi, alla fin fine indimostrabili. Del resto
non va dimenticato che siamo ben lontani dall’avere idee chiare e verità definitive, a cominciare dalla
stessa spiegazione ed origine del nome. L’abitudine alle idee correnti invita a pensare che la Commedia
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
dell’Arte sia un genere teatrale popolato di maschere fanno salti e smorfie, si innamorano e si
bastonano. L’uso del termine “commedia” ha finito per ridurre a un solo genere, quello puramente,
appunto, comico, mentre il sostantivo “arte” ha assunto sfumature romantiche di un’allusione alla
creatività pura. In realtà, però, il termine “commedia” rimanda probabilmente e semplicemente a
connotazioni più generiche della pratica teatrale, così come il termine “arte” rimanda alle corporazioni.
La commedia dell’Arte è dunque il teatro dei professionisti organizzati in compagnie. La Nuovo
Commedia dell’Arte è stata influenzata, ispirata a quella antica e, si badi, non costruita su di essa o
recuperata. La Commedia dell’Arte antica (così come quella di oggi) non ha mai avuto una estetica, uno
stile o una tecnica, ma conserva la suggestione profonda dell’immagine mitica degli attori dell’Arte
come attori creatori, maestri di ogni tecnica performativa. Claudia Contin Arlecchino, Ferruccio Merisi o
Michele Monetta, infatti, non parlano di una “ripresa” ma, piuttosto, di un omaggio alla vecchia
Commedia: “Chi volesse riprenderla, oggi, non può partire né dal proprio arbitro né da una presunta
tradizione, non credibile dopo una così lunga interruzione”. “Rifare” la Commedia è un fenomeno
soprattutto italiano e bisogna stare attenti a non parlare mai di “tecnica” della Commedia: ad oggi
possiamo parlare, semmai, di derivazioni, visto che ci mancano le tecniche espressive –e i modi d’uso, i
codici- con i quali si faceva la vecchia e tradizionale Commedia dell’Arte. Distinguiamo ora due linee
diverse nella scena italiana novecentesca: la prima è quella veneta-veneziana, incarnata soprattutto da
Giovanni Poli. Pur essendo ancora legata all’idea di un recupero-rifacimento del fenomeno storico –
erroneamente considerato come un genere- questa linea attoriale sta ben attenta a non cadere nella
pseudo-archeologia, i cui danni maggiori vengono prodotti a livello pedagogico. L’altra linea è quella da
Strehler fino a Leo de Berardinis, linea che vuole rendere omaggio al mito di un teatro creato dagli
attori-autori. Leggiamo quanto dice de Berardinis riguardo al suo spettacolo “Ritorno di Scaramouche”:
“Il ritorno di Scaramouche è quindi il ritorno di una mentalità: l’attore-autore che scrive col corpo, con la
voce, con la luce, coi suoni, con lo spazio scenico, con i proprio compagni…” Lo spettacolo di Elena Bucci
e Marco Sgrosso “La pazzia di Isabella. Vita e morte di Comici Gelosi” rappresenta un esito possibile
della linea registica di riscoperta della Commedia dell’Arte. Di questa performance ci è rimasta una
meticolosa descrizione dovuta alla penna del diarista Giuseppe Pavoni. Come già accennato, uno degli
episodi più importanti relativi al rilancio della Commedia dell’Arte è senz’altro quello che ha avuto come
protagonisti Leo de Berardinis e il suo Il ritorno di Scaramouche, con il quale il Leo risale sino alle fonti
moderne di quell’arte attorica e di quel teatro d’attore. “Avendo sempre identificato il teatro con l’arte
attorica e considerato il testo una delle sue tante componenti, era quasi naturale sentire la necessità di
indagare quel mondo per prenderne ispirazione. E mi avvicina ad esso [alla Commedia dell’Arte] anche il
fatto che, per tentare di essere un attore totale, ho affrontato pure testi veri e propri, cosa che anche i
comici dell’Arte facevano. Questo lavoro mi ha dato l’occasione di prendere coscienza del fatto che,
insieme a Shakespeare, la Commedia dell’Arte è un fondamento importante del mio teatro…” Una delle
sorprese e delle scoperte durevoli di questo incontro con la Commedia fu appunto la maschera, più
esattamente la mezza maschera. Elena Bucci conferma che la proposta di lavorare con la maschera fu
una formidabile occasione di cambiamento. Gli attori vennero chiamati ad essere pure autori di sé
stessi, dal testo alla creazione del personaggio, dall’allenamento fisico sino alla pratica
dell’improvvisazione. Il ritorno di Scaramouche, ad ogni modo, rappresenta l’ultimo del ciclo degli
spettacoli-capolavori di Leo, inaugurando successivamente una nuova fase, ripartendo da zero (o meglio
da Shakespeare, come ogni volta che è dovuto ripartire) e che si apre con Lear, del ’96. Lear nasce dalle
suggestioni avute dall’uso della mezza maschera e dal palchetto della Commedia dell’Arte e dalla
concezione di Leo che vede l’arte scenica come l’arte dell’attore. Non è un caso, infatti, che l’attore-
autore decida di assegnare le parti non a priori, ipotizzando aderenze con i personaggi ma, piuttosto, su
criteri di mentalità: “Questo è l’attore, colui che è nudo, a mani nude, senza protesi tecnologiche. Nudo
come? Nudo come l’attore della commedia dell’arte”. Ad ogni modo, non fu facile realizzare King Lear n.
1, specie per gli attori, chiamati a recitare Shakespeare alla maniera della Commedia. Così commenta
Sgrosso: “La cura della parola shakesperiana si inquinava della più recente passione per la genuinità
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
aspra dei dialetti e l’esperienza travolgente di Scaramouche lasciava in eredità le maschere e il palchetto
della Commedia dell’Arte. Rispetto al primo Lear, le prove ‘a tavolino’ venivano frequentemente
interrotte per sperimentare in scene stimoli che nascevano dall’improvvisazione.” Ed è ancora Marco
Sgrosso a sottolineare che quel Lear arrivò in momento di crisi personale di Leo, tanto da fargli
affermare: “Lo spettacolo era frammentario e provocatorio ma ricco di intuizioni e soluzioni geniali:
l’universo di Lear era frantumato perché Leo stesso era frantumato.” Tuttavia, sarebbe riduttivo definirlo
così e, infatti, Antonio Alveario ricorda Lear come il “più estremi dei lavori di Leo a cui ho partecipato,
perché siamo alla distruzione dell’involucro, allo sconfinamento teatrale.” Leo, d’altro canto, già negli
anni ’70 lavorava su un progetto di destrutturazione della forma messa in scena e di superamento della
rappresentazione, con Perla Peragallo e l’”l’attore jazz”, mediante pure la sceneggiata napoletana, la
rivista e le canzonette. Dieci anni dopo Il ritorno di Scaramouche, nel 2004, Elena Bucci e Marco Sgrosso
propongono “La pazzia di Isabella. Vita e morte di comici Gelosi”. Nello spettacolo delle Belle Bandiere è
evidente l’intento di rendere omaggio alla Commedia dell’Arte e di raccontare in qualche modo il teatro
e la vita di questi due straordinari Comici, famosi per i loro ruoli di Innamorata e di Capitano, ma anche
per le capacità letterarie di Isabelle. Non è un rifare l’opera ma omaggiarla, occasione per un confronto
libero eppure rispettoso con i fantasmi dei due grandi attori, tanto da far resistere Elena
nell’interpretare il cavallo di battaglia di Isabella: La pazzia di Isabella, appunto. Fra gli attori della loro
generazione, Elena Bucci e Marco Sgrasso furono scelti da Guccini non soltanto per il loro passato con
Leo de Berardinis, ma pure perché il percorso delle Le Belle Bandiere che si costruirono, mostrava la
loro grande affinità con i Comici dell’Arte. Così la Bucci parla dello spettacolo: “C’è un molteplice filo che
unisce questo agli altri miei progetti: la visione del teatro come luogo di un misterioso colloquio tra vivi e
morti, dove intreccio scritture originali intorno a persone realmente vissute che mi hanno guidato con il
loro mito luminoso alle mie invenzioni, secondo una pratica di lavoro che sento simile a ciò che si
immagina fosse la commedia all’improvviso. Le scritture sceniche e le elaborazione dei testi partono
dalla raccolta di materiali molto vari che alimentano improvvisazioni, scritte, riprese e corrette,
mescolano i registri comici e tragici, e si intrecciano a musica, canto, movimento fino alla creazione di
personaggi originali in maschera e non…” Marco Sgrasso aggiunge: “immagina un collegamento tra la
dinamica scenica descritta da Giuseppe Pavoni e un progetto teatrale che, partendo da questa memoria,
consentisse un confronti fra gli attori presenti e quelli rappresentati.” E dunque si capisce che, il loro
scopo, non era quello di mettersi alla pari con grandi attori quanto, piuttosto, quello di omaggiare il loro
percorso artistico per testimoniare l’importanza del lavoro civile della professione del teatro. Emerse,
comunque, la necessità di nuove scritture che dessero corpo teatrale agli Andreini e, dunque, si partì
dalle improvvisazione, dalle annotazioni, dalle correzioni. Scrivere all’improvviso in scena. Si partì dai
documenti di Pavoni e, d’altro canto, si riadattarono e si crearono pure scritture sceniche originali a
partire –sempre- dai documenti. Il testo, che pure rimane importante in un lavoro del genere, vacilla,
tanto da non corrispondere mai a ciò che viene rappresentato: il testo è sostanzialmente un canovaccio.
Conviene, però, confrontare il primo (2006) e l’ultimo (2014) testo della Pazzia. Dal punto di vista
drammaturgico la differenza maggiore sembra consistere nella scomparsa del personaggio chiamato
Peste, interpretato da Elena e dotato di una maschera dal lunghissimo naso adunco. Peste assolveva ad
una funzione essenzialmente informativo-narrativa, aiutando a mettere a diposizione del lettore e dello
spettatore le notizie principali concernenti la vita e l’arte di Francesco e di Isabella. Nell’ultimo copione
Peste sparisce e lascia il compito di narrare ad Elena-Isabella (pur sempre con la maschera). In pratica,
qui Peste, da personaggio vero e proprio diviene un altro dei modi di esistenza scenica di Isabella:
l’Isabella-narratrice che racconta se stessa, accanto all’Isabella invocata dall’Aldià dall’amato Francesco e
all’Isabella che recita Filliade. Dal punto di vista linguistico, il copione del 2014 si rivela per ciò che è: un
copione d’attore, caratterizzato dunque da un flusso di oralità, fortemente “dialettato” rispetto alla
versione del 2006. La versione del 2014 è chiaramente più ricca, con più varianti, ma restano entrambi
testi preventivi. Concludendo, possiamo affermare che lo spettacolo si sviluppa fondamentalmente sul
tema del “nulla resta” ed è soprattutto nel finale che trionfa. Francesco, che ha appena finito di lottare
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
lOMoARcPSD|11124565
con la Morte come Capitan Spavento, si toglie la maschera e racconta dell’improvvisa scomparsa
dell’adorata consorte sulla via dell’Italia, dopo i trionfi di Parigi. E conclude così: “Voglio vivere solo nella
memoria dei giorni e dei trionfi vissuti insieme… come in quel maggio 1589, ti ricordi?” Isabella raccoglie
l’invito a ricordare e rimembra la rivalità con Vittoria Piisimi, che esibì uno dei cavalli di battaglia di
Isabella. Il racconto arriva sino al punto in cui lei in scena rinsaviva bevendo un filtro e cominciava a
parlar d’amore, recitando e rivolgendosi al proprio amato come una di quelle tante volte che
interpretava il ruolo dell’Innamorata (anche se ora morta). Isabella si ridesta e attacca il monologo
finale, riconoscendo l’incapacità di recitare dentro un corpo che non le appartiene più, che la capisce e
che non capisce. Così come Elena non volle recitare il cavallo di battaglia di Isabella, pure quest’ultima
riconosce che: “La Pazzia, è andata, è stata, è data…” Ed ecco, dunque, che trionfa il “nulla resta”, nella
speranza di ritrovarsi [Isabella e Francesco] oltre il confine della vita e della morte.
Downloaded by Martina Cuomo (lamartee03@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Otello nel laboratorio di Stanislavskij. Introduzione al metodo delle «azioni fisiche»Da EverandOtello nel laboratorio di Stanislavskij. Introduzione al metodo delle «azioni fisiche»Nessuna valutazione finora
- Prove di Drammaturgia n. 1/2015: Per/formare l’opera. Arti viventi, spazi, costumiDa EverandProve di Drammaturgia n. 1/2015: Per/formare l’opera. Arti viventi, spazi, costumiNessuna valutazione finora
- La Poetica di Tadeusz Kantor: L'eredità di un regista pittoreDa EverandLa Poetica di Tadeusz Kantor: L'eredità di un regista pittoreNessuna valutazione finora
- GROTOWSKI - Il Teatro PoveroDocumento23 pagineGROTOWSKI - Il Teatro PoveroGiulia LeonciniNessuna valutazione finora
- P. BROOK Lo Spazio VuotoDocumento14 pagineP. BROOK Lo Spazio VuotodebNessuna valutazione finora
- Capire Il TeatroDocumento14 pagineCapire Il TeatroAlice LeoniNessuna valutazione finora
- Teatro e Attore Nel '900Documento3 pagineTeatro e Attore Nel '900matteosetturaNessuna valutazione finora
- Il Teatro Di Simone WeilDocumento68 pagineIl Teatro Di Simone Weilina_neckel1186Nessuna valutazione finora
- Ingresso A TeatroDocumento3 pagineIngresso A Teatrogiorgia santoNessuna valutazione finora
- Att InsaniDocumento4 pagineAtt InsaniRaz-rub IINessuna valutazione finora
- SEMIOTICA TEATRALE - AppuntiDocumento13 pagineSEMIOTICA TEATRALE - AppuntiStefano CosiminiNessuna valutazione finora
- SEMIOTICA TEATRALE - AppuntiDocumento12 pagineSEMIOTICA TEATRALE - AppuntiStefano CosiminiNessuna valutazione finora
- Prove di Drammaturgia n. 1/2010: Dramma VS postdrammatico: polarità a confrontoDa EverandProve di Drammaturgia n. 1/2010: Dramma VS postdrammatico: polarità a confrontoNessuna valutazione finora
- La danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoDa EverandLa danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoNessuna valutazione finora
- Storia Del Teatro Moderno e ContemporaneoDocumento81 pagineStoria Del Teatro Moderno e ContemporaneomimmaNessuna valutazione finora
- 2 DicembreDocumento2 pagine2 DicembreFrancesca BassaniNessuna valutazione finora
- Luca Ronconi e Rafael Spregelburd La Simultaneit Attaverso La ModestiaDocumento119 pagineLuca Ronconi e Rafael Spregelburd La Simultaneit Attaverso La ModestiaAlina MasgrasNessuna valutazione finora
- La Verticale del Ruolo: Metodo di auto-preparazione dell’attoreDa EverandLa Verticale del Ruolo: Metodo di auto-preparazione dell’attoreNessuna valutazione finora
- IlTeatroDiRegia ArtioliDocumento14 pagineIlTeatroDiRegia ArtioliTiberio EnsoliNessuna valutazione finora
- Editoriale. Ai Confini Della Performance Epica.Documento2 pagineEditoriale. Ai Confini Della Performance Epica.Zibaldone Estudios ItalianosNessuna valutazione finora
- Scritture Per La ScenaDocumento10 pagineScritture Per La ScenaTeresa CriscuoloNessuna valutazione finora
- Meldolesi PDFDocumento18 pagineMeldolesi PDFina_neckel1186Nessuna valutazione finora
- Luce Attiva: Questioni della luce nel teatro contemporaneoDa EverandLuce Attiva: Questioni della luce nel teatro contemporaneoNessuna valutazione finora
- Su ciò che viene chiamato «arte»: L’arte vista da TolstójDa EverandSu ciò che viene chiamato «arte»: L’arte vista da TolstójNessuna valutazione finora
- Cosa E' Il TeatroDocumento3 pagineCosa E' Il TeatroFRANCESCO CASELLANessuna valutazione finora
- Forma e Forza: Cinema, soggettività, antropologiaDa EverandForma e Forza: Cinema, soggettività, antropologiaNessuna valutazione finora
- Storia Del Teatro RussoDocumento37 pagineStoria Del Teatro RussoMegan CasiraghiNessuna valutazione finora
- BRECHT-Scritti TeatraliDocumento10 pagineBRECHT-Scritti TeatraliGiulia LeonciniNessuna valutazione finora
- REGIA TEATRALE - RiassuntoDocumento11 pagineREGIA TEATRALE - RiassuntoGiulia SalernoNessuna valutazione finora
- VIE FESTIVAL 13-23 ottobre 2016: Modena/Bologna/Carpi/Vignola Teatro/Danza/Musica/CinemaDa EverandVIE FESTIVAL 13-23 ottobre 2016: Modena/Bologna/Carpi/Vignola Teatro/Danza/Musica/CinemaNessuna valutazione finora
- La Forma Cinematografica EĖjzenštejn RiassuntoDocumento11 pagineLa Forma Cinematografica EĖjzenštejn Riassuntodisergiovalerio14Nessuna valutazione finora
- Il Metodo V.D.A.M. di Carlo Merlo: Una pedagogia attoricaDa EverandIl Metodo V.D.A.M. di Carlo Merlo: Una pedagogia attoricaNessuna valutazione finora
- Lo Spazio VuotoDocumento29 pagineLo Spazio Vuotosimone guaragnaNessuna valutazione finora
- 5592 Articolo 16079 1 10 20151124Documento4 pagine5592 Articolo 16079 1 10 20151124Kamal TidulNessuna valutazione finora
- Appunti Storia Del Teatro GuardentiDocumento23 pagineAppunti Storia Del Teatro GuardentiCecilia VidalNessuna valutazione finora
- La Crisi Della DrammaturgiaDocumento61 pagineLa Crisi Della DrammaturgiaMirko FelizianiNessuna valutazione finora
- Tesina Su Vita Di Galileo Di Brcht-TestoDocumento20 pagineTesina Su Vita Di Galileo Di Brcht-TestoFilippo CrudettiNessuna valutazione finora
- La Struttura Del Testo DrammaticoDocumento3 pagineLa Struttura Del Testo DrammaticoFRANCESCO CASELLANessuna valutazione finora
- Appunti Delle Lezioni Di Storia Del Teatro e Dello SpettacoloDocumento13 pagineAppunti Delle Lezioni Di Storia Del Teatro e Dello SpettacoloGianni BalestrieriNessuna valutazione finora
- Le Forme Del Melodramma Dallopera Al Fil PDFDocumento5 pagineLe Forme Del Melodramma Dallopera Al Fil PDFIvan Di LeonardoNessuna valutazione finora
- SEMIOTICADocumento4 pagineSEMIOTICAAlessandra NoceraNessuna valutazione finora
- Le Origini Del Teatro ModernoDocumento5 pagineLe Origini Del Teatro ModernoBiancaNessuna valutazione finora
- Craig. IL MIO TEATRODocumento210 pagineCraig. IL MIO TEATROSimonaNessuna valutazione finora
- Realtà e Sogno. Suggestioni poetiche con Theo AnghelopulosDa EverandRealtà e Sogno. Suggestioni poetiche con Theo AnghelopulosNessuna valutazione finora
- Corpo TeatroDocumento6 pagineCorpo TeatroPino AlessandriNessuna valutazione finora
- Tesi Di Laurea - Dal Testo Alla Scena Am PDFDocumento275 pagineTesi Di Laurea - Dal Testo Alla Scena Am PDFChiàCalapristiNessuna valutazione finora
- 85 Articolo 88 1 10 20191228Documento16 pagine85 Articolo 88 1 10 20191228Ilaria FranceseNessuna valutazione finora
- Teatro: strumento per comprendere e promuovere l'interazione socialeDa EverandTeatro: strumento per comprendere e promuovere l'interazione socialeNessuna valutazione finora
- Grotowski e Il Segreto Del Novecento TeatraleDocumento16 pagineGrotowski e Il Segreto Del Novecento TeatraleAndrea TuroneNessuna valutazione finora
- Grammatica DrammaturgicaDocumento30 pagineGrammatica Drammaturgicacinzia ferraraNessuna valutazione finora
- Dagli otto anni agli ottantotto: Il teatro per bambini e ragazzi del Piccolo Teatro di MilanoDa EverandDagli otto anni agli ottantotto: Il teatro per bambini e ragazzi del Piccolo Teatro di MilanoNessuna valutazione finora
- Manuale IstruzioniDocumento81 pagineManuale IstruzioniDavid MartínezNessuna valutazione finora
- Saldatrice: Manuale D'Istruzione Per L'UsoDocumento65 pagineSaldatrice: Manuale D'Istruzione Per L'UsoPietro KawasakiNessuna valutazione finora
- Vimec V64 RimastDocumento22 pagineVimec V64 RimastJesús Martínez FernádezNessuna valutazione finora
- Medicina AlternativaDocumento5 pagineMedicina AlternativaMatteoNessuna valutazione finora
- NSI - Tavola Di Ricarica 2015 - WebDocumento5 pagineNSI - Tavola Di Ricarica 2015 - WebMaxNessuna valutazione finora
- Ingredienti Del Testo - ORTOGRAFIADocumento46 pagineIngredienti Del Testo - ORTOGRAFIAGiovanni SbrizziNessuna valutazione finora
- ChiaroveggenzaDocumento4 pagineChiaroveggenzamimi gattoNessuna valutazione finora