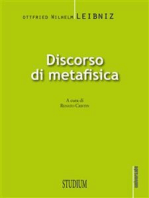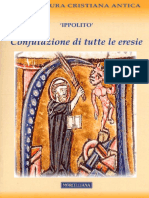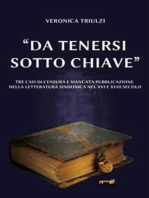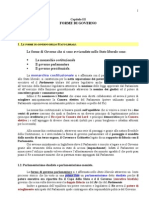Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
La Genesi Del Liber Pontificalis Alla Lu PDF
Caricato da
leostefano15Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
La Genesi Del Liber Pontificalis Alla Lu PDF
Caricato da
leostefano15Copyright:
Formati disponibili
ANDREA ANTONIO VERARDI
LA GENESI DEL LIBER PONTIFICALIS ALLA LUCE
DELLE VICENDE DELLA CITTÀ DI ROMA
TRA LA FINE DEL V E GLI INIZI DEL VI SECOLO
Una proposta
Premessa
La vexata quaestio della genesi e datazione del Liber Pontificalis è stata
riaperta ormai da circa dieci anni, sulla scia delle proposte dello studioso
olandese Herman Geertman1: la sua attività ha avuto il merito di sensibi-
lizzare la comunità scientifica nei confronti di un argomento considerato
sostanzialmente “chiuso” dopo l’impareggiabile studio effettuato da Louis
Duchesne sul finire del XIX secolo2.
Il breve contributo che qui propongo è figlio di questa nuova stagio-
ne di studi sul Liber Pontificalis ed ha tutti i limiti di un work in progress:
sarà, dunque, tutt’altro che esaustivo e, meno che mai, conclusivo. Il mio
desiderio è, piuttosto, quello di ampliare in chiave problematica il ventaglio
delle possibilità interpretative ed offrire, sperabilmente, un ulteriore motivo
di riflessione3.
1
H. Geertman, Documenti, redattori e la formazione del testo del «Liber Pontificalis», in
Id., Il «Liber Pontificalis» e la storia materiale. Atti del colloquio internazionale (Roma, 21-22
febbraio 2002), Koninklijkevan Gorcum, Assen 2003.
Questo saggio è stato ristampato, insieme ad altri dedicati dallo studioso al Liber, in Id., «Hic
fecit basilicam». Studi sul «Liber Pontificalis» e gli edifici ecclesiastici di Roma da Silvestro a
Silverio, a cura di S. de Blaauw, Peeters, Leuven 2004.
2
L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, I e II, E. De Boccard, Paris 1886-1892 (Anast. Paris
1955 e 1981).
3
In questo lavoro utilizzerò unicamente il materiale raccolto in occasione della mia tesi
di laurea magistrale, rimasta inedita, dal titolo Genesi e funzioni del primo Liber Pontificalis:
le cosiddette Epitomi (relatore prof.ssa Lidia Capo, correlatore prof.ssa Giulia Barone, discus-
sa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma «La Sapienza» nell’A.A
2007/2008). Da quel lavoro i miei studi sono proseguiti, con particolare attenzione alla materia
canonistica e liturgica contenuta nel Liber Pontificalis, aprendo nuovi possibili scenari che
sono oggetto della mia tesi di dottorato, la quale sarà discussa a breve presso l’università di
Roma Tor Vergata. Nel frattempo, però, sono state pubblicate altre ricerche; in particolare,
sull’argomento, gli atti di un convegno tenutosi ad Auxerre: F. Bougard-Michel Sot (eds.), «Li-
ber», «Gesta», Histoire. Ecrire l’histoire des évêques et des papes, de l’Antiquité au XXIe siècle,
Brepols, Turnhout 2009, in cui tutta la prima sezione è dedicata al Liber Pontificalis romano;
e soprattutto L. Capo, Il Liber Pontificalis, i Longobardi e la nascita del dominio territoriale
della chiesa romana, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2009.
Tali ricerche, condotte autonomamente ma mosse da analoghi punti di partenza e da comuni
considerazioni sullo status quaestionis, presentano però conclusioni solo in parte coincidenti
RSCr 10(1/2013) 7-28
03 Verardi.indd 7 04/09/13 10.50
8 Da vescovi di Roma a papi
Non è quindi mia intenzione affrontare in questa sede questioni, pure
assai importanti, come la tradizione manoscritta del Liber o analizzare pun-
tualmente tutte le ipotesi proposte negli anni dagli studiosi riguardo alla sua
genesi, quanto, piuttosto, presentare per grandi linee lo stato dell’arte e avan-
zare programmaticamente alcune possibili ipotesi, offendo un breve saggio
delle potenzialità di un possibile cambio di prospettiva rispetto alle tendenze
interpretative attualmente in auge.
1. In breve sul Liber Pontificalis: stato dell’arte4
Dalla fine del secolo XIX, si è soliti indicare univocamente con il titolo
di Liber Pontificalis (da ora in avanti LP), una raccolta di biografie papali,
presentate in serie cronologica a partire da Pietro e differenti per lunghezza,
che raccolgono notizie di vario genere (dati biografici, eventi salienti, atti-
vità legislativa – in campo giuridico e liturgico –, munificenza, ordinazioni
ecc...), secondo una struttura ben definita5.
Questo testo ha attirato da sempre l’attenzione degli studiosi essendo
la prima fonte, e spesso l’unica, a fornici sistematicamente informazioni ri-
guardo alla chiesa di Roma, dalle sue origini sino al medioevo. In particolare
esso è stato oggetto, sul finire del secolo XIX, di due edizioni critiche, rea-
lizzate a breve distanza l’una dall’altra, curate dal Duchesne e da Theodor
Mommsen6, le quali hanno avuto il pregio di delineare per la prima volta,
dopo un’attenta disamina dell’enorme e complessa tradizione manoscritta,
una possibile “storia” del testo e della sua origine.
Per quanto riguarda la sua presunta prima fase redazionale, datata in ma-
niera differente dai due editori al VI (Duchesne) o al VII secolo (Mommsen)7,
sono state individuate tre versioni di un medesimo testo: due caratterizzate
da biografie in media più brevi, e per questo interpretate come delle sintesi,
ed una da biografie tendenzialmente più ampie e più ricche di particolari,
identificata come una redazione a sé stante.
I due testi più brevi, denominati dagli editori epitomi (Mommsen) o
abregées (Duchesne), constano di una redazione contenente le biografie da
Pietro a Felice IV (526-530), denominata feliciana (da ora in poi F) e di un’al-
tra che riporta le biografie papali da Pietro a papa Conone (686-687), chia-
mata cononiana (da ora in poi K).
L’epitome feliciana è stata tramandata da tre manoscritti, tutti di area
francese, redatti tra la fine del secolo VIII e la metà del IX, i quali recano una
con le mie e, quindi, per il momento non saranno utilizzate nella redazione di questo contributo,
poiché verranno ampiamente discusse nella mia tesi dottorale.
4
Sullo status quaestionis, con accurata disamina delle diverse posizioni, L. Capo, Il Liber
Pontificalis, pp. 23-58.
5
Per la struttura del LP si veda L. Duchesne, Le Liber, p. XXXIII.
6
In ordine di apparizione si tratta di L. Duchesne, Le Liber; e T. Mommsen, Liber Pontifi-
calis. Pars prior, Gesta Episcoporum Romanorum I, Weidmannos, Berolini 1892.
7
Per la prima datazione, con ampie riflessioni, L. Duchesne, Le Liber, pp. XXXIII-XLVII.
Per la seconda, invece, T. Mommsen, Liber, p. XVIII.
03 Verardi.indd 8 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 9
collezione di diritto canonico conosciuta come Sanctimauriana, compilata
intorno alla metà del secolo VI, ed integrata verso la fine dello stesso, con
ogni probabilità nella Gallia meridionale. Sul rapporto tra questa collezio-
ne canonica ed F si basano le considerazioni degli editori riguardo alla sua
possibile datazione: sia il Duchesne che il Mommsen, infatti, concordano
per una datazione della collezione ultima al 590, ma il primo ritiene che l’e-
pitome, realizzata a Roma prima del 590, vi sia stata aggiunta durante la sua
compilazione, mentre il secondo che essa sia stata realizzata in Gallia in fun-
zione della raccolta canonica, in un periodo più tardo rispetto a quest’ultima,
e che vi sia stata apposta prima della realizzazione del testimone più antico
che la conserva, vale a dire alla fine del secolo VIII8.
L’altra epitome, quella cononiana, è tramandata unicamente da due ma-
noscritti, anch’essi di area francese, databili entrambi al secolo IX, i quali
conservano testi di argomento canonico e liturgico. Riguardo a questa reda-
zione i due editori non hanno formulato delle ipotesi di datazione molto chia-
re: entrambi, infatti, constatano che essa è stata utilizzata da due cronache
franche redatte alla metà del secolo VIII, ma da ciò il Mommsen ricava una
possibile redazione in Gallia nella metà del secolo VIII, mentre il Duchesne
evita di pronunciarsi chiaramente sulla questione, considerando comunque
la prima parte dell’epitome, quella sino a Felice IV, redatta a Roma in un
periodo non ben definito9.
Entrambi gli editori, comunque, considerano F e K come due epitomi,
di taglio diverso, derivate da un testo ormai perduto, che sarebbe da con-
siderare il vero è proprio LP. Di questo (denominato π) la versione giunta
sino a noi, dalla tradizione manoscritta ampia e complessa, rappresentereb-
be una sorta di riedizione definitiva, intrapresa intorno alla metà del secolo
VI, al tempo del pontificato di Bonifacio II (530-532) e proseguita poi a più
riprese sino alla metà del secolo IX, di una prima redazione oggi scomparsa
(π), che giungeva probabilmente, come i due testi più brevi, alla biografia
di papa Felice IV (526-530), ma che era stata intrapresa al tempo di papa
Ormisda (514-523)10.
Questo rimaneggiamento (detto P) sarebbe stato compiuto, secondo il
Duchesne, durante il pontificato di papa Vigilio (537-555), e completato al-
lora con le biografie comprese tra quella di papa Bonifacio II (530-532) e
quella di Silverio (536-537)11; per il Mommsen, invece, la seconda redazione
del testo, quella in nostro possesso, sarebbe stata redatta a Roma alla fine del
secolo VII, utilizzando però, per la parte relativa al secolo VI, fonti coeve12.
Come hanno notato gli editori, questi tre testi, pur nella loro differente
estensione cronologica, presentano, per le biografie da Pietro a Felice IV,
8
Per un’analisi formale dell’epitome feliciana e dei suoi manoscritti: L. Duchesne, Le
Liber, pp. XLIX-LIV; e anche T. Mommsen, Liber, pp. LXIX-LXXI.
9
L. Duchesne, Le Liber, pp. LIV-LVII; e anche T. Mommsen, Liber, pp. LXXI-LXXIV.
10
L. Duchesne, Le Liber, pp. XL-XLVIII.
11
L. Duchesne, Le Liber, p. XXXVI-XLI.
12
T. Mommsen, Liber, p. XIV.
03 Verardi.indd 9 04/09/13 10.50
10 Da vescovi di Roma a papi
delle particolarità che in qualche modo li differenziano tra loro e che porte-
rebbero a escludere una filiazione diretta delle due cosiddette epitomi (F e
K) dal testo più ampio in nostro possesso (P). La loro impresa è stata resa
ancora più ardua dalla mancanza – per tutti e tre gli scritti F, K e P – di una
tradizione manoscritta antecedente al secolo VIII, nonché da una sorta di
contaminazione laterale tra la tradizione dell’epitome cononiana e quella
di P: K infatti presenta un testo dalla fisionomia autonoma solo sino alla
biografia di papa Felice IV (526-530), mentre per il resto dà sicuramente una
sintesi del testo di P13.
Entrambi gli editori, consci della centralità del problema dei rapporti tra
questi tre testi per la comprensione dell’origine del LP, pur muovendo spesso
dagli stessi argomenti, hanno proposto due ricostruzioni, entrambe filologi-
camente plausibili, ma in fin dei conti alternative.
Per lo studioso francese, i due testi più brevi, F e K, sarebbero due testi-
moni indipendenti di una prima redazione del LP oggi perduta (artificiosa-
mente ricostruita dal Duchesne sommando il testo delle due epitomi), realiz-
zata a Roma probabilmente al tempo di papa Ormisda (514-523) e proseguita
sino al pontificato di Felice IV (526-530), mentre il testo più ampio, P, rap-
presenterebbe una seconda edizione realizzata sulla base di π al tempo di
papa Vigilio (537-555), mediante una revisione del suo materiale e l’aggiunta
delle biografie comprese tra il pontificato di Bonifacio II (530-532) e quello
di Silverio (536-537)14.
Anche il Mommsen pensò all’esistenza di una prima redazione del LP
oggi perduta, ma, per ragioni codicologiche e soprattutto linguistiche, la datò
agli inizi del secolo VII, e ritenne anche che da questo testo primigenio si fos-
sero sviluppati due differenti rami della tradizione, uno diretto, che avrebbe
dato vita sul finire del secolo VII ad una seconda redazione del LP (il nostro
P), caratterizzata da qualche cambiamento ed integrazione, ed uno indiretto
che, mediante il passaggio intermedio di un’epitome, anch’essa perduta, por-
terebbe ai testi di F e K, redatti in Gallia entro il secolo VIII15.
Come è noto, tra le due proposte, gli studiosi hanno optato per la tesi del
Duchesne, ritenuta quella storicamente più plausibile e dunque convincente,
percependo la questione dell’origine del LP come archiviata definitivamente
con la sua edizione – sebbene non siano mancate, negli anni, interessanti
integrazioni ed approfondimenti, che non hanno però mai messo in dubbio
l’impianto interpretativo dello storico francese16. Questo, almeno, sino a po-
13
A tal proposito L. Duchesne, Le Liber, p. LVII.
14
L. Duchesne, Le Liber, pp. XL-XLVIII.
15
T. Mommsen, Liber, p. XIV.
16
A mio avviso, l’integrazione più interessante all’ipotesi del Duchesne è stato quella
proposta da R. Cessi, Lo scisma Laurenziano e le origini della dottrina politica della Chiesa
di Roma, in «Archivio Reale della Società Romana di Storia Patria» XLII (1919), pp. 5-229,
in particolare pp. 71-107; ma v. anche R. Vielliard, Les titres Romains et les deux éditions du
«Liber Pontificalis», in «Rivista di Archeologia Cristiana» 5(1928), pp. 89-108; ma anche, più
recentemente, tra gli altri, P. Carmassi, La prima redazione del «Liber Pontificalis» nel qua-
dro delle fonti contemporanee. Osservazioni in margine alla vita di Simmaco, in H. Geertman
03 Verardi.indd 10 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 11
chi anni fa, quando appunto Geertman ha avanzato una serie di considerazio-
ni relative alla storia del testo, alla sua genesi ed al rapporto tra le tre redazio-
ni, che si distaccano di molto dalle soluzioni sino ad ora adottate, giungendo
anche a sostenere la necessità di una nuova edizione critica del LP17.
Nei suoi studi egli ha provato a ridisegnare il processo di formazione
dei testi relativi al Liber a noi pervenuti secondo un ordine inverso rispetto
a quello proposto dal Duchesne e, parzialmente, anche dal Mommsen: egli
ritiene che le epitomi siano successive a P, che sarebbe quindi la I redazione.
Esse deriverrebbero da questa, ma attraverso un rimaneggiamento (perduto)
del Liber P a noi giunto, sostanzialmente contemporaneo alla stessa prima
edizione, e dunque databile, come il primo, entro il 53018.
Tra le tre tesi sin qui sommariamente esposte, quella del Mommsen si
è rivelata nel lungo periodo poco persuasiva, e quella del Geertman manca
ancora del necessario apparato di dimostrazioni per scalfire in profondità il
sistema proposto dal Duchesne, le cui proposte, in ultima analisi, rimangono
ancora le più convincenti.
2. Dal Liber ai libri: tre testi per una storia? Una proposta
Le ipotesi sin qui avanzate, pur nella loro differenza, mi pare si muovano
comunque tutte all’interno di una medesima linea interpretativa che predili-
ge il testo della seconda redazione a discapito di quello delle due cosidette
epitomi, e che prevede, per sciogliere il nodo del rapporto tra i tre scritti, la
presenza di un passaggio intermedio tra le prime e la seconda (rappresentato
per il Duchesne dalla redazione π), con il quale spiegare le analogie e, soprat-
tutto, dar ragione delle analogie19.
Questo modo di procedere, pur filologicamente plausibile, mi sembra però
soffrire dei limiti dell’ecdotica lachmanniana, che, concentrandosi unicamente
sul problema delle varianti testuali, concede molto poco alle problematiche di
carattere storico. Questi limiti sono ancora più evidenti in presenza di un’opera
non autoriale e, soprattutto, aperta a revisioni ed integrazioni, per cui l’utilizzo
di un metodo strettamente filologico rischia di compromettere sensibilmente la
comprensione del suo effettivo carattere, facendo passare in secondo piano il
fatto che F, K e P, pur nella loro similarità, mantengono una fisionomia autono-
ma e godono comunque di una tradizione manoscritta propria.
Se, infatti, è innegabile che i tre testi abbiano tra di loro un rapporto di
stretta dipendenza, e che la seconda redazione P utilizzi le due epitomi20, lo
(ed.), Il «Liber Pontificalis», pp. 235-266, sebbene le sue proposte derivino dalla revisione
del Geertman.
17
H. Geertman, Documenti, redattori, pp. 267-284, mentre la proposta di una nuova edi-
zione in Id., Le biografie del «Liber Pontificalis» dal 311 al 535. Testo e Commentario, ibi,
pp. 285-355.
18
H. Geertman, Le biografie del «Liber Pontificalis» dal 311 al 535. Testo e Commenta-
rio, p. 270.
19
In particolare L. Duchesne, Le Liber, pp. LVII-LXVII.
20
Mi pare sia ancora valida la dimostrazione del Duchesne, ibi, pp. LX-LXV.
03 Verardi.indd 11 04/09/13 10.50
12 Da vescovi di Roma a papi
è pure, a mio avviso, il fatto che queste ultime presentino caratteristiche che
le rendono concettualmente “differenti” l’una dall’altra e rispetto alla cosid-
detta seconda redazione.
Una possibile conferma dell’autonomia delle tre redazioni è rintraccia-
bile nella natura stessa delle loro varianti disgiuntive. Analizzando F, K e P,
infatti, si nota facilmente che non tutte le divergenze sono attribuibili a corre-
zioni di stile o alla volontà di presentare in maniera sintetica, o più ampia, le
medesime notizie, ma che, al contrario, in molti casi esse sembrano essere il
frutto di una ben chiara e differente volontà narrativa: cioè la capacità degli
autori di un’opera di scegliere struttura, temi e modi espositivi, in modo tale
da rendere il loro testo funzionale al raggiungimento di fini determinati.
Senza entrare per il momento nello specifico delle notizie riportate dai
tre testi, un buon esempio credo possa essere costituito dalla presenza o meno
nei tre scritti di alcune tipologie di notizie.
Se si confrontano, infatti, le biografie contenute in F, K e P, si nota che,
sebbene la loro macrostruttura sia la medesima, diversa è, invece, la selezio-
ne sia dei temi da trattare, sia del modo di trattarli.
Un caso esemplare, a tal proposito, è offerto dal modo in cui i tre testi
affrontano la biografia di papa Marcello (308-309): l’epitome feliciana pro-
pone niente di più che una scarna voce di catalogo, fornendo unicamente
i dati relativi alla nazione del papa, al nome del padre, ai dati cronici di
imperatori e consoli coevi, alle ordinazioni, al luogo e data di sepoltura e
alla durata del pontificato21; rispetto ad essa l’epitome cononiana inserisce la
notizia relativa alla fondazione di un cimitero e l’istituzione in «quasi dio-
cesis» dei XXV titoli cittadini22; la seconda redazione (P) aggiunge ulteriori
particolari alle notizie sulla fondazione di luoghi adibiti al culto e introduce,
anche, una lunga sequenza narrativa a carattere agiografico, relativa alla vita
e alla sepoltura del papa23.
Queste distinzioni sono in realtà delle vere e proprie “tendenze” che ca-
ratterizzano i tre testi e che, in generale, possono essere così indicate: l’epi-
tome Feliciana, a differenza di K e P, non inserisce mai la rubrica relativa
alle donazioni papali ed è generalmente interessata all’attività legislativa
dei papi; la cononiana è poco interessata alle questioni dogmatiche e dedica
invece molto spazio alle costruzioni effettuate dai papi; mentre la seconda
redazione tende a dedicare più spazio alle notizie di fondazioni e donazioni,
così come a quelle a carattere agiografico.
Un altro possibile indizio a favore della tesi di testi distinti credo possa
essere rappresentato dalla loro chiara volontà di presentare in maniera diffe-
rente gli stessi argomenti, a seconda dei propri punti di vista, o delle proprie
aspettative di comunicazione.
Un esempio, tra i tanti, di questa dinamica appare nel modo in cui F, K
e P trattano la risoluzione dello scisma acaciano nella biografia di papa Or-
21
L. Duchesne, Le Liber, pp. 72-74 ; e anche T. Mommsen, Liber, p. 243.
22
L. Duchesne, Le Liber, pp. 72-74 ; e anche T. Mommsen, Liber, p. 243.
23
L. Duchesne, Le Liber, pp. 164-165; e anche T. Mommsen, Liber, pp. 43-44.
03 Verardi.indd 12 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 13
misda (514-523): per K, che alla questione dedica non più di qualche riga, la
soluzione sarebbe dovuta semplicemente alla morte dell’imperatore eretico
e all’ascesa al trono del cattolico Giustino24; per F, invece, che come P dedi-
ca ampio spazio alla vicenda, essa sarebbe stata opera del diacono Diosco-
ro, che «exposuit [...] culpas Acati, ut etiam omnes simul cum Iustino Aug.
adclamarent dicentes: Et hic et in aeternum damnetur Acatius»25; per P, anco-
ra, la soluzione sarebbe venuta da un’iniziativa di papa Ormisda che avrebbe
inviato, «cum [...] consilio» di Teodorico, al nuovo imperatore Giustino una
legazione «et cum vinculo cyrographi et textum libelli reintegravit ad unita-
tem sedis apostolicae damnantes Petrum et Acacium vel omnes hereses»26.
Come si può notare, le differenze tra i tre scritti sono molto lontane
dall’essere semplici varianti testuali e indicano chiaramente il differente
“concetto” che li anima: F, K e P, infatti, differiscono non solo nella selezio-
ne dei temi ritenuti importanti all’interno della “loro” storia dei vescovi di
Roma, ma anche nel modo di proporli al lettore.
Poiché, dunque, queste varianti sembrano caratterizzarsi come il risultato
di una ben chiara ed autonoma volontà narrativa degli “autori”, credo sia op-
portuno spostare l’attenzione da un piano prettamente filologico-testuale ad
uno storico-critico, nella convinzione che l’analisi dei rapporti tra i testi ed il
loro contesto sia la via più indicata per comprendere sino in fondo il rapporto
che intercorre tra F, K e P, e, soprattutto, chiarire in qualche modo aspetti
essenziali della loro genesi.
3. Roma tra V e VI secolo: una città ed una chiesa cittadina tra aspirazioni
universalistiche e politica locale
Come detto nei paragrafi precedenti, secondo la quasi comunis opinio
degli studiosi, la prima redazione del LP e le epitomi sarebbero state redatte
a Roma nella prima metà del secolo VI, precisamente tra il pontificato di
Ormisda (514-523) e quello di papa Vigilio (537-555), in un contesto storico
in cui sono in atto complesse dinamiche socio-politiche, le cui radici sono
collocabili nel secolo precedente, ma che trovano, più o meno forzatamente,
la loro risoluzione proprio in questa manciata di anni. Pochi periodi, infatti,
come i cento anni che corrono a cavallo tra V e VI secolo sono stati forieri,
per la città di Roma, di sconvolgimenti sociali, economici e politici tanto
turbolenti quanto, per i loro esiti finali, inaspettati27.
Nel tempo che intercorre tra il 451, data in cui si tenne il Concilio di
Calcedonia, ed il 555, anno in cui si concluse la guerra greco-gotica, si gio-
cò nell’Urbe una complessa partita volta a definire dipendenze e autonomie
L. Duchesne, Le Liber, pp. 98-100; e anche T. Mommsen, Liber, pp. 258-259.
24
L. Duchesne, Le Liber, p. 100; e anche T. Mommsen, Liber, pp. 260.
25
26
L. Duchesne, Le Liber, p. 270; e anche T. Mommsen, Liber, pp. 130.
27
Poiché l’argomento gode di una bibliografia sterminata, mi limiterò a citare in questo
paragrafo unicamente i testi essenziali per un inquadramento delle problematiche trattate.
03 Verardi.indd 13 04/09/13 10.50
14 Da vescovi di Roma a papi
delle élites cittadine, così come della chiesa locale, sia nei loro rapporti reci-
proci, sia rispetto ai poteri politici esterni “forti”, la cui azione si estendeva
sulla città: i nuovi regni sorti in Italia, prima quello di Odoacre poi quello dei
Goti, e l’impero d’Oriente in piena ripresa.
Da un punto di vista politico-istituzionale, poco dopo la metà del V se-
colo, il già complesso quadro tardo-antico, caratterizzato dall’avvicendarsi
vorticoso di generali innalzati al rango di imperatori in base all’umore dei
propri eserciti28, era stato reso ancora più instabile dalla definitiva scomparsa
di un’autorità imperiale riconosciuta in Occidente (la deposizione di Romolo
Augustolo, con l’invio delle insegne imperiali in Oriente è del 476). A ciò si
aggiungevano il disinteresse per la situazione italiana dimostrato dall’impe-
ratore di Costantinopoli, le cui preoccupazioni erano rivolte al mantenimento
di un’unità politica in partibus orientis, e l’affermazione sul territorio italico
della dominazione barbarica29, frutto di un colpo di mano prima, e di una mi-
rata politica imperiale poi, che ebbe nell’erulo Odoacre (re in Italia dal 477
al 493) il suo primo rappresentante, e nel goto Teodorico (re dal 493 al 526)
l’esponente politicamente di maggior rilievo30.
Il patricius goto, infatti, riuscì a creare sul territorio italico una nuova
istituzione politica a carattere monarchico, per certi versi analoga a quelle
romano-barbariche che negli stessi anni si andavano formando in Gallia e si
assestavano nell’Africa settentrionale, capace di esercitare un governo au-
tonomo nell’Italia centro-settentrionale e, allo stesso tempo, di imporsi con
forza sulla scena internazionale.
In pochi anni, infatti, la sua particolare capacità politica aveva permesso
a Teodorico di stringere alleanze con Visigoti, Burgundi, Vandali, Turingi ed
Eruli, presentandosi comunque quale unico rappresentante dell’imperatore
in Occidente, e di proporsi quale equilibrato interlocutore dell’antica aristo-
crazia senatoria, e anche, pur essendo ariano, delle autorità ecclesiastiche
cattoliche, in particolare del vescovo di Roma31.
Esemplare, a tal proposito, rimane la visita effettuata da Teodorico a
Roma nell’anno 500, durante la quale il re, secondo la ricostruzione of-
fertaci dall’Anonimo Valesiano, si comportò come un autentico sovrano
romano e cattolico32.
28
In generale sul V secolo si veda S. Mazzarino, L’impero romano, II, Laterza, Bari 1991
[ultima rist. 2010].
29
Si veda a tal proposito M. McCormick, Odoacer, the emperor Zeno and the Rugian
victory legation, in «Byzantion» 47(1977), pp. 212-222.
30
Su questa fase politica si veda F. Giunta, Gli Ostrogoti in Italia, in G. Pugliese Caratelli
(ed.), Magistra barbaritas: I barbari in Italia, Credito Italiano, Milano 1984, pp. 54-96.
31
Su Teodorico ed il regno goto d’Italia: J. Moorhead, Theodoric in Italy, Clarendon
Press, Oxford 1993. Ma anche, sui vari aspetti del suo regno: Teodorico il Grande e i Goti d’I-
talia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo (Milano, 2-6 Novembre
1992), Centro Italiano di Studi sull’alto medioevo, Spoleto 1993.
32
J. Moreau (ed.), Excerpta Valesiana (révisé par V. Velkov), Teubner Verlag, Leipzig
1968, paragrafi 65-67. Per un inquadramento cronologico dell’Anonimo Valesiano: G. Zecchi-
03 Verardi.indd 14 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 15
Non era certo il primo caso di visita di un sovrano a Roma, e le moda-
lità con cui essa si svolse, stando alla descrizione fatta dalla nostra fonte,
rientrano nel classico adventus regio tardo-antico, ma è la prima volta che,
come ha notato Massimiliano Vitiellio, «gli aspetti religiosi precedono il
cerimoniale» civile33. Questo cambio di “liturgia” mette certo in evidenza
un particolare rispetto del re per il vescovo della città, ma mostra anche un
progressivo mutamento della semantica del potere nel contesto politico e
culturale romano, che, se da un lato rendeva manifesta l’importanza rag-
giunta dal cristianesimo e del suo massimo rappresentante in Roma, cioè
il papa, dall’altro permetteva a individui ed istituzioni che non potevano
vantare legami con l’antica romanitas di trovare comunque una forma di
legittimazione politica agli occhi del popolo.
A questo quadro di instabilità si aggiungevano anche le problematiche
legate alla religione, che, pur riguardando questioni in parte prettamente ec-
clesiali, andavano ad incidere con forza sui già precari equilibri politici.
Sin dagli anni successivi al Concilio di Calcedonia (451), infatti, il vesco-
vo di Roma ed il patriarca di Costantinopoli, con al suo fianco l’imperatore,
si trovavano arroccati su differenti posizioni dottrinali34. Sebbene le proble-
matiche in gioco fossero molteplici e non tutte di carattere religioso, furono
principalmente due le questioni, entrambe regolate dal concilio calcedonen-
se, che infiammarono il confronto e causarono un progressivo allontanamen-
to tra le parti: la difficile ricezione presso gli orientali delle disposizioni del
Concilio di Calcedonia che definivano il dogma delle due nature di Cristo,
e condannavano il monofisismo35; il rifiuto da parte del papa di accettare la
disposizione che sanciva il primato in Oriente della chiesa di Costantinopoli,
ni, L’Anonimo Valesiano II: genere storiografico e contesto politico, in Teodorico il Grande e
i Goti d’Italia, pp. 808-819.
33
M. Vitiellio, Teoderico a Roma. Politica, amministrazione e propaganda nell’“adven-
tus” dell’anno 500 (Considerazioni sull’Anonimo Valesiano II), in «Zeitschrift für Alte Ge-
schichte» LIII, 1(2004), pp. 73-120.
Sulla cerimonia dell’adventus in epoca tardo-antica si veda in generale: S. MacCormack,
Change and Continuity in Late Antiquity: The Ceremony of Adventus, in «Historia» 21(1972),
pp. 721-752; M. McCormick, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzan-
tium and the Early Medieval West, Maison des Sciences de l’Homme et Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge 1986; P. Dufraigne, Adventus Augusti, adventus Christi. Recherches sur
l’exploitation ideologique et litteraire d’un ceremonial dans l’antiquité tardive, Brepols, Paris
1994, pp. 255-258; A. Fraschetti, La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana, Laterza,
Roma-Bari 1999, pp. 194-197 e 257-258.
34
Su Calcedonia e la politica di Leone riguardo al concilio, si veda M. Wojtowytsch, Pap-
sttum und Konzile von den Anfängen bis zu Leo I (440-461), A. Hiersemann Verlag, Stuttgart
1981, pp. 304-350.
35
Per quanto riguarda la prima problematica, i padri riuniti a Calcedonia, sotto la spinta
di papa Leone Magno e su ispirazione del suo Tomus Favianii, avevano precisato il dogma
delle due nature di Cristo e condannato il monofisismo, in particolare le dottrine professate da
Nestorio e da Eutyche. Sul Concilio di Calcedonia, ma con un interesse prettamente teologico
P.-T. Camelot, Storia dei Concili Ecumenici. II. Efeso e Calcedonia, Libreria editrice Vaticana,
Città del Vaticano 1997, pp. 111-163.
03 Verardi.indd 15 04/09/13 10.50
16 Da vescovi di Roma a papi
il cui patriarca, presule dell’oramai unica città imperiale, pretendeva un’au-
torità pari a quella del vescovo di Roma36.
Nel primo caso, mentre la condanna di Eutiche e del monofisismo venne
accettata unanimemente in Occidente, dove tutti i vescovi si schierarono con
il papa a favore della linea del Concilio, in Oriente invece la questione diede
vita a scontri accesi tra ortodossi e monofisiti, cui non furono estranee macchi-
nazioni politiche, inimicizie personali e diretti interventi dell’imperatore. Data
l’entità dello scontro, l’imperatore Zenone (425-491) promulgò nel 482 il co-
siddetto Henoticon (“Editto di Unione”), nel tentativo di offrire una soluzione
pacificatrice tra ortodossi, monofisiti e nestoriani. Questo modo di agire, però,
invece di placare gli animi creò forti tensioni tra le autorità religiose e politiche
orientali – in particolare tra imperatore e patriarca – ed il clero e vescovo di
Roma, che erano come detto in precedenza, di fede strettamente calcedoniana37.
Ad inasprire ancor di più la frattura dogmatica con il papa contribuiva
poi il tentativo orientale di “elevazione” della sede patriarcale di Costantino-
poli ai livelli più alti dell’autorità ecclesiale. Un passo importante in questa
direzione fu compiuto attraverso il c. 28 del Concilio di Calcedonia38, sotto-
scritto da tutti i vescovi orientali e mai accettato da Roma, nel quale non solo
veniva ribadito il privilegio d’onore della chiesa costantinopolitana, ma ve-
niva anche sancita, in virtù di questo, la sua autorità sulle metropoli orientali
del Ponto, dell’Asia e della Tracia, così come su quelle in territorio barbarico.
È interessante notare, a tal proposito, come in questa disposizione il con-
cetto di auctoritas apostolica, su cui si basava l’antico privilegio delle sedi
patriarcali di Roma, Antiochia e Alessandria, venisse completamente abban-
donato a favore di un honus civile, fondato unicamente sul prestigio dell’im-
peratore e del senato, per cui Costantinopoli diveniva improvvisamente supe-
riore agli antichi patriarchi orientali ed ormai quasi rivale di Roma39.
Questa dinamica risulta ancora più carica di implicazioni politiche se si
considera che ciò avveniva proprio negli stessi anni in cui il papato, oltre alla
tradizionale autorità in materia teologica e liturgica, da sempre riconosciuta-
gli, aveva iniziato ad avocare a sé anche un primato di natura giurisdizionale,
affermando che, in virtù del lascito di Pietro, il vescovo di Roma possedeva
una sorta di «sollecitudine per tutte le chiese»40.
36
Su questo argomento J. Gaudemet, Storia del diritto canonico. «Ecclesia et civitas»,
Editrice San Paolo, Torino 1994, pp.144-147; ed ancora sul primato del vescovo di Roma ibi,
pp. 154-166. Sulla politica di Leone I nei confronti dell’Oriente E. Caspar, Geschichte des
Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, I, Antiquariat th. Stenderhoff,
Münster 1985, pp. 462-564.
37
Su questi argomenti P. Maraval, La ricezione di Calcedonia nell’Impero d’Oriente, in
J.-M. Mayeur - C.-L. Pietri - A. Vauchez - M. Venard (eds.), Storia del Cristianesimo. Religione
Politica e Cultura, ed. it. a cura di G. Alberigo, III, Borla, Roma 2002, pp. 119-153
38
Sul canone 28 del Concilio di Calcedonia: V. Monachino, Il canone 28 di Calcedonia:
genesi storica, L.U. Japadre Editore, L’Aquila 1979.
39
Sulla sempre maggiore concorrenza tra Roma e Costantinopoli: L. Grig - G. Kelly (eds.),
Two Romes. Rome and Costantinople in Late Antiquity, Oxford University Press, Oxford-New
York 2012, in particolare pp. 3-80 e pp. 293-386.
40
J. Gaudemet, Storia del diritto canonico, pp. 154-166.
03 Verardi.indd 16 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 17
Naturalmente le due questioni andarono pian piano sommandosi, am-
plificando le problematiche relative ad ognuna di esse ed esasperando la già
difficile situazione. Gli esiti finali di questa vicenda, infatti, saranno gravidi
di conseguenze, causando l’interruzione della comunione tra la due chiese, la
scomunica reciproca del papa e del patriarca di Costantinopoli e, soprattutto,
l’inizio dello scisma acaciano41.
Come è facile immaginare, tutte queste dinamiche politiche e religiose
di carattere internazionale, o meglio sovranazionale, influivano direttamente
sulla situazione interna della città di Roma, dove le posizioni del re, dell’im-
peratore e del papa si arricchivano degli accenti tipici della politica locale.
Sia il senato che la chiesa cittadina, infatti, avevano ben chiare tutte le
potenzialità di questa intricata situazione politica, che lasciava loro notevoli
margini d’azione e, soprattutto, li rendeva essenziali per qualsiasi iniziativa
regia o imperiale che riguardasse il territorio italiano. Se da un lato, dunque,
impero e regno necessitavano del loro appoggio per affermare le proprie po-
sizioni tra le mura urbane, dall’altro le élites locali sapevano bene che l’ade-
sione o meno alle istanze di questo e quel contendente poteva assicurare loro
più spessore internazionale ed una maggiore affermazione politica e sociale42.
Il Senato, privato progressivamente di molte delle sue prerogative di go-
verno, tentava ora di volgere a suo favore questa situazione per ricavarsi degli
spazi maggiori di rilievo politico e puntava ad assumere completamente su di
sé le prerogative del governo della città, approfittando della buona disposi-
zione del re goto, come della lontananza dell’imperatore. Inoltre, forte delle
capacità economiche dei suoi componenti e dell’appoggio, spesso prezzola-
to, del popolo, tentava di proporsi quale principale interlocutore cittadino di
re ed imperatori, e d’altra parte come unica forza politica capace di difendere
presso questi i privilegi della città, di cui incarnava, simbolicamente, il prin-
cipale elemento di continuità con l’antica romanitas43.
Questa élite di aristocratici composta da clarissimi, spectabiles ed illu-
stres, che ricoprivano le più alte cariche della curia municipalis era riuscita
a mantenere le proprie posizioni di controllo dell’amministrazione pubblica
sotto il dominio goto e aveva continuato ad assicurare a Roma, anche in virtù
dei suoi vasti interessi economici nelle diverse province dell’impero, una
41
In generale sul contesto storico e sullo scisma: L. Duchesne, Histoire de l’Église au VIe
siècle, Ancienne Librarie Fontemoing & Cie E. De Boccard, Paris 1925, in particolare pp. 1-43;
C. Fraisse-Coué, La crescente incomprensione tra l’Oriente e l’Occidente (451-518), in J.-M.
Mayeur - C.-L. Pietri - A. Vauchez - M. Venard (eds.), Storia del Cristianesimo. Religione
Politica e Cultura, pp. 154-199. Sulle tappe dello scisma acaciano: J. Richards, The Popes and
the papacy in the early middle ages 476-752, Routledge and Kegan Paul, London 1979, pp.
55-68; sui testi publicistici prodotti dalle varie fazioni: E. Schwartz, Publizistische Samlungen
zum Acacianischen Schisma, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München
1934, in particolare sul contesto pp. 161-303.
42
Su questo C. Pietri, Aristocratie et société cléricale dans l’Italie chrétienne au Tem-
ps d’Odoacre et de Théodoric, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité» XCIII,
1(1981), pp. 417-467.
43
Ibi, pp. 418-419.
03 Verardi.indd 17 04/09/13 10.50
18 Da vescovi di Roma a papi
continua comunicazione tra centro, periferia ed istituzioni politiche ormai
stabilite a Costantinopoli44.
La Chiesa romana, invece, la cui visibilità politica risaliva alla pace co-
stantiniana, si era progressivamente affiancata al senato sia nel territorio cit-
tadino, sia nel più ampio e variegato panorama istituzionale internazionale.
Nella città erano state la munificenza imperiale e quella aristocratica, copiose
tra IV e V secolo, a garantirle la disponibilità di una notevole quantità di beni,
mobili e immobili, che le davano forza economica e le permettevano di avvia-
re sul territorio una complessa e capillare attività pastorale e assistenziale45.
Sul piano extra-urbano, invece, era stata la sempre maggiore consapevolez-
za del suo vescovo a permettere alla chiesa un’affermazione su vasta scala.
In virtù di un’elaborata dottrina fondata sul primato dell’apostolo Pietro, il
papa poteva infatti proporre la chiesa della città di Roma come modello per
gli usi liturgici di tutte le altre chiese, e insieme tentare di affermarsi come
capo della chiesa “universale”, e come massima autorità religiosa e morale
della cristianità, in aperta dialettica con gli altri vescovi e, soprattutto, con
il potere imperiale, con il quale condivideva le aspirazioni universalistiche e
l’investitura sacrale46.
L’equilibrio esistente tra senato e chiesa, favorito in origine anche dal
loro diverso peso politico e sociale, era stato però fortemente turbato dal
progressivo incremento della ricchezza urbana della chiesa, che aveva por-
tato l’aristocrazia senatoria a percepirla come una diretta minaccia per le sue
prerogative di preminenza economica e di controllo dell’amministrazione
cittadina47. A queste si aggiungeva anche una certa rivalità riguardo a quale
delle due istituzioni potesse rappresentare, extra urbem, la “voce” di Roma:
se da un lato, infatti, la romanitas del senato, come istituzione, era innegabi-
le, dall’altro era anche vero che il vescovo di Roma poteva ormai presentarsi
come rappresentante della cittadinanza tutta, essendo espressione del volere
del clero, del popolo e dello stesso senato, dal cui accordo dipendeva, almeno
formalmente, la sua elezione.
Come è facilmente intuibile, le implicazioni ideologiche del confronto
in atto non erano né poche né poco rilevanti: alla sua radice, infatti, mi pare
si possa individuare un differente modo di percepire Roma, la sua storia ed
il proprio ruolo all’interno di essa, così come una differente visione dei suoi
possibili sviluppi futuri. Posizioni differenti che, naturalmente, nella realtà si
concretizzavano in modi alternativi di leggere la situazione contemporanea
e intraprendere delle azioni volte alla realizzazione dei propri progetti. La
44
M.R. Salzman, The Making of a Christian Aristocracy: Social and Religious Change in
the Western Empire, Harvard University Press, Cambridge MA 2002.
45
C. Pietri, Évergétisme et richesses ecclésiastiques dans l’Italie du IVe à la fin du Ve sié-
cle: l’exemple romain, in «Ktema» 2(1978), pp. 317-337.
46
J. Gaudemet, La storia del diritto canonico, pp. 154-166.
47
Sugli aspetti economici dell’affermazione della Chiesa romana, in particolare all’inter-
no della città: F. Marazzi, I «Patrimonia Sanctae Romane Ecclesiae» nel Lazio (Secoli IV-X):
strutture amministrative e prassi gestionale (dal IV agli inizi del X secolo), Istituto Storico
Italiano per il Medioevo, Roma 1998.
03 Verardi.indd 18 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 19
chiesa cittadina desiderava allentare gli ormai troppo stretti vincoli che la
legavano all’impero, al momento lontano ed eretico, e all’aristocrazia cittadi-
na, che non erano più necessari né dal punto di vista economico, né da quello
politico; il senato, invece, voleva affermarsi come unica forza economica e
politica della città e della penisola e, per far ciò, doveva riuscire a controllare
in qualche modo l’istituzione ecclesiastica, sua concorrente diretta.
Questo almeno in teoria, dato che quelli che sembrano essere degli schie-
ramenti ben delineati e coesi riguardo alla politica interna, in realtà rivelano
al loro interno delle forti frammentazioni a proposito della politica estera: in
maniera trasversale c’erano senatori e chierici che vedevano di buon occhio
un riavvicinamento all’imperatore di Costantinopoli, e altri che credevano
invece più utile seguire una politica filo-gota, appoggiando l’idea di un’Italia
autonoma rispetto all’impero48.
In estrema sintesi credo si possa affermare, senza troppe remore, che
molte delle vicende che animarono Roma in questo periodo, sino alla guer-
ra greco-gotica, furono in buona parte il frutto di una complessa dialettica
tra aspirazioni personali dei componenti delle élites cittadine, sentimento
collettivo di appartenenza alle istituzioni e adesione ai loro sistemi ideolo-
gici di riferimento.
Caso emblematico, in questo senso, è sicuramente il cosiddetto scisma
laurenziano, che interessò la chiesa di Roma dal 498 al 514, dove tutte le
dinamiche, quelle locali come quelle internazionali, sopra esposte sfociarono
in un violento confronto in occasione dell’elezione del successore del papa
Anastasio II, deceduto nel 498. In questa occasione, infatti, quasi in contem-
poranea, vennero elevati al soglio di Pietro due pontefici: uno, Simmaco,
impostosi alla fine come papa legittimo, espressione di una fazione favo-
revole ad una politica filo-gota e anti-orientale; l’altro, Lorenzo, antipapa
per la storia, ma che in realtà per almeno quattro anni aveva effettivamente
controllato la chiesa cittadina quale pontefice, rappresentante della corrente
filo-orientale, favorevole ad una risoluzione dello scisma acaciano e a un
progressivo riavvicinamento con l’imperatore di Costantinopoli49.
La composizione dello scisma papale, avvenuta formalmente nel 506
con l’allontanamento da Roma del presbitero Lorenzo, dopo quasi un decen-
nio di lotte intestine che avevano minato profondamente la coesione sociale
all’interno della città, non aveva però prodotto alcuna soluzione duratura. Le
medesime dinamiche, infatti, si ripresentarono, mutatis mutandis, a distanza
48
Sulla possibile presenza di veri e propri partiti all’interno della società romana C. Pietri,
Le Sénat, le peuple chrétien et les partis du cirque à Rome sous le pape Symmaque (498-514),
in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire», LXXVIII (1966), pp. 122-140.
49
Sullo scisma Laurenziano: R. Cessi, Lo Scisma laurenziano; J. Richards, The Popes,
pp. 69-99; P. Carmassi, La prima redazione del «Liber Pontificalis», pp. 235-266; T. Sardella,
Società Chiesa e Stato nell’età di Teodorico. Papa Simmaco e lo scisma laurenziano,
Rubbettino, Soveria Mannelli-Messina 1996. Di particolare interesse la nuova edizione dei
cosiddetti “apocrifici simmachiani”, con ampio studio storico e filologico: E. Wirbelauer, Zwei
Päpste in Rom. Der Konflikt zwischen Laurentius und Symmachus (498-514). Studien und
Texte, TUDUV Verlagsgesellschaft, München 1993.
03 Verardi.indd 19 04/09/13 10.50
20 Da vescovi di Roma a papi
di poco più di un decennio, all’interno di un contesto politico e religioso
nuovamente in evoluzione: la risoluzione dello scisma acaciano e l’ascesa
al trono di Costantinopoli di un imperatore cattolico avevano, infatti, mutato
completamente il quadro istituzionale internazionale e offerto nuove e diver-
se prospettive alla chiesa e alle élites cittadine50.
È dunque comprensibile che le attenzioni dei contendenti si riversassero
nuovamente su Roma, ed in particolare che le tensioni sfociassero in aperti
contrasti in occasione delle elezioni papali: ottenere il controllo sulla prin-
cipale autorità ecclesiastica dell’occidente, con la possibilità di orientarne
la politica in campo internazionale, voleva dire accaparrarsi un importante
fattore di consenso51.
Le prospettive di sviluppo che nuovamente si aprivano per il senato e la
chiesa della città di Roma, però, erano destinate a rimanere solo potenziali,
dato che furono vanificate dall’inasprirsi dei rapporti tra imperatore e re, e
soprattutto dal conflitto che ne seguì52. La cosiddetta guerra greco-gotica,
durata quasi un ventennio, fu un evento traumatico per la città di Roma
e, più in generale, per tutto il territorio italico: l’impero riconquistava for-
malmente il controllo dell’Italia a discapito del regno goto, l’élite senatoria
scompariva quasi completamente, perdendo comunque le proprie prerogati-
ve di governo della città, e solo la chiesa, pur a fatica, provava a risollevarsi
e ad operare in un territorio martoriato e in una società civile quasi comple-
tamente annientata53.
4. Il LP e le epitomi: tre storie per una chiesa cittadina
Credo sia ora il caso di valutare, alla luce del contesto appena presentato,
alcune delle varianti presenti in F, K e P, per testare la plausibilità dell’ipotesi
che si tratti in realtà di tre testi autonomi per funzione e volontà narrativa.
Poiché però un’analisi di questo tipo, per essere effettuata puntualmente,
richiederebbe ben altro spazio, ho pensato conveniente concentrare la mia
attenzione su di una manciata di esempi significativi, capaci di offrire co-
munque un saggio delle potenzialità del cambio di prospettiva proposto.
50
Su questo: L. Duchesne, Histoire de l’Église, pp. 109-155; J. Richards, The Popes,
pp. 100-136.
51
Sono a mio avviso da interpretare in questo senso i problemi con cui si giunse alla con-
troversa elezione di Felice IV (526-530) e soprattutto a quella di Bonifacio II (530-532), occa-
sione di un nuovo scisma interno alla chiesa romana. Sulla prima elezione si veda L. Duchesne,
La succession du pape Félix IV, in «Mélanges d’archeologie et d’histoire de l’École Française
de Rome» 3(1883), pp. 239-266; sulla seconda P. Bertolini, Bonifacio II, in Enciclopedia dei
Papi, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2000, pp. 492-495.
52
E. Caspar, Geschichte des Papsttums, II, pp. 82-192.
53
Sul periodo Procopius Caesariensis, La guerra gotica di Procopio di Cesarea, a cura
di D. Comparetti, Bottega d’Erasmo, voll. I-III, Torino 1968-1970; E. Caspar, Geschichte des
Papsttums, II, pp. 193-305.
03 Verardi.indd 20 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 21
Esamineremo dunque qui il modo in cui F, K e P hanno trattato il Con-
cilio di Calcedonia, lo scisma acaciano e, in particolare, quello laurenziano,
poiché questi eventi, la cui importanza fu pari solo al loro livello di criticità,
più di altri possono a mio avviso mettere a nudo le posizioni degli autori dei
nostri tre testi, nei confronti sia dei principali temi oggetto della disputa, sia
degli schieramenti che in essi si fronteggiavano.
Per quanto riguarda il Concilio di Calcedonia, dalla presentazione del
contesto storico è emerso che le sue risoluzioni avevano aperto delle pro-
fonde spaccature tra la chiesa orientale e quella occidentale, affrontando
argomenti spinosi come il desiderio di Costantinopoli di proporsi come se-
conda sede episcopale, quasi pari grado con quella romana, e le dispute sulla
natura/e del Cristo.
Data la complessità dei temi trattati ci aspetteremmo dalle tre redazioni
del Liber un’attenzione particolare per quegli aspetti che più stavano a cuore
alla chiesa romana e al suo vescovo: le definizioni della natura del Cristo
e la difesa del primato della sede di Roma. Scorrendo però le biografie dei
pontefici interessati dal concilio e dalla sua problematica ricezione si rimane
colpiti, invece, dalla maniera molto sintetica, e spesso imprecisa, con cui
esso viene trattato.
Come è ovvio, tutti e tre i testi, concentrano la descrizione del concilio
all’interno della biografia di papa Leone (440-461)54, entro il cui pontificato
si svolse effettivamente la vicenda, mentre solo la redazione P vi aggiunge
anche un richiamo nella biografia del suo successore Ilario (461-468)55.
Innanzitutto, analizzando in maniera sinottica il testo delle tre redazioni,
l’elemento di maggior rilievo è rappresentato dalla totale assenza di espliciti
riferimenti al concilio nell’epitome cononiana, la quale riduce tutto l’evento
ad un pronunciamento in materia di fede da parte di papa Leone, insieme a
«multis episcopis, propter heresim Euticium et Nestorium», il cui testo sareb-
be stato posseduto, «hodie», dall’archivio della chiesa di Roma56.
Più articolata si presenta, invece, la ricostruzione nell’epitome feliciana e
nella seconda redazione, le quali, però, offrono ognuna una propria “versio-
ne” del concilio, nel complesso molto lontano dalla realtà dei fatti57.
Sebbene entrambe le redazioni riconoscano nell’eresia nestoriana ed eu-
ticiana la causa del concilio, diversa è l’attribuzione della sua convocazione:
per F, l’iniziativa fu presa su richiesta («per rogatum») dell’imperatore Mar-
ciano, mentre per P fu l’ordine («ex precepto») del papa a chiamare a raccolta
i vescovi per l’assemblea.
Questa differenza, che rimane la più significativa tra le due redazioni,
fu attribuita dal Duchesne ad un semplice errore; a mio avviso, alla luce
dei complessi rapporti tra imperatore e papa sul finire del secolo V e i primi
decenni del VI, credo piuttosto che risalga a una differente posizione degli
54
L. Duchesne, Le Liber, (F e K) p. 90 , (P) pp. 238-241.
55
Ibi, (P) p. 242
56
Ibi, (K) p. 90.
57
Ibi, (F ) p. 90, (P) p. 238.
03 Verardi.indd 21 04/09/13 10.50
22 Da vescovi di Roma a papi
autori nei confronti dei rapporti di potere tra il vescovo di Roma e l’impera-
tore di Costantinopoli. Dove infatti, l’epitome feliciana descrive una sorta di
cooperazione tra i due poteri per la risoluzione di un problema di fede, riguar-
dante tutta la cristianità, la seconda redazione, forse anche per una mutata
situazione politica, attribuisce un ruolo di preminenza al papa.
Salvo questa prima differenza, le due redazioni procedono poi con la de-
scrizione del concilio, sviluppata secondo un medesimo canovaccio, compo-
sto da due sedute deliberative, dall’invio della professione di fede conciliare
da parte dell’imperatore a papa Leone, accompagnato dalla richiesta di un
documento papale che riportasse chiaramente le posizioni dogmatiche della
chiesa romana, e dalla risposta di quest’ultimo, che avrebbe esaudito il desi-
derio imperiale, inviando un tomus fidei58.
Confrontando con attenzione il testo delle due redazioni, però, si nota una
serie di minute varianti narrative che riguardano principalmente l’invio del co-
siddetto tomus ed la conferma da parte del papa delle disposizioni conciliari.
Nel primo caso colpisce la facilità con cui le due redazioni variano la
collocazione temporale dell’invio a Costantinopoli da parte di papa Leone
del tomus «hoc est», come specifica P, «fidem apostolicae ecclesiae Roma-
nae cum cyrographo sancti episcopis Leonis», verosimilmente da identifi-
care con il famoso tomus ad Flavianum59: secondo l’epitome, questo testo
sarebbe giunto a Costantinopoli insieme alla conferma delle decisioni del
Concilio; mentre la seconda redazione, conformemente alla realtà, dà per
scontato il suo invio prima dell’apertura del Concilio, affermando che i ve-
scovi e l’imperatore erano «congregati una cum tomum», dando così al testo
leonino un ruolo centrale nello svolgimento della prima seduta. Tra le due
presentazioni quella di P mi sembra motivata dalla volontà di ribadire con
forza la centralità di Roma e del suo vescovo all’interno del concilio: secon-
do la sua redazione, infatti, malgrado l’assenza del papa, nessuna decisione
venne presa dal concilio se non basandosi sulla sua autorità.
Per quanto riguarda la conferma e la sottoscrizione dei decreti conciliari
da parte di Leone, l’epitome feliciana dice che il papa la inviò insieme al
tomus; la seconda redazione tratta la questione della conferma solo successi-
vamente, a conclusione di una notizia di carattere archivistico in cui vengono
enumerate le epistole scritte da Leone a sostegno delle disposizioni del con-
cilio calcedonense, dicendo che «per quas fidei confirmavit synodi». Anche
in questo caso la seconda redazione, con le sue informazioni più dettagliate,
non perde occasione di mettere in rilievo l’impegno di Leone, dal quale sem-
bra dipendere completamente la ricezione del Concilio.
58
Ibidem.
59
Si tratta di una lunga epistola dogmatica che espone tutta la fede della chiesa cattolica
sul mistero dell’incarnazione, inviato da Leone al patriarca di Costantinopoli Flaviano per
contrastare le teorie eretiche di Eutiche. Il testo del tomus è edito con il titolo Incipit epistola
papae Leonis ad Flavianum episcopum constantinopolitanum de Eutychem, in E. Schwartz
(ed.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, II.II, Walter De Gruyter & Co., Berolini-Lipsiae
1932, pp. 24-33.
03 Verardi.indd 22 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 23
Delle due descrizioni colpisce, comunque, il comune silenzio su di un
argomento controverso come il primato in Oriente della chiesa costantinopo-
litana e sul dissenso delle chiese orientali legate al monofisismo e quindi sul-
le difficoltà di accettazione delle disposizioni conciliari in merito alla natura
del Cristo in quelle terre. Se questo però sembra valere completamente per
F, forse uno strascico delle problematiche appena accennate può invece es-
sere individuato in P, che nella biografia di papa Ilario (461-468), immediato
successore di Leone, parla della conferma dei principali sinodi ecumenici
da parte del papa. La notizia mi sembra interessante sotto diversi aspetti: da
un lato, essa, in linea con le rivendicazioni leonine e gelasiane secondo cui
è solo il papa a confermare le disposizioni dei concili, specifica che il papa
aveva inviato molte decretali e lettere dogmatiche in oriente «confirmans III
synodos Niceni, Epheseni et Calcidonense vel tomum sancti episcopi Leonis
et damnavit Eutychem et Nestorium vel omnes sequaces eorum et vel omnes
hereses»; dall’altro afferma – e qui mi pare entri in gioco la questione del
primato – che mediante queste epistole il papa confermò «dominationem et
principatum sanctae sedis catholicae et apostolicae»60.
Più ampia e, in parte, più complessa è la vicenda del cosiddetto scisma
acaciano, il quale, come abbiamo visto, nasceva proprio sulla scia delle pro-
blematiche calcedonensi.
Anche in questo caso, mentre l’epitome feliciana e la seconda redazione
(P) dedicano ampio spazio alla vicenda, procedendo quasi con il medesimo
testo sino alla biografia di papa Felice III (483-491), l’epitome cononiana,
invece, tace quasi del tutto, riservando solo qualche riga alla sua risoluzione,
nella biografia di Ormisda (514-523).
Che quella dell’autore di K sia una scelta consapevole e non assimilabile
solo ad una volontà di sintesi, è provato a mio avviso dal modo in cui, poco
prima, il testo fa riferimento alla sollevazione del clero della città di Roma
contro papa Anastasio (496-498) per via della sua rinnovata comunione con
il diacono tessalonicense Fotino «sine consilio eorum», evento per alcuni
versi legato allo scisma acaciano, e trasformato, in questo caso, in una vicen-
da soprattutto interna alla chiesa romana61. Mi pare sia interessante notare,
anticipando un poco la questione, il differente atteggiamento che le altre due
redazioni hanno su questo fatto: F tace completamente la reazione del clero,
come le implicazioni di Fotino con lo scisma; P invece non solo rende più
ampio il fronte del dissenso contro l’azione papale, ma aggiunge anche che
Fotino era in comunione con Acacio, dando quindi alla questione una dimen-
sione decisamente più ampia rispetto a K62. Rimanendo sull’argomento, mi
pare che la medesima tendenza si possa riscontrare anche nella biografia di
papa Gelasio (492-496)63, dove F e P riportano in maniera lievemente diversa
la vicenda della riammissione alla comunione del vescovo Miseno: la prima
60
Ibi, (P) p. 242.
61
Ibi, (K) p. 96.
62
Ibi, (P) p. 258.
63
Ibi, (F) p. 94, (P) p. 255.
03 Verardi.indd 23 04/09/13 10.50
24 Da vescovi di Roma a papi
menziona solo la sua reintegrazione, senza aggiungere ulteriori informazioni,
la seconda, invece, ricorda la causa della sua scomunica («qui peccaverat in
causa Acacii et Petri»), ed inserisce un’ampia nota dedicata agli omicidi ad
opera degli scomunicati Acacio e Pietro a Costantinopoli, alla nuova con-
danna dei due da parte di una sinodo presieduta dal papa e all’arrivo a Roma
del vescovo cattolico alessandrino Giovanni, che cercava a Roma un rifugio
sicuro. Quest’ultima notizia mi sembra ancora più interessante ai fini della
nostra analisi, considerato che gli autori affermano che Gelasio avrebbe of-
ferto («praebuit») a Giovanni la sede episcopale di Alessandria, definendola
«sedem secundam», espressione apertamente in contrasto con il c. 28 del
Concilio di Calcedonia che assegnava invece a Costantinopoli questo titolo.
A ciò bisogna poi aggiungere il modo differente con cui le tre redazioni
narrano la conclusione dello scisma, avvenuta sotto il pontificato di papa
Ormisda, già parzialmente analizzata. Come abbiamo visto, anche in questo
caso K dedica alla questione non più di qualche riga, attribuendo la risoluzio-
ne dello scisma, di cui non ha mai parlato in precedenza, alla morte dell’im-
peratore eretico Anastasio e all’ascesa al trono del cattolico Giustino64; per F
e P, invece, che parlano ampiamente della vicenda, essa sarebbe stata il frutto
di prolungate trattative tra il papato, l’imperatore e la chiesa orientale, cui
parteciparono anche il re Teodorico e l’aristocrazia senatoria65.
Sebbene le narrazioni dell’epitome feliciana e della cosiddetta seconda
redazione si sviluppino su di una evidente base testuale comune, in esse si
rilevano, comunque, interessanti divergenze. Degna di nota è in primis la
notizia, riportata dal solo F, per cui di fronte all’opposizione del patriarca
e del clero di Costantinopoli, partigiani di Acacio, il diacono Dioscoro66
avrebbe esposto le ragioni della condanna in modo così convincente da ri-
solvere in modo definitivo il contrasto dottrinario. L’assenza di questa no-
tizia in P, che il Duchesne attribuisce ad un danno materiale nell’antigrafo,
mi sembra invece un’omissione intenzionale degli autori della seconda re-
dazione, le cui motivazioni potrebbero essere individuate nel clima del pon-
tificato di Bonifacio II (530-532), eletto papa dalla fazione filo-gota in op-
posizione proprio all’orientale Dioscoro: dopo la morte di questi, Bonifacio
fece firmare al clero partigiano dell’avversario un libello che ne condannava
la memoria67. Non è difficile, dunque, immaginare che si cancellasse allora
l’elogio entusiastico di un individuo ormai bollato dalla fazione avversa, e
vincente, come scismatico.
Interessante anche, ma questa volta sul piano dei rapporti con l’Oriente,
la breve notizia, riportata sempre da F, a proposito delle lettere e “confuta-
zioni segrete” di cui erano forniti i legati della prima ambasceria di Ormi-
64
Ibi, (K) pp. 98-100.
65
Ibi, (F) pp. 98-100, (P) pp. 269-270.
66
A proposito di Dioscoro: G. Braga, Dioscoro antipapa, in Enciclopedia dei papi, I, pp.
496-499
67
Su questo argomento, con edizione del testo del libello: L. Duchesne, La succession, in
particolare pp. 239 e ss.
03 Verardi.indd 24 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 25
sda a Costantinopoli. Secondo questa redazione i legati, per mandato papale,
qualora l’imperatore avesse rifiutato le condizioni poste da Roma per la ri-
soluzione dello scisma, avrebbero dovuto «divulgarle per la città» per influ-
ire sull’opinione pubblica e creare un elemento di pressione sull’imperatore
stesso (servivano probabilmente a questo le rivolte dei monaci ortodossi di
Costantinopoli)68. Secondo P, invece, che cita le lettere segrete ma non l’ordi-
ne papale, la loro diffusione sarebbe stata il frutto direttamente dell’iniziativa
dei legati e non alla volontà papale69.
Come si può notare non vi è una differenza sostanziale tra i due testi: en-
trambi sostengono che lo scisma è stato concluso nel migliore dei modi, con
il concorso di tutti e senza ledere nessuno, ma per F la questione è completa-
mente risolta con l’intervento di Dioscoro, quindi con un fatto tutto ecclesia-
stico, in cui il re goto d’Italia non ha alcun ruolo, mentre per P, essa sembra
dipendere direttamente dal consenso di Teodorico, verso il quale si dimostra
così una considerazione enorme70.
L’ultimo esempio è quello relativo al cosiddetto scisma laurenziano,
evento, come abbiamo visto, interno alla chiesa romana, che causò in città
una vera e propria guerra civile, che F, K e P trattano ampiamente nella bio-
grafia di papa Simmaco (498-514)71.
Il taglio differente che le redazioni vogliono dare alla vicenda si intuisce
già dal suo incipit: a proposito della doppia elezione, infatti, l’epitome feli-
ciana afferma che con Simmaco fu ordinato anche Lorenzo, «ex qua causa
separata aliqua pars clericorum vel senatorum», indicando chiaramente che
gli schieramenti erano eterogenei, cioè alcuni senatori e chierici appoggiava-
no il primo, altri il secondo, e che non si trattava di un fatto esclusivamente
del clero; nella stessa direzione si muove anche la seconda redazione, la qua-
le però, eliminando l’espressione «aliqua pars», assolutizza in un certo senso
il dissidio interno ai senatori, così come quello del clero; molto stranamente,
invece, l’epitome cononiana tace del tutto sulla questione degli schieramenti,
dando unicamente notizia della doppia elezione.
Tutti e tre i testi procedono poi menzionando l’intervento di Teodorico,
il quale, chiamato in causa, si pronunciò a favore di chi tra i contendenti era
stato ordinato per primo, cioè Simmaco72.
A questo punto sia F che P riportano la notizia di una sinodo tenuta dal
nuovo papa, nella quale, «intuitu misericordiae», Simmaco con il consenso
del clero avrebbe ordinato Lorenzo vescovo della città di Nocera73. La no-
tizia è riportata anche da K che, però, non parla affatto della sinodo, dando
68
L. Duchesne, Le Liber, (F) pp. 98-100, (P) pp. 269-270.
69
Ibidem.
70
Considerazione che in P si riscontra anche nella lista delle donazioni, in cui sono ripor-
tati di seguito sia i doni dell’imperatore cattolico Giustino che quelli dell’ariano Teodorico.
71
La biografia di Simmaco ed i suoi riferimenti allo scisma laurenziano sono tra i testi più
studiati dell’intero LP: si veda tra gli altri P. Carmassi, La prima redazione del «Liber Pontifi-
calis», e T. Sardella, Società Chiesa e Stato.
72
L. Duchesne, Le Liber, (F e K) p. 96, (P) pp. 260-261
73
Ibi, (F ) p. 96, (P) p. 260.
03 Verardi.indd 25 04/09/13 10.50
26 Da vescovi di Roma a papi
l’impressione di voler attribuire tutta a Simmaco la decisione dell’allonta-
namento di Lorenzo74.
La ricostruzione degli eventi prosegue parallelamente per le tre redazio-
ni, con la notizia relativa all’opposizione a Simmaco mossa da alcuni chierici
e senatori, che non solo avrebbero accusato di gravi colpe il papa di fronte
al re goto, ma avrebbero anche costretto quest’ultimo ad inviare in città il
vescovo Pietro d’Altino, quale visitator, e richiamato «occulte» Lorenzo in
città, riaprendo così lo scisma.
A questa visione comune degli eventi la sola redazione P aggiunge una
serie di riferimenti volti ad attribuire la colpa del nuovo scisma quasi esclu-
sivamente al senato, in particolare a due personaggi illustri quali Festo e
Probino, descritti come gli unici responsabili dell’invio della denuncia nei
confronti di Simmaco a Teodorico e della richiesta di un visitator. Questo
desiderio mi pare anche confermato dal fatto che lo scisma nel clero venga
presentato qui come successivo all’iniziativa della denuncia ad opera di «ali-
qui ex clero et aliqui ex senatu, maxime Festus et Probinus»75.
Formalmente questo nuovo scisma sarebbe stato risolto dallo stesso
Simmaco, che avrebbe convocato una sinodo per scagionarsi dalle accuse:
l’assemblea avrebbe riconosciuto innocente il papa che si era purgato con
un giuramento, e lo avrebbe reintegrato nella sua sede, condannando sia il
visitator Pietro, sia Lorenzo. È interessante notare, a tal proposito, che se per
F e P Simmaco sarebbe stato ristabilito all’unanimità «ab omnibus episcopis
et presbiteris et diaconibus et omni clero»76, per K, invece, Simmaco torna
sul soglio di Pietro, cum gloria, unicamente perché ha giurato la propria in-
nocenza, e la sinodo ha preso atto di ciò77.
A questo punto per l’Epitome Feliciana la questione dello scisma è com-
pletamente risolta, mentre l’Epitome Cononiana e la seconda redazione inse-
riscono due racconti differenti, ma simili nella sostanza, parlando di scontri
che interessarono ancora la città, in cui furono uccisi molti sacerdoti e violate
molte «mulieres sanctimoniales». Un evento traumatico che entrambe le re-
dazioni descrivono come voluto dai senatori contro la chiesa, e di cui i colpe-
voli erano in particolare Festo, per K e P, e Probino, per il solo P78.
5. A mo’ di conclusione: il LP, una fonte tra storia, memoria e politica
Mi pare che gli esempi che ho analizzato, pur essendo solo una sorta di
“test” preliminare, propongano un valido elemento di datazione reciproca
delle tre redazioni79, e soprattutto evidenzino chiaramente alcune delle loro
74
Ibi, (K) p. 96.
75
Ibi, (P) p. 261.
76
Ibi, (F ) p. 96, (P) p. 261.
77
Ibi, (K) p. 96.
78
Ibi, (K) p. 96, (P) p. 261.
79
Faccio riferimento alla possibilità di utilizzare la presenza/assenza dell’encomio di Dio-
scoro nelle tre redazioni per datare l’epitome feliciana a prima del pontificato di Bonifacio II
03 Verardi.indd 26 04/09/13 10.50
Verardi - La genesi del Liber Pontificalis 27
peculiarità testuali, offrendo dati importanti a favore della tesi che le due epi-
tomi e la seconda redazione del LP siano in realtà tre testi distinti e autonomi:
tre differenti punti di vista, tutti ecclesiastici, sulla città, sulla sua chiesa e
sulla sua storia.
In particolare essi hanno mostrato il differente atteggiamento che F, K e P
hanno nei confronti dei singoli eventi narrati, e dei soggetti che vi agiscono,
mettendo in luce anche il fatto che i loro autori sembrano calibrare volontaria-
mente il peso da dare alle singole notizie, valutando attentamente le possibili
implicazioni politico-ideologiche del testo che stanno redigendo. Ciò permet-
te di avanzare l’ipotesi che il diverso taglio narrativo adottato dagli autori
possa essere motivato dalla loro adesione a diversi schieramenti o posizioni
ideologiche propri del contesto di fine V ed inizio VI secolo, periodo del resto
individuato dagli studiosi come il più probabile per la loro redazione.
In questo senso, a mio avviso, si coglie tutta l’importanza sia delle va-
rianti testuali, capaci di dare a scritti molto simili valenze specifiche, sia dei
tanti silenzi, presenti in particolare in K, ma da cui non sono esenti né F né P,
i quali mi sembrano rispondere ad una vera e propria “strategia dell’oblio”,
che permette agli autori di non trattare situazioni ritenute particolarmente
“sensibili”: si pensi, ad es., all’utilizzo che ne fa K per evitare di trattare lo
scisma acaciano ed il Concilio di Calcedonia, o F per glissare sulla solleva-
zione del clero contro papa Anastasio e sugli scontri successivi al ritorno sul
soglio di Pietro di papa Simmaco, o ancora alla più volte citata soppressione
dell’encomio di Dioscoro in P.
Il passo successivo, ed è in questa direzione che credo debbano essere
sviluppate le future ricerche sul Liber, sarà quello di provare ad individuare i
motivi che stanno dietro “al detto” così come al “non detto”. Cercare di capi-
re, cioè, se le varianti e le omissioni presenti nelle tre redazioni siano dovute
alla particolare sensibilità dei loro autori nei confronti di alcuni temi, o se il
loro atteggiamento sia, in realtà, dettato dalla volontà di orientare le idee del
pubblico per cui erano pensate. Non credo, infatti, che ai fini di una più am-
pia comprensione dell’opera Liber e dello spessore storico delle sue tre dif-
ferenti redazioni, si possa prescindere dalla loro valutazione all’interno di un
più ampio processo di comunicazione, e dalla risposta, dunque, a due quesiti
fondamentali: cosa le tre redazioni vogliono comunicare e, soprattutto, a chi.
In un’epoca in cui il “fare memoria” è attività tutt’altro che neutra, in
cui si scrive e si riscrive la storia con l’intento di agire direttamente sul quo-
tidiano, l’opera che abbiamo qui brevemente presentato si rivela, alla luce
dei dati raccolti, molto lontana da quei testi destinati alla pietà popolare cui
(530-532), e l’epitome cononiana e la seconda redazione a partire da questo. Questa eventualità
mi pare combaci bene anche con l’unico dato cronologico certo rappresentato dalla biografia di
Felice IV (526-530) cui si fermano tutte e tre le redazioni, così come con le piccole varianti tra
F, K e P, presenti all’interno di questa biografia, le quali trovano ragione nelle problematiche
politico-istituzionali che portarono all’elezione di quel pontefice. A tal proposito si veda L.
Duchesne, La succession, pp. 239-266.
03 Verardi.indd 27 04/09/13 10.50
28 Da vescovi di Roma a papi
l’accomunò il Duchesne80, e molto più simile, nella volontà narrativa, ai tanti
testi di pubblicistica redatti proprio durante lo scisma acaciano e quello lau-
renziano, cui purtroppo non mi è stato possibile accennare in questa sede.
Sarà solo il futuro confronto tra gli altri temi trattati dalle tre redazioni del LP
ed il contesto storico-politico accennato, e soprattutto tra F, K e P e le opere
altre prodotte in questi stessi anni, a permettere di saggiare la plausibilità del-
la proposta che ho avanzato e di verificare se con i testi di pubblicistica le tre
redazioni del LP condividono solo la volontà narrativa o anche le funzioni.
ABSTRACT
The article discusses the ways in which the Epitome Feliciana (F), the
Epitome Cononiana (K), and the second redaction of the Liber Pontificalis
(P) have dealt with particularly critical events as the Council of Chalcedon,
the Laurentian schism, and the Acacian schism, in the light of the complex
historical and political context of Rome between the end of the fifth and the
beginning of the sixth Century. Drawing from data derived from the compari-
son between the texts and the context in which they were redacted, this paper
suggests that F, K and P might be three different versions of the same text
type: three Pontifical books characterized by independent narrative inten-
tions, and resulting from three alternative points of view, originating in the
ecclesiastical milieu, on the city and its church, on its history and its possible
future developments.
L’articolo analizza, alla luce del complesso contesto storico-politico del-
la Roma di fine V ed inizio VI secolo, le modalità con cui l’epitome feliciana
(F), quella cononiana (K) e la seconda redazione del Liber Pontificalis (P)
hanno affrontato eventi caratterizzati da una spiccata criticità come il Con-
cilio di Calcedonia, lo scisma acaciano e quello laurenziano. Sulla base dei
dati derivati dal confronto tra i testi ed il loro possibile contesto di redazio-
ne, il presente contributo propone l’ipotesi che F, K e P possano essere tre
differenti versioni di una medesima tipologia testuale: tre libri pontificales
caratterizzati da un’autonoma volontà narrativa, frutto di tre punti di vista
alternativi, tutti ecclesiastici, sulla città e sulla sua chiesa, sulla sua storia
passata e sui suoi possibili sviluppi futuri.
80
L. Duchesne, Le Liber, p. CLXI.
03 Verardi.indd 28 04/09/13 10.50
Potrebbero piacerti anche
- Puglia A. - Scrivere Nei MonasteriDocumento22 paginePuglia A. - Scrivere Nei MonasteriGabriele1883Nessuna valutazione finora
- Philosophumena I, o La Confutazione Di Tutte Le Eresie (Pseudo Ippolito) (Z-Library)Documento345 paginePhilosophumena I, o La Confutazione Di Tutte Le Eresie (Pseudo Ippolito) (Z-Library)Willer SiqueiraNessuna valutazione finora
- La Bibbia Nei Primi Trovatori - Silvia Cocco - PHD ThesisDocumento197 pagineLa Bibbia Nei Primi Trovatori - Silvia Cocco - PHD ThesisjoaocadenhoNessuna valutazione finora
- Commentario Agli Atti Di Paolo e TeclaDocumento240 pagineCommentario Agli Atti Di Paolo e Tecladanimura100% (1)
- Simonetti and Vian - L'Esegesi Patristica Nella Ricerca ContemporaneaDocumento27 pagineSimonetti and Vian - L'Esegesi Patristica Nella Ricerca Contemporaneaack67194771100% (1)
- Commentario Agli Atti Di Paolo e TeclaDocumento240 pagineCommentario Agli Atti Di Paolo e TeclapgmauNessuna valutazione finora
- Appunti Su Due Recenti Volumi Dedicati A Angelo ColocciDocumento32 pagineAppunti Su Due Recenti Volumi Dedicati A Angelo ColocciGerardo LarghiNessuna valutazione finora
- Dialectica e Sapientia Nel Metalogicon Di Giovanni Di Salisbury PDFDocumento93 pagineDialectica e Sapientia Nel Metalogicon Di Giovanni Di Salisbury PDFginofinNessuna valutazione finora
- Esegesi BiblicaDocumento7 pagineEsegesi BiblicaGiorgio MattaNessuna valutazione finora
- TRISTANO - Biblioteche Al Tempo Di PetrarcaDocumento11 pagineTRISTANO - Biblioteche Al Tempo Di Petrarcaabecedarij100% (1)
- S. Rizzo Il Lessico Filologico Degli UmanistiDocumento420 pagineS. Rizzo Il Lessico Filologico Degli UmanistiAnonymous OvTUPLm0% (1)
- Libri Liturgici e Formazione Dei TestiDocumento2 pagineLibri Liturgici e Formazione Dei TestiLuis López SánchezNessuna valutazione finora
- Sintesi Di Filosofia Medievale - Quadro e Politica - UNISIDocumento10 pagineSintesi Di Filosofia Medievale - Quadro e Politica - UNISISimona CapuozzoNessuna valutazione finora
- Bibbie Cattoliche e Bibbie ProtestantiDocumento18 pagineBibbie Cattoliche e Bibbie ProtestantiDomenico BevilacquaNessuna valutazione finora
- PDF 1) A. Momigliano, ''Storia Antica e Antiquaria''Documento6 paginePDF 1) A. Momigliano, ''Storia Antica e Antiquaria''Cosimo BettoniNessuna valutazione finora
- Immagini Di Vita Religiosa in Unepoca DiDocumento17 pagineImmagini Di Vita Religiosa in Unepoca DiVito CassoneNessuna valutazione finora
- BIANCHI, LUCA - L'Errore Di AristoteleDocumento227 pagineBIANCHI, LUCA - L'Errore Di AristoteleLeandro AntonelliNessuna valutazione finora
- Bellone - Paolo-SenecaDocumento39 pagineBellone - Paolo-SenecaOscar RivasNessuna valutazione finora
- Tacito, Annales 11-12. Introduzione, Testo e CommentoDocumento380 pagineTacito, Annales 11-12. Introduzione, Testo e CommentoTuttle ButtleNessuna valutazione finora
- BISANTI - Introduzione Allo Studio Della PDFDocumento62 pagineBISANTI - Introduzione Allo Studio Della PDFLour Gaya100% (1)
- Boletim de Arqueologia CristianaDocumento116 pagineBoletim de Arqueologia CristianaMarcelo Massao OsavaNessuna valutazione finora
- Castaldi Lucia. Il Codex AmiatinusDocumento14 pagineCastaldi Lucia. Il Codex AmiatinusLorenzo NienteNessuna valutazione finora
- Maria Di Pasquale Barbanti - Macrobio. Etica e Psicologia Nei - Commentarii in Somnium Scipionis - CUECM (1988)Documento215 pagineMaria Di Pasquale Barbanti - Macrobio. Etica e Psicologia Nei - Commentarii in Somnium Scipionis - CUECM (1988)Angelica Gizeth LozanoNessuna valutazione finora
- Mancini Rune VeneticoDocumento23 pagineMancini Rune VeneticoBiodini WoujaNessuna valutazione finora
- Dottrine Gnostiche Nelle PseudoClementineDocumento25 pagineDottrine Gnostiche Nelle PseudoClementineAlan BrcoNessuna valutazione finora
- Le Avventure Di Un Testo-Chiave Di Gregorio Magno (Tra Gerarchie Di Dio e Gerarchie Della Storia)Documento27 pagineLe Avventure Di Un Testo-Chiave Di Gregorio Magno (Tra Gerarchie Di Dio e Gerarchie Della Storia)jaldziamaNessuna valutazione finora
- Trizio 3 PDFDocumento323 pagineTrizio 3 PDFMichele TrizioNessuna valutazione finora
- Caiazzo, Irene - Un Commento Altomedievale Al de Arithmetica Di BoezioDocumento38 pagineCaiazzo, Irene - Un Commento Altomedievale Al de Arithmetica Di BoezioRoberto SchiavolinNessuna valutazione finora
- MundusDocumento13 pagineMundusAlberto LombardoNessuna valutazione finora
- Piovanelli Apocrifi Del Nuovo TestamentoDocumento10 paginePiovanelli Apocrifi Del Nuovo TestamentoAntonioXavierBatistaNessuna valutazione finora
- HistoriaDocumento119 pagineHistoriaeduarlangasNessuna valutazione finora
- Saggio Su Felice ToccoDocumento18 pagineSaggio Su Felice ToccoAndrea Francesco CalabreseNessuna valutazione finora
- 53 - Esegesi Storico-Critica Della Bibbia, Di Rinaldo FabrisDocumento16 pagine53 - Esegesi Storico-Critica Della Bibbia, Di Rinaldo FabrisElisa BettaNessuna valutazione finora
- Propedeutica Traina RiassuntoDocumento16 paginePropedeutica Traina RiassuntoAnna CeccarelliNessuna valutazione finora
- De Re Rum Natura - StoriaDocumento3 pagineDe Re Rum Natura - StoriaὈδυσσεύς ΟὐδείςNessuna valutazione finora
- A. Vauchez Profeti e Profetismi. Escatol PDFDocumento1 paginaA. Vauchez Profeti e Profetismi. Escatol PDFrogeriopamponetNessuna valutazione finora
- I Consilia Dei Giuristi - Una Fonte Di Produzione Giuridica Del Tardo MedioevoDocumento30 pagineI Consilia Dei Giuristi - Una Fonte Di Produzione Giuridica Del Tardo MedioevodonpedrodetoledoNessuna valutazione finora
- San Lorenzo Da Brindisi - Studi - Clemente MariaDocumento278 pagineSan Lorenzo Da Brindisi - Studi - Clemente MariaRondinele Augusto100% (1)
- 008 PDFDocumento204 pagine008 PDFdumezil3729Nessuna valutazione finora
- Sacramentarium Gregorianum ConcordantiaDocumento20 pagineSacramentarium Gregorianum ConcordantiaTomDok50% (2)
- XP Johan Damascus de Fide OrthodoxaDocumento352 pagineXP Johan Damascus de Fide Orthodoxabrunomorabito100% (1)
- ALESSIO Filologia MedievaleDocumento143 pagineALESSIO Filologia MedievaleGIOVANNI NICCOLINessuna valutazione finora
- (Filologia e Critica 3) Giuliana Lanata - Medicina Magica e Religione Popolare in Grecia. Fino All'Età Di Ippocrate-Edizioni Dell'Ateneo (1967)Documento43 pagine(Filologia e Critica 3) Giuliana Lanata - Medicina Magica e Religione Popolare in Grecia. Fino All'Età Di Ippocrate-Edizioni Dell'Ateneo (1967)licenciaturafilosofiaunilaNessuna valutazione finora
- Lutero BibbiaDocumento19 pagineLutero BibbiaGioelaNessuna valutazione finora
- Letture e Interpretazioni Della BibbiaDocumento7 pagineLetture e Interpretazioni Della Bibbiapersefone78Nessuna valutazione finora
- Fioredifilosofie 00 LatiuoftDocumento132 pagineFioredifilosofie 00 LatiuoftIsabel CoimbraNessuna valutazione finora
- Presentazione GATEDocumento2 paginePresentazione GATEMartin M. MoralesNessuna valutazione finora
- Considerazioni Sul Teologico Politico Nella Prima Lettera Di Clemente Ai CorinziDocumento26 pagineConsiderazioni Sul Teologico Politico Nella Prima Lettera Di Clemente Ai CorinziStefano BellandaNessuna valutazione finora
- Il Testamento Di Niccolo V La RielaborazDocumento32 pagineIl Testamento Di Niccolo V La RielaborazFranco Guillermo LachariNessuna valutazione finora
- Passaggio Da Cultura Medievale A RinascimentaleDocumento4 paginePassaggio Da Cultura Medievale A RinascimentaleAndrea ZerbettoNessuna valutazione finora
- Nicolotti - Perfidia - Iudaica Le Tormentate VicendeDocumento40 pagineNicolotti - Perfidia - Iudaica Le Tormentate VicendeDomingo García Guillén100% (1)
- Il Borghini 2012 - 10Documento47 pagineIl Borghini 2012 - 10RenatusNessuna valutazione finora
- TroleseDocumento15 pagineTroleseapi-3741103100% (1)
- Alberto Pincherle - La Formazione Teologica Di Sant'AgostinoDocumento205 pagineAlberto Pincherle - La Formazione Teologica Di Sant'Agostinoleonardo7804Nessuna valutazione finora
- Alle Origini Del Rituale Massonico IngleDocumento8 pagineAlle Origini Del Rituale Massonico IngleAndrea DigiulioNessuna valutazione finora
- Antichità - La civiltà romana - Filosofia: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 13Da EverandAntichità - La civiltà romana - Filosofia: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 13Nessuna valutazione finora
- "Da tenersi sotto chiave": Tre casi di censura e mancata pubblicazione nella letteratura sindonica nel XVI e XVIII secoloDa Everand"Da tenersi sotto chiave": Tre casi di censura e mancata pubblicazione nella letteratura sindonica nel XVI e XVIII secoloNessuna valutazione finora
- Castello LecceDocumento32 pagineCastello Lecceleostefano15Nessuna valutazione finora
- Idomeneo 1999 IndiceDocumento3 pagineIdomeneo 1999 Indiceleostefano15Nessuna valutazione finora
- PrefazioneDocumento9 paginePrefazioneleostefano15Nessuna valutazione finora
- PrefazioneDocumento9 paginePrefazioneleostefano15Nessuna valutazione finora
- Ancora Sul Comune PuglieseDocumento3 pagineAncora Sul Comune Puglieseleostefano15Nessuna valutazione finora
- Club Di Roma - I Limiti Dello Sviluppo (1072)Documento81 pagineClub Di Roma - I Limiti Dello Sviluppo (1072)leostefano15100% (2)
- Biblioteche Ed Archivi Di PugliaDocumento18 pagineBiblioteche Ed Archivi Di Puglialeostefano15Nessuna valutazione finora
- Il Vanini Non È Un PlagiarioDocumento22 pagineIl Vanini Non È Un Plagiarioleostefano15Nessuna valutazione finora
- RS43 Toponomastica Pugliese Colella RispostaDocumento10 pagineRS43 Toponomastica Pugliese Colella Rispostaleostefano15Nessuna valutazione finora
- Histoire de La Destruction Du Paganisme PDFDocumento529 pagineHistoire de La Destruction Du Paganisme PDFleostefano15Nessuna valutazione finora
- Romanizzazione SalentoDocumento32 pagineRomanizzazione Salentoleostefano15Nessuna valutazione finora
- Neobizantini Di Puglia PDFDocumento41 pagineNeobizantini Di Puglia PDFleostefano15Nessuna valutazione finora
- Sarcofagi Paleocristiani in Puglia. Sguardo D'insieme e ProblematicheDocumento41 pagineSarcofagi Paleocristiani in Puglia. Sguardo D'insieme e Problematicheleostefano15Nessuna valutazione finora
- MURATURE 23 11 2010 Modalita Compatibilita PDFDocumento46 pagineMURATURE 23 11 2010 Modalita Compatibilita PDFMichele AngiolilliNessuna valutazione finora
- Scritti Storia Arte IndiceDocumento3 pagineScritti Storia Arte Indiceleostefano15Nessuna valutazione finora
- Gli Insediamenti Preclassici Lungo La Via Appia Antica in PugliaDocumento64 pagineGli Insediamenti Preclassici Lungo La Via Appia Antica in Puglialeostefano15Nessuna valutazione finora
- Storia Delle Persone Che Sono Vissute Molti SecoliDocumento187 pagineStoria Delle Persone Che Sono Vissute Molti Secolileostefano150% (1)
- Alleau PDFDocumento196 pagineAlleau PDFleostefano15Nessuna valutazione finora
- L'Arte Salentina Nell'Età Normanna e SvevaDocumento28 pagineL'Arte Salentina Nell'Età Normanna e Svevaleostefano15Nessuna valutazione finora
- La Moneta Nella Tomba PDFDocumento8 pagineLa Moneta Nella Tomba PDFleostefano15Nessuna valutazione finora
- Archivio Storico Per Le Province Napoletane Indice Per AutoriDocumento135 pagineArchivio Storico Per Le Province Napoletane Indice Per Autorileostefano15Nessuna valutazione finora
- Riflessi Del Grande Scisma D'occidente in Terra D'otrantoDocumento18 pagineRiflessi Del Grande Scisma D'occidente in Terra D'otrantoleostefano15Nessuna valutazione finora
- Castello Gallipoli PDFDocumento19 pagineCastello Gallipoli PDFleostefano15Nessuna valutazione finora
- Massoneriae Chiesa AQCDocumento39 pagineMassoneriae Chiesa AQCleostefano15Nessuna valutazione finora
- ECM 3 Calcolo Delle Ruote Dentate (Hertz)Documento3 pagineECM 3 Calcolo Delle Ruote Dentate (Hertz)alessandroNessuna valutazione finora
- 1 Laura Bassi Articolo-2 PDFDocumento10 pagine1 Laura Bassi Articolo-2 PDFAnna Chiara FrauliniNessuna valutazione finora
- 1 1 Pila ISO OSIDocumento29 pagine1 1 Pila ISO OSIMicheleNessuna valutazione finora
- EDILTEC X FOAMcertificatoidoneitCAMDocumento3 pagineEDILTEC X FOAMcertificatoidoneitCAMrocchino gualanoNessuna valutazione finora
- Informatica Excel VbaDocumento98 pagineInformatica Excel Vbabosnia76Nessuna valutazione finora
- I Pronomi Personali e RelativiDocumento16 pagineI Pronomi Personali e RelativiCarmela DesioNessuna valutazione finora
- Cap III Forme Di GovernoDocumento7 pagineCap III Forme Di GovernogdsxxxNessuna valutazione finora