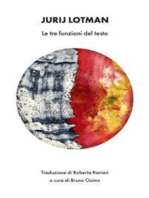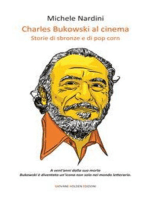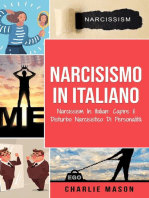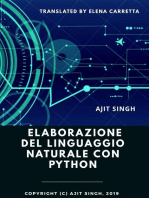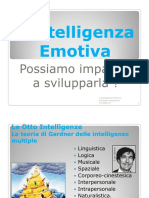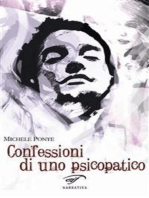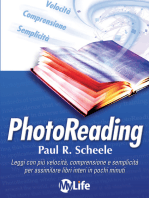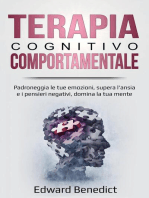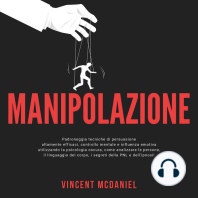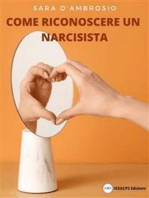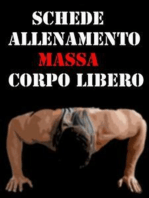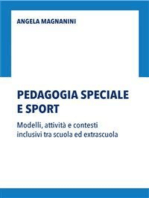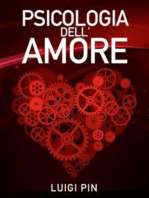Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Libro Lotman Cap 1-10
Caricato da
Dino Bahtic0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
534 visualizzazioni8 pagineRiassunto Libro Lotman Cap 1-10
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoRiassunto Libro Lotman Cap 1-10
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
534 visualizzazioni8 pagineRiassunto Libro Lotman Cap 1-10
Caricato da
Dino BahticRiassunto Libro Lotman Cap 1-10
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 8
Riassunto libro Lotman
Visone semiotica della cultura
Lotman vede la cultura come un sistema semiotico e quindi riprende una questione che riguarda
ogni sistema di questo tipo: il rapporto del sistema con l’extrasistema, cioè il mondo che si estende
al di là dei suoi confini.
Lotman pensa il sistema culturale semiotico come un insieme di lingue e definisce il sistema
extrasemiotico come extralinguistico, cioè come una realtà che le lingue della cultura devono
inglobare e trasformare in contenuto. In questa prospettiva risulta fondamentale l’attività di
traduzione: secondo Lotman la realtà extralinguistica va comunque pensata come una lingua, e
partendo di lì la definizione del significato è sempre, in fondo, la traduzione da una lingua all’altra.
Il sistema culturale non è quindi fatalmente chiuso in sé, ma “gioca” continuamente con lo spazio
che gli sta intorno o incorporandolo in sé attraverso la mediazione delle sue lingue, o proiettando
in esso i propri elementi e i propri schemi.
Capitolo 2 – Intersezione emittente - destinatario
In questo capitolo si parte dal fatto che la comunicazione presuppone un’emittente ed un
destinatario, che comunicano per mezzo di una lingua (scritta o parlata). Dopo aver introdotto tale
argomento l’autore va a mettere in evidenza come la totale uguaglianza tra emittente e destinatario
porterebbe sicuramente alla totale comprensione del discorso da parte di entrambi, tuttavia essa è
un male perché i due, se fossero uguali, non avrebbero nulla di cui parlare. Infatti in una normale
conversazione lo spazio linguistico del parlante e dell’ascoltatore è intersecato solamente in parte.
A B
In una situazione di non intersezione la comunicazione si presuppone impossibile, mentre una
completa intersezione la rende priva di contenuto. È proprio l’aspirazione di facilitare la
comprensione che costantemente porterà a tentativi di allargare il campo di intersezione. È però
presente anche la tendenza contraria, ovvero l’aspirazione di accrescere il valore del messaggio che
porta quindi al massimo ampliamento della differenza tra A e B.
Questo ci pone di fronte a una contraddizione insolubile: noi siamo interessati alla comunicazione
proprio a causa di quella situazione che rende difficile la comunicazione e, al limite, la rende
impossibile. L’incomprensione si presenta quindi come un meccanismo di senso prezioso quanto la
comprensione.
Capitolo 3 – Processi graduali vs processi esplosivi
I nostri organi di senso reagiscono a piccole dosi di stimoli che vengono percepiti come un
movimento continuo. In questo senso la continuità è una prevedibilità compresa. Il suo contrario è
l’imprevedibilità, il cambiamento realizzato nelle modalità dell’esplosione (improvvisamente).
L’imprevedibilità non è certo l’unica via verso il nuovo, intere sfere della cultura possono realizzare
il loro cambiamento soltanto sotto forma di cambiamenti graduali. Poiché i processi esplosivi e
graduali sono l’antitesi sono inseriti in un rapporto di reciprocità, non esiste uno senza l’altro. I
processi esplosivi si realizzano in un complesso dialogo con i meccanismi di stabilizzazione che sono
graduali.
Successivamente l’autore espone anche alcuni esempi per facilitare la comprensione del fenomeno.
Risulta interessante la correlazione tra scoperte scientifiche e realizzazioni tecniche. Le scoperte
scientifiche sono affini all’arte, nel senso che la loro origine è simile ad un’esplosione. La
realizzazione tecnica delle idee si sviluppa invece secondo le leggi della dinamica graduale. Il nuovo
nella scienza e nell’arte è attualizzazione dell’inatteso che necessita di tempo per essere compreso
appieno (e a volte non lo sarà mai…). Lo stesso vale per la storia, dove per esempio le scoperte
geografiche (esplosive) erano legate al progresso tecnico graduale.
I geni i creatori dell’arte non si sottomettono all’influenza direttrice della critica. Per esempio nella
letteratura l’incomprensione da parte del lettore di un’opera geniale non è l’eccezione ma la norma.
In quest’occasione Lotman cita anche la conclusione di Belinskij: il genio, che lavora per l’eternità e
i posteri può essere non soltanto incompreso dai contemporanei, ma può anche essere loro inutile.
Tuttavia la gente ha bisogno dell’arte e vorrebbe che l’autore dell’opera fosse un genio, ma accanto
a ciò egli auspicherebbe che le opere fossero comprensibili. Un simile genio accessibile
rallegrerebbe il lettore ed anche il critico, grazie alla sua prevedibilità (così che il critico possa
indicare infallibilmente i percorsi futuri dell’autore).
Capitolo 4 – Discontinuo e continuo
Finora si è visto come momenti di esplosione e momenti di sviluppo graduale si succedono, tuttavia
in varie sfere della cultura essi non si presentano come due fasi ben distinte ma si combinano
simultaneamente. Sia i processi esplosivi che quelli graduali, in una struttura funzionante
sincronicamente, adempiono ad importanti funzioni: gli uni assicurano l’innovazione, gli altri, la
continuità. Essi non sono in competizione, anzi l’attività di uno di loro stimola quella dell’altro.
Per esempio l’anti-romanticismo si sviluppa in concomitanza con il Romanticismo. Nemmeno un
testo è statico, anzi è un sistema dinamico finché ha dei lettori. Per lo strutturalismo tradizionale
non era così perché il testo era considerato statico e isolato nel tempo e nello spazio, ma soprattutto
isolato dal pubblico. Nella fase contemporanea invece il testo si inserisce nel tempo come un fermo
immagine suigeners, collocato tra passato e futuro. Lo spettatore collocandosi con il pensiero in
quel “tempo presente”, che è realizzato nel testo, è come se rivolgesse il suo sguardo al passato.
Rivolgendosi invece verso il futuro, l’ignoranza nei confronti di esso (il futuro) permette di attribuire
un significato a tutto. Per esempio non sapere se il fucile sparerà, se lo sparo provocherà una ferita
mortale o no, conferisce significatività all’intreccio. Tuttavia l’indeterminatezza del futuro possiede
dei confini, da esso è escluso ciò che in un dato sistema è impossibile. Queste possibilità di sviluppo
future sono contenute nel presente e la scelta del futuro si realizza come casualità; tale scelta è
quindi slegata dalle leggi della probabilità che nel momento dell’esplosione sono inattive.
Il momento dell’esplosione, nell’intreccio delle possibilità del movimento futuro, crea già una
catena di avvenimenti prevedibile e ne esclude degli altri. La morte di un soldato, provocata da una
scheggia di un proiettile casualmente intersecatasi con lui, spezza tutta una catena di avvenimenti
futuri potenzialmente possibili.
Il momento di esaurimento dell’esplosione è il momento di partenza dello sviluppo futuro, ma anche
luogo di autoconoscenza, in cui si innestano quei meccanismi che devono chiarire alla storia stessa
ciò che è successo. Inoltre c’è una radicale trasformazione dell’evento: ciò che è avvenuto
casualmente appare come l’unico svolgimento possibile. L’imprevedibilità viene sostituita con la
regolarità. Da questo punto di vista la scelta era stata oggettivamente predeterminata da tutto il
movimento di causa ed effetto degli avvenimenti precedenti, viene quindi eleminata la casualità.
Una sostituzione di questo genere si realizza facilmente in quelle sfere della storia dove domina la
gradualità. Essi sono sono quegli strati della storia dove l’azione si sviluppa in maniera rallentata e
la personalità singola gioca un ruolo minimale. Per esempio è normale che la storia della tecnica,
solitamente, venga percepita come anonima. I quadri vengono ricordati per il cognome dell’artista,
ma le automobili per il nome delle case produttrici e i nomi dei modelli. A riprova di ciò Lotman
porta una stori di un affermato ingegnere che si rammarica del fatto che il suo nome non sia noto
al pubblico, nonostante dice di aver fatto molto più di certuni che sono celebri; il povero ingegnere
afferma quindi: “…quanto a notorietà, ne godo come quel cane nero laggiù…”. Se il ponte fosse
crollato, sicuramente avrebbero ricordato il cognome dell’ingegnere, perché sarebbe stato un
evento non comune. Un buon ponte si dissolve nel flusso generale del livello della tecnica e le
qualità, se non sono straordinariamente evidenti, non vengono notate da nessuno. Lo sviluppo della
tecnica, generalmente, è prevedibile e ciò è dimostrato per esempio dalle opere meglio riuscite nel
campo della fantascienza.
A causa dei processi successivi all’esplosione che eliminano la sua casualità gli storici eliminano
quindi le fasi successive all’esplosione che abbiamo visto essere fortemente informative. Lo storico
guarda l’evento con lo sguardo diretto dal presente al passato. Questo sguardo, per sua stessa
natura, trasforma l’oggetto della descrizione. Egli costruisce una linea di successione che porti con
la massima attendibilità al punto conclusivo, trovando dei rapporti di causa ed effetto convincenti.
Nella storia viene quindi introdotto il concetto di scopo che è ad essa totalmente estraneo. Tuttavia
questa cosa è propria dell’uomo; allo storico è sufficiente indicare e rendere oggetto di studio gli
eventi indicandoli con il grado di oggettività che gli è accessibile (in altre parole: la casualità non
appartiene all’uomo).
Capitolo 5 – L’intersezione semantica come esplosione di senso. L’ispirazione.
Questo capitolo andrà ad approfondire lo studio delle relazioni fra espressioni linguistiche e il
mondo cui si riferiscono, in special modo legate all’esplosione che producono quando si rivela un
loro senso.
I cerchi da noi disegnati sulla carta rappresentano una particolare metafora visiva, e non un esatto
modello di questo oggetto. Qualunque spazio di senso può essere rappresentato soltanto
metaforicamente come uno spazio bidimensionale dai confini netti e univoci.
Con la diffusione su tutto lo spazio di una data lingua, tali intersezioni formano le cosiddette
metafore linguistiche. Queste ultime sono fatti della lingua comune della collettività. Il grado
estremo è rappresentato, nel dato caso, dalla metafora, innovativa per principio, che è valutata dai
portatori del senso tradizionale come arbitraria e offensiva del loro senso della ragione; la metafora
scioccante è sempre il risultato di un atto creativo (cioè legato all’arte), cosa che non le impedisce
in seguito di trasformarsi in una metafora di uso corrente.
Emerge chiaramente che il congiungimento dell’incongiungibile sotto l’influsso di una certa tensione
creativa si definisce ispirazione: questa è la disposizione dell’anima alla viva appropriazione delle
impressioni, di conseguenza alla rapida comprensione dei concetti, il che rende possibile la loro
spiegazione. Rimane comunque un problema: esprimere con la parola ciò che è extra verbale, e con
la logica ciò che è per la logica è al di là dei limiti. Infatti a volte, si verifica una cera incompatibilità
di principio di sensi perché essi non formano un unico quadro logico. Nel momento in cui avviene
l’esplosione imprevedibile, che si trasforma l’incompatibile in adeguato, l’intraducibile in
traducibile: è qui che avviene la contraddizione, la descrizione di un’esplosione di senso, si verifica
quando c’è il passaggio attraverso il confine dell’imprevedibilità.
Detto questo, lo spazio semiotico ci appare come un’intersezione su più livelli, con correlazioni
complesse interne, diverso grado di traducibilità e spazi di intraducibilità. Sotto questo strato è
situato lo strato della “realtà”. Entrambi questi strati formano insieme la semiotica della cultura.
Oltre i limiti della semiotica della cultura (la quale si occupa di studiare l’attività simbolica umana,
come creazione di segni e come modo per descrivere in che modo le cose acquisiscono un senso) si
estende la realtà, che si trova al di fuori dei confini della lingua. E cosi la realtà esterna sarebbe,
conformemente alle rappresentazioni di Kant, trascendentale (cioè stanno al di là dell’esperienza
stessa ma allo stesso tempo sono dentro l’esperienza, la rappresentazione cioè diventa attuale solo
quando si “incarnano” con i dati sensibili). Così il mondo della semiosi non è fatalmente chiuso in
sé: esso forma una struttura complessa che continuamente “gioca” con lo spazio che gli è esterno.
Da ciò si possono trarre delle conclusioni: in primo luogo l’astrazione di un linguaggio di
comunicazione come base della semiosi è una cattiva astrazione, dato che esso altera in maniera
impercettibile l’intera essenza del meccanismo.
Capitolo 6 – Spazio culturale e spazio extraculturale
La peculiarità dell’uomo come essere culturale necessita di una sua contrapposizione al mondo della
natura, intesa come spazio extraculturale. Per determinati aspetti del suo essere l’uomo apparatine
alla cultura, altri, invece, lo legano al mondo extraculturale. Così il confine è eroso ed è difficile
definire ciascun fatto come culturale o extraculturale, tuttavia se astraiamo dal caso singolo e
usiamo categorie di classificazione astratta la differenza è percettibile in misura sufficiente.
Secondo Tjutcev la natura è dotata di armonia. A essa si contrappone la disarmonia dell’animo
umano. L’armonia viene da lui pensata come immutabile o che eternamente si ripete. Mentre
l’uomo è inserito in un movimento disarmonico. Tale differenza ci porta a riflettere su una questione
fondamentale: il conflitto tra movimento chiuso (cioè regolare, che si ripete) e movimento orientato
linearmente.
Nel mondo animale ci troviamo di fronte ad un movimento circolare chiuso. In questo senso è
indicativa la differenza tra il processo di apprendimento negli animali e negli uomini. Per gli animali
i comportamenti sono di tipo ritualizzato: la caccia, la lotta tra i maschi… L’attribuzione del
capobranco ed altri momenti significativi prendono forma come un sistema complesso di pose e
gesti “corretti” che hanno un significato ben preciso per entrambi gli animali coinvolti. Il dialogo per
l’attribuzione della dominanza si conclude spesso con un’ammissione di resa. Per esempio, il corvo,
in segno di resa, porge all’altro corvo l’occhio e la lotta termina. Il vincitore di regola non approfitta
della possibilità di togliere l’occhio allo sconfitto. Per gli uomini invece non funziona così, difatti
questo fatto a dato vita ad un famoso proverbio russo: “Un corvo non caverà un occhio a un altro
corvo”.
La ripetitività ciclica è una legge dell’esistenza biologica, cui sono sottomessi il mondo animale e
l’uomo come parte di esso. Ma l’uomo non è totalmente immerso in questo mondo, ciò si manifesta
nelle differenze dell’apprendimento. L’animale apprende un sistema di comportamento rituale e la
supremazia si raggiunge con la forza e la rapidità di esecuzione di gesti ben precisi, ma mai con
l’invenzione di un gesto nuovo e inaspettato per l’avversario. Ecco, il comportamento dell’animale
è rituale, l’uomo, invece, tende all’invenzione di comportamenti nuovi, imprevedibili per
l’avversario. Dal punto di vista dell’uomo, l’animale è considerato stupido, dal punto di vista
dell’animale l’uomo è ritenuto disonesto (perché non osserva le regole). Questo perché l’uomo
costruisce la propria immagine dell’animale come quella di un uomo stupido mentre l’animale, a
sua volta, costruisce l’immagine dell’uomo come quella di un animale disonesto.
Così in situazioni “normali” gli animali evitano l’uomo, mentre egli, sin dall’inizio, come cacciatore,
ha cercato il contatto con loro. Attribuendo al comportamento degli animali la psicologia umana si
può dire che esso sia di ripugnanza e questo sentimento è originato dalla tendenza istintiva ad
evitare situazioni imprevedibili, questo è un po’ lo stesso che prova l’uomo di fronte ad un folle.
Capitolo 7 – Il mondo dei nomi propri
Non è possibile immaginare che una femmina di un branco di cervi, non condividendo il sentimento
comune, rimanga con lo sconfitto. Questo perché il linguaggio degli animali non conosce nomi
propri. Questi ultimi appaiono solo negli animali domestici, ma sono pur sempre frutto
dell’intelligenza dell’uomo.
È probabile che la più acuta manifestazione della natura umana sia l’uso dei nomi propri e
l’evidenziazione, legata a tale uso, dell’individualità, dell’originalità della personalità singola come
fondamento del suo valore per “l’altro”. L’io e l’altro sono i due lati di un unico atto di autocoscienza
e sono impossibili l’uno senza l’altro (“non vi è l’io senza gli altri”). Così come solamente la possibilità
della menzogna trasforma la verità in un comportamento cosciente e liberalmente scelto. Il piccolo
dell’uomo fa del danno coscientemente, viola dei divieti. Questo accade perché egli ha la possibilità
di compiere o di non compiere determinate azioni e spontaneamente esplora i confini delle proprie
possibilità. La possibilità di fare male è il primo passo verso la capacità di non farlo consciamente.
Un comportamento cosciente non è possibile senza scelta, cioè senza l’elemento dell’individualità.
La distinzione tra le parole “proprie” e quelle “altrui” divide il mondo del bambino in proprio e altrui,
ponendo le fondamenta di quel confine della coscienza che si conserva come la dominante più
importante della cultura. La tendenza del bambino ad ampliare la sfera dei nomi propri è stata
ampiamente provata. Tuttavia è attiva anche la tendenza opposta: correndo in un parco da un
albero all’altro, un bambino di tre anni eccitato ed entusiasta colpisce betulle, abeti, pioppi ed
esclama: “Albero!” Poi con lo stesso grido colpisce un palo dell’elettricità e scoppia a ridere. Di
fronte a noi non vi è soltanto la facoltà di generalizzare ma anche la possibilità di giocare con questa
facoltà, possibilità che è legata a processi propri solamente alla coscienza umana: la parola è
separata dalla cosa. Così l’uomo ha anche la facoltà di comparire nel ruolo dell’altro e quindi di non
essere quello che è. Un uomo può essere sé stesso singolarmente o fare parte di un gruppo.
La natura stessa del senso è definita dal contesto, per esempio la frase: “Di dove sei saltato fuori,
intelligentone?” è letta in chiave di allegoria se si sa che è rivolta ad un asino. Ecco che l’ironia
sottintende la conoscenza del destinatario, la beffa è sempre rivolta ad un’unità concreta, un nome
proprio. Tale problema è ancora più evidente con l’arte e i testi artistici che complicano i rapporti
tra prima e terza persona.
L’esistenza dei testi artistici ci è suggerita dall’esperienza psicologica del sogno. Con il sogno le
categorie del discorso vengono trasferite nello spazio visivo. Senza questa esperienza sarebbero
state impossibili sfere come l’arte e la religione. Il testo viene tradotto e memorizzato in forma
visiva, tale facoltà è proprietà esclusiva dell’uomo e permette di supporre che il confine dell’arte
non sia poi così lontano dalla sua coscienza.
Capitolo 8 – Lo scemo e il folle
Lotman analizza il binomio scemo folle con due antinomie: scemo vs intelligente e intelligente vs
folle. Insieme esse formano una struttura ternaria: scemo-intelligente-folle, dove scemo e folle non
sono sinonimi ma i poli estremi.
Lo scemo è privo di una pronta reazione all’ambiente che lo circonda ed ha un comportamento
prevedibile. Esso viola di continuo le giuste correlazioni tra situazione e azione. In tal senso le sue
azioni sono stereotipate, ma egli le adotta a sproposito; egli per esempio: piange ai matrimoni e
balla ai funerali. Egli non può escogitare nulla di nuovo.
Allo scemo è contrapposto l’intelligente, il cui comportamento è definito normale. Egli pesa ciò che,
secondo gli usi, bisogna pesare. Così anche il suo comportamento è prevedibile perché corrisponde
alle regole e alle usanze.
Il terzo elemento del sistema è il comportamento insensato del folle. Le sue azioni sono
imprevedibili e questa attività si rileva molto efficace in situazioni fortemente conflittuali.
Propria dell’uomo è la facoltà dell’iniziativa individuale, dell’azione completamente nuova ed
imprevedibile. Ulisse si salava e sconfigge il ciclope con un arguto gioco di parole e la furbizia. Ecco
che è intelligente chi compie delle azioni inaspettate per i suoi nemici. Nel conflitto con lo stupido
gigante capace di agire solamente in maniera stereotipata, il piccolo furbacchione ricorre all’arma
dell’inatteso, cerando circostanze in cui il comportamento stereotipato risulta insensato e
inefficace. Questa situazione si ripete nello scontro del normale con il pazzo. Lo scemo ha meno
libertà del normale, il folle ne ha di più.
L’uso della follia come efficace comportamento bellico è noto presso molti popoli e si fonda su una
comune base psicologica: la creazione di circostanze nelle quali il nemico perda l’orientamento.
Dividendo il mondo che ci circonda in normale e folle, Lev Tolstoj vedeva l’esempio più lampante di
quest’ultimo nel teatro. Nello spazio teatrale è come se gli attori non vedessero gli spettatori nella
sala ed imitano artificiosamente la somiglianza con la vita abituale; tutto ciò per Tolstoj era una
visibile incarnazione della pazzia.
Nerone visse passando dal ruolo dell’imperatore al ruolo dell’attore e viceversa e ciò diviene per lui
la norma. Questo doppio ruolo si rivela nel fatto che nei concorsi teatrali si autoproclamava
vincitore. E la sua costante mistione tra del teatro con la realtà fu alla base del celebre episodio
dell’incendio di Roma. In quell’occasione egli assistette all’incendio dalla torre di Mecenate e, lieto
della bellezza delle fiamme, cantò in abito scenico la presa di Troia. L’atto stravagante è quindi
passato dal domino dell’esplosione alla sfera dell’abitudine.
[…] Discute della differenza tra onore e gloria…non ci ho capito una sega.
L’uomo delle epoche arcaiche è propenso a schiacciare dal mondo la casualità. Quest’ultima gli si
presenta come il risultato di un qualche ordine, a lui sconosciuto. Da qui deriva la diffusa pratica
della divinazione, nel corso della quale ciò che è casuale può essere predetto. In questo senso è
interessante un episodio dell’Iliade nel quale Ulisse e Aiace gareggiano. Aiace casualmente scivola
su del fimo (letame) bovino e cade su di esso col volto. Questo dà a Ulisse la possibilità di superare
il rivale e ottenere il primo premio. L’episodio può essere una classica illustrazione
dell’intromissione della casualità imprevedibile nel corso degli eventi. Tuttavia il poeta dà anche una
spiegazione parallela, dove è la dea Atena ad aver aiutato Ulisse a vincere, facendo cadere Aiace.
Nel mondo irrompono eventi, le cui conseguenze sono imprevedibili. Questi eventi danno impulso
a un’ampia serie di processi successivi. Il momento dell’esplosione è come se fosse disinserito dal
tempo e da esso parte una nuova tappa del movimento graduale. Tuttavia l’esplosione genera tutta
una catena di altri eventi. Prima di tutto, suo risultato è la comparsa di un complesso di conseguenze
ugualmente verosimili. Soltanto una di esse è destinata a realizzarsi. La scelta di quell’una può
essere definita come casuale o come risultato dell’intromissione di altre leggi esterne al sistema. In
tal modo la realizzazione di questa potenzialità può essere caratterizzata come non realizzazione di
tutto un complesso di altre. Il cammino sia dell’uomo singolo che dell’umanità è cosparso di
possibilità irrealizzate, di strade perdute.
I processi graduali sono relativamente prevedibili. Carattere diverso hanno i processi che sorgono
come risultato di esplosioni. Qui ciascuno degli eventi realizzatisi è circondato da una nube di eventi
non realizzati. Le vie che essi avrebbero potuto iniziare risultano perdute per sempre. Il movimento
si realizza quindi non solo come nuovo evento ma anche come nuova direzione. Si prestano bene
per capire questo tipo di dinamica gli eventi storici, nei quali un avvenimento casuale apre il varco
all’inizio di una nuova e imprevedibile regolarità. Un’opera d’arte geniale non sarebbe stata
compensata da nulla, se il suo autore fosse morto durante l’infanzia per una casuale catastrofe. Ogni
grande evento non soltanto apre nuove strade, ma recide interi faci di potenzialità del futuro. Ciò
deve essere un tema di grande importanza e di riflessione per lo storico. Movimenti storici diversi,
ma tipologicamente simili come, per esempio, il movimento romantico nei vari paesi europei, o le
diverse forme di rivoluzioni antifeudali possono nel momento dell’esplosione scegliere varie strade.
Confrontarli tra loro è come dimostrare cosa sarebbe successo, in questo o quel paese, se i risultati
dell’esplosione in esso fossero stati diversi. Nello studio comparato delle culture introduce un
aspetto completamente nuovo: quello che è perduto in uno spazio storico-nazionale può essere
realizzato in un altro. Una visione del genere permette di studiare non solo ciò che è accaduto ma
anche ciò che sarebbe potuto accadere.
I periodi delle scoperte scientifiche e quelli delle invenzioni tecniche si possono analizzare come due
fasi dell’attività intellettuale. Le scoperte hanno il carattere di esplosioni intellettuali, esse non
possono essere decifrate dal passato e non è possibile prevedere le loro conseguenze. Ma nello
stesso momento in cui ha esaurito la sua energia interna, essa viene sostituita dalla catena di cause
ed effetti: giunge, così, il tempo della tecnica. Lo sviluppo logico sceglie dall’esplosione quelle idee
per le quali è già arrivato il momento, coglie ciò che può essere utilizzato. Il rimanente per un certo
tempo viene abbandonato all’oblio (varie possibili scoperte a cui ha aperto la via la relatività di
Einstein). In tal modo si può scorgere l’alternarsi di periodi di prevedibilità e imprevedibilità. Tuttavia
tale modello possiede un alto grado di convenzionalità, perché una catena coerente di esplosioni e
sviluppi graduali non esiste mai isolatamente nella realtà. Essa è circondata da processi a lei sincroni
che possono influenzare il regolare alternarsi di questi due momenti. Tuttavia questa alternanza
compare in modo abbastanza chiaro nei processi storici e sociali. Nella storia passiamo dal culto
dalla figura dell’eroe fino a quella del milite ignoto, c’è quindi un’esplosione che fa quindi
scomparire l’individualità.
Capitolo 9 – Il testo nel testo
La storia della cultura di qualunque popolo può essere analizzata da due punti di vista: da una parte
come sviluppo immanente, dall’altra come risultato di influenze esterne. Entrambi questi processi
sono strettamente intrecciati, perché qualunque analisi isolata inevitabilmente conduce alla
formazione di un quadro alternato. Tuttavia la complessità non sta in ciò ma sta nel fatto che
qualunque intersezione di sistemi aumenta bruscamente l’imprevedibilità del movimento
successivo. Con la collisione a volte prevale un sistema sull’altro, altre invece si genera un terzo
sistema. Così, per esempio, a partire dal regno di Elizaveta Petrovna la cultura nobiliare russa subisce
un processo di “francesizzazione”. L’intrusione della lingua francese in quella russa e la loro fusione
in una specie di lingua unica crea una “lingua delle dame” e così si iniziano a scrivere lettere mezzo-
francesi e mezzo-russe. Ma la lingua francese svolgeva, nella società russa colta dell’epoca
puskiniana, il ruolo di lingua del pensiero scientifico e filosofico. Alcuni si dissero sostenitori di tale
nuova lingua e altri furono oppositori. I sostenitori rilevavano la caratteristica positiva di inserire un
“frammento” di testo in una nuova lingua, che gioca il ruolo di generatore di nuovi sensi. Siamo
davanti al cosiddetto “testo nel testo” che è una costruzione retorica specifica, tramite la quale la
differente codificazione delle varie parti del testo diviene un fattore evidenziato della costruzione
del testo da parte dell’autore e della sua percezione da parte del lettore. Praticamente un
frammento di testo, strappato dai suoi legami di senso, viene introdotto in maniera meccanica in
un altro spazio di senso.
Il gioco basato sulla contrapposizione “reale vs convenzionale” è proprio di qualunque situazione in
cui si ha un “testo nel testo”. Il caso più semplice è rappresentato dall’inserimento nel testo di una
parte codificata attraverso lo stesso codice impiegato per tutto il rimanente spazio dell’opera, ma
che risulta raddoppiato. È il caso del quadro nel quadro, del teatro nel teatro, del film nel film, del
romanzo nel romanzo. Tutto questo fa si che lo spazio di base del testo venga percepito come
“reale”. È il caso dell’Amleto di Shakespeare che di fronte al pubblico dà agli attori indicazioni su
come devono recitare.
La cultura nel suo insieme si può considerare come un testo che si scinde in una gerarchia di “testi
nei testi” e che forma un complesso intreccio di testi. In essa c’è l’intrusione di multiformi elementi
casuali provenienti da altri testi. Essi entrano in un gioco imprevedibile con le strutture di base e
aumentano bruscamente le possibilità di successivi imprevedibili sviluppi. Se il sistema si
sviluppasse senza imprevedibili intrusioni esterne, allora si svilupperebbe secondo leggi cicliche.
Lotman conclude il capitolo con la frase: “l’imprevedibilità dell’arte è allo stesso tempo conseguenza
e causa dell’imprevedibilità della vita”.
Capitolo 10 – L’immagine capovolta
Nello sazio che si estende al di là della norma ci troviamo di fronte a tutta una gamma di possibilità:
dalla mostruosità alla sovra-norma della pienezza delle qualità positive. Uno dei procedimenti più
elementari per uscire oltre i limiti della prevedibilità è quel tropo, nel quale due oggetti contrapposti
si scambiano i contrassegni dominanti. Questo procedimento è ampiamente adottato dalla vasta
letteratura barocca del “mondo capovolto” dove, in molteplici testi, la pecora divorava l’agnello, il
cavallo cavalcava l’uomo e il cieco conduceva il viandante. Questi intrecci capovolti erano usati, di
regola, nei testi satirici; tuttavia l’inversione degli elementi indigna in maniera particolare un
pubblico stereotipato.
Il mondo capovolto si costruisce sulla dinamica del non dinamico. Una realizzazione di questo
processo è rappresentata dalla moda, che introduce il principio di dinamico in sfere del quotidiano
in apparenza immobili. Nelle società nelle quali le fogge del vestiario sono rigidamente sottoposte
alla tradizione o sono dettate dall’avvicendarsi delle stagioni, e in ogni caso non dipendono
dall’arbitrio della volontà umana, vi possono essere vestiti cari o a buon mercato, ma non esiste la
moda. Per di più, in tali società, più grande è il valore di un abito più lo si conserva, e viceversa, più
lungo è il tempo per cui è stato conservato e più è considerato grande il suo valore. Di questo tipo
è, per esempio, l’atteggiamento verso gli abiti rituali dei capi di stato e delle gerarchie ecclesiastiche.
Nello spazio culturale dell’abbigliamento si svolge una costante lotta fra la tendenza alla stabilità,
all’immobilità e l’orientamento opposto verso la novità, la stravaganza: tutto ciò che entra nella
rappresentazione della moda. In tal modo la moda diviene quasi la visibile incarnazione della novità
immotivata. Ciò permette di interpretarla sia come dominio di capricci mostruosi, sia come sfera di
creatività innovativa. Il parlante del linguaggio della moda è un creatore di informazione nuova,
inaspettata per il pubblico e a esso incomprensibile. Il pubblico non deve capire la moda e ne deve
essere indignato; in ciò consiste il trionfo della moda. Se il pubblico non è scioccato, la moda perde
il suo senso; essa ha paura di passare inosservata e di conseguenza “si nutre” non di sicurezza di sé,
ma del dubbio sul suo stesso valore.
[…] Parla di varie cose legate alla donna ma per me non sono rilevanti…
Potrebbero piacerti anche
- L Occhio Del NovecentoDocumento22 pagineL Occhio Del NovecentoLuigi Conquasso PezzuloNessuna valutazione finora
- Traduzione: aspetti mentali.: Saggi di Peirce, Levý, Mahony, Schreier Rupprecht, Ullmann, FavareauDa EverandTraduzione: aspetti mentali.: Saggi di Peirce, Levý, Mahony, Schreier Rupprecht, Ullmann, FavareauNessuna valutazione finora
- Come Vedere Il MondoDocumento7 pagineCome Vedere Il MondoEll IE100% (1)
- «Ci vorrà naturalmente una guida»: Memoria e dialoghi nell’opera di Dino BuzzatiDa Everand«Ci vorrà naturalmente una guida»: Memoria e dialoghi nell’opera di Dino BuzzatiNessuna valutazione finora
- I GiovaniDocumento32 pagineI GiovaniStefano SciacovelliNessuna valutazione finora
- Charles Bukowski al cinema: Storie di sbronze e di pop cornDa EverandCharles Bukowski al cinema: Storie di sbronze e di pop cornNessuna valutazione finora
- Loana Di EcoDocumento17 pagineLoana Di Ecomarcotrainito100% (1)
- Dialogo Con PontiggiaDocumento13 pagineDialogo Con PontiggiaLivia T.Nessuna valutazione finora
- Inter Media: La mediazione interlinguistica negli audiovisiviDa EverandInter Media: La mediazione interlinguistica negli audiovisiviNessuna valutazione finora
- Aura e ChocDocumento19 pagineAura e ChocFrancesca FestaNessuna valutazione finora
- Analisi Del TestoDocumento3 pagineAnalisi Del TestoelionanaqoNessuna valutazione finora
- L'informazione geografica: linguaggi e rappresentazioni nell’epoca del knowledge graphDa EverandL'informazione geografica: linguaggi e rappresentazioni nell’epoca del knowledge graphNessuna valutazione finora
- Tesina ParadossoDocumento17 pagineTesina Paradossoriccardobrogi50% (2)
- Narcisismo In italiano/ Narcissism In Italian: Capire il Disturbo Narcisistico Di PersonalitàDa EverandNarcisismo In italiano/ Narcissism In Italian: Capire il Disturbo Narcisistico Di PersonalitàNessuna valutazione finora
- Quando La Fotografia Diventa Arte?Documento13 pagineQuando La Fotografia Diventa Arte?Cristiano Toffoletti100% (1)
- 1) La Mutazione IndividualistaDocumento60 pagine1) La Mutazione IndividualistaAle AleNessuna valutazione finora
- Davide ZolettoDocumento6 pagineDavide ZolettoCaterina Mortillaro100% (1)
- LockeDocumento5 pagineLockeAlessioContuNessuna valutazione finora
- Odifreddi Il Labirinto Dello Spirito PDFDocumento20 pagineOdifreddi Il Labirinto Dello Spirito PDFanopticonNessuna valutazione finora
- Stefano Gensini Il Cosmo Che Non Tiene. La Fantasia RodarianaDocumento14 pagineStefano Gensini Il Cosmo Che Non Tiene. La Fantasia RodarianaStef Gens100% (1)
- Bollettino FilosoficoDocumento556 pagineBollettino FilosoficoluxfidesNessuna valutazione finora
- I Poteri Degli Schermi 1Documento33 pagineI Poteri Degli Schermi 1Francesca FestaNessuna valutazione finora
- Roland BarthesDocumento38 pagineRoland BarthesMarta MuschiettiNessuna valutazione finora
- Frammenti Di DemocritoDocumento4 pagineFrammenti Di DemocritoSoph VirgolaNessuna valutazione finora
- Svevo e L - InettoDocumento20 pagineSvevo e L - InettosaroNessuna valutazione finora
- Tipologia BDocumento2 pagineTipologia Bgabriel magoNessuna valutazione finora
- Elementi Di Semiotica PDFDocumento38 pagineElementi Di Semiotica PDFludovica paolessiNessuna valutazione finora
- La Torre Di BabeleDocumento6 pagineLa Torre Di BabeleManuela PutzuNessuna valutazione finora
- Come Scrivere Un Buon RaccontoDocumento6 pagineCome Scrivere Un Buon RaccontoPaolo Comolli100% (1)
- Astrazione e EmpatiaDocumento34 pagineAstrazione e Empatiaioginevra100% (1)
- Altri LibertiniDocumento2 pagineAltri LibertiniFaruk BecirovicNessuna valutazione finora
- AnalisiDocumento19 pagineAnalisiSara Iovine100% (1)
- Da Spazio Nasce Spazio Parte PrimaDocumento46 pagineDa Spazio Nasce Spazio Parte PrimaAvanziNessuna valutazione finora
- Eco Diario Minimo PDFDocumento3 pagineEco Diario Minimo PDFelviagarcia25Nessuna valutazione finora
- Pictorial TurnDocumento26 paginePictorial TurnMartina CasaleNessuna valutazione finora
- Breve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.Documento47 pagineBreve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.Denis ScottNessuna valutazione finora
- Remediation J.D. Bolter Grusin - OdtDocumento15 pagineRemediation J.D. Bolter Grusin - OdtLarisaNessuna valutazione finora
- Peirce e TempoDocumento57 paginePeirce e TempoFabio PetroneNessuna valutazione finora
- D'Annunzio Dall'Estetismo Al SuperuomoDocumento3 pagineD'Annunzio Dall'Estetismo Al SuperuomoPietro Lorenzo PavanNessuna valutazione finora
- W2 Borges La Casa Di Asterione PDFDocumento6 pagineW2 Borges La Casa Di Asterione PDFMartín RivaNessuna valutazione finora
- EtnoantropologiaDocumento10 pagineEtnoantropologiaSimona M.Nessuna valutazione finora
- Trucheck - It - Positivismo, Realismo, Naturalismo, VerismoDocumento5 pagineTrucheck - It - Positivismo, Realismo, Naturalismo, VerismoValentino Masi100% (1)
- Migrant IDocumento24 pagineMigrant Imacaraca77Nessuna valutazione finora
- Storia e Teoria Dei Nuovi MediaDocumento15 pagineStoria e Teoria Dei Nuovi Mediafederica landi100% (1)
- Käte Hamburger, La Finzione NarrativaDocumento29 pagineKäte Hamburger, La Finzione NarrativaAlvaroNessuna valutazione finora
- Seneca Tempo de BrevitateDocumento5 pagineSeneca Tempo de BrevitatesilgardiusNessuna valutazione finora
- Il Corpo e L'archivio - SekulaDocumento60 pagineIl Corpo e L'archivio - Sekulaimpression4Nessuna valutazione finora
- L'Interpretazione Dei Sogni - FreudDocumento3 pagineL'Interpretazione Dei Sogni - FreudAnonymous D5SCpuFNessuna valutazione finora
- Simbolismo, Estetismo e DecadentismoDocumento8 pagineSimbolismo, Estetismo e DecadentismoGiulio Lo BelloNessuna valutazione finora
- JaussDocumento7 pagineJaussFrancesca RavazziNessuna valutazione finora
- Lewis C. S. Lettere Di Berlicche #XXXVIIDocumento4 pagineLewis C. S. Lettere Di Berlicche #XXXVIIMafezzoli100% (2)
- La Coscienza Di Zeno - Il Capitolo Terzo, - Il FumoDocumento1 paginaLa Coscienza Di Zeno - Il Capitolo Terzo, - Il FumoDaniele PisciottaniNessuna valutazione finora
- Wittgenstein e L'umorismoDocumento8 pagineWittgenstein e L'umorismoPaolo MusanoNessuna valutazione finora
- Genius Loci - A WikibookDocumento25 pagineGenius Loci - A WikibookProf CannistraciNessuna valutazione finora
- Phi Un Viaggio Dal Chervello All'anima (Exerpt)Documento6 paginePhi Un Viaggio Dal Chervello All'anima (Exerpt)anisdangasNessuna valutazione finora
- Metodo Golfera - Lettura Veloce PDFDocumento118 pagineMetodo Golfera - Lettura Veloce PDFPino De PinisNessuna valutazione finora
- Grammatica SpagnolaDocumento59 pagineGrammatica SpagnolaLivio Demasi100% (3)
- Philip Goldberg Programma Di MT PDFDocumento114 paginePhilip Goldberg Programma Di MT PDFDino BahticNessuna valutazione finora
- Intelligenza EmotivaDocumento96 pagineIntelligenza EmotivaDino BahticNessuna valutazione finora
- IL TEMPO Dell' IPNOSIDocumento130 pagineIL TEMPO Dell' IPNOSIAntonio Caiazza100% (2)
- Intelligenza EmotivaDocumento96 pagineIntelligenza EmotivaDino BahticNessuna valutazione finora
- Noi Verbo FareDocumento50 pagineNoi Verbo FareAkira LiNessuna valutazione finora
- Cap2 - Modelli Di OttimizzazioneDocumento12 pagineCap2 - Modelli Di OttimizzazioneAlessio PaniniNessuna valutazione finora
- Manuale Utente - KalliopeCTI 4.5.18Documento48 pagineManuale Utente - KalliopeCTI 4.5.18MarcoNessuna valutazione finora
- Filosofia-Socrate e PlatoneDocumento14 pagineFilosofia-Socrate e PlatonePillimoGarauNessuna valutazione finora
- Dante OpereDocumento21 pagineDante OpereDino FrancoNessuna valutazione finora
- Pregh Corona Davvento e NovenaDocumento2 paginePregh Corona Davvento e Novenaapi-421393782Nessuna valutazione finora
- Risposte Cisco Cap 1-3Documento6 pagineRisposte Cisco Cap 1-3maNessuna valutazione finora
- Storia Della MusicaDocumento128 pagineStoria Della MusicaAlfonso BelfioreNessuna valutazione finora
- Metodologie DidatticheDocumento8 pagineMetodologie DidatticheMike HarperNessuna valutazione finora
- ArticoliDocumento1 paginaArticolitoritori88Nessuna valutazione finora
- La Ricerca Del Pensiero QSF 2Documento97 pagineLa Ricerca Del Pensiero QSF 2Michele Ruzzi100% (2)
- Photoreading: L’arte di utilizzare il cervello e la vista per apprendere velocemente e con facilitàDa EverandPhotoreading: L’arte di utilizzare il cervello e la vista per apprendere velocemente e con facilitàNessuna valutazione finora
- Anatomia della Coscienza Quantica: La fisica dell'auto-guarigioneDa EverandAnatomia della Coscienza Quantica: La fisica dell'auto-guarigioneValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3)
- Le Tattiche del Cambiamento - Manuale di Psicoterapia StrategicaDa EverandLe Tattiche del Cambiamento - Manuale di Psicoterapia StrategicaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Depressione, ansia e panico: la terapia psicologicaDa EverandDepressione, ansia e panico: la terapia psicologicaNessuna valutazione finora
- Manipolazione: Padroneggia tecniche di persuasione altamente efficaci, controllo mentale e influenza emotiva utilizzando la psicologia oscura, come analizzare le persone, il linguaggio del corpo, i segreti della PNL e dell'ipnosi!Da EverandManipolazione: Padroneggia tecniche di persuasione altamente efficaci, controllo mentale e influenza emotiva utilizzando la psicologia oscura, come analizzare le persone, il linguaggio del corpo, i segreti della PNL e dell'ipnosi!Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (4)
- La musica che guarisce: Esperienze e considerazioni all'interno dei laboratori di musicoterapia didatticaDa EverandLa musica che guarisce: Esperienze e considerazioni all'interno dei laboratori di musicoterapia didatticaNessuna valutazione finora
- Umberto Galimberti Eugenio Borgna Un luminare miopeDa EverandUmberto Galimberti Eugenio Borgna Un luminare miopeNessuna valutazione finora
- Gestione dello Stress e dell'Ansia In italiano/ Management of Stress and Anxiety In ItalianDa EverandGestione dello Stress e dell'Ansia In italiano/ Management of Stress and Anxiety In ItalianNessuna valutazione finora
- Come riconoscere un narcisista: Conoscere il narcisismoDa EverandCome riconoscere un narcisista: Conoscere il narcisismoNessuna valutazione finora
- Pedagogia speciale e sport: Modelli, attività e contesti inclusivi tra scuola ed extrascuolaDa EverandPedagogia speciale e sport: Modelli, attività e contesti inclusivi tra scuola ed extrascuolaNessuna valutazione finora
- Elaborato finale dell’attività di tirocinio. Progettazione di un percorso educativo-didattico in: sicurezza stradale a carattere inclusivoDa EverandElaborato finale dell’attività di tirocinio. Progettazione di un percorso educativo-didattico in: sicurezza stradale a carattere inclusivoNessuna valutazione finora
- Amori Supernova. Psico-soccorso per cuori spezzati senza un perchéDa EverandAmori Supernova. Psico-soccorso per cuori spezzati senza un perchéValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Il Libricino della Felicità: come liberarsi dalle zavorre e raggiungere i propri obiettiviDa EverandIl Libricino della Felicità: come liberarsi dalle zavorre e raggiungere i propri obiettiviValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (3)
- Simboli, tra conoscenza e destinoDa EverandSimboli, tra conoscenza e destinoValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- La meditazione di Vipassanā e la psicologia cognitiva: Oriente ed occidente a confrontoDa EverandLa meditazione di Vipassanā e la psicologia cognitiva: Oriente ed occidente a confrontoNessuna valutazione finora