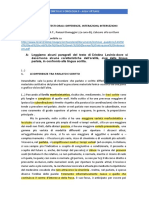Introduzione
Il IV libro dellEneide contiene la tormentata vicenda della storia di amore tra Enea e la
regina di Cartagine Didone. Nata quasi per gioco per il volere della dea Venere 1, che voleva
semplicemente rendere la permanenza di suo figlio a Cartagine la pi sicura possibile,
questa relazione diventa velocemente una vera e propria tragedia. Enea stato infatti
costretto dal volere del fato a partire per raggiungere il Lazio, e per questo motivo Giove
invia il suo messaggero Mercurio a ricondurre leroe a quel destino che il protagonista si
quasi dimenticato. Ma cos facendo trasforma il figlio di Anchise in un inconsapevole
carnefice, sordo a tutte le implorazioni sempre pi accorate che la regina di Cartagine
rivolge al suo indirizzo. Si apre cos lultima fase di questa relazione, che Virgilio descrive
con toni patetici. In un primo momento la regina pensa solo alla vendetta, passando
velocemente al rimpianto per non aver ucciso i troiani quando era ancora possibile. Didone
evoca dunque diverse divinit vendicatrici e lancia una terribile maledizione su Enea stesso e
i suoi discendenti 2. Infine, stravolta dallodio, Didone si suicida.
Questo comportamento ha attirato le critiche di molti commentatori, che hanno percepito
la figura di Enea come una semplice marionetta priva di vera volont. E questa presunta
mancanza di volont emergerebbe ancora di pi a causa della sua fuga precipitosa dalla
Libia: durante la notte Enea fa salpare la flotta e prende il largo evitando un ultimo
confronto con la sua amante, che poteva essere anche letale, dal momento che si temeva
che Didone potesse far appiccare fuoco alla flotta, uccidendo tutti i troiani.
Metro: esametri.
t iam prma nov spargbat lmine 3 trras
Tthon crocem linquns Aurra 4 cuble 5.
Rgin(a) speculs 6 ut prm(am) albscere lcem
vdit et aquats classm procdere vlis,
ltoraqu(e) t vacus senst sine rmige prtus 7,
trque quatrque man pects percssa 8 decrum
flventsqu(e) 9 abscssa coms 10 Pro Ippiter! bit
hc, ait t nostrs inlserit 11 dvena 12 rgnis?
Nn arm(a) xpedint totqu(e) ex rbe sequntur,
dripintque rats ali navlibus? te,
frte cit flamms, date tl(a), impllite rmos 13!
1
�Qud loquor? ut ubi sm? Quae mnt(em) insnia mtat?
nfelx Did, nunc t fact(a) mpia tngunt?
Tm decut, cum scptra dabs. En dxtra fidsque,
qum 14 secm patris aint portre pentis,
qum subiss(e) umers confct(um) aette parntem 15.
Nn potu(i) breptm divllere crpus et ndis
sprgere? nn socis, non ps(um) absmere frro 16
scanim patrisqu(e) epulndum 17 pnere mnsis?
Vr(um) ancps 18 pugna fuert fortna. fusset 19:
qum metu moritra? Facs in cstra tulssem
mplessmque fors flamms natmque patrmque
cm gener(e) xstinxm, memt super psa dedssem.
Sl 20, qui trrarm flamms oper(a) mnia lstras 21,
tqu(e) har(um) nterprs curr(um) et cnscia Ino 22,
ncturnsqu(e) Hecat 23 trivis ululta 24 per rbes
t Dir(ae) 25 ltrics et d 26 morintis Elssae 27,
ccipit(e) hac 28, meritmque mals advrtite nmen 29
t nostrs audte precs 30. si tngere prtus
nfandm 31 caput 32 c terrs adnre necsse (e)st,
t sic fta Iovs poscnt, hic trminus haret,
t bell(o) udacs popul vextus et rmis,
fnibus xtorrs 33, complx(u) avlsus Ili
uxili(um) mplort videtqu(e) indgna surum
fnera; nc, cum s sub lges pcis inquae
trdidert, regn(o) ut optta lce frutur 34,
sd cadat nte dim 35 mediqu(e) inhumtus harna 36.
2
�Hac precor, hnc voc(em) xtremm cum snguine 37 fndo.
Tm vos, Tyri, stirp(em) t genus mne futrum
xerct(e) odis, cinerqu(e) haec mttite nstro
mnera. Nllus amr populs nec fodera snto 38.
xorir(e) 39 aliqus nostrs ex ssibus ltor
qu face Drdanis ferrque sequre 40 colnos,
nnc, olm, quocmque dabnt se tmpore vres.
Ltora ltoribs contrria, flctibus ndas
mprecor 41, rm(a) arms: pugnnt ipsque neptesqu(e) 42.
Hac ait, t parts 43 animm versbat in mnis 44,
nvism quaerns quam prm(um) 45 abrmpere lcem 46.
Tm brevitr Barcn 47 nutric(em) 48 adfta Sychai,
nmque sum patri(a) ntiqu cinis 49 ter habbat:
nnam, cra mih nutrx, huc sste sorrem:
dc 50 corps propert 51 fluvili sprgere lmpha,
t pecuds sec(um) t monstrta picula dcat.
Sc venit, tuqu(e) psa pi tege tmpora vtta.
Scra Iov Stygi 52, quae rt(e) incpta parvi,
prficer (e)st anims finmqu(e) impnere cris
Drdanique rogm capits permttere flmmae 53.
Sc ait. lla gradm studi celebrbat anli.
t trepid(a) t coepts immnibus ffera Ddo
snguinem volvns acim, maculsque tremntis 54
nterfsa gens 55 et pllida mrte futra,
nterira doms inrmpit lmin(a) et ltos
cnscendt furibnda grads ensmque recldit
3
�Drdanim, non hs quaestum mnus in sus.
Hc, postqu(am) liacs vests 56 notmque cuble
cnspext, paulm lacrims et mnte morta
ncubutque tor dixtque novssima vrba:
Dlces xuvia, dum fta desque sinbat,
ccipit(e) hnc animm mequ(e) hs exslvite cris.
Vx(i) et qum dedert cursm Fortna pergi,
t nunc mgna me sub trras bit imgo.
rbem praclarm statu, mea monia vdi,
lta virm poens inimc(o) a frtre recpi,
flix, hu nimim felx, si ltora tntum
nmquam Drdania tetigssent nstra carnae.
Dxit, et s imprssa tor Morimur inltae,
sd morimur at. sic, sc 57 iuvat re sub mbras.
Huriat hnc oculs ignm crudlis ab lto
Drdanus, t nostra secm ferat mina mrtis 58.
Dxerat, tqu(e) illm medi(a) nter tlia frro
cnlaps(am) spicint comits, ensmque crure
spmantm sparssque mans. It clmor ad lta
tria: cncussm bacchtur Fma per rbem.
E gi la prima Aurora cospargeva le terre di nuova luce,
abbandonando il croceo giaciglio di Titone.
La regina, non appena vide biancheggiare la luce dallalto
e avanzare la flotta con le vele allineate,
e si accorse che le coste e i porti erano vuoti
senza la ciurma, battutasi tre e quattro volte il bel petto
4
�con la mano e strappandosi le bionde chiome, disse: Per Giove,
questo straniero se ne andr e si prender gioco dei nostri regni?
Altri non prenderanno le armi e non lo seguiranno da tutta la citt
e non strapperanno le navi dagli arsenali? Andate,
portate veloci le fiamme, date i dardi, spingete i remi!
Cosa dico? O dove sono? Quale follia turba la mente?
Infelice Didone, ora le empie azioni ti colpiscono? Allora
convenne, quando davi lo scettro. Ecco la destra e la promessa
di colui che dicono abbia portato con s i patrii penati,
che portava sulle spalle il padre affranto dagli anni.
Non potevo dilaniare il corpo travolto e gettarlo
alle onde? Non potevo annientare col ferro lui e i compagni
e porli nelle mense del padre Ascanio da divorare?
In verit la sorte della battaglie era dubbia. Lo fosse stata:
di chi ebbi paura, io destinata a morire? Avrei portato le fiaccole
contro laccampamento e riempito di fiamme le tolde ed eliminato
il figlio e il padre insieme al genero, e mi sarei gettata sopra le fiamme.
O Sole, che passi in rassegna con le fiamme tutte le opere del mondo,
e tu, Giunone, autrice e complice di questi affanni,
ed Ecate, invocata con grida nei trivi notturni attraverso la citt
e Dire vendicatrici e dei della morente Elissa,
accogliete queste parole, volgete ai malvagi una vendetta meritata
e ascoltate le nostre preghiere. Se necessario
che quelluomo nefando tocchi i porti e arrivi per mare alle terre,
e cos richiede il destino di Giove, questo termine rimanga fisso,
ma tormentato dalla guerra e dalle armi di un popolo audace,
5
�cacciato dalle sue terre, strappato dallabbraccio di Iulo,
implori laiuto e veda gli indegni funerali
dei suoi uomini; e dopo essersi posto sotto le condizioni
di una pace ingiusta, non goda del regno o della pace desiderata,
ma cada prima del tempo e insepolto in mezzo alla sabbia.
Chiedo pregando questo, spando questa ultima parola col sangue.
Allora voi, o Tirii, tormentate con lodio la sua stirpe e tutta
la razza futura, e mandate questi doni alle nostre
ceneri. Non ci sia n amore n patto tra i popoli.
Sorga un vendicatore dalle nostre ossa
a perseguitare i coloni dardani col ferro e col fuoco.
Ora, in seguito o in qualunque momento si presenteranno le forze.
Io auguro che le coste siano contrarie alle coste,
le onde ai flutti: combattano loro stessi e i nipoti.
Disse queste cose e volgeva lanimo in ogni parte,
cercando di spezzare il prima possibile lodiata luce.
Allora parl brevemente a Barce, nutrice di Sicheo -
infatti una nera urna possedeva la sua nellantica patria:
O nutrice a me cara, chiama qui la sorella Anna:
di di affrettare a cospargersi il corpo con acqua di fiume
e a condurre con s le pecore e le vittime indicate.
Venga cos, e tu stessa copriti le tempie con pie bende.
Ho il desiderio di fare un sacrificio a Giove Stigio, che ritualmente
ho preparato e intrapreso, e porre termine alle preoccupazioni
e dare alle fiamme il rogo delluomo dardanio.
Cos disse. Quella affrettava il passo con zelo senile.
6
�Ma Didone, affannata e sfrenata nei suoi propositi,
volgendo lo sguardo sanguigno, e cosparsa alle gote frementi
di macchie e pallida per la morte futura,
irruppe nelle soglie pi interne della casa e sal
furibonda sugli alti gradini e sguain la spada
del Dardano, dono non richiesto per questi usi.
Qui, dopo che ebbe visto le vesti iliache e il noto
giaciglio, indugiando un poco in lacrime e in pensiero,
giacque sul giaciglio e disse le ultimissime parole:
O dolci spoglie, finch il destino e il dio lo permettevano,
accogliete questa anima e scioglietemi da queste preoccupazioni.
Ho vissuto e ho percorso la via che mi aveva dato la Fortuna,
e ora la mia grande ombra andr sotto le terre.
Ho fondato una illustrissima citt, ho visto le mie mura,
avendo vendicato il marito ho punito il fratello nemico,
felice, oh troppo felice, se soltanto le navi
dardanie non avessero mai toccato le nostre coste.
Parl, e avendo premuto la bocca sul giaciglio disse: Moriremo
invendicate, ma moriamo! Cos, cos bene andare sotto le ombre.
Il dardano beva con gli occhi crudeli questo fuoco
dal mare, e porti con s questo nostro cattivo presagio di morte.
Aveva parlato, e le compagne vedono che quella cade sul ferro
in mezzo a tali frasi, e la spada schiuma di sangue
e le mani protese. Il clamore va per gli alti
atri: la Fama smania nella citt scossa.
1 Laccordo tra Venere e Giunone viene descritto come una sorta di incontro per siglare un
7
�accordo politico o matrimoniale: spesso le due cose corrispondevano nellantichit.
2 In tal modo, Virgilio inserisce nel proprio poema la causa eziologica dello scoppio delle
guerre puniche e il vero motivo per cui non ci potr mai esser pace duratura tra le due
nazioni; in una maniera tipicamente elegiaca, il destino di odio tra due popoli viene
determinato dalla relazione infelice vissuta dai fondatori delle rispettive citt.
3 novo [] lumine: si tratta di uniperbato, dal momento che laggettivo e il sostantivo
concordato sono separatati dal verbo spargebat (spargo, spargis, sparsi, sparsum,
spargere).
4 prima [] Aurora: da notare un altro forte iperbato.
5 croceum [...] cubile: si tratta del terzo iperbato allinterno dello stesso periodo di due
versi.
6 e speculis: le speculae sarebbero i posti di sorveglianza di una reggia o di una
fortificazione. Possiamo immaginare che Didone si fosse affacciata alle mura del palazzo,
poste in alto sul livello del mare, e abbia visto la flotta di Enea gi in alto mare.
7 C un esse sottinteso.
8 Pectus percussa: percussa participio perfetto del verbo percutio, percutis, percussi,
percussum, percutere. Pectus, accusativo singolare neutro del sostantivo di terza
declinazione pectus, pectoris, un accusativo di relazione che indica il punto dove la regina
si sta percuotendo. Laccusativo di relazione viene chiamato anche accusativo alla greca, dal
momento che un costrutto di origine greca, usato in latino soprattutto nellepica.
9 Flaventisque: arcaismo per flaventes.
10 comas: si tratta di un altro accusativo di relazione.
11 Inluserit: si tratta del futuro anteriore del verbo inludo, inludis, inlusi, inlusum, inludere,
che di norma regge il dativo della persona di cui ci si sta prendendo gioco (in questo
casonostris regnis).
12 Hic [] advena: si tratta di un nuovo iperbato abbastanza marcato.
13 La primissima reazione della regina furibonda. Non si ancora arresa al pensiero di
aver ricevuto una offesa tanto grave e spera ancora di potersi vendicare personalmente e
fisicamente di Enea.
14 quem: questo pronome relativo (come il successivo) si riferisce a un eius sottinteso ( il
fenomeno dellellissi del dimostrativo).
15 Con poche parole Didone stravolge limmagine tradizionale di Enea. La pietas di Enea,
che consisteva anche nel prestar fede nei giuramenti, in realt inesistente, dal momento
che con lei stato spergiuro. Il problema che per compiere il destino suo e di Roma, Enea
8
� stato costretto a sopportare molte sofferenze e sacrifici, compreso quello non secondario
di violare la propria natura andando contro alla propria pietas.
16 ferro: si intende la spada. Si tratta di una metonimia (in questo caso il materiale per
loggetto).
17 epulandum: si tratta del gerundivo del verbo epulor, epularis, epulatus sum, epulari
concordato ad Ascanium. Si tratta di un riferimento allempio banchetto di Tieste.
Atreo, padre di Agamennone e Menelao, era venuto a contesa per il trono con il fratello
Tieste. Atreo, fingendo una riconciliazione, offr un banchetto al fratello, solo che in realt
tra le varie portate erano stati imbanditi anche i corpi dei figli di Tieste, che erano stati cos
empiamente divorati dal padre.
18 anceps: composto di caput, capitis (testa) significa letteralmente dotato di due teste.
In maniera traslata indica la pluralit di esiti che pu avere una situazione incerta, quindi il
dubbio.
19 fuisset: congiuntivo piucheperfetto del verbo sum. Si tratta di un congiuntivo dellirrealt
(terzo tipo).
20 Sol: inizia con questa invocazione la maledizione che Didone scaglia sopra Enea e la sua
discendenza. Rendendosi conto che la vendetta fisica e immediata impossibile da
realizzare, la regina lascia agli dei il compito di riportare giustizia. Il Sole veniva spesso
invocato nei giuramenti, perch trovandosi in cielo era capace di vedere tutte le azioni
compiute sulla Terra.
21 lustras: il verbo lustro, lustras, lustravi, lustratum, lustrare indicava inizialmente latto
della purificazione, la lustratio. Dal momento che prima della battaglia lesercito schierato
veniva purificato mediante un sacrificio, il termine and a indicare anche la rassegna dei
soldati e pi in generale lesame di qualcosa.
22 Iuno: Giunone viene invocata in quanto protettrice del matrimonio. Didone ritiene infatti
di essere regolarmente sposata con Enea, anche se il loro matrimonio non stato sancito
dalla normale prassi.
23 Hecate: Ecate era una divinit molto particolare allinterno del Pantheon greco-latino:
essa infatti rappresentava la Luna durante la fase in cui scompare dal cielo (Luna Nuova) e
veniva spesso raffigurata insieme ad Artemide/Diana (Luna crescente) e Selene (la Luna
piena). Probabilmente anche a causa di questa sua triplice natura veniva venerata
allinterno dei trivi, dove si trovavano di frequente sue statue. In quanto rappresentazione
della Luna nella sua fase pi oscura, Ecate veniva considerata la dea della magia e veniva
invocata dalle streghe, sopratttutto in Tessaglia. Per la sua vicinanza col regno dei morti
viene invocata dalla Sibilla cumana prima dellingresso nellAde nel VI libro dellEneide.
24 ululata: Il significato del verbo ululo,ululas, ululavi, ululatum, ululare quello di ululare
o invocare mediante ululati. I cani neri erano considerati sacri a Ecate e spesso i loro
9
�ululati preannunciavano la sua venuta.
25 Dirae: le Dire sono da identificare con le Furie o Erinni. Questo gruppo di divinit
femminili erano attratte dagli spargimenti di sangue ed erano preposte al compimento delle
maledizioni. Particolarmente violente, le Erinni erano capaci di perseguitare una persona
anche per anni: famoso il caso di Oreste, perseguitato fino alla follia da queste divinit per
aver ucciso la madre Clitemnestra. Si tratta del mito cui si ispir lOrestea di Eschilo.
26 di: nominativo plurale irregolare di deus. Oltre alla forma regolare, si pu trovare anche
dii.
27 Elissae: si tratta sempre di Didone. Elissa sarebbe in realt il vero nome della regina
fondatrice di Cartagine (derivererebbe dal fenicio Allizzah), mentre Didone sarebbe solo un
soprannome attribuitole dai cartaginesi dopo la sua morte (vedi il commento di Servio
allEneide, I, 340). Il nome Elissa si trova comunque solo tre volte allinterno del poema.
28 haec: sottinteso verba.
29 numen: questo termine, che indicava inizialmente il volere della divinit, in seguit pass
a indicare la divinit stessa. In questo contesto il volere della divinit si doveva manifestare
come vendetta: per questo motivo traduciamo in tale maniera.
30 nostras [] preces: si tratta di un altro iperbato.
31 infandum: un termine composto dal prefisso in- (con valore negativo) e dalla stessa
radice del verbo fari (dire). Il significato originale era dunque indicibile. Ma dal
momento che i nomi delle persone che avevano compiuto empiet non potevano nemmeno
essere pronunciati per evitare di attirare il malaugurio, questo termine and presto a
ottenere il significato di empio, sacrilego.
32 caput: al significato originario di testa si pu aggiungere anche quello di persona
(anche oggi si dice contare per testa).
33 extorris: aggettivo composto dal prefisso ex- (fuori da) e il sostantivo terra (terra),
vuol dire letteralmente allontanato dalla propria terra, quindi esule. Questo termine di
origine giuridica. La maledizione di Didone si realizzer, ma solo in parte, quando Enea sar
costretto ad abbandonare il figlio e i suoi compagni per cercare lalleanza di Evandro e
Tarconte (libro VIII).
34 fruatur: il verbo deponente fruor, frueris, fructus sum, frueri uno dei cinque verbi che
reggono lablativo (gli altri verbi sono utor, vescor, potior, fungor).
35 ante diem: prima del giorno, ovvero prima del momento adatto per un uomo per
morire (ovvero da vecchio).
36 La prima parte della maledizione di Didone si realizza in parte allinterno e in parte
allesterno del poema. A partire dal libro VII dellEneide leroe raggiunge infatti il Lazio, ma
10
�viene costretto a combattere contro le popolazioni locali guidate da Turno, re dei Rutuli.
Costretto a chiedere laiuto dellarcade Evandro, rimane per un certo tempo separato dai
suoi uomini e molti troiani cadono in battaglia. Invece, la morte di Enea non viene descritta
dal poema. Secondo alcune fonti leroe sarebbe morto combattendo contro popolazioni
ostili nel letto di un fiume appena pochi anni dopo il suo arrivo nel Lazio.
37 cum sanguine: versare il proprio sangue era un modo per rendere sicuro lavverarsi della
maledizione.
38 Sunto: si tratta dellimperativo futuro del verbo sum. Questo modo viene usato piuttosto
raramente, se si esclude il genere trattatisco-giuridico (come il De agri cultura di Catone). In
questo contesto come se Didone stesse dettando le leggi di comportamento che il suo
popolo dovr seguire nei confronti dei romani.
39 exoriare: Si tratta dellimperativo presente di seconda persona singolare del verbo
deponente exorior, exoriris, exortus sum, exoriri, un composto da ex- e orior che vuol dire
letteralmente venir fuori.
40 qui [] sequare: si tratta di una relativa col congiuntivo che assume valore finale (ovvero,
una relativa impropria).
41 imprecor: sottintendi esse.
42 Con la seconda parte della maledizione Didone condanna il suo popolo a combattere una
guerra spietata contro i romani. Il vendicatore destinato a sorgere dalle sue ossa non
altri che Annibale Barca, il famoso condottiero che sconfisse pi volte i romani durante la
seconda guerra punica. Si racconta che Annibale, ancora bambino, fosse stato convinto dal
padre Amilcare a prestare un giuramento di odio eterno nei confronti dei romani molto
simile a quello espresso nella maledizione della regina morente. Lintero racconto della
permanenza di Enea a Cartagine assume cos i connotati di una etiologia, ovvero un
racconto che serve a spiegare le lontane origini del conflitto tra romani e punici. Il genere
eziologico aveva avuto un notevole successo in et ellenistica; il poeta Callimaco ad esempio
aveva composto gli Aitita, unintera collezione di racconti di questo tipo (purtroppo andata
persa quasi del tutto).
43 partis: forma arcaica per partes.
44 omnis: forma arcaica per omnes.
45 quam primum: in questo caso quam ha valore di rafforzativo del superlativo irregolare
primum; lavverbio primum e laggettivo primus, prima, primum sono infatti superlativi di
una forma che non possiede il grado normale -che doveva comunque essere imparentato
con la preposizione prae- e il cui comparativo consiste in prior.
46 invisam [...] lucem: si tratta di un iperbato molto forte.
47 Barcen: il nome della nutrice ricorda molto da vicino il cognome della famiglia Barca, che
11
�aveva dato i natali ad Amilcare e Annibale, strenui rivali dei romani nel corso delle guerre
puniche. Molti vedono in questo quasi una prefigurazione della futura realizzazione della
maledizione di Didone.
48 nutricem: la nutrice svolgeva il ruolo essenziale della confidente nei confronti dei
personaggi femminili nelle tragedie greche.
49 cinis: La cenere indica in questo caso lurna che la contiene. Si tratta di una metonimia (il
contenuto per il contenente).
50 Dic: si tratta dellimperativo irregolare del verbo dico, dicis, dixi, dictum, dicere.
Costruiscono limperativo in questo stesso modo anche il verbo facio e il verbo duco.
51 dic [] properet: sottinteso un ut con funzione dichiarativa.
52 Iovi Stygio:si tratta di Plutone, il dio dei morti.
53 Didone finge di voler compiere un rituale magico in cui avrebbe dato fuoco a tutti i regali
di Enea per dimenticarlo. Ma gi il fatto che il rito in onore di Plutone (Giove Stigio) getta
una luce inquietante sui reali propositi della regina.
54 trementis: forma arcaica per trementes.
55 trementis...genas: si tratta di un accusativo di relazione.
56 vestis: forma arcaica per vestes.
57 sic, sic: si tratta di una geminatio intensiva che serve a rendere maggiormente patetiche
le ultime parole della regina.
58 La richiesta della regina si realizza quando allinizio del libro successivo Enea vede il fumo
levarsi senza sapere il motivo del rogo. Una ulteriore conferma del fatto che la maledizione
destinata a realizzarsi.
12