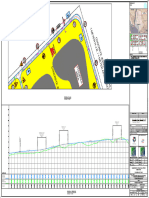Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Atletica Studi - Vittori - Allenamento Della Forza Nello Sprint
Atletica Studi - Vittori - Allenamento Della Forza Nello Sprint
Caricato da
Francesco Iavarone0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
207 visualizzazioni13 pagineAtletica Studi - Vittori - Allenamento Della Forza Nello Sprint
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoAtletica Studi - Vittori - Allenamento Della Forza Nello Sprint
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
207 visualizzazioni13 pagineAtletica Studi - Vittori - Allenamento Della Forza Nello Sprint
Atletica Studi - Vittori - Allenamento Della Forza Nello Sprint
Caricato da
Francesco IavaroneAtletica Studi - Vittori - Allenamento Della Forza Nello Sprint
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 13
| |‘ ALLENAMENTO
DELLA FORZA NELLO SPRIN
Carlo Vittori
INTRODUZIONE
Il capitolo della forza muscolare rappresenta, nel libro della metodologia deltallenamen-
to sportivo, il eaposaldo pit) importante, giacché tratta della qualita fisica fondamento
{ella motrciti dell'uomo, come causa dello spostamento dei gravi ¢ della velocita che ad
essi si vuole fare acquisire. Deve per questo essere considerata la vera e propria qualita
fisica «pura» di base
‘Usualmente, ma erroneamente, insieme a questa viene inclusa la velocita come qualita fi-
sica fondamental, che in ralta, dovrebbe essere, invece, intesa come una «capacitin de-
rivata, dipendente dallapplicazione di una forza ed esclusivo effetto di quest ultima.
Eventualmente, tra le qualita fisiche di base potrebbe trovare posto la «rapiditi»,intesa e
definita come quella carateristica che consente di muovere rapidamente, liberi da sovrac-
catico, uno o pi segmenti del corpo.
Ma anche la misura di questultima rischia di timanere un‘astrazione con scarso valore,
nel caso in cui sia elevato il carico ed alta la velocita che ad esso si vuole imprimere co-
‘me, ad esempio, nello scatto di un ciclista di velocita su pista, o quello di uno sprinter
nel‘atletica leggera. In tutti e due i casi la velocita del loro avanzamento sara sempre in
funzione della forza e della brevita della sua estrinsecazione, poiché sara il dinamismo di
questultima a determinare altresi Ia rapidita dei movimenti e cioé la loro frequenza. Di
scarsa indicazione sara, infatt, il valore della rapidita misurata con movimenti a vuoto
poiché non sara questo ad assicurare un‘alta frequenza quando i due specialisti dovranno
accelerare il peso del loro corpo, bensi la capacita di esprimere alte punte di forza in tem-
Pi brevi e sempre pitt brevi.
LA FORZA MUSCOLARE E LE SUE DIVERSE ESPRESSIONI
La forza muscolare si pud definire come la capacita che i componenti intimi della materia
muscolate (miofibrille) hanno di contrarsi, cioé di accorciarsi.
Questa é Ia caratteristica distintiva della parte proteica della sostanza muscolare.
Ad ulteriore chiarimento, si puo citare V'aforisma di Hoke: «Ut tensio sic vis» che ci con-
sente di considerare la tensione esterna del muscolo che si evidenzia a seguito di una
contrazione, come la forza stessa di coesione della componente contrattle del muscolo
(parte miofibrillare) che é stata necessaria per sviluppare tale tensione,
E assodato, quindl, che la prerogativa del muscolo & quella di contrarsie che in tale fun-
zione risiede lo sviluppo delle sue capaciti di forza. Ma @altretanto vero che tale funzio~
| 1
ne pud essere sviluppata e determinata da fenomenologie diverse che ci spingono & pren- 7
deze in considerazione differenti modi di esprimere la forza, pid che different tipi di for-
‘Tengo a precisare che le terminologie che qui vengono usate si allontanano da quelle abi-
tuali, poiché sono convinto che esse consentono di comprendere meglio i fenomeni che
tali diverse espressioni determinano.
Si definiscono, quindi, due gruppi diversi di manifestazioni della forza:
a) espressione di forza attiva;
») espressione di forza reativa,
a) La prima é Feffetto di forza prodotto da un «ciclo semplice» di lavoro muscolare: quel-
lo di accorciamento della parte contrat.
L’accorciamento si determina nel muscolo in perfetto stato di quiete; esempio: un braccio
disteso ed immobile viene flesso con una contrazione del bieipite brachiale e sinergici,
‘oppure: una estensione degli arti inferior, posti in posizione immobile di semi-piegamen-
to, a carico dei muscoli estensoi
Gli unici movimenti che si evidenziano, sono quindi, la flessione del braccio ¢ Festensio-
ne degli arti inferior.
») La seconda @ Yeffetto di forza prodotto da un «doppio ciclo» di lavoro muscolare:
quello di «stiramento-accorciamenton.
La forza altro non é che la resistenza che si oppone ad un‘azione; esempio: Veffettuazione
i un balzo verso Falto, partendo dalla posizione ereta, si determina in conseguenza di un
rapido semipiegamento degli arti inferiori (azione di discesa), al quale fa seguito un al-
trettanto rapida inversione del segno del movimento a causa dellestensione degli art in-
feriori. Orbene, & proprio nella fase finale del semipiegamento che si evidenziano le ten
sioni muscolari atte a create le forze di resistenza che si oppongono al'azione di schiac
ciamento completo delle gambe causata dallenergia cinetica sviluppatasi nella rapida di-
scesa (primo ciclo di lavoro muscolare). L‘inversione del movimento e, quindi, Yaccor-
ciamento (secondo ciclo di lavoro muscolare) del muscolo & conseguente alle tensioni in-
stauratesi nella precedente fase di «stiramento»:
Fanno parte del primo gruppo:
1) Fespressione «massima dinamica» della forza;
2) Hespressione «esplosivan della forza.
I secondo gruppo comprende, invece:
3) Fespressione «esplosiva-elastica» della forza;
4) Yespressione «esplosiva-elastica-riflessa» della forza.
Nel prosieguo della tattazione, soltanto per comodita di esposizione, verranno usate, pet
Aefinize le diverse espressioni di forza, terminotogiesintetiche anche se scienificamente
non esatte
1) Per forza massima dinamica s‘intende quella forza che viene espressa per spostare,
senza limitazione di tempo, un catico pia elevato possibile, con un solo movimento. Si
definisce dinamica non petché lo spestamento é veloce, ma perché si contrappone alla
forza isometrica nella quale non c’é movimento,
2) Pet forza esplosiva sintende quella forza che viene espressa con ur‘azione di contra
zione il pit potente possibile, come se fosse una «esplosione», per conferire al carico d8
2
spostare Ia maggiore velociti possible, partendo da una situazione di immobilita dei seg-
‘enti propulsivi, Nello sprinter, ad esempio, il massimo della forza esplosiva si evides.
zia sulla prima spinta sul blocco di partenza dell'ato posto anteriormente,
3) Pet forza esplosiva-elastica sintende quella forza di tipo reattivo che la muscolatura
immagazzina ogni qual volta subisce, prima di accorciarsi, uno stiramento, Il movimento
che si evidenzi, in maniera pit o meno marcata, si pud considerare un molleggio,
ché consiste in un piegamento-estensione, pit 0 meno rapido. In conseguenza del piega
mento, gli elementi elastci in serie del muscolo, sottesi dallenergia cinetica e dalla forza
di trazione che nel contempo la componente contrattile sviluppa, accumulano una ceria
quantiti di energia che resttuiscono immediatamente, nella suecessiva contrazione, in-
grandendone gli effetti. Questa espressione di forza si evidenzia nello sprinter special.
‘mente nei primi passi,
4) Per forza esplosiva-elastica-riflessa sintende quel tipo di forza che si manifesta, come
1a forza esplosiva-elastica, in conseguenza di un piegamento (momento di lavoro recessi-
v0 0 di contrazione eccentrica)dell'rto propulsivo ma, in questo caso, i pi rapido pos.
sibile edi ampiezza assai limitata
La rapidita e la limitatezza del piegamento delf'arto, nel momento delfappoggio a terra,
sono, infatti, le due condizioni essenziali perché si produca, per «via riflessay, unlulterio”
re stimolazione nervosa che si coneretizzera nelle eccitazione di una quota aggiuntiva di
unit motrci, nella fase suecessiva di contrazione e, quindi, in un «surplus» di forza, Da
qui il termine di forza riflessa». B questa Vespressione fenomenologica pi rapida della
forza e per questo essa soltanto pud consentire allo sprinter di correre velocemente, dato
il brevissimo tempo di cui esso dispone per esprimerla: circa 9 centesimi di secondo.
Tato dua, mediamente i tempo appogsio del pede a tere nella corsa lanciata a mas-
sima velocia
FATTORI DETERMINANTI LE DIVERSE ESPRESSIONI DI FORZA
Dovendo soffermare la nostra attenzione sulla corsa e, quindi, sug art inferiri in quan-
to sistemi propulsivi utiizzati per sviluppare velocit, sara bene, per comprendere meglio
42 composizione qualitaiva ed il valore quantitativo di ciascuna espressione i forza, fare
tiferimento ad una serie di moviment classic dimpulsione degli arti stessi, con cui se ne
ontraddistingue la loro prerogativae funzionalita
{divers eserizi che verranno presi in esame hanno come denominatore comune il piega-
‘mento-estensione delle gambe che pud essere realizzato in forma lenta o soto forma ve-
Joce di vero e proprio movimento impulsivo.
1 piegamento-estensione pi 0 meno profondo e, quindi, pil o meno rapido, ma sempre
«Seguito con impegno massimo, si realizza attraverso lattivazione dei muscoli antigravi-
{ezionali o estensori degli art inferiori, che servono le tre articolazionidell'anca, del gi-
occhio e della caviglia, component la catena cinetica di propulsione.
Nel caso della forza massima dinamica, fesercizio consiste in un piegamento massimo al
Guale fa seguito il raddrizzamento estensione degli arti infetiori effettuato con il massi-
to catico possibile e, come gia detto, senza limitazione di tempo. Per tale motivo, questo
& Vunico degli eserezi scelt a non avere le caattristiche dinamiche di un vero e proprio
‘movimento impulsivo. Molto verosimilmente, la forza sviluppata sari molto prossima al
Valore del carico sopportato dagli arti inferiori (peso del corpo + sovraccarico aggiunti-
Y0), propio in conseguenza della bassissima velocita del movimento. Se la velocita di
riddsizrameto dle game ose, infati,clevat, sculpt on p=
presenterebbe il massimo.
Il fattore caratterizzante questa espressione di forza & la capacita contrattile. 1! valoe
quantitativo di questa forza in uno sprinter pud essere considerato sufficiente quando i)
sovraccarico spostato raggiunge il doppio del peso del corpo del'atleta
Significato importante assume indice che scaturisce dal rapporto trail peso del sovrac.
cearico ¢ quello del corpo, che definisce il valore della «forza relativa», giacché é il pro-
prio corpo che nella corsa atleta deve accelerare. Tale indice deve raggiungere almeng
‘un valore pari a2.
Ls Yor ass dnamice rppreseta afore base in quanto invest ed interes
‘qualité fondamentale del muscolo: quella di contrarsi.
Come si potra notare, infatti, nella Figura n. 1, la capacita contratile e, quindi, la forza
‘massima dinamice, costituisce il denominatore comune a tute le altre espressioni, come &
logico che sia, essendo questa unica cosa che il muscolo sa fare ed & chiamato a fare.
‘Tattle alte manifestazioni sono, con quella di forza massima, in una correlazione che va
decreseendo a misura che diminuisce la sua incidenza percentuale sul totale della forza,
espressa, Cosi, ad esempio, la correlazione sari alta tra la forza massima dinamica e
quella esplosiva, poiché alta é la incidenza della capacita contratile su tutta Ia forza
esplosiva espressa. Questa incidenza, invece, é minima nella manifestazione di forza
esplosiva-elastica-iflessa.
Perle altre espressioni di forza, il movimento di piegamento-estensione degli arti inferio-
1 € cosi rapido e potente da dar vita ad un vero e proprio impulso che, trasferito all'atleta,
ali fa compiere un balzo verso alto.
Ponendo sotto i piedi delfatleta un tappeto a conduttanza, collegato ad un cronometro (6
stema adottato per la prima volta dal Prof. Carmelo Bosco) & possibile rilevare il tempo
di volo, quindi, epplicando la formula 1/2g + t,ricavare Velevazione in em, Certamente,
chi raggiunge una maggiore elevazione ha sviluppato un netto impulso pitt grande.
Con una piattaforma piezomettica, invece, & possibile, oltre ai rilevamenti sopra citati,
avere il grafico della curva della forza, con i valori della sua intensita e del tempo impie-
‘gato ad esprimerla, Questo sistema & stato realizzato con la preziosa collaborazione del
Prof. Roberto Bonomi, sia nella Scuola di Atletca Leggera di Formia, sia a Rieti, luogo
i residenza del Prof. Bonomi
Perla forza esplosiva, lesercizio consiste in una rapida e forte estensione-raddrizzamento
degli arti inferior in posizione di semipiegamento, con le mani ai fianchi ed in stato di
perfetta immobilita
‘Limpegno massinate deve consent lo svilupp dun balzo vertical ip alto posi
ile.
Come si pud notare dalla Figura n. 1, al fattore della capacita contrattile, si aggiunge, in
questa manifestazione di forza, un secondo fattore relativo alla capacita di sincronizza-
zione della contrazione delle fibre, per avere un loro pit: massiecio reclutamento istanta-
neo. Capaciti questa che non viene impiegata nella forza massima dinamica, E proprio
per tale piccola quota parte che quest ultima non é in correlazione con la forza esplosiva.
In effetti, € assai maggiore la parte che, invece, le pone in stretta colleganza. Cid vuole
Soprattutto significare che un miglioramento della forza massima dinamica comporta an-
che un innalzamento delle prestazioni di forza esplosiva, ma non in una misura cosi gran
dde come si otterrebbe se venisse migliorata anche la capacita di reclutamento con eserci-
tazioni pit proprie specifiche a questa capacita, Se ne deduce un principio fondamenta-
le delfallenamento, secondo il quale é indispensabile, ai fini di una prestazione ai limiti
4
[ ATTOR DETERMINANT! LE DIVERSE ESPRESSION/-1FORZA
delle possibilit, intervenire con mezzi specifici di training su tutte le tessere che com-
pongono il complesso mosaico delle capacit necessare alla prestazione.
‘Volendo confrontare il valore delle forze sviluppate nelle due espressioni sopra citate non
si pud fare altro che valutare le punte di forza in esse sviluppate, giacché non é possibile
un confronto del loro netto impulso in quanto, nel caso della forza massima dinamica, il
traeciato della forza non si presenta come quello di un impulso, a cupola, bens rimane st
4i una linea molto prossima ad una ret, che si colloca ad un livello di intensit di carico
pari al peso delltleta pit il sovraccarico.
| valoti prestativi della forza esplosive per uno sprinter, riferiti ai centimetri di elevazione
ottenuti con Fesercizio di cui sopra, sono legati e correlati alla fase di messa in moto o di ac-
celerazione nei primi 15-20 metr. Sulla base dei tanti dati raccolti nel passato, si possono
‘molto verosimilmente proporre dei parametria cui € possibile far rferimento per conoscere
illivello delle eapacita degli atleti eaccertarsi anche se il loro valore é suffciente per realiz-
are Ia prestazione cronomettica ipotizzatae programmata I parametri sono i seguenti
Prestazione sui 100m
10,60/10,40
10,40/10,20
10,20/10,00
questo éeffetto dovuto alla componente elastica, da cui il nome di forza esplosiva-clastica
La differenza in centimetri tra le prestazioni dei due salti ottenuti con i due esercizi sopra
esposti viene definita indice di elasticita in quanto cid che li differenzia é soltanto questa
capacita. In uno sviluppo equilibrato di tute le componenti che determinano tali manife~
stazioni di forza, lindice di elastiita si pud considerare, mediamente, pari al 20% cirea
della prestazione in centimetriottenuta nel test di forza esplosiva.
1 parametri prestativi di questa espressione di forza sono, a seconda del risultato erono-
metrico, i seguent
Prestazione sui 100 m
10,60/10,40
10,49/10,20
10,20/10,00
Per lespressione di forza esplosiva-elastica, lesercizio consiste in un rapido doppio mo-
vvimento di semipiegamento-estensione delle gambe, partendo dalla posizione eretta, con
Je mani ferme ai fianchis Ovviamente limpegno, sempre massimale, deve consentire un
balzo verticale pit alto possibile.
In questo movimento, il netto impulso che ne deriva (ora possiamo esprimerci con questo
termine di paragone), & senz“altro maggiore di quello prodotto con Yesercizio precedente
di forza esplosiva, in quanto maggiore ¢ Yelevazione che si raggiunge.
Ai fattori che determinano il precedente tipo di forza si aggiunge, infatt, in:
Prestazione del balzo in cm
40-45
45-52
5258
er Vespressione di forza esplosiva-elastica-tiflessa, gli esercizi utilizzati anche come test
di vetfica sono due,
Il primo, n. 4 consiste in una suecessione di 4-5 balzi verticali eseguiti con un rapido &
brevissimo movimento di molleggio di tipo «rimbalzo» come quello di una palla che vie-
ne scagliata a terra. Si cerchera di andare piii in alto possibile limitando al massimo la
deformazione muscolo-articolare del ginocchio ¢ della cavigtia, conseguente al violento
ccontatto a terra dopo il volo precedente, Senza dubbio, il setore pii fortemente sollecita-
toe messo a durissima prova é quello del piede-caviglia, la cui muscolatura (tricipite su-
tale e sinergici) deve sopportare
Prestazione del balzo inom
48-53,
53-60
60-68
il maggiot carico in una situazione di grande difficolta meccanica della sua leva, giacché
il contato a terra dopo il volo, per essere efficacemente reativo, deve avvenire sulla par-
te motatarsale del piede e non su tuta la sua superficie Si pensi che un atleta di cirea 75
Kg che si solleva 75 cm circa fa registrare, sul successivo contatto & terra, un carico di
circa 1000 Kg.
Una breve deformar
ne del sistema biomeccanico arto inferiore sortisce un doppio effet-
16
to: accorciamento del tempo di contatto maggiore accumulo di energia elastica-riflessa
pella fase di stiramento-contrazione eccentrica nel contromovimento che, resttuita nella
successiva contrazione concentrica, ne aumenta gli effetti. Le due fasi, qui esposte sepa-
ratamente per comodita didattica, si suecedono con una tale rapidita da impiegare un
tempo di circa 160 millesimi di secondo, durante il quale si sviluppano punte di forza
dellordine espresso in precedenza. II legame di interdipendenza tra la fase eccentrica e
{quella concentrica di contrazione vera ¢ propria, che costituiscono il «molleggio» dell'ar-
to inferiore, & cosi stretto che Vefficacia dellmpuslo accelerante, conseguente alla con-
trazione vera e propria, & inversamente proporzionale alla deformazione da stiramento
che la stessa muscolatura subisce, nel momento recessivo del contatto al suolo.
Quando questo esercizio viene usato come test, il cronometto collegato al tappeto deve
essere predisposto in modo da consentire il rilevamento sia dei tempi di volo sia di quelli
i contatto, poiché la valutazione delle capaciti sara fatta sia sulla quantita di forza
espressa (in base all'atezza del volo) sia sul tempo impiegato ad esprimerla (in base ai
tempi di contatto)
Migliore efficienza si avra con una maggiote altezza del volo ed una diminuzione dei
tempi di contatto; con la diminuzione dei tempi di contatto, senza variazioni dell'altezza,
oppure viceversa, con aumento delf'eltezza, senza variazione dei tempi di contatto,
Ii secondo esetcizio, n. 4a, ha una esecuzione molto simile a quella dell esercizio n. 3, ec-
cezione fatta per le braccia che, invece di rimanere ferme con le mani ai fianchi, vengono
utilizzate distese in un’oscillazione vigorosa, coordinata e sincrona al semipiegamento -
estensione degli arti inferiori. Si tratta del vecchio test di Abalakov, che diversi anni ad~
dietro veniva usato dai saltatori in alto ventralisti, per misurame le capacita di spinta ver-
ticale, delle gambe.
Questo esercizio, gia utlizzato con gli sprinter come fondementale mezzo di allenamento
‘muscolare, venne introdotto anche come test poiché convinti che potesse integrare Valtro
1. 4 ed essergli complementare. I fatto che determinano la forza espressa nei due eser
2, presumibilmente, sono gli stessi: la componente contrattle, le capacita di reclutamen-
toe di sincronizeazione, la componente elastica e quella riflessa, ma differente, invece, la
Joro incidenza quantitativa, come pud osservarsi dalla Fig. n. 1. Diversi sono anche i tem-
pi medi di sviluppo della forza: intomo ai 240 millesimi nelfes, 4a; circa 160 millesimi
nel'es. 4 (vedasirispettivamente le Figg. 2 € 3)
Leelevazione verticale nei due esercizi 4 e 4a € maggiore di quella che si raggiunge nel-
Yes. 3, quindi, pia grande anche il loro netto impulso. Era, percid, logico pensare che il
«surplus» di forza evidenziato nell’s, 4a, diverso dal 3 solo per uso delle braccia, dipen-
desse dal movimento di queste ultime. Si pensé che fosse verosimile lipotesi secondo
la pit che apprezzabile quantita di energia cinetica sviluppata nella oscillazione delle
braccia distese si trasferisse prevalentemente sui muscoli del quadricipite, stimolandoli in
uel'ulteriore rapido stiramento necessario a produrre quel «surplus» di forza per via «ri-
flessa». I muscoli del quadricipite, sono quelli che verso la fine del movimento ammor-
tizzante sono i pid impegnati a frenare il pid rapidamente possibile il corpo animato dal-
Venergia cinetica della veloce discesa, e per questo i pit bisognosi di utilizzare la supe~
reccitazione nervosa riflessa causata dalla oscillazione delle braccia che faciliterd anche
1s rapidita dellinversione del movimento di discesa ed inizieri Ia fase accelerante,
1 piedi, mobilizzati dalla muscolatura del polpaccio, intervengono in rapida suecessione
dinamica a concludere Yestensione-raddrizzamento degli art inferiori.
Da questo esame biomeccanico scaturi il concetto di complementarieta dei due test 4 €
4a, Mente il primo poteva essere utlizzato come esercizio di potenziamento prevalente-
n
Sa
mente dei piedi e dei polpacci e come test per verificare la crescita della loro efficenza, il
econdo poteva essere usato con gli stessiscopi, ma rivolti principalmente al setore dei
quadticipidi e pit genericamente delle cosce.
da sorpresa interessante fu nel constatare che in molt atleti di quaificazione e discipline
tportive diverse, ivalri della elevazione vertical nei due test erano pressoché usual
oltierano, perd, anche coloro che presentavano disuguaglianza dei due dati: maggiore
Yelevazione nel test 4, rispetto al 4a, 0 viceversa.
‘Ma la cosa ancor pill importante venne fuori quando ci si rese conto che le differenze ri-
scontrate sugli atleti appartenenti agli ultimi due gruppi erano dipendenti dalle specialita.
di loro praticate. Al gruppo che aveva una maggiore resa nel test 4, appartenevano atleti
the, nelle loro prestazioni, usavano pili i piedi delle cosce (corridori di 400 metri ad
{sempio), mentre era viceversa per V'altro gruppo (caleiator, sprinter male allenati, gioca-
{ori di basket). Gi atleti che presentavano gli stessirisultati nei due test avevano, invece,
certamente svolto con saggezza metodologica un training con un equilibrato sviluppo in-
tegrale dei settori muscolari impegnati a produrre propulsione. Ed ecco ribadita anche la
fanzione dei due test come indispensabili mezzi per individuare meglio sia le carenze sia
i mezzi ed i metodi per colmarle.
Ma é assolutamente necessario, oltre alla equivalenza delle prestazioni di elevazione nei
due test 4 e 4a, che questi ultimi abbiano un valore tale da essere stimato ottimale per ot-
tenere prestazioni, nello sprint, di alta qualificazione.
[Non potendo perd proporre precise parametrazioni da rferire a prestazioni cronometriche
sui 100 metri, come gia fato per le altre espressioni di forza, ci si limita a riportare alcuni
dati ricavati dalle medic dei risultati pi elevati, verso i quali bisognerebbe tendere con
Tallenamento, almeno con quegliatleti che denotano potenzialita per raggiungere un‘alta
qualita di prestazione nello sprint.
Tparametri sono i seguenti
Testn.4
Prestazioni del volo
tempo cm
760/800 71/78
Tempi di contatto
14syis2
Test n. 4a
Prestazioni del volo
tempo om.
760/800 71/78
Tempo dl coniatto
—,
plosiveslastics
espressione
2 mete,
Tomo a spints
EsNae
‘ Nellambito di questi valori,affinché si possa giudicare ottimale sia Yentti della forza sia
il suo tempo di espressione, tra la meta del tempo di volo (che rappresenta poi il tempo
cffettivamente impiegato per raggiungere lelevazione corrispondente) ed il tempo di con-
tatto deve sussistere un rapporto aggirantesi intorno ai 2,6.
fe 30 pistiatorma plezometiiea (Dai! ol Pro” Roberto Bonomi)
curve delle forze relative
reaiat
COMBINAZIONE DELLE ESPRESSIONI DI FORZA_
UTILIZZATE IN UNA COMPETIZIONE DI 100 METRI
Fig.2
AL
1 una competizione di 100 metti& verosimile pensare che nella fase inizale di messa in
| ot)
moto, considerata Yentita della massa da spostare (in uno sprinter di 180 cm di alteza il
peso del corpo pu essere di circca 75-78 Kg), le espressioni di forza che vengono impe-
‘nate in pi grande misura sono: la forza massima dinamica (per il suo fattore di capaci
contratile), la forza esplosiva (per le capacita di sincronizzazione e di reclutamento
istantaneo che la sostengono) ela componente elastica della forea(vedasi grafico n. 1),
[ld MM
ie F305 O88
11 Combinazione delle espressioni di forza utlizate in una g
100m
Del resto, a posizione raccolte¢ chiusa del corpo e degli arti inferiori che determina tem-
pi dappoggio piuttosto Lunghi, compresi fra i 260 millesimi circa della prima spinta sul
bloceo anteriore ed i 115 cirea del decimo passo, non consentono di utlizzare misure ric-
che di espressioni pitt veloci di forza
‘A misura che Yatleta procede, acquistando velocita e per causare ulteriore velocita, favo-
rito anche dal'apertura dell'angolo al ginoechio (che passa dai 90° circa sul bloceo ai
140° circa della fase lanciata), la combinazione di forze progressivamente si trasforma
arricchendosi di un fattore determinante la rapidith dei movimenti propulsivi e, quindi,
della frequenza dei passi. Questa é la forza riflessa, che pian piano sostituisce tna cospi-
ccua parte della forza massima ed esplosiva che pur rimane come capacita basica. Non po-
trebbe essere altrimenti, giaccheé la potenza delle propulsioni pud essere determinata sol-
tanto da una miscela di forze atricchita prevalentemente da manifestazioni rapide ({ tempi
dd appoggio nella fase di alta velocita durano appena 90 millesimi), quale quella reativa-
Limpegno muscolare che nella fase di messa in moto era prevalentemente sulle cosce si
sposta progressivamente sui piedi e sui glutei, con il crescere della velociti.
Nella fase lanciata, durante il contatto del piede a terra, la funzione di tenuta eccentrica
del quadricipite prevale su quella concentrica accelerante, tanto che il suo intervento sul~
Ja potenza dell imputso & piuttosto basso rispetto a quanto dovuto al piede, al gluteo ed ai
flessori della coscia sul bacino delfarto oscillante.
‘Mentre la coscia sul bacino ed il piede sulla gamba si iperestendono, nella fase acceleran-
1c, il ginocchio rimane sempre lezgermente flesso con un angolo di circa 168°-172°,
Tali conceti, espressi in maniera cosi schematica ¢ semplificata soltanto per facliterne la
‘comprensione, riguardano, invece, fenomeni che siinterseeano, si confondono e sfumano
80
Yuno nel’altro in una felice e proficua combinazione dinamica che soltanto la macchina
tumana pod partoree,
CONDIZIONI INFLUENZANTI LO SVILUPPO,
DELLA FORZA MUSCOLARE
La prima e pitt antica proposizione sulla forza, divenuta ormai postulato, dice che il valo-
re della sua dimensione 0 capacita dipende dalla grandezza del muscolo, cioé dall'area
della sua massa magra, o della sua parte contrattle. Questo vuol dite che sullo stesso i
dividuo (€ non su individui diversi) un muscolo che diventa piii grosso é capace di espri-
sere pitt forza. Tale ingrossamento & dovuto all aumento dei diametri trasversi di ciascu-
1a fibra, conseguente alla ipertrofia della sostanza proteica contratile,
Le condizioni che debbono verificarsi perché si realizzi ipertrofia muscolare sono due:
a) entité della tensione muscotare;
») tempo di mantenimento della tensione.
Lentita della tensione del muscolo & ditettamente proporzionale al numero delle unit
mpegnate, cosi come il numero di queste ultime é direttamente proporzionale alla
del movimento e alfentita del carico da spostare. Cid vuol dire che si pud ottene-
re un aumento della tensione facendo crescere sia la velocita del movimento sia il cario.
Se la velocita oil carico sono massimi, il muscolo (il che equivale a die le sue unit mo-
trici) si contrae in toto ela tensione & massima e pressoché di egual valore nei due casi
E un errore pensare che lo spostamento di carichi crescent effettuato con massimo impe-
‘ano comport un aumento progressivo delle unita motrici impiegate. Se cosi fosse, Vanda-
mento della forza-velocita di Hill non sarebbe pit una curva esponenziale.
Se si esegue un balzo verticale per andare il pit in alto possibile, quindi con il massimo
impegno, nulla incide sulle differenze di tensione che si abbia o meno un catico sulle
spalle.
Le differenze delle tensioni non sono significative; quindi, il conseguente aumento di
ipertrofiae di forza che si registra con Tuso del earico & dovuto al fatto che esso compor-
{a un alfungamento del tempo di tensione necessario per vincere ed accelerare al mass
‘mo la maggiore resistenza, Questo & il vero motivo che giustifica Yuso di carici aggiunti
¥i, quando si vuole ottenere ipertrofia muscolare.
1 carico, perd, in questo caso deve essere molto elevato ¢ lo spostamento veloce, per
quanto consentito dal eatico, in modo da mettere in criti veri effettori della forza (per-
che soltanto cosi si avr una loro risposta «supercompensativan) e non la parte metabol
2, qualora il carico fosse molto basso ¢ le ripetizioni molto numerose. Quanto sopra det-
to & quanto si deve esigere da una ordinata e coerente metodologia rivolta al migliora-
‘mento della forza massima dinamica. Un carico molto basso che venisse spostato molto
velocemente ma poche volte influirebbe pit sulle capacita del sistema nervoso centrale di
éemettere salve di treni di stimoli con pit alta frequenza, per un pit massiccio reclutamen-
teistantaneo di unita motrci
MEZZI E METODI PER L'ALLENAMENTO
DELLE DIVERSE ESPRESSIONI DI FORZA
Resta, ora, da esporre in questo capitolo i mezzi ed i metodi da adottare per il migliora-
81
‘mento delle diverse qualita di forza utilizzate dallo sprinter nella sua prestazione di coma Hf
veloce.
La strategia segue il principio secondo cui i migliorie pit apprezzabili effetti delfallena.
‘mento. si evidenziano quando i suoi elementi costituiscono una combinazione di mezaj
generali e specifici, Sarebbe, perd, pit corretto definili mezzi indiretie diretti, com.
prendendo nei primi quei mezzi che, migliorando le qualit di base, influiscono in mane
ra mediata sulla prestazione, e nei secondi, invece, quei mezzi dellallenamento che, uti-
lizzati in unattvita gestuale riproducente in toto o in parte quella prestativa, la influenza.
no immediatamente.
Un esempio pud servire per faclitare la comprensione: per il miglioramento delle capa.
cit di scatto, un esercizio di piegamento massimo delle gambe (squat) con un sovraccart-
Potrebbero piacerti anche
- Tesina Metodologia AllenamentoDocumento3 pagineTesina Metodologia AllenamentoAndrea BussoneNessuna valutazione finora
- La Forza Rapida Nel Giocatore Di Pallacanestro, Metodi e Test Per La ValutazioneDocumento24 pagineLa Forza Rapida Nel Giocatore Di Pallacanestro, Metodi e Test Per La ValutazioneAlberto BiolchiNessuna valutazione finora
- Lavoro Ulivieri CentrocampistiDocumento22 pagineLavoro Ulivieri CentrocampistiPier Francesco BattistiniNessuna valutazione finora
- Lezione Viscidi 2vs2 (22-6-2011)Documento6 pagineLezione Viscidi 2vs2 (22-6-2011)Pier Francesco BattistiniNessuna valutazione finora
- Presentazione Preparazione MentaleDocumento23 paginePresentazione Preparazione MentalePier Francesco BattistiniNessuna valutazione finora
- Preparazione Atletica c5Documento26 paginePreparazione Atletica c5Fittizio77Nessuna valutazione finora
- La Preparazione Fisica Nel RugbyDocumento12 pagineLa Preparazione Fisica Nel RugbyGiorgio MarrasNessuna valutazione finora
- Lezione 1 Metodologia Corso Preparatore Atletico ProfessionistaDocumento3 pagineLezione 1 Metodologia Corso Preparatore Atletico ProfessionistaAnonymous B8bf28M0oNessuna valutazione finora
- Tappeto Di BoscoDocumento5 pagineTappeto Di Boscoscienze_motorieNessuna valutazione finora
- Preparazioni Seconda CategoriaDocumento14 paginePreparazioni Seconda CategoriaELNA83Nessuna valutazione finora
- Tesi Corsa BiomeccanicaDocumento67 pagineTesi Corsa BiomeccanicaGiacomoCarlucci100% (1)
- Functional Training Summit: Guido BrusciaDocumento19 pagineFunctional Training Summit: Guido BrusciaTeresa CoccoNessuna valutazione finora
- Forza Nel Calcio Perondi Cover CIA NoDocumento82 pagineForza Nel Calcio Perondi Cover CIA NoPier Francesco BattistiniNessuna valutazione finora
- Lezione Terminologia - MOVIMENTO UMANO PDFDocumento68 pagineLezione Terminologia - MOVIMENTO UMANO PDFsteNessuna valutazione finora
- Lezioni AccameDocumento183 pagineLezioni AccamePier Francesco Battistini100% (1)
- CAMBI Di DIREZIONE (xSITO)Documento19 pagineCAMBI Di DIREZIONE (xSITO)luca_leddaNessuna valutazione finora
- Traumi Settore GiovanileDocumento69 pagineTraumi Settore GiovanilePier Francesco Battistini100% (1)
- Prof. Bastianini - La CorsaDocumento84 pagineProf. Bastianini - La CorsaalbertoNessuna valutazione finora
- Tesi - Allenamento e AlimentazioneDocumento67 pagineTesi - Allenamento e AlimentazioneΓιάννης Χατζηκυριακίδης100% (1)
- SDS N°56Documento64 pagineSDS N°56Pierpaolo PolinoNessuna valutazione finora
- Presentazione Sassi Rampinini Convegno Isokinetic 2005 - 0Documento2 paginePresentazione Sassi Rampinini Convegno Isokinetic 2005 - 0patruoxNessuna valutazione finora
- Lezione Viscidi Giochi Di Posizione (30!06!2011)Documento7 pagineLezione Viscidi Giochi Di Posizione (30!06!2011)Pier Francesco Battistini50% (2)
- Schemi Motori e Capacità CoordinativeDocumento8 pagineSchemi Motori e Capacità Coordinativeenrym_88Nessuna valutazione finora
- Tesi MetodologiaDocumento4 pagineTesi Metodologialorenzo100% (1)
- DownloadDocumento103 pagineDownloadIacopoMariaFilippoBarni100% (1)
- Aggiornamenti in RiatletizzazioneDocumento24 pagineAggiornamenti in RiatletizzazioneLuca BevarNessuna valutazione finora
- Match Analysis IIDocumento8 pagineMatch Analysis IIAttilio Sacripanti100% (3)
- Scuola Calcio S.S. Rende: Allenamento Funzionale Della ForzaDocumento18 pagineScuola Calcio S.S. Rende: Allenamento Funzionale Della ForzaalleniamoNessuna valutazione finora
- Metodo Coniugato MistoDocumento11 pagineMetodo Coniugato MistoRaffoNessuna valutazione finora
- Guida Cross Fit PDFDocumento138 pagineGuida Cross Fit PDFClaudio RiberaNessuna valutazione finora
- Match Analysis IDocumento10 pagineMatch Analysis IAttilio Sacripanti100% (7)
- La Prevenzione Degli Infortuni Nel Calcio: Autore Carlo SegattiniDocumento26 pagineLa Prevenzione Degli Infortuni Nel Calcio: Autore Carlo Segattinialleniamo.com100% (1)
- La Corsa Ad Ostacoli (Urss) - Trad Luciano BagoliDocumento36 pagineLa Corsa Ad Ostacoli (Urss) - Trad Luciano Bagoliofficinaatletica100% (1)
- Sandro Bencardino - Allenamento Funzionale Nel BasketDocumento45 pagineSandro Bencardino - Allenamento Funzionale Nel BasketpippoNessuna valutazione finora
- Allenamento Funzionale CalciatoreDocumento37 pagineAllenamento Funzionale CalciatorepatruoxNessuna valutazione finora
- RSA Perondi Allenatori Cover CIA NoDocumento112 pagineRSA Perondi Allenatori Cover CIA NoPier Francesco Battistini100% (1)
- Pallacanestro e StatisticaDocumento12 paginePallacanestro e StatisticaioenopioNessuna valutazione finora
- HIIT Vs Low Impact - 1 - Ossigeno, Cardiofrequenzimetri e ObesitàDocumento17 pagineHIIT Vs Low Impact - 1 - Ossigeno, Cardiofrequenzimetri e ObesitàIronPaolo DangerousFitnessNessuna valutazione finora
- Basket. Forza e DisequilibrioDocumento68 pagineBasket. Forza e DisequilibriomednasrallahNessuna valutazione finora
- Elementi Di Periodizzazione Ed Elaborazione Del Programma Di Allenamento Definitivo 6 DicembreDocumento60 pagineElementi Di Periodizzazione Ed Elaborazione Del Programma Di Allenamento Definitivo 6 Dicembregabriel ungureanuNessuna valutazione finora
- Allenamento Della VelocitàDocumento4 pagineAllenamento Della Velocitàlino85Nessuna valutazione finora
- Lezione Metodologia Dell'allenamento - Nicholas TownsendDocumento35 pagineLezione Metodologia Dell'allenamento - Nicholas TownsendJoseph StewartNessuna valutazione finora
- Presentazione Corso Traino IlcoachDocumento33 paginePresentazione Corso Traino IlcoachCorrado De SimoneNessuna valutazione finora
- Warm Up e RugbyDocumento29 pagineWarm Up e Rugbyaz1985100% (2)
- Original Strength ITADocumento108 pagineOriginal Strength ITAniccolò GradiNessuna valutazione finora
- !!!la Preparazione Di Donadoni A CovercianoDocumento5 pagine!!!la Preparazione Di Donadoni A CovercianoyoutellataleNessuna valutazione finora
- Teoria e Pratica Massaggio Sportivo: Dispensa DidatticaDocumento184 pagineTeoria e Pratica Massaggio Sportivo: Dispensa DidatticaRoberto GeraciNessuna valutazione finora
- Instabilita' Dolorosa Di Spalla (Triennale)Documento63 pagineInstabilita' Dolorosa Di Spalla (Triennale)Giuseppe FoggiaNessuna valutazione finora
- Giangiacomo Contini - Sempre Più VelociDocumento40 pagineGiangiacomo Contini - Sempre Più VelociChristine BrownNessuna valutazione finora
- 160 Febbario PDFDocumento132 pagine160 Febbario PDFanes2016Nessuna valutazione finora
- Valutazione AntropometricaDocumento8 pagineValutazione AntropometricaioannesturrisoricisNessuna valutazione finora
- Tecnica e Tattica Calcistica DEFINITIVADocumento18 pagineTecnica e Tattica Calcistica DEFINITIVASimoneNessuna valutazione finora
- Dal Montreal Track Test Agli Yo-Yo Test - RuspantiniDocumento25 pagineDal Montreal Track Test Agli Yo-Yo Test - RuspantinialexruspNessuna valutazione finora
- Allegati 15122016184447Documento45 pagineAllegati 15122016184447Oum Mohib Boudali100% (1)
- Prevenzione Inf Nel Calcio AIPACDocumento48 paginePrevenzione Inf Nel Calcio AIPACmikk85Nessuna valutazione finora
- TTD Attivita Motoria PreventivaDocumento22 pagineTTD Attivita Motoria PreventivaAntonio PappaleporeNessuna valutazione finora
- 10 603110 0000100201 Mah Civ SHD 000105 - 02Documento1 pagina10 603110 0000100201 Mah Civ SHD 000105 - 02ibrahemomr9993Nessuna valutazione finora
- Tav - p2 - Territorio Comunale in Zto Su Mappa CatastaleDocumento1 paginaTav - p2 - Territorio Comunale in Zto Su Mappa Catastalealessandro pacielloNessuna valutazione finora
- Bonfiglioli CatalogDocumento28 pagineBonfiglioli CatalogDeep RavalNessuna valutazione finora