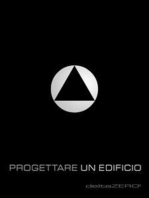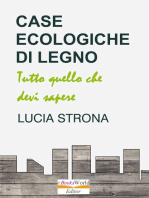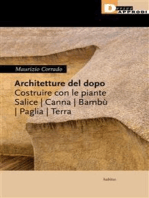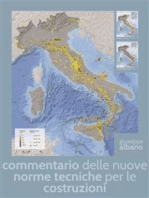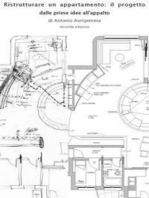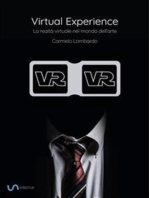Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Architettura e Bioclimati
Caricato da
Serena D'angeloCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Architettura e Bioclimati
Caricato da
Serena D'angeloCopyright:
Formati disponibili
Alessandro Rogora
Architettura e
bioclimatica
Professionisti, tecnici e imprese
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone
Se
sistemi editoriali
AS9
La rappresentazione
dellenergia nel progetto
Estratto della pubblicazione
Dedicato a Teresa, Valentina e Matteo
V
VI
Ringraziamenti
Un grazie sincero a chi mi ha dato fiducia e mi ha spronato a completare questo lavoro.
Tra le innumerevoli persone cui sento di dovere qualcosa mi limiter, per brevit, a
citare il prof. Gianni Scudo e larch. Neri Braulin che hanno indirizzato e sostenuto i
miei sforzi partecipando alla discussione sui contenuti del testo, larch. Claudia Losa
per la realizzazione di gran parte delle immagini e il dott. Giuseppe Rosa per aver
aspettato pazientemente la conclusione del lavoro.
Un ringraziamento particolare va anche ai miei studenti che hanno sperimentato la
difficolt della materia e sono stati, forse inconsapevolmente, i primi, veri giudici del
mio lavoro.
VII
Estratto della pubblicazione
I
n
d
i
c
e
Indice
Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
1 Rappresentazione dellambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Definizione di ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Scala di rappresentazione delle condizioni ambientali . . . . . . . . . . 4
1.3 I dati climatici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 La rappresentazione ascalare
delle condizioni ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1 Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Irraggiamento solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3 Illuminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4 Vento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3 Localizzazione delle rappresentazioni ascalari
e rappresentazioni a scala urbanistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1 Le emergenze ambientali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2 Sole/ombra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3 Illuminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.4 Vento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4 Rappresentazione a scala edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.1 Tecniche grafiche di rappresentazione dei flussi . . . . . . . . . . . . . 79
4.2 Regole di funzionamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.3 Indicazioni per il predimensionamento
dei sistemi naturali di controllo ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4 Andamento delle condizioni termiche in un ambiente confinato. . . . 94
4.5 Andamento delle condizioni di illuminazione
in un ambiente confinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
IX
Estratto della pubblicazione
X
5 Tecniche di simulazione energetica mediante modelli . . . . . . . . 107
5.1 Costruzione di modelli fisici per lanalisi
del funzionamento ambientale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.2 Strumenti per lanalisi del soleggiamento. Heliodon . . . . . . . . . . 111
5.3 Strumenti per lanalisi dellilluminazione naturale. CieloArtificiale. . . 113
5.4 Introduzione ai metodi informatici di simulazione . . . . . . . . . . . 117
6 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Estratto della pubblicazione
P
r
e
f
a
z
i
o
n
e
Prefazione
di Gianni Scudo
Un aspetto importante della crisi dellarchitettura moderna la carenza di controllo
dei caratteri ambientali in fase di progetto, di costruzione e di uso dellambiente
costruito.
Per caratteri ambientali si intende un insieme di aspetti che riguardano da un lato le
prestazioni ambientali dellarchitettura in rapporto alle esigenze umane di benesse-
re multisensoriale (lo star bene connesso al caldo, freddo, alla luce, al suono ecc.) e
dallaltro le prestazioni ambientali dei processi costruttivi, cio il come si risponde alle
esigenze con un uso delle risorse culturali, materiali ed energetiche che abbiano un
livello elevato di sostenibilit cio il minimo impatto ambientale a livello locale e
globale.
Tutti gli insediamenti antichi, moderni e contemporanei sono stati e sono in diversa
misura insostenibili, perch sono sistemi termodinamici aperti di tipo dissipativo. Tut-
tavia lo sviluppo recente (degli ultimi 60 anni) ha fortemente accentuato la insosteni-
bilit ambientale determinando un aumento a forbice degli squilibri nel Sud e nel
Nord e tra Sud e Nord del mondo (limpronta ecologica un indicatore quantitativo
sintetico dinsostenibilit ambientale degli USA circa doppia di quella dellUE, che
ha sua volta quasi tripla della media mondiale dei Paesi in via di sviluppo).
I movimenti ecologici europei e mondiali hanno elaborato strategie a diversa scala,
che, partendo dalla critica dei limiti sociali e ambientali del modello di sviluppo e degli
stili di vita dominanti a elevato spreco e inquinamento, hanno innescato pratiche
alternative sostenibili pi o meno radicali, basate sulla logica ecosistemica dellinte-
grazione duso di tutte le risorse inclusi gli scarti (dai progetti pionieri ZERI di G. Pauli,
alle comunit che vivono di rifiuti urbani, al modello Curitiba o Brema, allecologia
industriale...)
La sostenibilit dellambiente costruito si sta sviluppando a livello di movimenti e isti-
tuzioni; anche se non sempre la logica pioniera dei movimenti si traduce in politiche
istituzionali, importante che la dialettica tra sperimentazione e istituzione permetta
la crescita di utopie concrete che costituiscono i mattoni dei progetti di sostenibilit
locale.
Questa sfida molto importante investe direttamente il ruolo e lattivit degli architetti
e la loro formazione, processo che richiede un impegno innovativo di revisione delle
logiche, degli strumenti e delle azioni progettuali. La sostenibilit riguarda struttural-
mente la dinamica morfologica o morfogenesi. Le forme in natura sono il prodotto di
tempi lunghi di evoluzione e selezione e si formano attraverso un processo di interfac-
cia con lambiente con il quale scambiano materia ed energia necessarie alla loro cre-
XI
Estratto della pubblicazione
P
r
e
f
a
z
i
o
n
e
XII
scita che a sua volta plasma lambiente circostante. Anche le forme dellarchitettura
sono prodotte da un processo analogo reso pi complesso dalle esigenze culturali
delle societ umane. Alcune societ umane hanno costruito insediamenti che hanno
utilizzato e stanno utilizzando a scala globale le risorse materiali ed energetiche in
modo socialmente e ambientalmente molto rischioso.
Ecco perch gli aspetti di morfologia, di selezione e uso dei materiali e dellenergia
sono aspetti cruciali nel progetto di sostenibilit.
sempre pi necessario prevedere con cura lenergia consumata nei processi di pro-
duzione, trasporto e assemblaggio in cantiere, le prestazioni energetiche, lenergia
necessaria per luso, la manutenzione, e per le potenzialit di riuso e riciclaggio, oltre
naturalmente lutilizzo di fonti rinnovabili (sole, vento, calore ambientale) per raffre-
scare, riscaldare, ventilare, illluminare naturalmente, produrre e accumulare energia
elettrica.
Gli strumenti classici dellarchitettura sono orientati essenzialmente al controllo dei
caratteri distributivi, struttural tecnologici e stilistici o di linguaggio (le utilitas, fir-
mitas e venustas vitruviane) che attengono essenzialmente allo spazio e molto
meno ai caratteri ambientali intesi nel senso sopra descritto che investono la dimen-
sione del tempo (cicli giornalieri e stagionali del sole e del vento, tempi di rinnovabilit
delle risorse ecc.)
Lintegrazione quindi dei contenuti e degli strumenti che riguardano lapproccio
ambientale al progetto di architettura ha dei vincoli di carattere teorico.
Gran parte derivano dal carattere autoreferenziale di molti approcci alla progettazio-
ne che tendono a considerare i caratteri ambientali (e gli strumenti in grado di con-
trollarli) non come parte integrante del progetto, ma come un contributo di tipo spe-
cialistico: per esempio, lapproccio bioclimatico viene risolto con interventi general-
mente a valle del progetto iniziale come fanno i consulenti delle strutture e degli
impianti ai quali si richiede o di modificare il meno possibile la configurazione del pro-
getto o, al contrario, di esaltarne alcuni caratteri (lesibizione muscolare della
struttura, degli impianti ecc.)
I caratteri ambientali non si con-fondono nel complesso degli altri caratteri architetto-
nici in una struttura organica, ma si tende a utilizzarli per il loro carattere espressivo
attraverso la sensazionalit dellinnovazione tecnologica, essenzialmente per far
meraviglia.
Esiste invece una tendenza, in particolare nel contesto centro nord europeo, a inte-
grare le tematiche della sostenibilit nella progettazione architettonica radicata nei
luoghi, nei contesti fisici e climatici e caratterizzata da una grande differenziazione
regionale. Larchitettura dello spazio pubblico, degli spazi di transizione, delle abitazio-
ni e dei servizi, insomma di tutto il tessuto connettivo che costituisce la base del pro-
getto di sostenibilit ambientale e sociale la struttura che metabolizza e dissipa
attraverso forme, materiali, sistemi di mobilit e impianti dal 60 al 70% delle risorse
Estratto della pubblicazione
P
r
e
f
a
z
i
o
n
e
materiali ed energetiche. quindi in questo ambito che bisogna concentrare gli
interventi per riequilibrare e rendere vivibile lambiente nel quale viviamo.
In questo campo della formazione, il controllo dei caratteri ambientali nel progetto di
architettura riveste un ruolo essenziale e spesso sottovalutato, come dimostrano le
empasse dei piani di sostenibilit urbana che non entrano quasi mai nel merito di
come e quanto la morfologia dellambiente costruito determini differenti modelli
duso delle risorse.
Il contributo di Rogora si muove nellalveo dellelaborazione di strumenti per il dimen-
sionamento dei caratteri ambientali nel progetto di architettura, aggiornando una
serie di contributi esistenti ed elaborandone alcuni di originali.
Uno degli aspetti pi interessanti di aver focalizzato linteresse su strumenti che per-
mettono di fare previsioni di prestazioni ambientali (caldo, freddo, luce ecc.) nelle pri-
me fasi della progettazione, quando cio linsieme di vincoli e risorse comincia a con-
formarsi con decisioni che riguardano la morfologia e lorientamento degli edifici e
dello spazio aperto, la distribuzione degli spazi interni, il tipo di struttura, le tecnologia
e materiali dellinvolucro.
Linterazione tra il campo dei flussi ambientali del sito e le scelte progettuali determi-
nano fin dallinizio le modifiche di microclima allesterno e allinterno degli spazi e i
metodi semplificati eleborati da Rogora permettono di simulare in modo approssima-
to, ma coerente con il processo di progettazione, le prestazioni relative alla disponibili-
t di radiazione, di vento, allandamento delle condizioni termiche e dilluminazione
naturale in un ambiente confinato.
Un apporto interessante relativo alle tecniche grafiche di rappresentazione dei flussi
ambientali che permettono di disegnare le logiche generali di funzionamento
ambientale degli interscambi tra organismo edilizio e campo delle forze ambientali
che sono essenzialmente temporali e quindi sfuggono ai tradizionali strumenti della
progettazione.
Il progetto dellarchitettura sostenibile si struttura infatti intorno alle fluttuazioni delle
risorse ambientali (ritmi del sole, del vento, della rinnovabilit delle risorse materiali
ecc.) e in questo campo non esiste una tradizione di notazione. Lautore riuscito a
elaborare un sistema di rappresentazione efficace e coerente che include i principali
flussi e i fenomeni fisici coinvolti nelle trasformazioni. Costituisce quindi un contributo
non marginale allelaborazione della rappresentazione grafica dei complessi fenome-
ni spazio-temporali connessi con la previsione dellinterazione forma/tecniche e forze
ambientali nel progetto di architettura.
XIII
Estratto della pubblicazione
I
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
Introduzione
Quando incominciai a operare nel campo della cosiddetta progettazione bioclimatica,
architettura energeticamente consapevole o architettura solare passiva, uno dei prin-
cipali problemi che mi si present fu come introdurre i concetti energetici nel proces-
so di progettazione, ovvero come rendere compatibili queste informazioni con gli
strumenti del progetto.
Come studente prima, ma successivamente anche come professionista e insegnante,
ho trovato grandissime difficolt nel dare una rappresentazione dei flussi energetici
nellambiente e della loro variazione allinterno del progetto. Daltra parte rappresen-
tare significa conoscere e permette di spostare il problema del rapporto tra energia e
architettura dal piano dellottimizzazione di una condizione specifica (tipica della pro-
fessione dellingegnere) a quello della progettazione di una condizione adeguata (pi
vicina allapproccio dellarchitetto).
Paradossalmente fino ai primi anni Ottanta (in particolare nel ventennio Sessanta
Ottanta), pur non essendo disponibili sofisticati strumenti di rappresentazione come
quelli odierni (software di rappresentazione e animazione tridimensionale, realt vir-
tuale ecc.), vi stata una significativa produzione di metodi semplificati di analisi e
rappresentazione delle condizioni ambientali. Negli ultimi ventanni linteresse per la
rappresentazione grafica dei fenomeni energetici (specialmente nelle fasi di pre-pro-
gettazione) invece andata spegnendosi a favore di una rappresentazione
oggettuale sempre pi sofisticata.
A tuttoggi in Italia vi carenza di testi operativi e professionali di introduzione alla
progettazione bioclimatica, probabilmente anche in ragione del ridotto numero di
realizzazioni bioclimatiche significative nel nostro Paese e alla scarsit di progettisti
disposti a sperimentare nella loro professione questo approccio.
Questo libro vuole essere un piccolo contributo in questa direzione, raccontando la
mia personale esperienza di progettista, consulente e ricercatore su questi temi.
Il testo strutturato in 3 sezioni distinte che si propongono di: fornire un inquadra-
mento teorico dei diversi temi; mostrare le soluzioni operative dei problemi esposti
teoricamente ripercorrendo, quando possibile, progetti e realizzazione che ho potuto
seguire direttamente; fornire gli strumenti operativi di lavoro, sotto forma di allegati,
utilizzabili per compiere le analisi (sw, file ecc.).
Le modalit di rappresentazione ambientale per il progetto descritte in questo libro
abbracciano un ambito molto diverso e per certi versi pi ampio di quello a cui il pro-
gettista abituato.
Normalmente la rappresentazione dellambiente si limita a una descrizione oggettua-
XV
I
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
XVI
le della realt ottenuta attraverso immagini fotografiche e schizzi, oppure a una descri-
zione codificata che traduce la realt in un linguaggio convenzionale quale il dise-
gno tecnico. Si hanno cos rappresentazioni planimetriche, sezioni, fronti, spaccati,
assonometrie, e quantaltro la topografia e la geometria descrittiva ci mettono a
disposizione.
Ogni epoca ha utilizzato strumenti di rappresentazione conformi alle proprie necessi-
t e al proprio tempo legando, per certi versi, tecniche di rappresentazione e
produzione architettonica.
Strumenti considerati obsoleti o poco duttili, rispetto ad altri apparentemente molto
pi efficienti, possono per risultare molto efficaci se osservati con maggiore attenzio-
ne. Prendiamo lesempio dei software di videoscrittura che hanno finalmente liberato
le segretarie dalluso del bianchetto e della carta copiativa e che hanno permesso di
operare continue correzioni che non richiedevano lintera riscrittura del testo ma solo
poche variazioni a video, oppure le potenzialit della posta elettronica che annulla le
distanze e azzera i tempi... come pensare che la vecchia stilografica e le lunghe opera-
zioni postali possano dare qualcosa in pi o di diverso di quel che si pu avere con lu-
so di questi mezzi? Eppure come pu essere trasferito nel testo a video il tratto prodot-
to dalla penna che si modifica con lumore riuscendo a diventare spigoloso per la rab-
bia, tremolante per leccitazione o insicuro per la paura? Le stesse correzioni, difficili da
nascondere tra le righe del testo, sono in un certo modo parte della comunicazione
che nessun computer riuscir tanto facilmente a sostituire nemmeno quando diven-
ter versatile e portatile come i palmari da taschino. Cosa dire poi della lettera cartacea
affidata alle mani del postino, il ruolo e il valore del tempo, lattesa della risposta e il
rischio di dimenticare qualcosa nel messaggio che avrebbe richiesto di nuovo le
complesse operazioni postali e la relativa, lunga attesa.
La sola descrizione dei caratteri dimensionali e materiali degli edifici non appare oggi
completamente soddisfacente per il progettista. Se pensiamo che la conoscenza e il
controllo dei fenomeni energetici debbano essere parte integrante del bagaglio cul-
turale e della professione dellarchitetto, occorre indagare metodi e tecniche di rap-
presentazione capaci di descrivere questi fenomeni in modo che risultino utilizzabili
nel processo di progettazione e lo modifichino in modo da migliorarne i risultati.
Figura 1 Esempio di uno scritto con annotazioni.
Estratto della pubblicazione
I
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
Questo testo cerca di introdurre alcune modalit di descrizione/rappresentazione del-
lenergia (calore, luce e pressione acustica) nella progettazione architettonica.
Si cercato, per quanto possibile, di ordinare gli strumenti di analisi e rappresentazio-
ne ambientale dellenergia secondo una sequenza tipo che riprende le operazioni
seguite da un progettista nel proprio lavoro. Pur riferendosi sempre alla fase iniziale
della progettazione (e quindi trattando solo superficialmente la fase di approfondi-
mento), gli strumenti descritti vanno dai pi generali a quelli pi specifici. In ogni sin-
gola situazione star quindi al progettista scegliere quali strumenti utilizzare e quali
non considerare perch inadatti alle proprie necessit.
Il testo cerca di descrivere gli effetti che hanno le variazioni delle condizioni ambienta-
li sul progetto dellambiente costruito secondo un approccio che non cerchi di ottene-
re poche informazioni assolutamente precise ma quante pi informazioni possibili per
formarsi un quadro verosimile e probabile, quindi utile ai fini progettuali. In questottica
preferibile descrivere in maniera meno sofisticata un fenomeno complesso (anche
introducendo delle semplificazioni grossolane, purch sensate), piuttosto che non
descriverlo affatto a causa della sua complessit.
Per il progettista un sistema di analisi preciso ma farraginoso, lungo da utilizzare e che
richieda dati molto specifici, risulta assolutamente inutile nelle fasi iniziali e pi creati-
ve del proprio lavoro perch non commisurato al tipo di definizione che il progetto
XVII
Figura 2 Sezione di Casa Serra a Barcellona. Sovrapposto al disegno architettonico rappresentata la
relazione delledificio alla radiazione solare diretta.
Estratto della pubblicazione
I
n
t
r
o
d
u
z
i
o
n
e
XVIII
ha in questa fase. Daltra parte esistono molti esempi di valutazione delle condizioni
ambientali, anche abbastanza precisi, ottenuti dando indicazioni di tipo qualitativo e
parametrico degli elementi di involucro.
I capitoli che seguono introducono alcuni metodi di analisi e rappresentazione del-
lambiente congruenti con le fasi iniziali del processo di progettazione che permetto-
no di ottenere informazioni utili per definire limpianto progettuale.
Figura 3 Esempio di rappresentazione della luce in un ambiente secondo la visione del progettista.
Figura 4 Esempio di schermata del software CLArelativa ai diversi gradi di isolamento dellinvolucro.
R
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
m
b
i
e
n
t
e
1 Rappresentazione dellambiente
1.1 Definizione di ambiente
La definizione di ambiente pu riferirsi a molteplici ambiti, in questo caso si intende
limitarla ai parametri fisici che contribuiscono a definire la sensazione termica, lumi-
nosa e acustica, ovvero: luce, radiazione, calore, umidit, vento e rumore. Di questi ele-
menti possibile dare una semplice descrizione fisica (condizioni puntuali specifiche
di ognuno dei parametri considerati), eventualmente legandola a un andamento tem-
porale (variazione nel tempo giorno, ora, mese del valore di ogni parametro), oppu-
re tentare di dare anche una lettura spaziale indicandone, se possibile, gli effetti siner-
gici (comfort termico, luminoso, acustico). Questa seconda posizione certamente pi
interessante per la progettazione degli ambienti, anche se si presenta pi complessa
nellanalisi e meno ricca di strumenti di rappresentazione codificati e oggettivi.
Unulteriore annotazione riguarda la variabilit degli effetti che un insieme di stimoli
fisici pu produrre in soggetti diversi, fatto che rende difficile (qualcuno sostiene addi-
rittura impossibile) darne una rappresentazione utile e obiettiva.
1
Figura 1.1 Andamento delle condizioni termiche (variazione del budget energetico) in una piazza di
Milano.
Estratto della pubblicazione
D
e
f
i
n
i
z
i
o
n
e
d
i
a
m
b
i
e
n
t
e
2
Personalmente credo che la rappresentazione delle condizioni energetiche nellam-
biente sebbene semplificata e approssimata e la descrizione della loro variazione
spazio/temporale, possa essere di fondamentale aiuto al progettista nel prendere
decisioni consapevoli e congruenti con landamento delle forze della natura.
Si tratta naturalmente di iniziare a indagare nuovi sistemi di rappresentazione (in mol-
ti casi semplicemente di riscoprirli) accettando sia la fatica che questo approccio
richiede, sia le conseguenze e i limiti che esso comporta. Infatti come sarebbe possibi-
le esplicitare delle tendenze o dei conflitti tra natura e artificio senza cercare di
risolverli una volta descritti?
Probabilmente molta della resistenza che alcuni architetti hanno nellaccettare qual-
siasi strumento di valutazione che limiti o indirizzi il loro atto creativo da ascrivere al-
lidea di superiorit dellatto progettuale (appunto creativo) che deve permanere libe-
ro da ogni vincolo e ogni possibile valutazione impedendo, tra laltro, qualsiasi compa-
razione e valutazione di qualit del prodotto finale.
Oltre a questa possibilit di valutazione sarebbe anche interessante individuare ed
esplicitare la capacit perturbante che le diverse scelte di progetto hanno sulle condi-
zioni locali per permettere al progettista di comprendere come, quando e quanto
abbiano pesato specifiche scelte sul comportamento ambientale del progetto. Descri-
vere limportanza della messa a dimora di unessenza vegetale, della scelta di un mate-
riale di rivestimento o del tipo di pavimentazione (ma anche la costruzione di un
Figura 1.2 La finestra mediterranea un elemento dellarchitettura che pu funzionare come barriera o
connessione a flussi energetici diversi.
Estratto della pubblicazione
R
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
m
b
i
e
n
t
e
muro, lapertura di una breccia, la chiusura di una porta ecc.), permetterebbe di sapere
come e quanto ogni azione modifichi le condizioni locali specifiche.
Purtroppo questo problema assai distante dalla soluzione; credo comunque che
ogni piccolo passo compiuto in questa direzione sia un buon passo.
3
Figura 1.3 Villa Capra (Palladio 1567), Casa Studio (Le Corbusier 1922).
Figura 1.4 Modifica locale del pattern del vento in presenza di un ostacolo.
S
c
a
l
a
d
i
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
a
m
b
i
e
n
t
a
l
i
4
1.2 Scala di rappresentazione delle condizioni ambientali
In molti casi la rappresentazione delle condizioni ambientali di tipo ascalare e
aspaziale (un valore o un insieme di valori), anche se a ogni scala grafica corrisponde,
normalmente, la possibilit di esprimere meglio e pi convenientemente, informa-
zioni diverse relative ai flussi e ai livelli energetici.
Alcune informazioni sono valide per porzioni ampie di territorio (oppure sono insen-
sibili alle variazioni locali), altre hanno un valore generale ma possono essere modifi-
cate in relazione allintorno specifico.
Certe analisi e rappresentazioni ambientali hanno significato unicamente a scala
micro-urbanistica, altre ancora a scala edilizia mentre alcune sono significative solo a
scala di dettaglio.
Lesperienza insegna che gli strumenti di aiuto alla progettazione, generalmente pi
efficaci, sono quelli che hanno una rappresentazione congruente con i disegni di pro-
getto (planimetrie, piante e sezioni) e sono quindi pi immediatamente comprensibili
dagli operatori. Tra laltro questo tipo di rappresentazione pi immediata e general-
mente meglio accettata perch non richiede codici interpretativi molto diversi da
quelli classici. Purtroppo non sempre possibile arrivare a rappresentazioni compati-
bili con gli usuali codici di rappresentazione e diviene quindi necessario provvedere
anche in maniera diversa.
Nei capitoli seguenti vengono definiti alcuni strumenti di rappresentazione alle diver-
se scale indicando obiettivi, modalit, limiti e vincoli al loro utilizzo.
Figura 1.5 Temperature dellaria, medie, minime e massime rilevate a Milano nei diversi mesi dellanno.
Estratto della pubblicazione
R
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
m
b
i
e
n
t
e
1.3 I dati climatici
InItalia esiste una rete ampia e diffusa di stazioni di rilevamentodei dati climatici che fan-
no per capo a organismi diversi spesso senza alcun coordinamento tra di loro.
Le stazioni di rilevamento pi note sono quelle dellAeronautica Militare (Servizio
Meteorologico dellAeronautica Militare) che registrano dati di temperatura, umidit,
radiazione e velocit del vento. Oltre allAeronautica Militare si occupano del rileva-
mento dei dati: il Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici, lUfficio Centra-
le di Meteorologia del Ministero dellAgricoltura, le Agenzie Regionali per la Protezio-
ne dellAmbiente (ARPA), alcune ASL, Universit, centri di ricerca, le comunit montane,
i circoli sportivi (vela, canoa, tiro ecc.), gli osservatori astronomici, diverse associazioni
ma anche privati cittadini. Molti di questi soggetti utilizzano procedure standard di
rilevamento dei dati e li elaborano offrendo valori precisi e statistiche dettagliate, altri
forniscono informazioni frammentarie e incomplete, sia a causa del tipo di strumenta-
zione utilizzata che per limpossibilit di elaborare i dati (registrati solo su supporto
cartaceo) con il risultato di avere uninformazione diffusa ma difficile da reperire e
spesso scarsamente utilizzabile.
5
Figura 1.6 Indicazioni delle stazioni di rilevamento riportate in dati climatici per la progettazione edile
e impiantistica, (CNR).
I
d
a
t
i
c
l
i
m
a
t
i
c
i
6
Unaltra fonte da cui attingere i dati climatici, relativi a una specifica localit, sono le
norme e i testi che, in modo diverso, si sono interessati di climatologia. Le fonti pi
conosciute e facilmente reperibili sono: la norma UNI 10349 (Dati climatici), che riporta
i dati relativi a 101 capoluoghi di provincia, e il testo Dati climatici per la progettazione
edile e impiantisticaedito dal CNR nel 1982 e, recentemente il software Meteonorm
1
.
Resta il fatto che generalmente i dati climatici hanno formati differenti nelle diverse
pubblicazioni e, quandanche vengano resi omogenei nelle unit di misura, spesso i
valori per la medesima localit differiscono da una fonte allaltra. I motivi di questa
discrepanza possono dipendere dalla differente epoca di rilevamento ed elaborazio-
ne, dal luogo specifico di rilevamento, dal tipo di strumentazione utilizzata per il rileva-
mento ma anche dai diversi obiettivi per i quali sono stati elaborati. Nel nostro caso lo-
biettivo non di tipo normativo e quindi cercheremo di utilizzare i dati pi verosimili
che non sono necessariamente quelli indicati dalla normativa.
Figura 1.7 Suddivisione dellItalia per zone climatiche (fonte Aeronautica Militare).
1
Alcuni dati (relativi alla norma UNI, alla pubblicazione del CNR appena citata o comunque provenienti da altre sta-
zioni di rilevamento presenti sul territorio) sono riportati in allegato su supporto magnetico (vedere gli allegati per la
lista completa).
Estratto della pubblicazione
R
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
d
e
l
l
a
m
b
i
e
n
t
e
In tutto il testo la descrizione dei colori segue una specifica convenzione. Il blu signi-
fica freddo, lazzurro fresco, il verde comfort (o comunque il valore intermedio tra
freddo e caldo), larancione tiepido e il rosso caldo. Quando necessaria una maggio-
re definizione delle condizioni termiche, e sono quindi necessari 7 valori, vengono
utilizzati il giallo e il turchese rispettivamente per indicare le condizioni di leggero
7
Figura 1.8 Suddivisione dellItalia per zone climatiche (fonte UE ricerca Archisun).
Figura 1.9 Grado di trasparenza dellinvolucro di un edificio contemporaneo.
Estratto della pubblicazione
I
d
a
t
i
c
l
i
m
a
t
i
c
i
8
caldo e leggero freddo a ridosso del comfort (le immagini a colori sono riportate nel
CD allegato).
Esperienze compiute da molti ricercatori (Serra, Zld, Rogora ecc.) dimostrano che lin-
dicazione di un valore scelto tra un numero ridotto di opzioni risulta pi significativo e
meno fuorviante dellindicazione o della richiesta di un valore numerico preciso. Lin-
dicazione qualitativa del valore (alto-basso) particolarmente adatta alle fasi iniziali
del progetto in cui molte scelte non sono ancora completamente definite ma solo
abbozzate. Restringendo la scelta a 5 valori la precisione dellinformazione non risulta
molto inferiore a quella ottenuta indicando valori numerici e garantisce una comuni-
cazione migliore anche con persone poco ferrate nello specifico settore
tecnico/disciplinare.
Estratto della pubblicazione
L
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
a
s
c
a
l
a
r
e
d
e
l
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
a
m
b
i
e
n
t
a
l
i
2 La rappresentazione ascalare
delle condizioni ambientali
2.1 Temperatura
In un determinato luogo la temperatura dellaria varia nel tempo seguendo un regime
giornaliero e un regime stagionale. Nel nostro emisfero le temperature minime annua-
li si registrano, normalmente, nel mese di gennaio mentre i valori massimi di tempera-
tura si rilevano nel mese di luglio.
Allinterno di una giornata tipo le temperature pi basse si registrano di notte (verso le
3 del mattino in estate e verso le 6 in inverno), mentre i valori massimi si rilevano nel
pomeriggio (verso le ore 14 in inverno e verso le 16 in estate).
Conoscendo le temperature minime e massime e lora in cui si registrano questi valori
possibile ricostruire la variazione oraria (media) delle temperature che ha un anda-
mento sinusoidale secondo la relazione:
t = t +t sin
(h-
12
+t sin
(h- )
12
h m 1 2
)
Dove:
h = ora del giorno
= (h
max
+ h
min
)/2
t
2
= t
m
/ [2* (sinB-2cosB * tan (B/2))]
t
1
= 2*t
2
*cosB/cos (B/2)
B = (h
max
-h
min
)/12
Naturalmente la variazione reale della temperatura in un certo giorno ha un andamen-
to imprevedibile dovuto alle mutazioni improvvise dei fattori metereologici. Landa-
mento medio dei valori di temperatura in un periodo di tempo abbastanza lungo
segue per le variazioni appena descritte.
Le temperature medie nei mesi estremi e lescursione termica media mensile (diffe-
renza tra il valore massimo e il valore minimo di temperatura) sono informazioni signi-
ficative perch descrivono sinteticamente le condizioni climatiche a cui ledificio deve
far fronte in un determinato luogo.
In citt la temperatura dellaria si modifica rispetto al regime termico misurato in un
ambiente rurale dando origine alla cosiddetta isola di calore. possibile stimare la dif-
ferenza massima di temperatura tra citt e campagna t
max
in un giorno sereno utiliz-
zando la seguente correlazione empirica basata su dati rilevati in citt europee:
9
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
10
t
max
= 2,01*log P 4,06
dove:
P = popolazione del nucleo urbano
Temperatura dellaria e sensazione termica sono parametri correlati ma non variano
allo stesso modo. La temperatura un parametro fisico misurabile strumentalmente in
maniera oggettiva mentre la sensazione termica dipende anche da altri fattori sia di
tipo fisico che di tipo fisiologico e psicologico.
possibile definire il parametro Temperatura equivalente che indica la temperatura a
cui sembra essere lambiente in cui ci troviamo. Questa sensazione termica equivalente
dipende dalla temperatura dellaria, dalla temperatura radiante, dallumidit e dalla
velocit dellaria. Una valutazione semplificata della Temperatura equivalente (To),
valida per condizioni invernali in ambienti confinati, data dallespressione:
To=
(Ta+ Tmr)
2
dove:
Ta = Temperatura dellaria a bulbo secco;
Tmr = Temperatura media radiante.
Se si vuole considerare anche il periodo estivo e le condizioni negli ambienti esterni
occorre invece utilizzare equazioni pi complesse (Serra 1997).
Occorre comunque ricordare che la temperatura giudicata come ottimale (tn) da un
soggetto non fissa ma dipende dalle condizioni ambientali in cui si trova. Per un sog-
getto abituato a vivere in ambienti senza riscaldamento il valore di tn vale:
Figura 2.1 Variazione delle temperature nel giorno medio dei mesi di gennaio e luglio a Milano Linate.
L
a
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
z
i
o
n
e
a
s
c
a
l
a
r
e
d
e
l
l
e
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
a
m
b
i
e
n
t
a
l
i
tn = 0,53 tm + 11,9
dove:
tm = valore medio della temperatura ambiente.
In inverno con temperatura media dellaria esterna = 2 C, tn vale 12,96 C mentre in
estate con temperatura di 20 C, tn vale 22,5 C.
Un altro indice delle condizioni termiche di una localit sono i Gradi Giorno (GG). I gra-
di giorno (GG) definiscono lintensit del periodo freddo in un determinato luogo in
termini di differenza di temperatura e durata.
I GG si calcolano con la formula:
GC= (t - t )
b
1
n
c
dove:
t
b
= temperatura di riferimento ritenuta adeguata calcolata tenendo presente che
un edificio non riscaldato registra una temperatura media superiore di circa 3 C
rispetto alla temperatura media esterna;
T
e
= temperatura media esterna.
Cambiando il valore della temperatura di base cambia, ovviamente, il valore dei GG
per la localit.
Lespressione 2000 GG su base 16 C significa che il calcolo dei GG stato eseguito
ponendo t
b
= 16 C. Ammettendo temperature dellaria inferiori (per esempio aumen-
tando leggermente le temperature medie radianti degli ambienti), i gradi giorno e
quindi i fabbisogni energetici diminuiscono.
Adifferenza della temperatura dellaria esterna la temperatura del terreno si mantiene
molto pi stabile. Maggiore la profondit a cui viene rilevata la temperatura, minori
sono le sue variazioni nellarco dellanno. La variazione annua della temperatura a una
determinata profondit segue un andamento sinusoidale con valori correlati a quelli
della temperatura esterna; dipende dal tipo di terreno, dalla temperatura media annua
e dallescursione media annuale secondo la formula di Hadvig.
Assumendo una diffusivit del terreno media pari a 10
-6
m
2
/s, considerando il periodo
di un anno ed esprimendo la formula si ottiene:
T (h, t) = T
a
+ A e
-0,316h
cos [0,0172 (t-t
max
) -0,316h]
dove:
T (h, t) = temperatura del sottosuolo alla profondit h e allistante t;
T
a
= temperatura media annua dellaria esterna;
A = escursione termica annua.
Negli allegati riportato un foglio di calcolo per la stima dellandamento orario della
11
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
12
temperatura dellaria esterna e per la valutazione della temperatura del terreno a
diverse profondit.
2.1.1 Le termoisoplete
Un interessante modo per descrivere landamento della temperatura in una determi-
nata localit quello di rappresentarne la variazione oraria media nei diversi mesi.
Inserendo questi dati in un diagramma cartesiano si ottengono le termoisoplete,
ovvero delle linee che rappresentano il luogo dei punti in cui si hanno le medesime
condizioni di temperatura dellaria.
Se si sceglie un intervallo abbastanza contenuto (1 o al massimo 2 gradi) le aree com-
prese tra linee di eguale temperatura rappresentano periodi di tempo con condizioni
termiche stabili e definite. Colorando opportunamente ognuna di queste fasce di
temperatura (con la convenzione indicata nel par. 1.3) si ottiene una mappa delle con-
dizioni termiche orarie del sito di progetto utile per ragionare sullorganizzazione
delle attivit negli spazi aperti e in quelli confinati.
In figura 2.3 rappresentato il diagramma delle termoisoplete relativo alla localit di
Milano Linate.
Come gi detto occorre ricordare che la sensazione termica dipende anche da fattori
non fisici (culturali, fisiologici e psicologici). possibile definire un adattamento medio
alle condizioni climatiche, in termini di sensazione modificata rispetto agli stimoli ter-
mici (ma anche in termini di modifica del vestiario nelle diverse stagioni) che
riportato nella figura 2.4.
Se invece delle semplici temperature dellaria i valori di temperatura venissero pesati
rispetto agli altri parametri del comfort (umidit, velocit dellaria e adattamento alle
Figura2.2 Temperaturamediadellariaesternaetemperaturamediadel terrenoadiverseprofonditSerre(SA).
Estratto della pubblicazione
Potrebbero piacerti anche
- Architettura SenzaDocumento79 pagineArchitettura SenzaYuriClark89Nessuna valutazione finora
- Raccolta Progetti Architettura EcosostenibileDocumento24 pagineRaccolta Progetti Architettura EcosostenibilenucciafontanaNessuna valutazione finora
- Climatizzazione di edifici con pompe di calore geotermiche. Analisi termodinamica ed economicaDa EverandClimatizzazione di edifici con pompe di calore geotermiche. Analisi termodinamica ed economicaValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Materiali EdiliDocumento88 pagineMateriali EdiliAnnaLisa ManiconeNessuna valutazione finora
- BioarchitetturaDocumento11 pagineBioarchitetturaVeronica De StefaniNessuna valutazione finora
- Schede Architettura SostenibileDocumento88 pagineSchede Architettura SostenibileFrancesco FulviNessuna valutazione finora
- Architettura OrganicaDocumento5 pagineArchitettura OrganicaJosephine MinichiniNessuna valutazione finora
- Zibaldone Di Architetture - PraticaDocumento55 pagineZibaldone Di Architetture - PraticaFrancesco FulviNessuna valutazione finora
- Elementi Della Progettazione ArchitettonicaDocumento51 pagineElementi Della Progettazione ArchitettonicaCindy Jennifer Valle MercedesNessuna valutazione finora
- ScaleDocumento24 pagineScaleFrancesca de GobbiNessuna valutazione finora
- Guida Esame Abilitazione ArchitettoDocumento10 pagineGuida Esame Abilitazione Architettomaximdanciu206Nessuna valutazione finora
- Facciate Ventilate - 3551Documento94 pagineFacciate Ventilate - 3551Marco FormichiNessuna valutazione finora
- Architettura TecnicaDocumento10 pagineArchitettura TecnicaGenny PherNessuna valutazione finora
- MANCOSU - Schede ManualiDocumento7 pagineMANCOSU - Schede ManualiBowmancadNessuna valutazione finora
- Case Ecologiche di Paglia. Tutto quello che devi sapereDa EverandCase Ecologiche di Paglia. Tutto quello che devi sapereValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (3)
- Esame Di Stato Architetti AversaDocumento112 pagineEsame Di Stato Architetti Aversasil83% (6)
- Prontuario-Estratto: LIMITI PROFESSIONALI DELLA FIGURA DELL'ARCHITETTODocumento6 pagineProntuario-Estratto: LIMITI PROFESSIONALI DELLA FIGURA DELL'ARCHITETTOmaximdanciu206Nessuna valutazione finora
- Domande Di Esame Per Architettura 100 Quesiti Per Prepararsi All'Esame Di StatoDocumento67 pagineDomande Di Esame Per Architettura 100 Quesiti Per Prepararsi All'Esame Di StatoChiara Tanadini100% (1)
- Particolari Costruttivi TettoDocumento19 pagineParticolari Costruttivi Tettoksav2012Nessuna valutazione finora
- Tipologie EdilizieDocumento68 pagineTipologie Ediliziecagot89Nessuna valutazione finora
- Case Ecologiche di Legno. Tutto quello che devi sapereDa EverandCase Ecologiche di Legno. Tutto quello che devi sapereValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (5)
- Architetture del dopo: Costruire con salice, canna, bambù, pagliaDa EverandArchitetture del dopo: Costruire con salice, canna, bambù, pagliaNessuna valutazione finora
- Esercizi Vari - Esame Di Stato Architettura 2019Documento51 pagineEsercizi Vari - Esame Di Stato Architettura 2019Joris KatkeviciusNessuna valutazione finora
- Formazione-Computo Metrico EstimativoDocumento19 pagineFormazione-Computo Metrico EstimativoGiovanni PolverinoNessuna valutazione finora
- Strutture in LegnoDocumento27 pagineStrutture in LegnomarcocorraoNessuna valutazione finora
- Le Chiusure Orizzontali Superiori PDFDocumento203 pagineLe Chiusure Orizzontali Superiori PDFCarlo ColucciNessuna valutazione finora
- Guida Esame Di Stato Architetto R100 PDFDocumento21 pagineGuida Esame Di Stato Architetto R100 PDFMichele Giuliani100% (1)
- Tecnologie Per L'architettura IpogeaDocumento386 pagineTecnologie Per L'architettura Ipogeagiorgiation50% (2)
- Case Legno PDFDocumento80 pagineCase Legno PDFFORCEOFWILL88Nessuna valutazione finora
- Quaderno 02 Murature DallA Alla ZDocumento71 pagineQuaderno 02 Murature DallA Alla ZMarco FoglieriNessuna valutazione finora
- Commentario delle nuove norme tecniche per le costruzioniDa EverandCommentario delle nuove norme tecniche per le costruzioniValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Gli stili architettonici del '900: Spiegati agli stupidiDa EverandGli stili architettonici del '900: Spiegati agli stupidiValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Composizione ArchitettonicaDocumento132 pagineComposizione ArchitettonicaGiulioOstanelloNessuna valutazione finora
- Materiali Per L'ediliziaDocumento3 pagineMateriali Per L'ediliziaSimone AgizzaNessuna valutazione finora
- Esame Di Stato Da ArchitettiDocumento7 pagineEsame Di Stato Da ArchitettiChiara TanadiniNessuna valutazione finora
- Standard Urbanistici DM 1444 - 68Documento6 pagineStandard Urbanistici DM 1444 - 68Michele GiulianiNessuna valutazione finora
- La Casa in LineaDocumento140 pagineLa Casa in LineaDonatoGalloNessuna valutazione finora
- Isolamento Termico Efficace Per Balconi A Sbalzo (3698)Documento24 pagineIsolamento Termico Efficace Per Balconi A Sbalzo (3698)Mattia TiernoNessuna valutazione finora
- Tecniche Di ConsolidamentoDocumento19 pagineTecniche Di ConsolidamentoMarioBrossterNessuna valutazione finora
- Ark 78parzDocumento28 pagineArk 78parzleoale2100% (1)
- BIM SlideDocumento35 pagineBIM SlideantgerardiNessuna valutazione finora
- ESECUTIVIDocumento7 pagineESECUTIVIRoberto BernyNessuna valutazione finora
- PRONTUARIO TECNICO (Requisiti Minimi)Documento126 paginePRONTUARIO TECNICO (Requisiti Minimi)D50% (2)
- Virtual Experience: La realtà virtuale nel mondo dell’arteDa EverandVirtual Experience: La realtà virtuale nel mondo dell’arteNessuna valutazione finora
- Architettura Adolf Loos - Casa MullerDocumento8 pagineArchitettura Adolf Loos - Casa MullerIsrael ZurubisanaNessuna valutazione finora
- Architettura XIX - XX SECOLODocumento172 pagineArchitettura XIX - XX SECOLOireire82Nessuna valutazione finora
- AtlanteConsolidamentoEdificiStorici estrattoCAP3Documento49 pagineAtlanteConsolidamentoEdificiStorici estrattoCAP3Andreea CrăciunNessuna valutazione finora
- ProntuarioDocumento17 pagineProntuarioGevionNessuna valutazione finora
- Walter GropiusDocumento8 pagineWalter GropiusoggianniNessuna valutazione finora
- Costruire Il Paesaggio 10+1 Istruzioni Per L'usoDocumento29 pagineCostruire Il Paesaggio 10+1 Istruzioni Per L'usoarchitetoreNessuna valutazione finora
- Processo Edilizio e Sistema Tecnologico Prof. Arch. Fabrizio Orlandi BrizioliCorso Di Tecnologia Dell'architettura - AA 2006-2007Documento12 pagineProcesso Edilizio e Sistema Tecnologico Prof. Arch. Fabrizio Orlandi BrizioliCorso Di Tecnologia Dell'architettura - AA 2006-2007Maxim Lucian DanciuNessuna valutazione finora
- Elenco Norme UNI Per EdiliziaDocumento76 pagineElenco Norme UNI Per EdiliziaMarco Berti100% (2)
- Manuale Progettazione Dimensionamento Pompe Di Calore - WebDocumento66 pagineManuale Progettazione Dimensionamento Pompe Di Calore - WebMarcWorldNessuna valutazione finora
- Architettura e BioclimatiDocumento25 pagineArchitettura e BioclimatiSerena D'angeloNessuna valutazione finora
- Dati Climatici ZonaDocumento213 pagineDati Climatici ZonaLuigi BennardoNessuna valutazione finora
- Idraulica - 41 - It-Impianti Ibridi PDFDocumento44 pagineIdraulica - 41 - It-Impianti Ibridi PDFanescuveronicaNessuna valutazione finora
- Rischio Sismico e Classificazione Climatica Di Guidonia Montecelio (RM)Documento2 pagineRischio Sismico e Classificazione Climatica Di Guidonia Montecelio (RM)tiziana11869Nessuna valutazione finora
- E0201E812Documento16 pagineE0201E812mepg2000Nessuna valutazione finora
- UNI - 10349 - 2016 Dati Climatici EstiviDocumento30 pagineUNI - 10349 - 2016 Dati Climatici EstivivanlilithNessuna valutazione finora
- Corso Di Impianti Tecnici - IsettiDocumento27 pagineCorso Di Impianti Tecnici - IsettisupermarioprofNessuna valutazione finora
- Lezione 16Documento70 pagineLezione 16smmdmmNessuna valutazione finora
- Manuale Sottofondi LECADocumento32 pagineManuale Sottofondi LECAErmanno MantovaNessuna valutazione finora
- GIULIANO CAMMARATA - Certificazione Energetic A Degli EdificiDocumento88 pagineGIULIANO CAMMARATA - Certificazione Energetic A Degli Edificidorian928Nessuna valutazione finora
- Opuscolo 14: RISPARMIO ENERGETICO CON GLI IMPIANTI DIRISCALDAMENTODocumento16 pagineOpuscolo 14: RISPARMIO ENERGETICO CON GLI IMPIANTI DIRISCALDAMENTODomenico BevilacquaNessuna valutazione finora
- Contabilizzazione Calore Valvole Termostatiche - Esonero - Linee Guida CniDocumento28 pagineContabilizzazione Calore Valvole Termostatiche - Esonero - Linee Guida CnialessiomanzoNessuna valutazione finora
- (Agg. Prof.) Guida Alla Certificazione Energetica - DispensaDocumento18 pagine(Agg. Prof.) Guida Alla Certificazione Energetica - DispensaLorenzoBenincasaNessuna valutazione finora
- Art 7 Comma 7 Obbligo Valvole TermostaticheDocumento22 pagineArt 7 Comma 7 Obbligo Valvole TermostaticheDaniele PagnozziNessuna valutazione finora
- Approfondimento Anit GradigiornoDocumento5 pagineApprofondimento Anit GradigiornoLorenzo MasottiNessuna valutazione finora
- Relazione Legge 10 TermusDocumento8 pagineRelazione Legge 10 TermusCARLANessuna valutazione finora
- IMPIANTODocumento26 pagineIMPIANTOsnssvt84Nessuna valutazione finora
- UNI TS 11300 1 2014 PDF 21 35Documento15 pagineUNI TS 11300 1 2014 PDF 21 35GiuseppeNessuna valutazione finora
- 7 - Esempio Attestato Di Qualificazione Energetic ADocumento4 pagine7 - Esempio Attestato Di Qualificazione Energetic ACiccio PasticcioNessuna valutazione finora
- Tesi Di Laurea in Architettura TecnicaDocumento139 pagineTesi Di Laurea in Architettura TecnicaGiovanni Cechet100% (2)
- TermotecnicaDocumento131 pagineTermotecnicafrankbooksNessuna valutazione finora