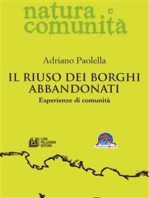Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Villa Tarantola
Caricato da
Gian LuigiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Villa Tarantola
Caricato da
Gian LuigiCopyright:
Formati disponibili
VINCENZO CARDARELLI. VILLA TARANTOLA E ALTRI SCRITTI. PREMIO LETTERARIO STREGA 1948. /:/VILLA TARANTOLA.
Fin da ragazzo ho amato le distanze e la solitudine. Uscire dalle porte del mio paese e guardarlo dal di fuori, come qualche cosa di perduto, era uno dei miei pi abituali diletti. Piacere e terrore mi portavano in certi luoghi romiti, sacri alla morte, a cui per non pensavo se non per quel tanto che m'impediva d'inoltrarmi troppo in un cos pauroso reame. Uscito da Porta Clementina, dove comincia la via del cimitero e delle tombe etrusche, la mia evasione, di solito, s'arrestava pochi passi pi in l. Di rado mi spingevo fino a quella strana, disabitatissima villa, chiamata Villa Tarantola, che vede gi il camposanto ed era allora per me un sito misterioso, enigmatico, evocante, nel suo nome, i velenosi ragni che danno il ballo di San Vito. Di l da una siepe di bosso si vedeva, attraverso il cancello, un corretto viale di elci bassi e ombrosi, e gi in fondo una casina moderna e rossiccia, a terrazza, sovrastata dalla ruota metallica d'una pompa a vento. Il piccolo e ombreggiato edificio, somigliante pi a un mulino che a una casa di abitazione, copriva l'orizzonte, che in quel punto vastissimo. Le sue persiane color cenere apparivano costantemente chiuse come il cancello a cui mi affacciavo. N mai mi avvenne di udire voci o scorgere anima viva curiosando l dentro. L'aspetto di questa solitaria villetta era irreprensibile e il terrore o piuttosto stupore che m'inspirava, tutte le volte che io ficcassi il naso fra quelle sbarre, d'una qualit ben nota ai lettori d'Edgardo Poe. Villa Tarantola non che un nome al mio paese: il nome d'una localit sprovvista, per ragioni facili a capirsi, di qualsiasi attrattiva. Pochi sanno o si domandano a chi appartenne in origine e come costui pot avere l'idea di costruirla in una regione cos visibilmente riservata alla morte Perch si chiami villa, dato che non ci abita nessuno. E come si potrebbe abitare da quelle parti? Perch quella siepe civettuola, quel viale, se non servono probabilmente che a mascherare un comune podere? Questo familiarmistero sono arrivato a chiarirlo soltanto qualche anno addietro, ragionando con un vecchio artigiano del mio paese, e ci che ho saputo intorno alle origini di Villa Tarantola, mi ha fatto molto piacere perch dimostra, in fin dei conti, come i miei stupori di fanciullo non fossero del tutto ingiustificati. Non c' mai stato a Tarquinia un pazzo cui sorridesse la prospettiva d'un soggiorno campestre in certi luoghi, a quell'epoca, e nessun ugure, certo, avrebbe autorizzato, in altri tempi, una simile fantasia. Villa Tarantola il portato di una impresa archeologica mal riuscita, il ripiego d'un deluso cercatore d'oro etrusco, che aveva comprato quel campo nella speranza di scoprirvi chiss quale tesoro. Se non che, di gran lunga meno fortunato di altri miei concittadini ai quali avvenne, anche a caso, di fare incontri memorabili nel sottosuolo tarquiniese, imbattendosi, fra l'altro pi d'una volta, in guerrieri armati e dormenti su letti di pietra, che, percossi dall'aria, si dissolvevano in pochi secondi come se fossero offesi da quelle violazioni; pare che il brav'uomo, nel suo magro possedimento, non riuscisse a trovare se non due o tre tombe sac-
cheggiatissime, contenenti alcuni sarcofaghi vuoti, di nenfro, che si vedono ancora oggi allineati lungo il viale che ho detto e sono per avventura quanto di pi vivo e parlante si riscontri nell'inanimata villetta. Da ultimo, poich non gli sarebbe stato facile disfarsi d'una propriet squalificata archeologicamente e di poco pregio dal lato agricolo, decise di servirsene a scopi voluttuari ed estetici. Il cercatore di ntichit etrusche s'improvvis giardiniere come s'era improvvisato archeologo. Dove prima sorgevano tumuli sospetti quanto illusori, fiorivano la lenta ginestra e il tenace asfodelo, in quell'aspro e sassoso terreno che egli aveva manomesso, scassato e stravolto in lungo e in largo, fece nascere non la vigna, che l,non potrebbe attecchire, bens una villetta moderna, all'inglese, tutta pettinata e livellata come un campo di tennis, quasi volesse nascondere le tracce delle sue infruttuose ricerche o vendicarsi della terra che lo aveva ingannato, alterandone il profilo naturale e storico. Ma era fatale che quella tragica terra dovesse rivelarsi, ad ogni modo, pi forte di lui. Il fondatore di Villa Tarantola s'illudeva forse di legare il suo nome a questo monumento di giardinaggio. Ahim, il popolo non tard a dargliene un altro, scritto nei luoghi, nella triste solennit del paesaggio che circonda la inamena villetta; giacch, a parte che su quelle nude alture non si pu immaginare altro giardino se non quello dei morti, i campi argillosi e cocenti della nostra necropoli sono famosi, oltre tutto, per la "Tarntula Apuliae" la quale, nei mesi estivi, li predilige talmente da far pensare che porti nel suo grosso ventre il veleno delle tombe etrusche. Chiunque nato in Maremma conosce vita, morte e miracoli della tarantola, ragno elegiaco e terraiolo, molto meno pericoloso di quel che la fantasia popolare farebbe credere. La sua presenza lamentevole soprattutto perch accusa l'abbandono in cui sono lasciate certe terre. Nella ferace Tarquinia non pu vivere che in una piccolissima parte del suo territorio, fra le deserte rovine della Civita, in mezzo ai sepolcri dei lucumoni, come altrove bazzica le rovine greche, ricercando, in ogni caso, le terre aride e solari del Mezzogiorno, dove incombe il silenzio delle civilt tramontate. E vive rintanata, durante il giorno, in un comodo nido tappezzato di seta e facilmente riconoscibile per via d'un intreccio di seta e pagliuzze che ne protegge l'ingresso. Ma basta zufolare un poco e frugare con un filo di paglia nel suo profondo rifugio percha tarantola venga fuori. A quel doppio solletico l'estroso e musicale insetto, non resiste. Il che farebbe credere che vada a caccia di grilli. E morde l'uomo a caso, L'uomo che costretto a dormire in campagna nella cruenta stagione della trebbiatura e della pressa del fieno, che da noi una vera guerra. Allora inietta un veleno leggero che non fa ballare affatto (questa superstizione ha origine dal fatto che una volta le vittime della tarantola si curavano a suon di cembali, con una danza sfrenata, che poi si chiam tarantella) ma d luogo, in certi casi, a una sorta d'imbambolamento, quale io vidi tanti anni fa, proprio sulla stradetta di cui si discorre, in una giovane campagnola aggredita dal malefico ragno. La portavano alL'ospedale col carretto, e lei stava in piedi l sopra, incantata, trasumanata, bellissima. La sua bianca faccia splendeva come quella di una santa in estasi. Nella luce d'un tramonto d'estate, in quel paesaggio, non potevo fare un incontro
pi commovente e oserei aggiungere significativo, per quel che riguarda gli effetti che pu produrre un ragno abitatore di terre cos macerate e mortifere. Ma la scienza non crede ai misteriosi malori che si attribuiscono alla tarantol. E queste mie non sono che impressioni e fantasie di professore lo Comunque, posto che la tarantola non una favola al mio paese, nessuna forza umana poteva impedire che la borghese villetta, situata nei suoi regni, assumesse ben presto quel colore, quel nome sconcertante, per cui da bambino io non potevo guardarla, n sentirla nominare, senza immaginarmela come la casa delle tarantole. Ero, a dire il vero, alquanto diviso fra il gentile aspetto del sito e l'orrido nome che gli si dava. Ma la sua solitudine quasi paurosa, il suo allarmante silenzio, erano proprio tarantoleschi. L dentro, secondo me, vivevano, senza far rumore, miriadi di tarantole. Da pi di mezzo secolo, abbandonata al proprio destino, vale a dire alle cure d'un giardiniere laborioso e fedele, che sembra custodirla come un monumento e forse abita in quella casma senza che nessuno se ne sia mai accorto, Villa Tarantola vive la sua vita silenziosa ed occulta, conservando inalterato il suo aspetto decoroso e impeccabile, quantunque sia passata, in tutti questi anni, per le mani dei proprietari pi diversi. La sua sorte non cambia. una villa incantata, stregata, come quella fanciulla che incontrai nei suoi pressi. La fitta e sempreverde siepe di bosso che la circonda ne accresce la solitudine, la rende, per cos dire, tutta vegetale e perci pi impressionante. Bassa come , serve a proteggere e anche a nascondere il misterioso dominio assai pi che se fosse cinto da una muraglia. In un paese dove le terre sono limitate da fossi, stradelli, cippi marmorei, muri a secco, fratte spinose, oppure, trattandosi di vigna o di villa, da un alto e nobile muro, la gente non pu che scostarsi da questa insolita, educatissima siepe che non fiorisce e neppure appassisce, che ha l'aria di voler essere confidenziale ed tuttavia cos arcigna, cos puritana; vero simbolo della propriet privata come la intendevano i possidenti del secolo scorso, senza nessuna concessione alla fantasia. C' chi, per renderla un po' allegra e domestica, la chiama scherzosamente "il frattone". Ma non v'illudete. Nessuno la frequenta, nemmeno i ramarri. Eppoi quella non via da idillici indugi. Ben altro ritiro ci aspetta sulla rotabile di Villa Tarantola. cos che il solitario giardino, sopraffatto da troppe altre cose pi grandi, viene ad essere perfettamente escluso dalle nostre consuetudini e dai nostri affetti. Noi non lo nominiamo se non a motivo di riferimento topografico. Nessuna leggenda s' formata intorno ad un sito cos perduto, nelle cui vicinanze accaddero, di tempo in tempo, fatti meravigliosi e tremendi L'enormit di Villa Tarantola consiste appunto nell'essere totalmente priva di vita, di necessit, di ragione. Ma poich in natura non si d vacuo, come dice Leonardo l'inesplicabile villa divenuta un luogo assai strano, quasi sacro. La fantasia popolare l'ha dedicata all'infernale Tarantola ed fuori dubbio che nel disinteresse con cui la si guarda e se ne discorre si nasconde un vago senso d'orrore e di reverenza. Soltanto i frati cappuccini, che hanno fatto di Villa Tarantola una meta delle loro passeggiate serali, possono sorvolare su quel nome orripilante e credo che siano riusciti a famigliarizzarsi un po' con questa singolare vil-
letta. FINE D'UNA BANDA Nella vecchia banda comunale del mio paese si facevano rispettare i valori. In un suonatore di cornetta o clarino, si lodavano soprattutto certe qualit essenziali e native come, per esempio, la voce, il sentimento, la dolcezza del labbro, che solo alcuni privilegiati potevano vantarsi di possedere. I virtuosi, gli "sminfaroli", erano tenuti in sottordine. A poco a poco molti di costoro, delusi e inviperiti, si allontanarono dal severo istituto, lasciando credere d'aver sofferto chiss quali angherie, e cos nacque non soltanto una nuova banda, ma addirittura un partito, che si chiam "cittadino", il cui primo atto, una volta al potere, fu di sciogliere l'odiatissimo corpo musicale che era stato causa di tanta discordia. Di quest'ultimo io mi trovavo a far parte, in qualit di moccioso suonatore di genis. Da un giorno all'altro dovemmo consegnare strumento e montura, lasciare il Palazzo Vitelleschi, nostra magnifica sede, per ridurci pi tardi, quando la banda comunale fu ricostruita sotto altro titolo, col denaro dei privati, in un semplice magazzino. Allora il Municipio non ebbe pi una banda, ma la citt ne aveva due, che s'azzuffavano financo nell'intonazione degli strumenti, suonando l'una mezzo tono pi su dell'altra. E fu in questo secondo e agitato periodo della vita musicale e pubblica del mio paese che io mi vidi promosso alle superiori armonie del corno. Ma nulla ormai avrebbe potuto consolarmi del convincimento che m'ero fatto, di esser nato sotto cattiva stella. C'era davvero di che avvelenare la esistenza d'un ragazzo a vedere come la lista dei candidati al Consiglio comunale, che noi appoggiavamo, uscisse, da ogni nuova elezione, regolarmente sconfitta. Alla fine di quelle giornate elettorali, cariche di passioni contenute e di speranze dissimulate, la dignit dei vinti era pari, se non superiore, allo strepito dei vincitori, il giubilo si scontrava col lutto, il silenzio contegnoso d'una parte della cittadinanza isolava le dimostrazioni, le fiaccolate della parte avversa, che, sebbene fatte a suon di pifferi, non riuscivano ad essere allegre e non duravano pi d'uno sprazzo di bengala. Tutti poi andavano a letto con la coscienza poco tranquilla, non potendosi immaginare una condizione pi iniqua di quella che s'era determinata al mio paese con queste rivalit elettorali e bandistiche. Iniqua, ma necessaria, poich a tali avvenimenti noi siamo debitori dell'acqua potabile, che fu la grande impresa del partito cittadino o, per meglio dire, L'opera d'un potentissimo conte, capeggiatore della fazione. Di quest'uomo benemerito, il cui nome ormai scolpito in una lapide, non potrei parlare se non con molto rispetto. Era cavaliere di cappa e spada in Vaticano, viveva abitualmente a Roma, e veniva a Tarquinia soltanto per qualche mese dell'anno, in autunno o in primavera, offuscando col numero dei suoi servitori, coi suoi "attacchi" a quattro, a sei, tutti gli altri signori del mio paese, che magari vantavano tradizioni pi illustri, ma non possedevano che una modesta carrozza a due cavalli, con cocchiere in livrea. Non si creda tuttavia ch'egli cercasse, col suo splendore, di mettersi in mo-
stra, essendo anzi un uomo alquanto evasivo e quasi irraggiungibile, un mito, un'istituzione amministrativa pi che una persona. Bens quello era il tono della sua casa. Il conte aveva un figlio, cerimoniere di Corte, e una giovane e bella nuora, dama d'onore della Regina. Dimodoch si potrebbe dire che avesse anticipato di molti anni, da parte sua, L'evento della Conciliazione; e contro una tale potenza c'era poco da fare. Sarebbero bastati i dipendenti del conte, o quelli che abitano all'ombra del suo palazzo, in una festosa parrocchia, detta scherzosamente "il villaggio", ad assicurare il trionfo di un'elezione. Ma il popolo parteggiava per lui. La dispettosa genia dei campagnoli idolatrava quest'uomo, questo malinconico feudatario che, senza far discorsi in pubblico, senza dimostrare ambizioni di sorta, prometteva al nostro paese l'acqua potabile e la spartizione delle terre (quelle del Comune, beninteso), lasciando per di pi aperti alla cittadinanza, per familiare consuetudine, i cancelli d'una sua villa, dove noi andavamo da ragazzi ad ammirare l'albero del pepe, a mangiare le guainelle e le nespole del Giappone. Il clero poi, sotto sotto, soffiava nel fuoco di quel partito che noi chiamavamo "nero" e lo era infatti in tutta l'estensione del termine. Fazione municipale e parrocchiana, politicamente agnostica, quindi ostile alle ideologie liberali dei signori del Circolo, i quali avevano amministrato il Comune per tanti anni, arrivando a mangiarsi, come si diceva comunemente, anche le tavole del teatro. Tale fama purtroppo gravava su coloro che s'erano tassati per mantenere la nostra banda e che noi disperatamente sostenevamo: quasi tutti buoni oratori, umanisti, compositori di acrostici e sonetti per nozze, spiriti faceti, che rappresentavano al mio paese quanto poteva esservi una volta di pi colto, di pi garbato, di pi illuminato, ma a cui si faceva carico d'aver dato fondo al denaro pubblico, oltre che al proprio, sotto la guida d'un uomo terribile, passato in proverbio per la sua scaltrezza e voracit. Era costui l'antico e ormai detronizzato segretario comunale, di professione anche notaio. Conosceva i segreti di tutto il paese e la gente lo odiava forse per questo, attribuendogli un potere diabolico. Il piccolo e vecchio notaro, obeso, pallido, vestito costantemente di nero, in palandrana, aveva una figura da Don Abbondio, con folte sopracciglia irsute e canute che sentivano il cattivo tempo. Non poteva dirsi, in verit, un tipo accostante, n cercava d'esserlo. Viveva rintanato nel suo funebre archivio, in una bella e segretissima casa, gi convento di frati, posta alL'ingresso della citt, in fondo a una piazzetta alberata. A quella porta si bussava soltanto per ragioni testamentarie; e non si apriva se non dopo che una delle sorelle del segretario, naturalmente zitellone, allo stesso modo che il nostro uomo era scapolo, aveva allungato il capo al davanzale come una tartaruga. Il popolo chiamava questo personaggio "il tarlo"; e l'amministrazione comunale impersonata da lui fu sempre detta "L'amministrazione del tarlo". E probabile che il povero segretario non meritasse il soprannome che gli si dava. Ma il fatto che la fazione dove io mi trovai coinvolto all'alba della vita era simboleggiata da quel vorace insetto che, secondo una favoletta nostrana, rosicchi il legno della santa croce e quando arriv ai chiodi si fece scrupolo di continuare. Per la qual cosa noi diciamo anche, di certi atti di generosit ipocrita e tardiva,
che sopravvengono quando il male gi fatto e non pi possibile farne dell'altro: "Lo scrupolo del tarlo". Vi lascio giudicare se potevo essere pi sfortunato nella scelta del mio primo partito. Immaginate l'impopolarit della logora banda alla quale mi onoravo di appartenere, e tutte le sorprese; le riflessioni d'un ragazzo che entra, per cos dire, nella vita in cos poco allegre contingenze. Invano il nostro impareggiabile trombone si faceva tremare la bazza filando, nei concerti in piazza, le angeliche note dei duetti verdiani e donizettiani. La severit, la freddezza, la cattiva disposizione del pubblico nei nostri riguardi, avrebbero scoraggiato la banda di Pianella. Perfino il "miserere" del Trovatore, cavallo di battaglia della nostra cornetta, non oteneva che scarsissimi applausi. Tutto l'entusiasmo del popolino era per le strepitose marcette della "banda nova"; e di noi, che avevamo un passo di marcia pi cadenzato a lento, si diceva che su questo punto non potevamo competere coi nostri rivali e che la nostra banda era buona per gli accompagnamenti funebri e per la processione del Venerd Santo. Si voleva insomma una banda allegra e non musona. Si desideravano suonatori di forza e non di grazia. E fu con questo gusto, di questo passo, che il partito cittadino, in coccarda bianca e azzurra, and al potere, vi si consolid, senza curarsi di ridare al Comune quella banda che aveva sciolta; forse perch il problema non era facile da risolvere, dato che i migliori musicanti rimanevano sempre quelli della "banda vecchia", divenuti ormai veri banditi. I due corpi musicali vissero cos, finch poterono, con l'obolo dei privati. Finch un giorno, tanti anni dopo, davanti al prodigio di quell'acqua che veniva da molto lontano, traverso chilometri e chilometri di tubatura (e tutto il paese in festa si mosse per andarle incontro come se si trattasse della venuta d'un Papa), le due parti si riconciliarono e con ci fu segnata la sorte delle due bande nemiche. Queste infatti, destino un po' ironico per due sodalizi che dovevano essere la personificazione dell'armonia, cessati gli odii partigiani, si videro condannate a sparire, per mancanza di protettori. In tanta universale concordia nessuno adesso pensava pi alle due bande che, d'altra parte, non avrebbero potuto fondersi, a causa di quella differenza di tono che le separava irreparabilmente. Eppoi l'esperienza dimostrava come al mio paese la musica servisse piuttosto a inferocire gli animi che ad ammansirli. Cosicch in definitiva, chi ci and di mezzo, in questa rivoluzione cittadina, fummo noi bandisti. Noi che c'entravamo come i cavoli a merenda. Noi che, ignari del sacro mito d'Orfeo, avevamo fatto della musica un detestabile uso. Noi fummo i veri sconfitti. E cadde, con l'istituzione bandistica, tutto ci ch'essa comporta e significa. Finirono, o divennero un'ombra di quel che furono, le processioni della Settimana Santa, la Fiera di maggio, le feste in genere, i veglioni, le vignate, le ottobrat'e, le serenate. Una strana pace, pi deleteria d'ogni guerra, s'accamp fra le nostre mura, ormai disertate dal genio della musica. Eppure, come ho detto, da queste comunali vicende scatur al mio paese un bene incalcolabile Se oggi chiedi a
uno di Tarquinia come mai le ragazze vengon su cos colorite, al contrario di quel che accadeva una volta, ti risponder additandoti la fontana. E l'acqua, il miracolo dell'acqua che ha moltiplicato la popolazione e fatto rifiorire le guance di quelle giovinette che a tempo mio, in primavera, apparivano tutte un po' estenuate ed anemiche, e andavano a farsi le iniezioni in farmacia, quando non si limitassero, per pudore, a bere qualche ovetto, a mangiare qualche bistecchina e a trangugiare con disgusto un mezzo bicchiere di vino rosso. Accostiamoci dunque alla nostra fontana materna; la quale non detto sia di ieri, perch l'acqua di fonte noi l'abbiamo sempre avuta, sia pure non cos eccellente e copiosa. Beviamo un sorso di quel prezioso elemento che cost tanti sacrifici di cui nessuno pi si ricorda. I vecchi sorridono con indulgenza di queste antiche discordie cittadine e ne parlano come d'un trascorso di giovinezza. MEMORIE Dal mio paese, di sera, si vedono i lumi di Montefiascone, citt particolarmente nota, dalle nostre parti, per il suo seminario e per i suoi piccoli seminaristi vestiti di viola. Molti miei amici d'infanzia, senz'alcuna vocazione per il sacerdozio, portarono quella veste paonazza, a cui per io preferivo la bersaglieresca divisa del collegiale. di Spoleto. Ma il paterno scetticismo didattico e culturale non mi concesse nemmeno la modesta uniforme del convitto di Amelia, dove sospiravo d'entrare, soprattutto in omagggio ai famosissimi fichi di questa citt. Cosicch, se proprio ci tenete a saperlo, io appartengo a quella difficile, ombrosa e variamente stimata categoria di persone che hanno studiato e si sono fatte da s. Di padre in figlio i destini degli uomini si perpetuano. Anche mio padre veniva dal nulla, bench di buona famiglia, finita in malora. Da bambino aveva conosciuto la dura poesia delle strade carreggiabili. E se ne gloriava. Giunto a farsi una modesta posizione in commercio, da spedizioniere prima, poi da esercente, non mostrava nessun desiderio di migliorarla. Viveva chiuso nel suo ceto, nella sua condizione, come in una casta. Tutto il suo orgoglio lo metteva nel vendere merce ottimo a prezzo adeguato, senza curarsi dei concorrenti, nell'imballare i carciofi, gli abbacchi meglio d'un altro, nel saper giudicare a colpo d'occhio quante piante pu contenere un carciofeto, quanto pu valere una vigna. Molte persone infatti, le quali non avevano che soldi, si giovavano del suo ingegno ed egli era ben lieto di porre in comune questo capitale che natura gli aveva dato e che gli permetteva di primeggiare, nelle varie piccole societ commerciali di cui fece parte, senz'averne l'aria e senza correre troppi rischi. In quelle amicali unioni, pure portando il suo contributo di denaro, faceva tutto lui Lavorava per s e per gli altri. E avrebbe potuto sembrare quasi un servo dei propri soci, mentre in realt era il loro ispiratore, un uomo competentissimo nel suo mestiere e quanto mai geloso della sua indipendenza. Per farla corta, mio padre pretendeva ch'io diventassi niente altro che un buon commerciante, alla sua maniera. E non per nulla una delle sue massime che pi frequentemente lo sentivo ripetermi era questa: "Tratta chi pi di te e fagli le spese". Non immaginava fino a qual punto gli somigliassi e come lo avrei purtroppo imitato, ma in campi
assai meno generosi di quelli che, con tanta sicurezza, egli sapeva stimare prima che fiorissero. Ecco la ragione vera per cui non volle che studiassi e fece, senz'accorgersene, la mia rovina Giacch io ero nato allo studio, avevo il bacillo della cultura e della letteratura nel sangue. Per conseguenza, quando non trovai pi scuole da frequentare fui un ragazzo perduto, a cui veniva meno il suo naturale alimento. Cercai allora la scuola nella vita, nel mondo. A sedici anni, cio un anno avanti che mio padre morisse, ero gi lontano da lui e dal mio paese. E se ripenso a questi fatti e cerco di ricostruirne le date mi pare impossibile che io abbia cominciato a vivere cos presto. Il tempo che un ragazzo impiega ordinariamente nell'apprendere un'arte o nello studio del latino e del greco io lo trascorsi fra gente adulta, girovagando, impicciandomi di politica. Potrei paragonare la mia adolescenza a quella d'un mozzo, se cedessi un poco alla fantasia. A mio padre tornai soltanto per assisterlo negli ultimi giorni della sua vita, sostenendo senza batter ciglio il sospetto, da parte sua, ch'io approfittassi della sua malattia per salvarmi dalla fame che mi era piaciuto affrontare. La sua morte l'ho scontata prima che avvenisse. Tutte le lacrime di cui potevo disporre le ho versate un giorno che recatomi a visitarlo al Policlinico di Roma, dov'egli era stato sottoposto ad una inutile operazione, lo trovai come un albero secco, mangiato dalle formiche. Appena mi vide gli occhi gli s'inumidirono, ma in quel medesimo istante le sue lacrime tornarono indietro come succhiate da un'immane forza interna. Mi guard, al solito, burberamente, chiedendomi che venivo a fare. C'eran cose urgenti da sbrigare a Tarquinia. Cominciava la mietitura ed egli era fornitore di grascia. Volle che ripartissi in giornata; non manc di ripetermi, pi volte, a proposito di quei quintali di bianco lardo lucchese che avrei dovuto somministrare, la sua consueta raccomandazione "fai perbenino", ed io sarei ripartito, probabilmente, abbastanza tranquillo, se non avesse aggiunto che di l a una quindicina di giorni contava di essere a Tarquinia anche lui. Sapevo, purtroppo, e vedevo che non si sarebbe pi alzato da quel letto. A questo contrasto non potei reggere. Mi tenni appena quanto era necessarlo per sottrarmi alla sua vista. Poi non saprei dire quel che accadde in me. Uscii dall'ospedale piangendo e singhiozzando come un bambino smarrito, e in tale stato salii sul tranve che portava a San Pietro. Per tutto il tragitto piansi disperatamente, pubblicamente, meravigliandomi, di tanto in tanto, che nessuno dei molti passeggeri che si avvicendavano sulla vettura me ne chiedesse la ragione. Forse, poich mi trovavo sul tranve del Policlinico, era facile capirla questa ragione e i buoni romani lasciavano ch'io dessi sfogo al mio dolore. Se no ci sarebbe da credere davvero che Roma sia una citt crudelissima, come sospettai allora vagamente. Quando m'arriv la notizia della morte di mio padre ogni possibilit di soffrirne era ormai esaurita. Presi la via di casa, entrai in camera, e guardandomi un po' nello specchio mi dissi che da quel momento ero solo. Avevo diciassette anni. Cos mi staccai da quel tronco umano che sempre stato
per me, pi che un padre, un forte esempio morale, anche nei suoi non pochi e non lievi errori, nella tremenda integrit del carattere. Dimenticato per qualche tempo, cominci a ridestarsi, via via che la vita si complicava e ingrossava, prima di tutto nei sogni. Per lungo tempo il sogno che facevo su lui fu sempre il medesimo. Tornavo nel luogo dove ho trascorso l'infanzia: il "buffet" della stazione, di cui si discorre nel "Sole a picco". Mio padre, immoto, stava sempre allo stesso posto e mi guardava in silenzio, con un'espressione indicibilmente dolorosa. Ma io non potevo restare. Un treno arrivava. Dovevo ripartire subito. E nulla era pi straziante di questo distacco, di quest'incubo che m'ha perseguitato per anni e anni. Finch ultimamente, qualche anno fa, lo rividi in un sogno bizzarro che non so quanto valga la pena di raccontare. Credo ch'io fossi a Ventimiglia e incontravo mio padre come una persona che s' persa di vista, di cui non s'ha pi notizia da tanto tempo. Era ancora vivo, anzi ringiovanito, in faccende, con una triste aria smemorata, e chiuso in se stesso pi del solito. Giungeva dalla Costa Azzurra, vestito abbastanza bene, ma borghesemente, cio in un modo che non gli si addiceva affatto. A quel che potei capire s'era dato alla letteratura, con molte pretese, ignorando che anch'io facevo lo stesso mestiere. O forse lo sapeva, se non che fra noi due c'era non so quale contrasto. Egli scriveva per il pubblico e non dava nessun peso a quel che potevo scrivere io. Mi fece una compassione enorme, soprattutto perch lo vedevo disorientato e novellino in quest'arte. Per la prima volta mi sentivo superiore a mio padre e decisi, dentro di me, di aiutarlo, con tutte le mie forze, a non perdere le sue illusioni. Adesso la sua ombra non mi visita pi, sembra essersi placata, forse perch io non ho ormai che una memoria assai stanca di queste cose che vo raccontando. Sono venuto a Roma a diciannove anni, con sette lire in tasca, e non avevo altre conoscenze che un avvocato socialista abruzzese, proprietario d'una casa in via Bonella e fratello d'un monsignore che ricopriva un'alta carica in Vaticano. Per vivere, nei primi anni, dovetti fare i mestieri pi vari: addetto a vigilare l'andamento delle sveglie in un deposito d'orologi a via Tor de'Specchi (occupazione non indegna di uno che, pi tardi, si sarebbe presunto un discreto osservatore dei tempi); amanuense nello studio d'un bisbetico avvocato piemontese e socialista anche lui, che non riusc mai ad entrare in Parlamento, nonostante il danaro profuso per tenere in piedi le leghe dei contadini del Tivolese e il mio appoggio oratorio; impiegato nella segreteria della Federazione metallurgica, la quale aveva sede in via Alessandrina, oggi scomparsa, come via Bonella e tante altre strade in quei pressi, nella sontuosa via dell'Impero; contabile, di fatto se non di diritto, in una cooperativa repubblicana di scalpellini o marmorari che si voglia dire, nei cui registri figuravano soprattutto due grosse partite, il Monumento a Vittorio e il Palazzo di Grazia e Giustizia; infine, dopo un congruo periodo di disoccupazione e di mlseria menarrabile, giornalista. Ero a cavallo. Potevo compiacermi del cammino percorso. A ventidue anni abitavo gi in una pensione del pi elegante quartiere
di Roma, quello di Piazza di Spagna, avevo il mio sarto, il mio barbiere, il mio lustrino preferito, frequentavo la Terza Saletta di Aragno e godevo, per di pi, i favori di Forina, Peppino, camerieri ben noti, figure ormai storiche, tavoleggianti di prim'ordine che servivano due uova al piatto su grandi vassoi o guantiere, come si dice al mio paese, d'argento massiccio. Che cosa desiderare di meglio? Questi dunque furono i mestieri che esercitai a Roma in una specie di vita anteriore, al tempo del tranve a cavalli e dei lumi a gas, quando i romani si chiamavano "buoni Quiriti", i consiglieri del Campidoglio "padri coscritti", e don Prospero Colonna, magnifico sindaco di una modesta capitale di cinquecentomila abitanti, veniva detto scherzosamente "don Cerino". PRIMI PASSI Io venni a Roma col vento o, per meglio dire, con la nostalgia dei treni che andavano verso la Citt Eterna o ne portavano l'odore. Nato nel Lazio, in un paese dove si parla un linguaggio molto simile a quello romano, cresciuto per di pi lungo la ferrovia, niente avrebbe potuto impedirmi di correre la mia modesta avventura. La Valigia delle Indie, che io vedevo passare per la deserta maremma una volta la settimana, sfiorava appena la mia fantasia. Questo treno fantasma, uso ad apparire e sparire sul crepuscolo, pi veloce d'un pipistrello, non fermava alla mia stazione. Se no, credo che sarei finito chi sa dove. Ma tutti i diretti, gli omnibus, i misti, e perfino i treni merci che, sostando a Tarquinia pi o meno lungamente, magari isonto per rifornirsi di acqua, riprendevano la loro corsa in direzione dell'Urbe, erano per me un invito a salire. Partiti, li accompagnavo con lo sguardo per tutta la curva del litorale, fin dove scomparivano, lasciando sul loro cammino qualche nuvoletta di fumo bianco, presto dissipata dal vento. Negli anni della puerizia, sentendo ragionare di Roma, dell'Osteria della Cuccagna, ritrovo in quell'epoca dei tarquiniesi residenti nella Capitale, del mirabile ponte apribile di San Paolo, che si chiudeva per lasciar passare il treno, quindi si riapriva, fantasticavo di andarmene fra i Sette Colli, raccogliervi non so quali allori, per tornare poi al mio paese vestito da bersagliere, sopra una macchina volante. Non mi bastavano le piume, volevo anche tornare a volo, in un tempo in cui Dlagrange era di l da venire. Che cosa accendeva in tal modo la mia immaginazione? Certo i calori primaverili e i romanzi di Giulio Verne. Finalmente, a diciannove anni, "riche de mes seuls yeux tranquilles", eccomi nella citt dei miei sogni, portatovi anche un po' , bisogna pur dirlo, dalle mie utopie socialiste, da quel tanto di romantico e randagio che tali utopie contenevano. E ognuno pu immaginare da quali gironi abbia avuto inizio il mio viaggio per l'Urbe. Mi pare d'aver detto quel che desideravo. La via che mi condusse a Roma non quella dell'Universit dell'impiego, degli affari, della fortuna. Io sono della razza dei piccoli migratori interni Sto a Roma per fatalit regionale come un lombardo pu stare a Milano, un emiliano a Bo-
logna, un toscano a Firenze, e cos via. Se fossi nato altrove che nel Lazio la mia vita si sarebbe svolta certamente, con maggiore o minor successo non so, in tutt'altro capoluogo. La mia residenza nell'Urbe non ha niente di ambizioso: un fatto naturale e pacifico. Una simile persuasione mi conforta quando penso di aver trascorso, starei per dire provvisoriamente, la maggior parte della mia esistenza in una citt non mia, lungi dal mio paese nativo, in una condizione che, per quanto le mie parole possano sembrare esagerate, ha tutto il sapore di un esilio. Ma torniamo alle memorie. duro il cammino d'un giovane che, oltre a farsi una cultura, deve provvedere, possibilmente, a non morire di fame. In questa non comune situazione mi trovai a Roma nei primi anni. Stimer sempre un miracolo esser riuscito a cavarmela. Ma la vita piena di risorse e la fortuna assiste chi non nato per lasciarsi schiacciare. Per dare un'idea degli espedienti a cui talvolta necessario appigliarsi, narrer brevemente una felice avventura capitatami in un tempo che, privo di lavoro, avevo perso da alcuni mesi la memoria del letto e della tavola apparecchiata. Passando un giorno davanti a un'agenzia di collocamento mi fermai a leggere, pi per curiosit che per altro, gli annunci contenuti in una tabella appesa fuori dell'uscio e vidi che si cercava un professore di pedagogia disposto a scrivere una tesi per una diplomanda del Magistero femminile. Deciso, entrai nell'ufficio. Chiesi l'indirizzo della studentessa che aveva pubblicato quell'annuncio e mi presentai a lei e a sua madre in un arnese indescrivibile, con una barba ispida e lunga di non so quanti giorni, spacciandomi, ahim, per quel che non ero. Le due donne, senza far caso al mio aspetto, che forse giudicarono conveniente a un povero dottore in pedagogia, certo laureato da poco, mi accolsero come un salvatore. Il tempo degli esami stringeva, l'urgenza era grande da ambo le parti, e non ci fu difficile intenderci su tutto. La tesi aveva per tema "Il naturalismo in pedagogia", doveva consistere in non meno di duecento pagine dattiloscritte ed essere consegnata entro quindici giorni al pi tardi. Accettai con entusiasmo queste condizioni. Infine si venne al compenso, e mi si offrirono duecento lire, cifra sbalorditiva in quegli anni, per uno che si trovasse nelle mie congiunture. Un paio di giorni dopo consegnavo il primo capitolo, ricevendo un anticipo che mi serv a rivestirmi e a trasformarmi da capo a piedi. Quando tornai per consegnare il secondo capitolo, a cui segu un nuovo anticipo, mi vergognavo un po' di farmi vedere con la faccia rasata e quegli abiti lustri e fiammanti ch'erano un'aperta confessione della mia miseria. Tuttavia n la madre n la figlia, due timide perugine, fecero il pi piccolo rilievo sul prodigioso cambiamento del professore. Seguitarono insomma, senza dubbio per delicatezza, a fingere di non accorgersi delle mie apparenze. Se non che alla fine di quella spaventosa fatica, in virt di quegli acconti che mi venivano benevolmente concessi, via via che la tesi usciva dal mio cervello in tumulto, si era operata in me una metamorfosi faustiana. E niente di pi naturale che fra il dottore improvvisato e l'impreparata discente sorgesse un
amoruccio, presto interrotto dalla partenza di colei che io avevo sospinta nella carriera dell'insegnamento, prestandole il mio magistrale soccorso anche nelle tesine orali. Almanaccai questa tesi nella sala di lettura della biblioteca Vittorio Emanuele, di cui ero a quei tempi zelante frequentatore, saccheggiando un famoso testo francese di storia della pedagogia, ma traducendolo, sunteggiandolo e parafrasandolo ad ogni passo, ossia cercando di esprimere con parole mie quel che leggevo e venivo a conoscere per la prima volta, non senza mescolarvi tutte le considerazioni e fantasie che la calda lettura poteva suggerirmi, specie nel capitolo su Rousseau, scritto con la testa in fiamme. Non credo sia stato un lavoro inutile, neppure dal lato della mia formazione. Un'altra fatica del genere, bench meno speculativa, avevo sostenuto pochi mesi prima, scrivendo, in brevissimo tempo, quasi tutto un libro, di cui per fui l'estensore pi che l'autore e che non porta naturalmente il mio nome. Trattava di questioni economiche e sindacali, con uno spirito che allora si diceva riformista o collaborazionista. Un autorevole professore di economia, leggendo questo libercolo, and in brodo di giuggiole e gli dedic un lungo ed entusiastico articolo sopra un grande giornale. L'unica recensione favorevole e senza riserve che io abbia ottenuto nella mia vita, per quel tanto che la detta opera pu appartenermi. Incredibile, strapazzosa, fu la mia fecondit giovanile. Tra i ventidue e i ventiquattro anni, redattore di un giornale quotidiano, mi feci conoscere come uno dei pi fertili imbrattacarte che si siano mai scatenati in una redazione. In quel tempo avrei voluto vedere qualcuno che osasse rimproverarmi la mia pigrizia. Ero tipo da scrivere due articoli in un giorno, sei colonne di cronaca su due avvenimenti diversi, in uno stesso numero. Non mi contentavo di eseguire con diligenza il lavoro che m'era stato assegnato. Facevo di tutto, strafacevo, suonando spesso, come ebbe a dire giustamente Eduardo Boutet, critico drammatico del quotidiano in questione, "Malbrough s'en va-t en guerre" con le trombe del Giudizio Universale. Il pi umile fatto di cronaca nera diventava per me un ottimo pretesto a divagazioni politiche, filosofiche, teologiche. E ricordo che, a proposito del delitto commesso dal cameriere d'un grande albergo, il quale aveva ucciso un suo compagno di lavoro per gelosia delle preferenze che il direttore gli dimostrava, scrissi uno dei miei soliti pezzi, dove la narrazione del fatto era sommersa in un mare di considerazioni, e lo intitolai pacificamente: Caino e Abele. Sotto il romantico titolo di "Gocce di sangue" avevo instaurato in cronaca una fiorita rubrica per i ferimenti e perpetravo, di tanto in tanto, delle "Malinconie romane", firmandole, a capriccio, con diversi pseudonimi, alcuni dei quali, i pi costanti, erano Simonetto, Calandrino, Caliban. Non so come non mi venne mai in mente di firmarmi Ariele. Non mi sentivo un angelo, nemmeno a quell'et. Eppoi lavoravo per un giornale a fosche tinte. Ma il bello
che queste divagazioni, alquanto incorporee, malinconiche soprattutto per il modo come erano scritte, non passavano inosservate. C'era gi chi mi diceva: Ti leggo, ti seguo. Cominciavo a provare il perturbante piacere delle congratulazioni. Un giorno il mio redattore capo, con affettuoso compiacimento, mi rifer che l'onorevole Fradeletto aveva molto appreZZato non so che frase o immagine d'una mia cronaca e se la era trascritta nel taccuino. Un altro giorno mi sentii lodare come scrittore aulico e latineggiante ed io pensai, molto seriamente, che chi nasce a Tarquinia il latino ce lo deve avere nel sangue; giacch inutile ripetere che in quella acerba et non avrei potuto vantare altre cognizioni linguistiche se non quelle ricevute, per dirla con Dante, dalla poppa della balia, ossia dalla parlata del mio paese. Purtroppo non ne facevo alcun uso e il mio modello di stile e di lingua era piuttosto Paolo Valera. Motivo per cui, nonostante che un articolo su Ibsen, scritto negli ultimi tempi del mio noviziato giornalistico, mi abbia valso l'attenzione di Emilio Cecchi e questo memorabile complimento del mio direttore: "Bellissimo quel tuo articolo. Non ci ho capito niente, ma bellissimo", mi affretto a concludere la mia poco pietosa esumazione dicendo che le sole cose possibili uscite dalla mia penna, in quello stravagante periodo di entusiastica attivit pubblicistica e letteraria, furono forse i miei resoconti parlamentari o di comizi, banchetti e congressi di ogni genere; a cominciare da un congresso di filosofi che tenne occupate le cronache per qualche settimana e che, per il luogo in cui si svolse (una famosa biblioteca dedicata alle donne di servizio) mi apr le porte d'un curioso mondo, filantropico, femministico, estetizzante, che meriterebbe di essere descritto. - Avevo in quel tempo una straordinaria facolt di ritenere il pensiero altrui e di trascriverlo con la velocit e l'esattezza d'uno stenografo. Come da bambino sapevo leggere meglio di qualunque altro della mia classe, cos da giovane avrei potuto sostenere una gara col pi provetto resocontista d'Italia. Ero nato cancelliere o amanuense, come volete Non si trattava, in sostanza, che d'una certa capacit di attenzione e di memoria e stimo di potermela attribuire senza offendere la modestia. la sola virt che io allora possedessi, in grado piuttosto eminente. Ma nessuno se ne accorse. L avvenire che il giornalismo mi prometteva era quello dell'articolista: mestiere difficile, che non ho ancora appreso. E due anni e mezzo di quel lavoro dannato dovevano finalmente fiaccare la mia resistentissima fibra, gi abbastanza provata dalle sofferenze patite, riducendomi sopra una tavola operatoria, dalla quale mi alzai trasformato e impoverito. Lasciando il Policlinico, dopo una degenza di quindici giorni, preceduta da una lunga malattia trascorsa, in una primavera tormentosa, un po' sul mio letto, un po' in una casa di salute, ero un altro. Nella stessa corsia dove mio padre era morto, forse sulla stessa tavola dov'egli sub un'operazione inutilmente e da cui si vedeva, giacendo, la cupola di San Pietro, avevo smarrito, rinnovandomi, gran parte del mio furore nativo. Con questa non lieve, ma forse provvidenziale caduta, si chiudevano i miei primi quattro anni di vita romana e addirittura la mia giovent.
Sopraggiungeva il 1911 Anno fatidico, cinquantenario della nostra Unit nazionale. Molte cose accaddero in quelL'anno. Fra l'altro, nell'estate del 1911, il mio giornale, che era, per chi non l'avesse ancora capito, "L'Avanti!", si trasfer a Milano. Io avevo facolt di seguirlo. Nel caso contrario mi sarei dovuto contentare d'una modesta indennit limitata alle risorse di un'amministraZione in rovina. Scelsi l'indennit. E ne approfittai per cambiare strada, per interrompere una carriera intrapresa con troppo impeto. Fu allora che lasciai Roma una prima volta e me ne andai a Firenze, a ricominciare la mia vita da capo, fra i pragmatisti, gl'idealisti, i socratici, i tomisti e i teosofi del caff Paskowski. ANNI DI GIOVENTU' I primi quattro anni della mia residenza a Roma formano un ciclo assai ben concluso e felice nella mia vita, nonostante le mie misere condizioni economiche e le strane occupazioni a cui dovetti piegarmi. Furono anni di giovent, incommensurabili e pieni di vicende. Posso dire di non averli sprecati. In quei quattro anni conobbi il mondo e specialmente Roma in tutti i suoi aspetti, dai pi bassi ai pi alti. Fui occupato e disoccupato, intento allo studio e dedito ai pi sbrigliati divertimenti. Passavo da una condizione all'akra sentendo che tutto era prowisorio e guardavo il mondo come si guarda il paesaggio in ferrovia. Non era possibile umiliarmi in quel tempo. Andavo per la mia strada e sarebbe stato difficile influire sul mio destino. Io fui la delusione di tutte le belle anime che avrebbero voluto mettermi sulla buona via, non avendo fretta di arrivare a niente, non sapendo neppure io a che cosa mirassi. Ricordo un periodo lunghissimo trascorso intorno al Colosseo, senza mai uscire da quelle parti dove avevo ufficio, casa, trattoria e qualche vaga attrattiva amorosa. Fu allora che, sui prati dell'Orto Botanico, feci la mia prima lettura di Shakespeare nella traduzione del Rusconi: una lettura che ripresi pi tardi, in una ottima e scrupolosa traduzione francese, e tenne occupato il mio spirito per un paio d'anni. Ragione per cui probabile che io conosca Shakespeare abbastanza, per quel tanto che un poeta pu essere conosciuto mediante una traduzione. In quell'epoca scrissi anche una commedia intitolata: "Per diverse vie". Come l'ebbi sottoposta ad un capocomico, L'uomo del mestiere cap a fiuto quanto poco valesse la pena di leggere quel copione. Si limit dunque a prendere atto del titolo e restitu il lavoro spiritosamente, dicendo: "Per diverse vie... Lui faccia la sua, io faccio la mia". Questa commedia l'ho smarrita, insieme con una lunga novella e un dialogo filosofico scritto in tempi ormai pi maturi, da cui scaturirono alcune pagine del mio primo libro. Lo avevo intitolato "L'ultima lezione dello scettico", ed era forse niente altro che un risentimento dell'"Apologia di Socrate" e del "Fedone". Di tutto ci che posso avere scritto in quel guazzabuglio lirico-fisolofico rimangono le pagine che ho dette, alcuni versetti coi quali si apre il mio libro di poesie ("La speranza nelL'opera ecc.") e una frase inedita che mi si vorr permettere di salvare dal provvidenziale naufragio: "Lasciate che
venga l'ora della passione e vedrete come il genio lucido e ragionativo". Io capitai a Roma troppo tardi, sulla fine di un'epoca. Il carnevale romano tramontava fra le scoppole che ricevevano al Corso, il Gioved grasso e Marted grasso, tutti coloro che si lasciavano cogliere in bombetta. I nuovi tempi urgevano. E fu un miracolo se potei conoscere certi aspetti di questa citt, destinati a sparire con le prime demolizioni, coi primi slarghi, abbellimenti e spostamenti del 1911. Ricordo via del Tritone strettissima e trafficatissima, il Traforo ancora sgocciolante, essendo stato aperto al pubblico un anno avanti la mia venuta nell'Urbe, e via Nazionale, dal Traforo in su, alberata, coi sedili fra un albero e l'altro. Dove ora sorge la Galleria di Piazza Colonna c'era un grande spiazzo ghiaioso, con una celebre osteria per forcstieri, gi in fondo. E proprio in uno dei primi giorni che stavo a Roma, verso la mezzanotte, vidi uscire da quella osteria uno strano personaggio con un cappellaccio all'Ernani, inferraiolato come Amleto nella scena del cimitero. Alto, diritto, maestoso, percorreva, in direzione di San Claudio, L'immenso sterrato solitario, in penombra, ed io, dal marciapiedi del Corso, lo vedevo incedere come su un palcoscenico. A un tratto una donna elegantissima, di alta statura, uscita anch'essa dalla taverna, lo raggiunse e lo schiaffeggi. Ma l'uomo dal mantello seguit a camminare impassibile, senza neppure volgere lo sguardo alla sua schiaffeggiatrice. Il mio eroe cadde di colpo nella mia stima e non si pi rialzato. Pi tardi potei identificarlo. Era Gordon Craig, famoso scenografo inglese, di gusto preraffaellita. E colei che lo aveva percosso, anzi demolito ai miei occhi di provinciale appena inurbato, credo fosse Isadora Duncan, sua amante. Mi era toccato probabilmente di assistere ad una scena di gelosia, dovuta al vino di Frascati, che gli stranieri usano bere senza prudenza come se fosse birra. Ma ne derivai un'impressione cos sgradevole, per via di quegli abiti onde lo schiaffeggiato s'ammantava, che non ho mai potuto prendere sul serio Gordon Craig, n la sua scenografia, neppure quando ebbi tra le mani una raccolta dei suoi poco esemplari bozzetti. Ho sempre visto in lui un uomo che portava un mantello abusivamente. Di tipi che vestivano come Gordon Craig ce n'erano a bizzeffe nella Roma di quei tempi. S'incontravano specialmente a Piazza di Spagna, via del Babuino, via Margutta, Piazza del Popolo. E non stonavano affatto in quella cornice settecentesca e neoclassica, in quel quartiere gi detto fiammingo, ben noto per i suoi "studi" di artista, le sue botteghe di antiquari, le fioraie ciociare, e due vecchie modelle incartapecorite, coi capelli di stoppa, che lo hanno bazzicato e direi quasi caratterizzato per lungo evo. Fra le pitture polverose del Caff Greco e i busti del Pincio si potevano vedere, negli anni della mia giovinezza, le ultime basette, gli ultimi collettoni e cappelloni dell'Ottocento. Cominciarono a diradarsi alla fine del 1911, mentre il loro secolo moriva, con un po' di ritardo, nelle esposizioni di Valle Giulia. Ma ora qui voglio ricordare, di quegli stessi anni, un personaggio pi serio e caratteristico. Fu la mia
prima guida per le vie di Roma, colui che m'insegn a distinguere i diversi stili e le epoche dell'architettura delL'Urbe. A lui devo le mie prime cognizioni in materia. Era uno dei pi sollazzevoli frequentatori della Terza Saletta di Aragno e i suoi amici lo dicevano scherzando "la foca sapiente", essendo egli di pelle olivastra, grasso, trasudante olio come una foca o un leone marino, e capace di recitarvl a memoria interi canti dell'"Eneide", di snocciolare per ordine cronologico i nomi di tutti i Papi. Soffriva d'insonnia. Motivo per cui lo s'incontrava nelle ore migliori, nelle ore delle confidenze. Capitava in Terza Saletta, di sera, quando su quei divani di velluto giallooro non rimanevano che alcuni giovani un po' lontani dalla sua cerchia, ed io L'accompagnavo talvolta all'"Umberto", celebre ristorante romano, oggi scomparso, dov'egli cenava, per solito, dopo la mezzanotte. Uomo di grandi amori e di grandi fobie. Bastava nominargli Corrado Ricci per vederlo andare in bestia. Non so perch odiasse tanto Corrado Ricci. Era stato, anni prima, funzionario alle Belle Arti, quindi "epurato" per scarso rendimento, in seguito a una storica inchiesta fatta sul personale della Minerva, e pu darsi che attribuisse al proprio ex-direttore quella piccola disgrazia o vergogna che pesava sulla sua incolpevole vita di figlio di famiglia ormai quarantenne. Abbastanza ricco, ma di figura tutt'altro che vantaggiosa, fuorch nelle proporzioni, trascurato nel vestire, precocemente calvo, con una gran barba corvina e fitta, che poi mi pare si togliesse, con gli occhi sempre un po' rossi, da fratacchione uso alle veglie, sentiva di non poter piacere alle bramatissime donne. Questo era, in sostanza, il suo dramma, il motivo segreto di tutta la sua inquietudine e della sua buffa e dolorosa esistenza, ci che lo indusse infine a diventare, pi che amico, protettore, paladino d'un altro frequentatore della Terza Saletta che poteva dirsi, per i suoi felici rapporti col bel sesso, il contrario assoluto di lui: un uomo di mondo, elegantone, un po' equivoco, e fortunato con le donne. Guai a chi gli toccasse questo amico del cuore che non aveva alcun rapporto con la cultura e per il quale non avrebbe esitato anche a battersi in duello. Stimo questo esempio di amicizia bellissimo. Mi piace creder vera la voce che si diffuse a suo tempo: cio che la persona di cui ho parlato lasciasse, morendo, tutte le sue sostanze a questo suo diversissimo sozio. Ricorder sempre con affetto il bizzarro erudito che coonest con la sua dottrina la lunga esperienza che io avevo gi fatta di Roma, negli anni in cui la mia sola casa era la citt stessa, questa reggia favolosa che i Papi costruirono a consolazione dei derelitti. Penso talvolta a tutte le famiglie di cui sono stato inquilino, io che non ho famiglia. una materia scottantissima. Ci sarebbe da scrivere un romanzo. Va bene che, in fondo, io non ho conosciuto se non famiglie d'affittacamere, oppure talmente disordinate ed incaute da ammettere con facilit persone estranee nel loro seno. Ma non detto che
siano le meno cristiane e neppure le meno interessanti per quel che concerne la vita domestica. Fatto sta che a questo proposito credo di saperne pi io che molti padri di famiglia. E mi sono scoperto strane attitudini alla vita casalinga. Ho gustato per lunghi periodi, specie in paesi lontani, in luoghi di villeggiatura, tutti i piaceri e gli svantaggi d'una tale vita, pur essendo il perfetto contrario di quel che si dice un amico di casa. Sono passato in mezzo a una quantit di famiglie come uno straniero, un pellegrino o, se volete, un vagabondo, lasciando per sui miei passi, se l'amor proprio non m'inganna, quasi sempre dei buoni ricordi. Le mie padrone di casa, quando io sar morto, potranno testimoniare della mia discrezione e delle mie fatiche. E qualcuna vi dir che nel momento in cui mi licenziavo da lei scoppi in lacrime, dopo avermi trattato malissimo per tutto il tempo della mia dimora. Un'altra potrebbe parlarvi del mio disgraziato amore verso una delle sue giovanissime figlie; e la pi antica di tutte, quella che rammento come un sogno, nella luce conventuale d'una vecchia casa di Roma, delle legnate che le somministrava suo padre, per essersi, come dire?, invaghita del suo imberbe inquilino ch'era lontanissimo dal sospettarlo e dal rendersi ragione, per conseguenza, di quelle busse cos frequenti. Una sola delle mie tante padrone di casa potrebbe raccontarvi, se fosse ancora al mondo, un doloroso episodio che non torna a mio onore. Ero allora molto giovane, stavo a Roma da poco tempo, e abitavo nelle vicinanze della stazione, presso una signora calabrese, vedova e con un solo figlio, impiegato e poeta. Dormivo in un camerino che riceveva luce e fumo dalla cucina. Il giovane poeta, uso a rincasare molto tardi, si tratteneva spesso in cucina, prima d'andare a letto, per farsi la barba. Girando la chiavetta della luce elettrica illuminava di necessit la mia stanza. Onde io, non ancora addormentato, aprivo gli occhi, e mentre lui si radeva, davanti a uno specchietto appeso alla cappa del camino, mi perdevo a immaginare le sue serate, le sue splendide serate nella Roma di quegli anni, tutta risonante di successi letterari e teatrali. Perch questo poeta io lo conoscevo gi di nome, anzi di pseudonimo, e potete figurarvi la mia meraviglia nel trovarmi sotto il suo tetto, la considerazione e il rispetto che avevo per lui. Eppure, se fossi stato un po' meno sulle nuvole, avrei dovuto capire che la sua vita non era cos felice come io fantasticavo. Fra l'altro mi sarei accorto, dalla sua faccia scavata e terrea, ch'egli era condannato da un male che non perdona. Infatti, due o tre settimane dopo il mio ingresso in casa sua, col sopraggiungere dell'autunno, L'idoleggiato poeta, a cui non mi legavano che le mie ingenue fantasticherie, si allett per non pi rialzarsi. Io lo sentivo tossire di l dalla fragile parete che separava le nnstre due camere. E quei colpi di tosse, a poco a poco, invece di muovermi a compassione o, per meglio dire, insieme con la compassione che non potevo non avere per quel giovane sventurato, fecero nascere in me un sentimento di rancore profondo verso la casa che mi ospitava Pensavo con terrore e ribrezzo alla eventualit che la
madre dell'infelice mettesse nel mio letto i lenzuoli del figlio. L'aria del mio camerino, gi cos poco sana, la sentivo ormai infetta, irrespirabile. Mi consideravo tradito. E tutto il mio segreto malanimo si riversava su quella povera donna che m'aveva ricevuto nel proprio domicilio, ben conoscendo le condizioni del suo figliolo. Ma se lasciassi credere ch'io fossi dominato da una semplice e fredda preoccupazione d'ordine igienico darei un'idea molto piatta e meschina del mio stato d'animo. Davanti a quella brutta avventura che m'era capitata si ridestava in me un antico, infantile orrore verso certe forme di malattia. Ero ancora fresco di campagna. Credo che io debba essere perdonato per quel che ho detto e dir in seguito. La giovent spesso egoista e crudele senza saperlo. Io non avevo allora altro bene che la salute e lo difendevo oscuramente, irrigidendomi di fronte al male, con la incoscienza propria di quell'et. Nondimeno mai mi pass per la testa di cambiar casa. E questa una contraddizione che non saprei spiegare neppure con la povert; giacch, volendo, avrei potuto procacciarmi le poche lire che mi occorrevano per lasciare il mio non raccomandabile alloggio e cercarmene un altro. Perch rimasi? Forse per pigrizia, imbarazzo, rassegnazione? Oppure fu un motivo pi nobile, come chi dicesse delicatezza, che mi viet di sottolineare troppo apertamente, con la mia diserzione improvvisa, la sciagura di quella casa? Certo che rimasi; e niente lasciai trapelare dei miei sentimenti, che soltanto una madre meridionale poteva intuire. Un odio silenzioso e tremendo si stabil fra me e lei, specialmente da parte sua. Evitavamo di vederci, di parlarci. E in queste condizioni, ahim, il tempo seguit a correre senza che io trovassi la forza e il momento di bussare alla camera dell'infermo per fargli una visita. Non per timore di avvicinarmi a lui (L'aria sua la resplraVO gi abbastanza) ma per quell'oscuro stato di disgrazia in cui ero caduto. Di giorno in giorno i rapporti tra me e sua madre si facevano pi cupi. E con quale animo sarei andato al suo capezzale? Inoltre, bisogna pur dirlo, lo non ero e non mi sentivo l dentro che un misero e passeggero inquilino. Vedevo, assistevo, soffrivo quella tragedia da estraneo, fra le pareti del mio stambugio che non mi avrebbe permesso di trastullarmi in casa durante il giorno, quand'anche lo avessi potuto e desiderato. Passavo perci le mie giornate fra il lavoro, la biblioteca, i caff, i teatri, affrettandomi, la mattina, ad abbandonare il mio triste covo prestissimo, per non tornarvi che a sera tarda, soltanto per coricarmi. Questa era, del resto, la vita doverosa d'un subinquilino a Roma, in quegli anni. Vita furtiva, evasiva, e un po' maledetta, che pareva esente da ogni obbligo di carit e di religione. Stare in casa il meno possibile era il primo dovere d'un poveraccio che abitasse una camera in subaffitto. Spesso fra lui e i suoi appigionanti non esisteva nemmeno la consuetudine del saluto. Ecco dunque in che modo, poco pi che ventenne, sbalestrato, ignaro delle convenzioni sociali, non supponendo di avere verso chi mi alloggiava altri impegni fuorch di pagare la pigione, potei commettere il grave errore di cui mi accuso e che, d'altra parte, scontai caramente. Giacch una mattina la mia piccola e scarna padrona di casa, veden-
domi sbucare dal camerino e avviarmi come un ladro verso l'uscita, mi ferm sul corridoio coi pi acerbi rimproveri. Stava ritta in mezzo alla cucina e, senza fare un passo per avvicinarmi, deplorava ad alta voce la mia mancata visita al figlio, ma con un tono che diceva come quel rimprovero, cos giustificato, non fosse, in realt, che un pretesto. Non di una semplice infrazione alle buone e caritatevoli usanze quella madre si doleva, ma di tutto ci che le nascondevo e che lei aveva benissimo indovinato e lungamente sofferto in silenzio. Le sue veementi parole erano un'appassionata reazione al mio tacito cruccio, alle mie ragioni inammissibili, all'inconcepibile idea che io potessi non curarmi che della mia salute e avere persino qualche obbiezione da fare mentre suo figlio moriva. Un'immensa piet inteneriva la sua voce, nominando la sua creatura. Ergendosi di fronte a me con tutta la forza e la maest del suo dolore materno, la disgraziata vedova, costretta ad affittare un piccolo vano del suo modestissimo appartamento, sembrava, direi quasi, reclamare il diritto di avere un figlio malato e il dovere da parte mia di una solidariet che in quell'et selvaggia non potevo concederle. Le nostre due posizioni erano orribilmente scoperte. E mentre questa indescrivibile scena accadeva, il giovane tossiva nella sua stanza ed io lo sentivo ormai cos lontano, cos poco esigente, cos estraneo a quel dibattito orrendo, che mi sarei messo a piangere se mai avessi avuto, in vita mia, le lacrime facili. Non ricordo come fin questo scontro inatteso. Credo per che lo sopportassi in silenzio. E di l a poco me ne andai da quella casa; non prima tuttavia d'aver riconosciuto il mio torto, chiesto perdono all'affranta donna, e fatta la mia triste visita al figlio. Me ne andai. Ma non per le ragioni che si potrebbero immaginare. La verit che, rimasto a un tratto disoccupato, fosse provvidenza o castigo, non ero pi in condizione da permettermi il lusso d'un camerino. S'inizi allora un periodo che, per circa un'annata, non sapendo come sfamarmi, dove dormire, potei respirare, sia di giorno che di notte, un'aria fin troppo libera e pura. Ho avuto padrone di casa un po' dappertutto: a Roma, a Milano, a Venezia, a San Remo, sul lago di Como, a Lugano. Senza contare le proprietarie di trattoria o di pensione con le quali sono stato a contatto. Soggiorni, per lo pi, brevi ma intensi, confidenziali, e qualche volta assai felici come quell'estate che trascorsi in un paesucolo sopra Cernobbio, presso una famiglia il cui capo era a Londra a fare il cuoco. Intorno a me non c'erano che donne e bambini, tutti affezionati e servizievoli, salvo il pi piccino che non voleva riconoscermi della nidiata e col quale ebbi subito uno scontro fierissimo. Il paese dove abitavo non un paese, ma un gruppo di case posto sulla via del Bisbino. Vede il lago dall'alto, fronteggia una montagna nuda e orrida, detta l'Inferno, e sovrasta quell'albergo per miliardari che Villa d'Este. Come io capitassi a Cernobbio sarebbe un po' difficile dire. Ci andai sulle tracce di una bellissima ragazza straniera, conosciuta a San Remo l'inverno precedente ma soltanto di vista, la quale, all'inizio della primavera, aveva lasciato il suo lussuoso albergo sanremese, per trasferirsi a Villa d'Este. Non avendo nessuna
speranza e quasi direi nessun desiderio di avvicinare questa creatura straordinaria, usa a trascorrere la sua splendida e malinconica esistenza in luoghi come quelli che ho nominati, mi contentai di seguirla, con tutta la discrezione che il caso richiedeva, e fissai la mia dimora in un sito da cui potessi vederla almeno col cannocchiale. Sono cose che si leggono, senza buttar via il libro, nei romanzi. Non capisco perch non dovrebbero succedere nella realt. Questa fanciulla stupenda che mi vide per due intere stagioni sui suoi passi, da una stazione climatica all'altra, e che poi torn a incontrarmi a San Remo, senza mai fare una mossa villana, una risata, un gesto d'impazienza, uno dei pi squisiti ricordi della mia vita, un ricordo consegnato alla poesia, giacch uno sfogo poetico, in tali circostanze, non poteva mancare, e qualcuno forse conosce un mio componimento in prosa ritmata, che s'intitola "Polacca" dove appunto, con la vaga intenzione d'ispirarmi alle "polonaises" di Chopin, cercai di dipingere la figura, il passo e il trasparente carattere di questa indimenticabile sconosciuta. Ma il bello che una volta a Cernobbio la persi quasi di vista. Nel grande albergo del lago di Como ella si era sepolta ormai come in un chiostro. Poi and a San Pellegrino, a Salsomaggiore, ed io fui talmente distanziato dalle sue abitudini che se penso a quell'estate le prime cose che mi vengono alla mente non riguardano lei, bens il paesaggio, le persone in mezzo alle quali vissi per alcuni mesi, come in famiglia, e soprattutto la mia padrona di casa, creatura di nessuna avvenenza. Anche di costei ho gi parlato, ma in una lirica paginetta che ho perfino esclusa dalla ristampa d'un mio vecchio libro, e ora vorrei tornare a discorrerne un po' pi distesamente e alla buona. Era una donna di media statura ed et, magrissima, brutta, sdentata, ma singolarmente estrosa e vispa. Non credo che prima di me avesse ospitato altre persone in quella sua bianca villetta nuova nuova e sonora, che forse era il frutto dei guadagni di suo marito e che, occultando la vista del panorama ad un suo vicino, aveva creato fra lei e quest'ultimo una situazione abbastanza fastidiosa. Tanto che anch'io, innocentissimo, fui perseguitato dall'astio di quel possidente a cui avevano tolto il diletto di poter guardare non so che punto del paesaggio dalla sua finestra. Ma tralasciamo certi particolari. Atteniamoci alla mia piacevole appigionante, la quale era degna di considerazione per diversi motivi. Donna di casa perfetta, moglie d'un cuoco, sapeva improvvisare su due piedi una piccola cena gustosissima, facendo ballare le patate sulla padella con un'arte incomparabile, e lavorava dalla mattina alla sera come un'ape operaia. Con tutto ci le rimaneva tempo a sufficienza per osservare quel che si dice il creato, le vicende meteorologiche e stagionali, alla maniera contadinesca, e non gettava mai gli occhi sul lago, sui monti, senza dirne qualcuna delle sue. L'estate procedeva spietata, senza il conforto di un po' di pioggia. Schiudendo un tantino la porta sulla terrazza, a mezzogiorno, si vedeva il lago, glU sotto, bollire, in un'aria fumida e rossa, come la pegola dantesca. La notte, in camera, non si riusciva a tirare il fiato. E per tutta quella stagione la mia fantastica padrona di casa non fece che vagheggiare temporali e piovaschi. Sentiva la pioggia nel vento che passava, la vedeva nelle
acque del lago che, secondo lei, erano cresciute (n so come facesse ad accorgersene a tanta distanza) in una nuvola nera che si posasse sulla luna. Certe sere, illusa da uno di questi segni, si metteva ad aspettare lo scroscio alla finestra come un'innamorata. Eccola a un tratto serrare porte e vetri quasi che da un momento all'altro la tempesta dovesse scardinare la casa. Poi di l a poco sospirava: " passata". Oppure, in tono rassegnato e nostalgico: "Vuol dire che va a piovere su in Val d'Intelvi. Deve aver piovuto su in Val d'Intelvi". Questo nome beato risuonava spesso al mio orecchio e a poco a poco io finii per immaginarmi Val d'Intelvi come un luogo ideale, perpetuamente rugiadoso e fiorito. I miraggi e le nostalgie della brava massaia perseguitata dall'afa mi si comunicavano. Ma una notte si scaten finalmente dalle nostre parti un vero diluvio. Alla mattina l'aria era ventilata e freschissima, il cielo netto, squillante. E udii la mia donna, che venuta alla finestra, per non so quale faccenda, notava allegramente: "I monti si sono avvicinati". Si arriv cos ai primi di agosto, quando l'estate, specie in Lombardia, accenna a declinare. Allora, una sera, inginocchiandosi davanti al fuoco per prepararmi la solita cena, se ne usc in questa bellissima osservazione: "Ma dio, gi si conosce che le giornate si cominciano a scorciare". Aveva il dono di esprimersi questa donna. Parlava a scatti, a sussulti, con una invidiabile propriet di linguaggio e una fantasia che non saprei definire altrimenti se non settentrionale e romantica. Degna di una ballata di Burcher quest'immagine che le scapp un giorno di bocca, sentendo correre, su e gi per le scale, il suo irrequieto bambino, calzato di zoccoli: "Quando si muove lui pare J'Anticristo a cavallo". In genere per non si esprimeva per immagini, ma con parole semplicissime che ricevevano tono e valore dal grande impeto con cui le pronunciava. Quelle parole, senza che lei se ne avvedesse, le costavano molto. Il suo fragile corpo appariva tutto squassato dal suo tempestoso discorrere. Era difficile competere con lei nel litigio. Poteva diventare facilmente una furia. Allora i gesti pi strambi e demoniaci gareggiavano con le parole. Credo che avesse pure qualche facolt medianica, perch un giorno, mentre me ne stavo in camera, occupato a buttar gi alcune annotazioni sopra di le-i, ronzava fuori delL'uscio, avendo intuito, non so come, L'oggetto del mio lavoro N a credere che fra me e lei potessero correre dei sensi amorosi. Almeno io non me ne accorsi Ma il fatto che, a poco a poco aveva finito per interessarsi del proprio inquilino ed io non mi stancavo di studiarla come un entomologo pu studiare una farfalla. La curiosit che destava in me era del tutto letteraria, etnica, filologica. E fu cos che, osservando il suo carattere, mi parve di capire meglio Manzoni, i suoi personaggi e le sommosse ch'egli descrive. Era insomma un buon campione della razza lombarda, anzi comacina: razza ch'io non m'attenter di definire, ma che certo assai vivace, risentita e perfino talvolta, specialmente nelle campagne, un po' spiritata. Certe sere splendeva sul lago una luna da Sabba classico. Allora, con una mezza bottiglia di Barbera in corpo, io
mi divertivo a erudire la mia rozza e insonne ospite intorno ad alcune diaboliche facezie del "Faust". E bisognava sentirla e vederla ridere. Con quell'unico dente in bocca, pareva proprio una Forcide, una delle tre figlie di Forco, rimaste a guardia della reggia degli Atridi, dopo il compimento dei fati: le quali possedevano, fra tutte, un solo dente e se lo scambiavano a vicenda. Eppure quest'amabile strega, di grembo angusto e apparentemente infecondo, si ornava, come ho detto, di una quantit di figli, e se il suo uomo non fosse stato a Londra avrebbe continuato ad essere non meno prolifica che laboriosa e intenta a seguire il tempo, i fenomeni cosmici, umani e sociali, tale essendo la sua prodiga e operosa natura. Da una quindicina d'anni ormai, stanco di vagabondaggi e di nuove esperienze domestiche, abito in un quartiere moderno di Roma, poco lontano dal centro. Il Tevere separa il mio domicilio dai luoghi che sono solito frequentare di giorno e segna, per cos dire, il limite fra me e il mondo. Una distanza minima in apparenza, ma in realt incalcolabile. Coloro che abitano ai confini estremi dell'Urbe, in vista dei Colli albani o del Soratte, i nababbi dei Quartieri Alti, non avranno mai quel senso di allontanamento e distacco dagli affari cittadini che, per il fatto di dover attraversare un fiume, posso avere io ogni sera, tornando a casa. Tutti sanno che cosa vuol dire un fiume, specialmente in citt: le distanze che crea, le differenze che serve a stabilire fra un luogo e l'altro. Ogni sera, tornando a casa, io ho il senso di varcare una frontiera, di rientrare quasi nei miei domini. Credo che niente s'accordi meglio coi pensieri e con lo stato d'animo d'un uomo che torna, un po' stanco, al suo domicilio, o ne esce agguerrito, quanto il dover passare un corso d'acqua. Lo dice anche lo stornello romano: "Ve d la bona sera e passo ponte". Questo uno dei principali motivi per cui a me piace e mi diverte abitare in Prati. Il ponte che percorro abitualmente quello che ha sostituito l'antico traghetto di via Ripetta, da cui si scorge di notte, in tempi normali, il faro dai tre colori che splende sulla vetta del Gianicolo: bellissimo saluto all'inizio del pi pittoresco, del pi trafficato fra i ponti romani moderni. Tale passaggio dilettevole appunto perch trafficato. La gente che vi s'incrocia sui marciapiedi va lesta, senza tuttavia rimaner sorda alla preghiera del mendicante che proprio a questo varco ti aspetta per farti pagare il pedaggio; poich, a parte che a Roma ben di rado si nega un obolo a chi lo chiede, le persone che attraversano un ponte sono singolarmente disposte alla carit. Su questo ch'io dico, in certi giorni d'inverno, con tramontane fortissime, si possono vedere eleganti signore frettolose arrestarsi, togliersi il guanto con cura e cercare a lungo nella borsetta una sperduta monetina da regalare a un cieco, a una madre implorante. Sono spettacoli che non disdicono alla caritatevole Roma, avventure che capitano sui ponti Quel senso di vuoto, da cui siamo colti l sopra, ci richiama, si direbbe, alla precariet della vita La vista del fiume ci dismemora, ci alleggerisce. E guai a noi se cedessimo alla tentazione di affacciarci su quelle acque che gorgogliano con-
tro i piloni, si inabissano sotto i nostri piedi, per tornare di l dal ponte, a fluire tranquille, ineluttabili. A forza di guardare l'abisso, dice Nietzsche, finirai per cadere nell'abisso. Ah, com' incredibilmente attirante seguire il corso d'un fiume, sdraiarsi con la fantasia nel suo letto! Forse per questo le persone che rimangono troppo a lungo affacciate ad un ponte destano sospetti. Occorre andar lesti nella divertente e vertiginosa atmosfera fluviale. Poco pi gi, verso San Pietro, le sensazioni che d il Tevere sono indubbiamente pi ricche, le sue sponde pi ridenti il paesaggio pi illustre. Ma l la natura sopraffatta dal costume, dalla storia. Passando di notte per Ponte Sant'Angelo non puoi far a meno di pensare a Marozia, ai Crescenzi, a Ottone III, al Giubileo dantesco, a Cesare Borgia, e magari a quel povero babbeo del cardinal Vitelleschi, mio celebre concittadino, il quale, da vicario del Papa, capitano della Chiesa, terrore del popolaccio romano e dei baroni laziali e marchigiani, fin a un tratto prigioniero in Castello, per un inganno tesogli dal castellano sul ponte levatoio, mentre marciava alla testa d'un esercito di quattromila fanti e duemila cavalli. Vedete quanti ricordi, quali pensieri, pu suscitare, nel fuggevole transito, uno di quei ponti religiosi e monumentali della vecchia Roma, che fanno di tutto per nascondere la loro essenza e l'infido elemento che scorre l sotto. In Prati invece il Tevere non ha storia. E un fiume come tutti gli altri, un fiume da canottieri, scortato da grandi alberi frondosi e queruli, sorvolato spesso, in pieno inverno, da nuvoli altissimi di stornelli, e non porta se non messaggi del tempo che fa sui monti. Guardandolo di sfuggita non nel senso della deriva, ma controcorrente, io penso alla valle tiberina, alle belle campagne umbre, ai pascoli che l'almo fiume lambisce nel suo percorso. E a quel modo che le sue acque argillose, ombrate di verde, mi ricordano costantemente la terra etrusca, le sue catastrofiche piene mi rallegrano come la visita di qualche mio compaesano. Quel po' di contatto che, vivendo in citt, riesco a mantenere con la natura, con le stagioni, con le mie proprie origini, lo devo insomma a questo modestissimo ponte che sono costretto ad attraversare due volte al giorno. In esso per me il simbolo del passaggio e della distanza. Tanto che, a volte, indipendentemente dal sole e dai venti che lo flagellano, mi sembra che tutta la fatica del mio cammino consista nel sorpassare quel breve tratto e prendo un autobus o una carrozzella soltanto per andare da un capo all'altro. Quando io esco di casa e vado verso la societ, verso il mondo, il Tevere , ai miei occhi, una specie d'Acheronte, da pensarci due volte prima di varcarlo, ma al ritorno, di notte, un vero Lete. Giunto all'altra riva non ho pi memoria di quel che mi sono lasciato alle spalle e niente di spiacevole potrebbe pi capitarmi, se non fosse uno strano incontro, che faccio regolarmente, col guardiano d'un grande negozio di mercerie situato sul mio cammino. Ci vediamo da anni e anni e costui non s' ancora convinto, si direbbe, che io non sono un ladro, anche se ho l'abitudine di rincasare ad ore piccole. Lo trovo quasi sempre seduto e
sonnecchiante nel vano d'un ingresso del negozio: quello d'angolo, che d su una via trasversale, poco illuminata. Ma basta che mi veda o senta i miei passi perch si alzi battendo i piedi sul selciato come un cavallo che aombra e faccia la sua brava ispezione alle numerose vetrine del popolare magazzino e anche alle saracinesche di qualche bottega pi su; la qual cosa gli permette di pedinarmi per un buon tratto senza che io abbia motivo di risentirmi o di protestare. Il buon guardiano fa il suo dovere. Chi potrebbe impedirglielo? Ma per quale singolare associazione d'idee si rammenti del suo dovere quando passo io, un mistero che vorrei chiarire. Intanto chiaro ch'egli si giova di me come d'una sveglia. Il brav'uomo approfitta del mio passaggio, per controllare le sue vetrine, allo stesso modo che le massaie di Konigsberg, scusate il richiamo forse un po' orgoglioso e non del tutto appropriato, aspettavano il ritorno di Kant dalla sua passeggiata mattinale per buttar gi la minestra. E questo accade immancabilmente. E una persecuzione, un incubo notturno a cui potrei sfuggire soltanto sobbarcandomi a sacrifici maggiori, cio a condizione di cambiar itinerario, passando per un ponte che non mi garba affatto oppure per una triste via alberata e sbagliatissima, dove non si vede mai nessuno e che io evito di notte come di giorno. Inutile dire che preferisco l'incontro col povero guardiano occhialuto, che non riesco a odiare, nonostante me ne dia, da tanto tempo, cos fondato argomento. Sul portone di casa m'imbatto, di solito, in un altro personaggio che s'interessa di me senza darlo a vedere e sta in agguato del mio ritorno per motivi assai pi familiari e comprensibili. Questo personaggio non possiede le chiavi del suo paradiso. E il gatto del mio cortile, un vecchio gatto forastico e ciondolone, con una grossa faccia baffuta da Gatto Mammone. Venne tempo fa dalla Toscana, col nuovo portiere, e si subito meravigliosamente acclimatato attorno a quell'aiuola che fiorisce in mezzo al cortile, della quale ha fatto la sua giungla. Non ho intenzione d'indugiarmi a lungo sopra le sue malefatte notturne e diurne. Mi limiter a dire che tutti i disordini, tutti i rumori sospetti che, trascorsa una certa ora possono allarmare la quiete di questo decoroso e vigilatissimo fabbricato, dandovi la sensazione pi certa che la notte, qua dentro, cominciata, sono da attribuire alla sua irrequieta e demoniaca presenza. E lui che funesta le mie lunghe veglie d'inverno coi suoi amori dannati, che mi fa trovare, al mio ritorno in casa, il secchio delle immondezze scoperchiato e rovesciato sulla soglia, che tresca fra i vasi allineati su un muro, sotto la mia finestra, facendone cadere sempre qualcuno e fuggendo, in quell'atto, spaventato. Spesso, purtroppo, mentre sono gi nel cortile e sto per raggiungere un porto sicuro, il colpevole e diffidente animale, sbucando non si sa chi dove, mi taglia la strada alla voltata, o si fa cogliere a frugare in qualche secchio, su un pianerottolo, la qual cosa lo induce a svignarsela catastroficamente, saettando fra le mie gambe, gi per le scale, con una di quelle formidabili fughe che fanno venire la pelle d'oca a chi ha la disgrazia di suscitarle.
Con tutto ci io e lui siamo amici, senza dimostrarcelo troppo, alla maniera gattesca. Abbiamo, com' facile intendere, alcune cose in comune. Entrambi abituati a vegliare di notte e a dormire il giorno, ci si scontra in quelle ore quando l'addormentato e spettrale edificio sembra non avere altri abitatori che noi due. Come avremmo potuto, alla lunga, rimanere indifferenti l'uno all'altro, non venire, diciamo cos, a un compromesso? E una sera che pioveva e io rincasavo pi tardi del solito capii chiaramente come questo gattaccio, apparso da poco nel mio cortile, m'avesse gi fiutato, si fosse reso conto appieno del ritmo della mia esistenza e nutrisse nei miei riguardi persino un certo affetto, forse in omaggio alla regolarit delle mie abitudini e al mio felino attaccamento ai luoghi. Se ne stava al riparo, accucciato, sulla soglia d'una bottega, a un passo da casa mia. L per l non lo riconobbi e m'avvicinai per accarezzarlo. Allora egli apr la bocca, e fu con un senso di piacevole sorpresa e ribrezzo che io vidi rilucere, nelL'oscurit e nella pioggia, due bellissime fauci color rosa. M'affrettai a ritirar la mano temendo che volesse mordermi. Invece se ne usc in un gnaulo inatteso, indefinibile, che era un vero e proprio rimprovero. Non so se mi sbaglio, ma ebbi l'impressione che mi rimproverasse d'esser tornato cos tardi, come se fra me e lui esistesse non so che tacita intesa. Rimasto chiuso fuori, esposto all'acqua, elemento odiosissimo per un gatto, a quanto si pu giudicare, stava l ad aspettarmi. Infatti, appena mi mossi verso il portone, salt gi dalla soglia, mi segu come un cagnolino e approfitt del mio ingresso per rientrare nei suoi possedimenti. Quasi ogni notte accadono cose del genere. Sia che lo tormenti il desiderio d'entrare o d'uscire, spesso e volentieri, tornando a casa, lo trovo sul portone o dietro. Io gli do il passo naturalmente. Come uno che capisce a fondo i motivi di queste sue capricciose e polemiche voglie, cerco di venirgli in aiuto con la massima discrezione, con tutta l'accortezza che necessaria per non insospettirlo, essendo assai difficile, come sapete, rendere un servizio a una bestia e in particolar modo a un gatto. Ed egli mi ripaga qualche volta, nell'atto in cui, riconquistato il suo caro cortile, s'avvia, con dissimulata impazienza, verso l'arboreo nascondiglio, rispondendo al mio richiamo con una regale alzatina di coda. Qui tutto. Eccovi presentato l'unico inquilino di questo gran casamento col quale sia riuscito a fare amicizia. L'immenso edificio dove abito conosciuto da tutti i vetturini romani col nome di "palazzo delle colonne" o "palazzo dell'Avvocatura Erariale". E incredibile come questa seconda prerogativa s'imponga ai botticellari dell'Urbe e come la mia importanza, la mia autorit siano assicurate dal momento che salgo in carrozza e do l'indirizzo del mio domicilio. L'Avvocatura Erariale s' trasferita altrove da un pezzo, lasciando il posto a un centinaio circa di famiglie che hanno cominciato a farsi notare soltanto da quando s' diffusa la radio. Del resto, devo riconoscere che gli attacchi della radio alla mia
solitudine sono tanto insolenti quanto svogliati, fuggevoli e poco persuasi; e non si pu immaginare, in complesso, un cortile pi taciturno, pi ordinato, pi inanimato di questo. Poco discosto dal centro d'una grande e rumorosa metropoli, in uno dei quartieri pi popolari di Roma, il cortile in questione, forse a motivo delle sue austere tradizioni giuridiche, l'albergo del sonno, un luogo incantato o, se volete, la reggia del cattivo umore. Di quando in quando, per qualche notte, si ode il frignare d'un neonato, ma lo scandalo subito soffocato, prima che io faccia in tempo a preoccuparmene. Il nastro bianco alla maniglia del portone, il portone chiuso a met, sono i soli avvenimenti che mi ricordano la vita e la morte qui dentro. E mi domando come sia possibile nascere e morire senza emettere un grido. Inutilmente ho cercato di spiare gli amori, le gioie, le tragedie dei miei coinquilini. In tanti anni di dimora in questo cortile non sono riuscito a scoprire un segreto. I miei stessi padroni di casa, che dormono muro a muro con la mia camera, dnno prova d'una discrezione disumana. Non solo non russano, ma evitano, direi quasi, di respirare. La loro discrezione tale che, data la mia condizione di subinquilino, io vivo in mezzo a loro in una solitudine irrimediabile, circondato da un vuoto pneumatico Il mio ritorno in famiglia, una qualunque sortita dalla mia stanza, sono sottolineati da luci che si spengono, da porte che sbattono, da voci che si abbassano, da conversazioni che s'interrompono. E il bello che tutte queste cose mi piacciono, mi convengono, corrispondono esattamente, oltre che alla mia stessa maniera di comportarmi verso i miei ospiti, all'idea niente affatto edonistica, anzi un po' penitenziale e fratesca, che io ho del domicilio. Non per niente abito qui da tanto tempo. Vuol dire che mi ci trovo bene. E la mia sola preoccupazione di non morirci, ossia di non dare alle persone che hanno la bont di ospitarmi l'estremo disturbo. Anni addietro colei che una strana deficienza della nostra lingua mi costringe a chiamare la mia padrona, rimase incinta. Durante questo periodo, a un certo punto, per non so quale orgoglioso pudore, cominci a farsi vedere sempre meno, finch scomparve addirittura. Della sua presenza nell'appartamento non avevo pi ormai che percezioni auditive. E fu cos che in una mattina d'inverno, mentre i minuti passavano senza che io avvertissi i soliti rumori della sua levata, in un silenzio grave ed enorme, venne al mondo una bambina, che ha trovato nel suo regno una porta chiusa, una regione inviolabile e uno strano personaggio di cui credo non si sia resa ancora ben conto. Questa bambina spuntata come il grano sotto la neve ed io la sentii nascere, in quel silenzio straordinario, in quell'altissimo e muto stupore che si era impossessato di tutta la casa. /:/ASTRID OVVERO TEMPORALE D'ESTATE. In una malinconica estate del dopoguerra, mentre in Italia infierivano gli scioperi e incombeva perfino un sospetto di colera, partii da Milano, una mattina, per recarmi in un paesino del lago di Como, dove mi proponevo di trascorrere alcuni mesi in operoso raccoglimento. Avevo ri-
mandato quella partenza all'infinito, secondo il mio solito, e adesso che mi ci ero deciso capitai proprio, manco a dirlo, in un giorno di sciopero. Sicch, alla stazione Nord, mi tocc di salire su un trenino pilotato da studenti, dove tutti viaggiavano senza biglietto. A Como una pi ingrata sorpresa mi aspettava: lo sciopero si estendeva ai battelli. Non era del tutto naturale quel senso di infinito riposo auditivo da Cui fui subito colto arrivando in vista delle verdi e tranquillissime acque del Lario, nelle prime ore del pomeriggio. Vi si aggiungeva qualche cosa d'insolito, vorrei dire una morte apparente, che non tardai a spiegarmi vedendo il lago nettamente sgombro d'imbarcazioni. Come proseguire il cammino che ora mi premeva di portare a termine al pi presto? Per il paese a cui ero diretto, situato a un dipresso nei luoghi dei "Promessi Sposi", un autobus partiva alle otto di sera. Non ebbi pazienza di aspettarlo. Noleggiai un motoscafo, che qualcuno venne ad offrirmi, e filai per via d'acqua. In piedi, col vento in faccia, nell'ora pi dorata del giorno estivo, filai davanti alle stalue della Villa Carlotta e ad altre innumerevoli ville in fiore e paesaggi assolati e bellissimi, che si succedevano velocissimamente. Alle otto di sera, mentre avrei dovuto partire da Como, io mi compiacevo d'essere gi a cena, sulla terrazza di quell'albergo che avevo scelto a caso, ma non potevo non scegliere, perch, oltre ad essere d'aspetto modesto quale a me conveniva, sta a due passi dalla caletta e fu il primo a venirmi incontro. E bene chiarire che il destino mi condusse in quell'albero. Se no la mia storia non arrivo, parrebbe non avere alcun rapporto con l'episodio in questione. Ma chi pu dire quando, come nasce un a-*** Il modesto albergo dove io m'ero affrettato a deporre le mie pesanti valige, pesanti soprattutto perch contenevano se non altro, per spiegarsi le cifre inverosimili a cui arrivava il conto della settimana. Il proprietario di questa locanda era un terribile uomo inquartato e sanguigno, uso ad esercitare la sua professione in modo assolutamente perentorio. Sia che i magri affari dell'annata l'avessero inasprito o ch'egli manifestasse, nel suo comportamento, la propria indole, il fatto che trattava i clienti come degli ostaggi, sottoponendoli a vere taglie di guerra. Avido, industrioso, attivissimo, faceva tutto lui. Cominciava con l'andare alla pesca delle trote, per procacciarsi gratuitamente quel cibo che poi bisognava pagar caro in ragione delle sue fatiche e della gloria stessa che vantava nel porgerlo, come frutto della sua valentia di tiratore di fiocina, che a sentir lui non c'era l'eguale in tutto il paese ed esigeva, per conseguenza, un soprappi di riconoscimento. Eccolo in cucina, portare in tavola, sorvegliar l'andamento delle camere. Quasi quasi avrebbe rifatto anche i letti, se la dignit e la decenza non lo avessero costretto, per quest'ufficio, a servirsi d'una cameriera nostalgica, la quale veniva da Milano ogni anno a far la stagione e voleva essere comandata con molta cautela, potendosi ferire facilmente. Un piccolo aiuto il laborioso esercente lo riceveva pure, o almeno avrebbe dovuto riceverlo da una sua figliola giovanissima: un pezzo di ragazza tarchiata e maschia, ma con la testa piccola in proporzione del
corpo e la frangetta dei capelli sulla fronte, come una donna di Renoir; che camminava buttando i piedi molto avanti e mettendo in mostra, a cagione della corta gonnella, in grande uso a quei tempi, due polpacci mirabili. Non priva, per dirla con Manzoni, "di quella grazia un po' guerriera delle nostre contadine". Ma solo in rapporto al fisico; giacch, in quanto al carattere, la bella comacina era assai pi sgarbata che forastica. Si capiva che il servire a tavola non le andava a genio. Aveva delle malinconie da signorina borghese, in aperto contrasto col suo aspetto robusto e villereccio, e appena sbrigate, in fretta e di malavoglia, le sue faccende, correva a rincantucciarsi, in sala da pranzo o sulla terrazza, col romanzo in mano. La chiamer Angelina. Il romanzo ch'ella divorava in quei giorni era "Mit" di Virgilio Brocchi. Angelina aveva poca simpatia per me, che usava qualificare, in mia assenza, genericamente e con poco riguardo, "il giornalista". Me ne accorsi fin dalla prima sera, durante la cena, grazie alla sua dispettosa e sfuggente maniera di servirmi. Tutte le sue garbatezze, le sue nostalgie, andavano a quel tavolo dirimpetto, gaiamente ornato da ben quattro ragazze forestiere, vivacissime, vestite coi colori pi festosi che l'estate pu suggerire; le quali ridevano, si alzavano ad ogni momento, sotto l'occhio indulgente d'una donnetta, apparentemente fatta di miele e di giulebbe, molto meticolosa e lenta nel mangiare, che poi seppi essere la madre di due di quelle fanciulle e moglie d'un console norvegese residente a Parigi. Il rimanente della clientela si riduceva a due coniugi inglesi di mezza et, seduti ad un tavolo alla mia destra. Persone abbastanza nobili, a giudicare dall'aspetto; che tuttavia se non fossero esistite sarebbe stato lo stesso, tanto poco si poteva supporre di entrare in dimestichezza con questi due commensali. Nelle mie vicende amorose non ebbero alcuna parte e se li ricordo soltanto per dare un'idea delL'ambiente in cui queste vicende fiorirono. L'uomo appariva giovane ancora, bench delicato, logoro, la donna un po'anziana, al tramonto della sua bellezza, di un'eleganza preziosa. Entrambi appartati, riservati. Non si curavano di altro che d'un ravviatissimo can barbone color cioccolatta, oggetto supremo d'interessamento e forse unico punto di contatto di quella coppia taciturna e dignitosamente triste. Tale dunque l'albergo dov'io conobbi Astrid, in quelle singolari circostanze che ho accennate in principio, col terrore del colera in giro e tanti altri assai pi reali flagelli che imperversavano sul nostro paese. Quasi nessuno quelL'anno and in villeggiatura e i pochi forestieri vaganti per la penisola potevano usufruire, negli alberghi semivuoti, di una comodit eccezionale. Mentre le citt, strabocchevoli di popolazione, piene di truppa smobilitata, ma non svestita, di reduci disoccupati, che affollavano i comizi e si colluttavano per le vie in grigioverde, erano in preda ai peggiori disordini, le nostre stazioni climatiche pi lussuose i monti, i laghi, le spiagge offrivano al raro e sperduto villeggiante uno spettacolo squallidissimo. In quell'alberguccio, uno dei pi affollati di tutto il pae-
se, le sette persone che ci avevo incontrate non ebbero ad aumentare, n diminuirono, fino a tanto che io vi rimasi. E si aveva il senso di essere bloccati. Ognuno, al mio posto, trovandosi prigioniero di quattro giovani donne, si sarebbe affrettato ad uscire dal proprio riserbo, se non altro per obbligo di galanteria o di solidariet nella disgrazia. Eppure (chi lo crederebbe?) malgrado il fatidico inizio io lasciare passare quindici giorni senza cercar di conoscere le mie piacevoli coinquiline e compagne di solitudine, ponendo anzi ogni mia cura a tenermene lontano, quantunque le intraprendenti fanciulle, che si dovevano molto annoiare in quel deserto paese, mi facessero l'onore di manifestarmi ogni sorta di curiosit e di attenzioni. Per circa due settimane, sordo a ogni invito a ogni lusinga, io gareggiai coi due inglesi nel difendere il mio splendido isolamento. N questo il solo particolare ridicolo d'una storia che a pi d'un lettore parr forse troppo semplice. Quando si arriva in un paese per la prima volta si sempre un po' astratti e disorientati. Soltanto i commessi viaggiatori possono vantarsi immuni da questo difetto. Per me il viaggiare sempre stato una catastrofe. E tutto l'incanto d'essere in un paese che non conosco dura quanto pu durare il mio sogno. Una volta che mi sono reso conto di dove sto e delle persone che mi circondano, addio, ricomincia la noia di esistere. Ci spiega la mia difficolt a far conoscenze di ferrovia o d'albergo, la mia nessuna tendenza a viaggiare in carovana, e vai discorrendo. Sono un viaggiatore insocievole. Mi rammento d'una curiosa avventura capitatami in treno, una notte, fra Milano e Roma. Viaggiavo in seconda. Lo scompartimento era pieno zeppo e un bello spirito, di quelli che s'incontrano appunto in ferrovia, pareva essersi proposto di passar la nottata in allegra veglia, approfittando largamente della presenza di una signora sola per dirne e farne intendere d'ogni colore. In pochi minuti ciascun viaggiatore stim doveroso cavare dal portafoglio il proprio biglietto da visita e far combutta con quel faceto individuola signora compresa. Cos venne a formarsi la pi chiassosa combriccola di buontemponi che si sia mai vista in uno scompartimento ferroviario. Non c'ero che io che mi ostinassi a rimanere taciturno in un angolo, col naso al finestrino, mostrando chiaramente di non voler essere della partita. Una cos strepitosa allegria una tale programmatica ilarit, mi avevano messo di malumore. A lungo andare il mio poco solidale contegno fin per essere notato e per imbarazzare alquanto, specie nei momenti in cui, come accade, L'ilarit illanguidiva. In quei penosi intervalli mi si gettavano di traverso certe occhiatacce, piene di livore, di odio, quali si riserbano, da simile gente, alle persone ch'essa giudica presuntuose, soltanto perch provviste d'un minimo di buona creanza e non facilmente classificabili. Malgrado ci io persistei nel mio atteggiamento per quanto fu lungo il viaggio, pi irrigidito del giacobino nella carrozza di "Boule de suif", ma senza fischiettare la "Marsigliese". La mia protesta era tremendamente silenziosa.
Venne il mattino che tutti apparivano disfatti per il sonno perso e abbrutiti dal ridere. Allora qualcuno, a pochi chilometri da Roma, tir fuori una bottiglietta di non so che liquore e servendosi di un bicchierino d'alluminio (uno di quei bicchierini che si svitano dalla bottiglia stessa, a cui fanno da tappo) ne offr un sorso ad ogni persona presente, quasi a suggello dell'indimenticabile notte. Io fui escluso, beninteso, ostentatamente escluso. E questa punizione me la tenni come ben meritata. Nel caso particolare, oltre alla naturale pigrizia e timidezza, io avevo le mie buone ragioni per condurmi come ho detto. Il lettore mi ha gi capito. Contavo di lavorare, in quell'estivo ritiro, e non mi sorrideva troppo l'idea di perdermi in avventure sentimentali. Infine poteva anche darsi che quelle sbrigliatissime ragazze si volessero prender gioco di me. Anzi era pi che probabile. Io ne ero certo senz'altro. Giunsi cos al punto che incontrandole di sera a passeggio, lungo riva, e sentendole ridere da lontano, senza dubbio al mio indirizzo, sfuggivo a nascondermi tra gli alberi. Non parlo di ci che mi accadeva in albergo, all'ora dei pasti, bersagliato com'ero da una quantit di commenti chiarissimi, sebbene espressi in una lingua incomprensibile, da occhiate impertinenti, da risatine continue, cui non si peritava di associarsi quella donnina morbida e anzianotta, seduta a capo tavola, che avrebbe dovuto dare il buon esempio e che, al contrario, pareva approfittare del divertimento delle ragazze per abbandonarsi inosservata alla sua golosa lentezza manducatoria. Non potevo fare una mossa che non suscitasse uno schiamazzo in tutto quel gallinaio. Durante il giorno, mentre me ne stavo chiuso in camera, cercando di spremere un po' di sugo dal mio faticoso cervello, mi si ricordavano al pianoforte, dalla sala da pranzo, a suon di Tipperay e valzer di Maskowski. La sera poi, sul punto di andarmene a letto, due di esse venivano ad una finestra superiore alla mia e l rimanevano lungamente a bisbigliare e ridacchiare ogni volta che vedessero passar la mia ombra sul muro di faccia. Proprio s'erano messe in testa di non darmi pace. La mia resistenza le esasperava. Combattevamo ormai una tacita guerra da cui m'illudevo di uscir vincitore, senza riflettere che, a poco a poco, ci avevo preso gusto ed ero quindi gi debellato. Notai che la pi impertinente di tutte, la pi sfacciata in siffatte imprese, era anche la pi goffa, cio la figlia minore del console, che poi fin per accettare la corte del medico del paese. Mentre la pi sorniona e costante, la pi traditora, coi suoi sguardi lunghi e fatali di sotto le ciglia, era per l'appunto Astrid. Oim, in questa forma il gioco incominci a piacermi. E presto il guardarci cos fissi e di nascosto, da un tavolo all'altro, divent una dolcissima consuetudine. Meraviglia dell'amore con gli occhi. Volutt infinita, privilegio della timida e ardente giovent, piacere perfetto che sparisce nel momento in cui fra due esseri che si sono cos naturalmente scrutati e comunicati non c' pi quella magica e ignota distanza. Piacere felino, gattesco. Amai in tal guisa delle donne che neppure conobbi, seguendole da un paese all'altro, camminando sulla loro trac-
cia fuggitiva come Apollo dietro Dafne, come Teseo guidato dal filo d'Arianna, ma senza fare un passo di pi per raggiungerle. Esse si dileguarono e a me non rimase che il ricordo d'una strada incantata o di qualche stagione felice. Con Astrid purtroppo le cose andarono altrimenti. Con lei fui costretto ad allungare il passo. Un bel giorno mi trovai di l da quella soglia che avevo tanto esitato a varcare. Ed eccomi in mezzo ai guai. Dal seguito di questo racconto si vedr chi era Astrid. Io non intendo far psicologia, n scandagliare gli abissi del cuore femminile. Narrer i fatti come "realmente si svolsero", senza curarmi di nascondere l'ingenuit e quasi ridicola inesperienza con cui furono da me vissuti e sofferti. Dir solo che, a giudicarla dal di fuori, non si sarebbe potuto immaginare nulla di pi pacificamente borghese di questa ragazza, figlia d'un legatore di libri di Cristiania, impiegata nel negozio paterno e non certo superiore, quanto a levatura mentale, ad una delle nostre signorine di studio. Parlava l'inglese come la propria lingua, cosa non rara tra gli scandinavi, e un poco anche il francese, ma con una pronuncia pessima che mi ricordava spesso il banchiere alsaziano di "Pre Goriot". Non conosceva una parola della nostra lingua. Ignorava Ibsen. La sua voce strascicata e nasale poteva essere quella d'una vecchia o d'una bambina lunatica. Di aspetto grande e formosa, con la fronte alta, i capelli biondi e sciolti, la pelle finissima, rosea, sotto la quale si vedeva scorrere il sangue, le spalle ampie, sostenute e ben ante, i larghi occhi umidi, cupamente azzurri, sarebbe stata fisicamente perfetta se alla fiorita opulenza dei fianchi e delle braccia divinamente tornite, degne di Nausicaa, avesse fatto riscontro un seno un po' pi rilevato o, per meglio dire, meno avaro. Cos ella incarnava una figura di Vestale o di atleta femmina, ma senza nulla di acerbo, n di aggressivo nei modi, anzi pigra, sedentaria e taciturna per natura, bench allenata ad ogni genere di "sports", a cominciare dal "flirt". Viaggiando sola tra la Norvegia e l'Italia ne aveva filato uno in ferrovia, con un signore attempato, e un altro in Inghilterra, presso la famiglia che l'ospitava, con un giovinetto di sedici anni. Per conto suo non poteva essere pi che ventenne ed era tanto sviluppata nella persona quanto spiritualmente immatura e senza Uscivamo ogni giorno soli dopo colazione, cio nelle ore pi ardenti del pomeriggio, incuranti della canicola, per delle lunghe passeggiate a piedi o in barca, giovandoci tacitamente il pretesto delle lezioni d'italiano e d'inglese che avremmo dovuto scambiarci ma di cui regolarmente ci dimenticavamo. Le prime volte, camminando a fianco di lei, che mi sorpassava in altezza di quasi tutta la testa, mi pareva di camminare sul vento. Ero cos felice, mi sentivo soffocare dalla grazia di quelle prime confidenze a cui stimavo di non poter corrispondere in maniera abbastanza degna. Io ero trascinato, vicino a lei, come in una nuvola odorosa, e quando la vedevo sdraiata in barca non mi saziavo di contemplare quel suo corpo giovane e ricco di
leonessa. Avrei voluto baciarla mentre dormiva, prenderla di soppiatto e di furto. Portava per solito un abito di seta celeste, a fiori, entro cui le sue forme giocavano liberamente, e uno scialle mezzo spagnolo, bianco avorio, sulle spalle. Era l'abito che pi le donava, l'abito della nostra prima passeggiata, di sera, allorch lei, bisticciatasi con le sue compagne che gi cominciavano a tormentarla, corse da me, ed io, innamorato pazzo, inebriato da quella piccola fuga notturna, riuscii ad esprimermi e comportarmi in maniera da convincerla di avere incontrato "un poeta". Cos vestiva anche il giorno che un mio gesto bast a far crollare il suo radioso castello d'illusioni. Quel giorno, alla solita ora, direi quasi, faunesca, il barcaiolo ci aveva lasciati in un giardino di magnolie, a cui si poteva accedere dal lago, quanto per via di terra. In piedi, fra quelle piante odorose e frondose, Astrid mi mostrava la schiena e teneva un braccio sospeso al ramo d'un albero. A un tratto mi avvicinai e le posi una mano sulla spalla. Si volt di scatto, con una faccia avvampata e serissima. "Vous tes fou", ammon a bassa voce, quantunque nessuno all'infuori di me potesse udirla, come per sottolineare la gravit dell'evento. Sbigottito da una tanto inattesa reazione io non seppi ribattere sillaba. Quindi un imbarazzante silenzio si stabil fra noi due. Uscimmo da quel giardino quasi subito, come Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre. Varcando strada e campi ci trovammo, senz'accorgercene, a prendere il t in un paesino di pescatori alquanto lontano dal nostro. Qui non si pot pi continuare a tacere e la parola "amore" fu pronunciata per la prima volta. Frattanto Astrid si era del tutto riavuta dal suo scompiglio di poco prima. La tacita passeggiata le aveva giovato a riprendersi, a riordinare le proprie idee. L'occasione di definire i nostri rapporti non poteva giungere per lei pi opportuna. Con incredibile tranquillit e freddezza, con la sicumera d'una bambina che s'accinge a recitare una parte o a sostenere un esame a cui s' preparata da lungo tempo e aspettava impaziente di cimentarsi, ella mi dichiar che non mi amava, che non m'avrebbe mai amato, insistendo particolarmente sul fatto che io lasciassi ogni speranza. Ammetteva, beninteso, che avremmo potuto rimanere buoni amici lo stesso. Ma in quanto all'amore non voleva sentirne discorrere, lo escludeva nel modo pi assoluto, per il momento e per sempre, giacch, lei, aggiunse infine, dopo un attimo di esitazione, abbassando gli occhi (e credo che dicesse il vero e che avesse ragioni da vendere) lei non poteva amare che uno "sportman". Per convincermi che le sue parole erano sincere occorreva quest'ultimo argomento; e mi mise un'allegra disperazione nel cuore. Ah dunque non mi amava! M'ero ingannato. Tanto meglio. Chiamai con insistenza il cameriere, pagai e proposi di tornare all'albergo. Non potevo rimanere un minuto di pi con una donna che mi aveva fatto simili dichiarazioni. Ero pieno d'uno strano cruccio, col sangue rimescolato, come se avessi patito chiss quale offesa. Un furore pazzo mi aveva messo le ali ai piedi, sicch la poverina, quantunque sportiva e di gamba lunga, faceva fatica a seguirmi e spaventata forse delle conseguenze del suo discorso tirava a rallentare la marcia. Non le dissi, lungo la strada, una sola
parola, n credo che la mia faccia fosse tale da incoraggiarla ad affrontare il mio silenzio; finch giunti sulla soglia dell'albergo, la salutai seccamente, deciso a non guardarla mai pi. In quale stato io passai la serata il lettore se lo pu immaginare. C'era da quelle parti, ospite onorario d'un albergo di gran lusso, un mio amico pittore (pittore di genere e alla moda) che in quei tempi di inflazione, a Milano, guadagnava fior di quattrini e, per di pi, approfittando elegantemente delle sue relazioni col mondo milanese, riusciva a procurarsi delle magnifiche villeggiature gratuite. Non ci vedevamo quasi mai. Quella sera per dovetti riconoscermi troppo infelice e solo per poter disprezzare quel piccolo conforto che la sua costante amabilit mi assicurava. Andai dunque a trovarlo e fu con questo provvidenziale compagno che mi recai a cena il pi lontano possibile dalla mia pensione e dal paese stesso, in una taverna del lago di Lecco, dove mangiammo del pesce fritto, innaffiato da alcune bottiglie d'un buon vino bianco. La mia lirica esaltazione era paragonabile a quella che pu produrre una grossa perdita al gioco. Ci che io provavo in tale circostanza era il piacere di sentirmi puro e posto nella disgrazia, la volutt del supplizio. Lontano dalla donna amata e che non mi amava, orgogliosamente e volontariamente lontano, io andavo centellinando la mia tortura minuto per minuto, me ne ero ubbriacato, e per prolungarla oltre il limite, allo scopo di non rimettere piede in albergo prima che Astrid fosse andata a dormire, la volgevo in riso, intrattenendo il mio saggio amico, presunto uomo navigato, con la descrizione delle mie pene d'amore che lo sollazzavano un mondo. Tornammo verso le nostre abitazioni a notte inoltrata. Tutto il paese dormiva, a finestre chiuse o spente. Nel gran silenzio lacustre non si udiva che la solita ninna nanna dei campanelli delle reti che i pescatori, di sera, lasciano andare sul lago alla deriva. Giunti che fummo sulla deserta piazzetta, in vista del mio albergo, io akoli occhi da quella parte. E che vedo? Che cosa vedo, mio Dio? Astrid era l, nel buio della terrazza, contro ogni sua consuetudine, seduta e avvolta in uno scialle nero, in atteggiamento fermissimo, quasi statuario, da far pensare alla moglie d'un pescatore che stia scrutando in una notte burrascosa il ritorno d'una barca che forse ha fatto naufragio. La mia sorpresa, dinanzi a questa rivelazione, non fu cos viva come si potrebbe credere. Era troppo profonda per venire immediatamente alla superficie. Forse anche io avevo inconsciamente desiderato e previsto ci che i miei occhi scoprivano adesso senza apparente stupore. Fatto sta che seguitai a camminare col mio lento passo, a discorrere come se nulla fosse, tanto che la persona che mi accompagnava, non avendo motivo di guardare sulla terrazza, non ebbe alcun sospetto dell'accaduto, che io tenni per me, o meglio, ei lsi, allontanai fino all'ultimo, rimanendo ancora a lungo, sulla piazzetta, con quel po' po' di segreto che occupava il mio animo, a ragionare e perfino ad accalorarmi di cose che non m'interessavano minimamente. Passati alcuni istanti Astrid si alz e scomparve. La rividi la mattina dopo e, senza che io le chiedessi nulla, cadendo quasi tra le mie braccia, non ebbe difficolt a confessare che per tutta quella tremenda serata non aveva fatto che aspettarmi
e desiderarmi. Le nostre passeggiate continuarono. Ma ormai non c'era giorno che qualche nuovo accidente non intervenisse a turbare la nostra felicit. Io mi comportavo, a dire il vero, con disperata leggerezza. In preda a un continuo delirio, non riuscendo a trovar riposo in quell'avventura cos inevitabilmente fuggevole, avrei voluto convincere Astrid che l'amore un gioco, una burla, una pazzia. Invece lei aveva ben altre opinioni in proposito e si crucciava di tutto e di nulla, secondo il momento. "Vous me traitez comme une cocotte", era il suo ritornello. Ogni giorno doveva essere l'ultimo delle nostre amorose peregrinazioni, non ci saremmo pi guardati. E ogni sera, prima di coricarsi, veniva alla finestra a sussurrarmi che mi perdonava. Qualche altra volta poi, sempre di sera, accadeva a lei di lasciarsi andare a manifestazioni di tenerezza un po' soverchie, dandone la colpa alla luna. Sulla via delle tante piccole concessioni a cui s'era lasciata condurre avevo trovato un punto interdetto, una proibizione assoluta: quella di baciarla in bocca. Il giorno in cui accadde il gran fatto, ella non si ribell. E fu lungo. Ma poi sbott a piangere, mi scagli tra le lacrime uno sguardo d'ira infantile, e se ne usc in quest'apostrofe da spezzare il cuore: "Vous n'avez rien de sacr". Capii allora, ma troppo tardi, ch'ella aveva sacrificato la sua bocca che sapeva di rosa, allo "sportman" che doveva sposarla. Ebbi anche quella sera bisogno del suo perdono. Me lo fece sospirare un po' pi del solito, poi me lo concesse. Ed ecco in che modo fin l'avventurosa giornata. Sussurratomi il suo "je vous pardonne", indugiavamo a discorrere sommessamente, nel silenzio della notte, da una finestra all'altra. La sua era al piano di sopra, ma di fianco alla mia, e poich le nostre due camere davano sul lago non si pu immaginare un paesaggio pi incantato e sognante di quello che avevamo davanti agli occhi. Io ero felicissimo, fuori di me dalla gioia che anche quella sera fosse scesa sul mio capo la sua benedizione. Se no, come avrei potuto dormire? Ecco che il gatto dell'albergo, visitatore asslduo della mia camera, era saltato sul davanzale e mi si andava strofinando ai panni irrequieto. Pi lo scacciavo, pi lui tornava a far le fusa addosso a me. Col dorso inarcato la coda ritta, ronfava e brontolava, strusciandomisi al gomito, come una pila bollente. Quel gatto sentiva il temporale che sarebbe scoppiato la notte stessa. Quel gatto sentiva l'amore di cui vibrava il mio essere. A un certo punto, per liberarmene, mi viene in mente di collocarlo sul cornicione che passava sotto la mia finestra, non proprio a portata di mano, ma quasi. Concepire una simile balordaggine ed eseguirla fu cosa d'un attimo. Una volta gettato l, sospeso nel vuoto, nell'impossibilit di saltare in istrada, per la troppa altezza, quanto di risalire, L'animale si trov smarrito e si accovacci cheto cheto, quasi avesse coscienza di essersi meritato quel piccolo castigo. Ora per si trattava di riprenderlo, cosa difficile a cui non avevo pensato: difficile appunto per quei pochi centimetri di distanza che intercorrevano fra il cornicione e la mia mano. Cominciavo a rendermi conto delle conseguenze della mia prodezza. Gi immaginavo i
lagni del gatto durante la notte, le proteste del vicinato e lo scandalo che ne sarebbe seguito il giorno dopo in albergo e per tutto il paese, ma pensavo soprattutto ai due inglesi. Che stupido scherzo! E Astrid che me lo aveva lasciato compiere senza fiatare, quasi ad incoraggiarmi col suo silenzio. Astrid che aveva assistito tranquillamente a tutti i miei vani tentativi di salvataggio, si decide infine ad intervenire per domandarmi, con una punta di cattiveria infantile nella voce assonnata, come avrei fatto adesso a togliere la bestia da quella singolare situazione. Io ero deciso a tutto, pur di evitare lo scandalo che temevo, e non c'era che scendere sul cornicione, alto quanto basta per rompermi il collo cadendo, ma risposi che mi sarei accinto all'impresa, come infatti desideravo, non avendo nessuna voglia di esibirmi in un esercizio a cui mi sentivo cos poco portato, quando lei si fosse ritirata. "Faites-le maintenant", implor la crudele, con voce piangente addirittura. Sfido chiunque a resistere a una simile preghiera. N io ero in grado, in quel momento, di pensarci due volte. Mi calai fuori dalla finestra, posi i piedi sul cornicione, e agrappandomi con una mano al davanzale raccolsi con l'altra il micio, sotto gli occhi della mia bella che, forte del suo buon diritto, non aveva rinunciato ad impormi quell'atto di coraggio disperato e buffissimo. Si trattava di un'altezza non inverosimile, per di pi il cornicione era abbastanza sporPente e comodo. Ma io soffro di capogiro, sono il contrario assoluto d'un acrobata, d'un sampietrino, e si dovr convenire che una tale prova d'amore, data in presenza d'una spettatrice cos esigente, non poi del tutto ordinaria. Quanta pericolosa felicit, quanti affanni, quante follie, in meno d'un mese. Addio lavoro, addio amici, addio a tutto. Nella mia mano si leggono i segni di tre o quattro tempe ste amorose che avrebbero devastato la mia esistenza. Sono tracce di antichi rivolgimenti e diluvi, non meno remote, rispetto al breve corso della vita d'un uomo, di quelle che il geologo discopre nelle pieghe della terra. Uno di questi cataclismi fu certo il mio incontro con Astrid. Quando accadde io avevo trentatr anni ed ero in un punto assai delicato della mia parabola di scrittore. Tutte le altre storie o mattane d'amore che posso aver avuto prima e in seguito non furono che un'inezia in confronto a questa. Contro le rive di quel lago, propizio ai dolci riposi, quanto alle pi funeste perdizioni, la navicella del mio ingegno non dir che facesse naufragio, ma certo si aren per un tempo incalcolabile. E trovo fra le mie pagine pi ingiallite un pensiero che si riporta a quei giorni e che, a questo punto, mi sembra opportuno trascrivere: "La vita d'un uomo non fatta, in sostanza, che d'una serie interminabile d'incidenti. L'avventura, L'imprevisto, sono pi spesso che non si creda, i veri fili conduttori della nostra quotidiana esistenza. Guidati in grandissima parte dal caso, noi intrecciamo amori, amicizie facciamo i nostri affari o il nostro danno, secondo il carattere. Che poi L'unico dato sicuro e permanente in questo caos di combinazioni. "Io fui sempre sorpreso dall'amore in momenti nei quali
mi proponevo di raccogliermi e di lavorare. Tutte le volte che mi prefissi di fuggirlo. Quando meno me lo sarei aspettato. Allora un'occasione di perdermi, sulla mia strada, non manc mai". C'imbattemmo, per nostra disgrazia in un'estate piovosa. Quasi ogni giorno, uscendo, ci pigliava l'acqua, ma faceva cos caldo che la polvere delle strade percossa dai goccioloni, mandava odore di cartucce appena sparate. E queste acquate ci costringevano a lunghe soste, nei pi diversi luoghi, dove si aspettava invano che spiovesse, con gran dispetto di lei che non riusciva mai a trovarsi puntuale in albergo alL'ora del t a pregiudizio dei nostri rapporti. Tornavamo ad ore impossibili, inzuppati fradici, accolti da un silenzio glaciale. Se ci ripenso, mi pare che quella mia con Astrid, pi che una storia d'amore, sia stata una storia d'acquazzoni. La famiglia del console presso la quale Astrid trascorreva le sue vacanze in viaggio, aspettava di giorno in giorno i passaporti per raggiungere a Parigi il rispettivo marito e padre. Non quindi da credere che Astrid e le sue amiche fossero in Italia per rimanervi, n molto, n poco. La loro meta era un'altra. In tempi come quelli che ho descritti soltanto il caso, un disguido, potevano averle condotte su quella riva, dove stavano sempre sul piede di partenza, in una specie di quarantena che, per essersi prolungata oltre il previsto, si trasform a poco a poco in un soggiorno vero e proprio, in una villeggiatura quasi normale. Ma tutto poteva finire da un momento all'altro. Quei passaporti erano la mia spada di Damocle. E chi s' trovato qualche volta nella sala d'aspetto d'una stazione, in compagnia di una persona amata, pronta a spiccare il volo per un lungo viaggio, pu avere un'idea, bench vaga, delle circostanze estremamente angosciose e precarie in cui questa mia storia si trascin per circa due mesi e del mio stato d'animo. La diplomatica famiglia si componeva, come ho detto, di una minuscola signora garbatissima, furbissima e, come tutte le persone tenere di corteccia, abbastanza dura di cuore, e delle sue due figlie. C'era con loro, nella stessa condizione di Astrid, un'altra ragazza, anche lei di Norvegia, bionda e piccola come una bambola. Non parlava l'italiano, n il francese. Ella dunque per me era sordomuta. Si faceva sentire per al piano abbastanza. E ogni volta che io, scherzando, le dicevo qualche parola nella mia lingua, la timidetta, dopo esser rimasta un po' sospesa, nel vano intento di capire, correva con gli occhi alle sue amiche, scoppiando a ridere. In tutta questa lacrimosa storia fu certo la pi innocente, ad ogni modo la pi discreta, e la ricordo con gratitudine. Ma il mio racconto s'avvia ormai rapidamente alla fine. Lascio di conseguenza la piccola norvegese al suo tranquillo destino, per occuparmi un poco della figlia maggiore del console, personaggio assai meno innocente; la quale, da parte sua, non aveva nulla che potesse interessare la mia fantasia, se non forse il fatto di essere maritata con un ufficiale della marina inglese, sbalzato in India all'indomani del matrimonio: maritata per una notte. Questo particolare veniva riferito da lei, dalla sorella e dalla madre, con goffa compiacenza, come qualche cosa di romanzesco, che rialzava le
sorti dell'intera famiglia e conferiva alla detta signora, agli occhi delle sue pi giovani amiche, un fascino indiscutibile. Si preparava adesso a ricongiungersi col legittimo consorte, passando per Parigi. Ma pare che una volta l trovasse di gran lunga pi divertenti le "boites" di Montmartre e di Montparnasse che tutte le vagheggiate meraviglie dell'India lontanissima, di cui aveva tanto vanamente discorso, in previsione del suo viaggio, da essersene stancata prima di vederle. Motivo per cui il marito, esattamente informato, forse dall'"Intelligence Service", sui gusti eccentrici della poco delibata moglie, si affrett a chiedere il divorzio e l'ottenne. E il curioso che l'epilogo di questo matrimonio durato ventiqUattrore io venni a saperlo, alcuni mesi dopo, da una di quelle incredibili notiziole del "Corriere della sera", che si stimano generalmente inventate e sono invece, a giudicare da questo caso, verissime. Il mondo piccolo e l'Europa pettegola. Costei era l'amica migliore di Astrid. Natura ama i contrasti. Avanti ch'io capitassi in quell'albergo stavano sempre insieme, inseparabili. Fu con lei ch'io vidi Astrid, la prima sera, tornare da Como. Erano loro che venivano a cinguettare sopra la mia finestra, imitando in qualche modo, se mi si consente il paragone, Sonia e Natacha rispetto al principe Andrea, nel famoso episodio di "Guerra e pace". E Astrid che nei propri confronti non ammetteva gelosia, sostenendo il principio ben noto e femminilissimo che quando un uomo ama una donna deve fargli piacere tutto quel che la rende felice, mi aveva formalmente vietato d'interessarmi di questa sua amica e soltanto di lei. Certo un'amicizia assai stretta legava le due giovani donne, cos profondamente diverse. Giacch non era il caso d'illudersi sul significato di quella proibizione con la quale Astrid, anche a voler supporre in lei un'ombra di gelosia, un po' di ruzzo amicale e femminile, non mirava ad altro che a non guastarsi con la cara compagna e a conciliarla al suo amore. Impresa difficile, come vedremo. Piccolo dramma segreto, che io sfiorai senza badare ad approfondirlo e spiega molte cose che allora m'apparvero incomprensibili. Al contrario della sua nobile amica la figlia maggiore del console era una comune borghesuccia aggressiva e pungente. Rammento le arie di superiorit che si dava nei rapporti con la famiglia, da brava ragazza appena maritata, per la quale il matrimonio non era stato forse che un mezzo di emanciparsi dalla tutela domestica. Non bionda, ma scura di capelli e di carnagione, com'ella sosteneva debba essere il vero tipo della norvegese (allusione diretta e poco benevola ad Astrid, che infatti aveva sangue svedese dal lato materno, un sangue pi puro, dicevo fra me) la sua figura di falsa magra poteva dirsi elegante; sebbene avesse, malgrado l'altezza, qualche cosa di troppo minuto e costretto che faceva pensare ad una gemella. Un intenditore nostrano, affezionato ai diminutivi, L'avrebbe definita "un bel corpicino". E un uomo un po' pi accorto di quel che io non fossi si sarebbe senza dubbio orientato verso di lei, per giunta maritata, situazione classica. Invece io, non soltanto avevo commesso l'errore di non notarla, ma, per colmo d'inopportunit, mi ero innamorato proprio della sua amica pi intima. Niente di pi
naturale dunque che la sposina di una notte potesse vedere me e il mio amore per Astrid come il fumo agli occhi, pur senza lasciarmelo trapelare in alcun modo, se non da qualche involontaria ironia, da qualche inesplicabile tono di rimprovero, che le sfuggivano di tanto in tanto; anzi facendomi il miglior viso del mondo, discorrendo, passeggiando con me. E pressappoco alla stessa maniera ipocritamente amichevole e irreprensibile solevano comportarsi nei miei riguardi la madre e la sorella di lei, che erano, per chi non l'avesse ancora capito, le meno leggiadre della compagnia. Cos il mio amore procedeva tempestoso, in mezzo ad ostilit d'ogni genere e, quel ch' peggio, segrete ostilit di donne. "Elles disent que vous me tuerez". Nientemeno. Quando la cara fanciulla mi rivel questo timore grottesco, probabilmente simulato per spaventarla o forse insinuatosi in quelle deboli teste per il fatto di vedermi dimagrito come un gatto randagio, annerito dal sole come un beduino, io non ebbi neppure la forza di sorridere, tanto ero ormai insensibile e sordo ad ogni cosa che non riguardasse la mia felicit pi immediata. Ma quelle nordiche donne operavano indefessamente per indurre Astrid ad allontanarsi da me; e le loro occulte opposizioni, pi o meno giustificate e legittime, dovevano riuscire tanto pi efficaci sull'animo della ragazza in quanto, dopo averla abbondantemente ammonita ed avvelenata, dopo averle fatto balenare la terribile prospettiva di finire trucidata in Italia, la lasciavano libera, secondo il costume protestante, di regolarsi a suo giudizio. Sistema, in realt, perfidissimo. Quali effetti ne scaturissero mi sembra dimostrato abbastanza. Ogni giorno trovavo Astrid, senza un motivo plausibile in apparenza, eroicamente decisa ad abbandonarmi, a rientrare nell'ordine, salvo ad uscirne poche ore dopo. Disperata, sempre in lacrime, in guerra con me e con le sue compagne, con l'amore e con l'amicizia, chiese consiglio, per lettera, a sua madre, non so poi a quale scopo. Il responso materno fu, com'era da prevedersi, negativo. Ah, tutto mi veniva contro! Tornando la sera dalle nostre passeggiate, io leggevo qualchecosa di ostile perfino negli occhi degli abitanti del luogo, gente, in verit, poco amena; e particolarmente di quelli che stavano ad osservarci sulla soglia delle botteghe. A met luglio si respirava in quel paese, in quell'albergo, un'aria afosa e sinistra, resa pi intollerabile dalla vista delL'indaffarato e apoplettico albergatore, che irrompeva trionfante in sala da pranzo tenendo alto sulle due mani il piatto delle sue trote fumanti, pescate da lui, come se portasse in tavola il ciborio, per rivelare poi, all'ora del conto, la sua vera faccia di legittimo discendente da qualche stirpe di contrabbandieri o briganti del posto. Il contegno di Angelina si faceva sempre pi isterico. La cameriera guai a domandarle un servizio. In questo venale soggiorno, privo di ogni umano conforto, dove tutto adesso, a cominciare dalla cornice pittoresca, mi appariva ordinato per inclinare la mente all'idea del suicidio, Astrid era un angelo cattivo, scacciato dal cielo, che lasciava passare le giornate intere senza guardarmi e mi faceva soffrire per dei nonnulla pene indescrivi-
bili. Pericolosa ragazza, la cui naturale disposizione a tormentarsi e a tormentare non aveva certo bisogno di essere incoraggiata. Nordica fino ai capelli, piena di una preconcetta sfiducia verso l'oggetto dei suoi sogni, sentiva l'amore come una specie di "boxe", una collutazione, un castigo, una perpetua punizione da infliggere all'indegno. Il che non le impediva di essere fondamentalmente una creatura tenerissima. E mai forse era tanto occupata ad amarmi, a volermi bene, come quando mi negava tutto di lei, perfino lo sguardo. Con tutto ci io avrei commesso qualunque pazzia pur di prolungare all'infinito quella sciagurata esistenza. Mi sarei arrampicato sui tetti per quei rari istanti di felicit che la volubile e lunatica Astrid mi concedeva. Si udiva spesso, dopo cena, sotto la nostra terrazza, un concertino di mandolini, e lei, sempre amorosa a quell'ora, col capo appoggiato ad un'antenna della tenda, mormorava guardandomi languidamente: "C'est romantique!" Poi le ragazze uscivano a passeggio ed io le seguivo a distanza. La sera era calda e piena di fumi. Tornate all'albergo si trattenevano alquanto nella sala da pranzo, gaiamente illuminata, a fare il chiasso, a suonare e ballare fra di loro. Presto si ritiravano e il solerte proprietario s'affrettava a spegnere i lumi. Soltanto Astrid rimaneva su qualche volta per delle ore, in sala o in terrazza, lontana da ogni compagnia, a ruminare i suoi sogni, le sue fantasie impossibili. Reduce dalle mie passeggiate solitarie io rientravo, certe sere, verso la mezzanotte, che magari aveva piovuto, con la faccia lavata dal vento. La trovavo ancora in piedi. Rimanevamo un po' a chiacchierare. Ella mi metteva un dito sul mento: "Je ne vous ai jamais vu aussi beau que ce soir". E nel dir questo c'era nel suo sorriso la crudele smemoratezza del cielo rasserenato. La folle avventura durava da un pezzo ed io non pensavo quasi pi al brusco risveglio che stava, ahim, per sorprendermi, allorch una mattina la moglie del console, spalmando al solito, in terrazza, il suo burro e la sua marmellata sui panini del caff e latte, mi annunci, come la cosa pi naturale del mondo, che partivano tra una settimana. Partivano per un motivo, sia pure apparente, lontanissimo da quello che ero abituato a temere. Non si trattava dell'arrivo dei passaporti, bens d'un avvenimento assolutamente inatteso e imprevisto, che sorgeva a un tratto a scompigliare la mia esistenza. Un'ordinanza del municipio proibiva i bagni lungo la passeggiata. Ora proprio quello era il punto preferito delle ragazze, per il solo fatto di essere inconsueto e a due passi dall'albergo. L usavano tuffarsi ogni mattina, sotto gli occhi di tutti, le superbe nuotatrici, mettendo in mostra, con pagana innocenza, le loro fiorenti nudit sportive. L'ordinanza del municipio (pudori del dopoguerra) colpiva proprio loro. Fare il bagno nel vecchio porto abbandonato, come voleva la consuetudine locale, sarebbe stato assai scomodo, oltrech poco igienico. D'altra parte, non si poteva pretendere che le ragazze rinunciassero a quello "sport", che costituiva la loro grande occupazione quotidiana, il loro diletto maggiore, la ragione principale della loro permanenza su quella
riva; dove il caldo, fra l'altro, cominciava ad essere insopportabile. Insomma, dopo quel disgraziato incidente, il lago non aveva pi attrattiva ai loro occhi. A sentire la mia gentile informatrice, nessuna di esse, neppure Astrid, ci stava di buona voglia. Il mare invece le allettava. E appunto per questo avevano deciso di trasferirsi in un paese della riviera ligure, a Ospedaletti. "Connaissez-vous ce pays?" Cos pressappoco si esprimeva la giudiziosa donnetta, con abbondanza d'argomenti e impagabile bonomia, come se volesse scusarsi di quella tanto giustificata partenza, la cui ragione vera e nascosta era naturalmente ben altra. Corsi da Astrid. Ebbi conferma della fatale notizia, contro la quale non c'era nulla da obiettare; giacch la libert di Astrid non poteva influire su quella delle sue amiche, smaniose di misurarsi, dopo tanto sguazzare nell'acqua dolce, coi cavalloni marini. E alla nostra separazione si doveva pur giungere, per quanto allora mi sembrasse incredibile, se non fra una settimana, fra due Di ci che avvenne da quel momento non ho che una memoria confusa. Mi pare che cominciai a contare i giorni che mi separavano dalla sua partenza come se si trattasse della mia morte. Io me la figuravo gi partita. Un minuto dopo ella non era pi che un ricordo: il triste, incenerito ricordo che l'amore lascia dovunque passa e ci sorprende ogni volta che una persona amata si assenta, sia pure per poche ore, dai luoghi in cui siamo soliti a incontrarla. Quale tremendo silenzio subentrava in quel tetro albergo, dove io rimanevo solo, coi due melanconici inglesi, circondato da fantasmi e da sopravvissuti, sempre con la sua larva davanti a me. Come sostenere le ore che pi vivamente me l'avrebbero evocata, le gaie ore della colazione, della cena e degli spassi serali, divenute ormai cos funebri? Non avrei potuto gettare gli occhi su quella finestra, guardare quel tavolo, ripassare per quella strada, senza che le molte cose accadute fra me e lei si mutassero in altrettante sensazioni di morte e l'immagine sua in uno spettro fluttuante. L'avrei vista anche sui monti e sulle acque. Tutto il paese sarebbe stato posseduto e stregato dalla sua assenza. Questo era ci che ella mi lasciava, il sollecito, enorme retaggio espiatorio di poche settimane d'amore. Inorridito, la parola, da una visione talmente paurosa, io non dormivo pi, non pensavo pi ad altro, e ogni sera, chiuso nella mia camera, cercavo di esprimere alla partente i miei lugubri sentimenti, con certe lettere, scritte in francese, che la tenera Astrid non leggeva mai senza piangere. "Vous me faites pleurer". Allorch, di l a poco, tutto fin fra noi, il dispiacere pi grosso che le diedi fu di pretendere la restituzione di quelle barbare lettere che m'affrettai a bruciare. Avrebbe voluto tenersele come un ricordo, un trofeo, del suo viaggio in Italia. Ma era in gioco la mia reputazione letteraria e non potevo transigere. Giunse finalmente il giorno del distacco. E qui devo ri-
conoscere che mai si cerc di concludere con tanta solennit e buona grazia una storia cos inopportuna e fastidiosa, dalle persone stesse che la giudicavano tale. Rendo volentieri omaggio alla correttezza di quella gente che, rispettosa delle convenienze, abituata evidentemente a non lasciar conti aperti, neppure nel campo delle passioni, mi risparmi l'impressione di essere abbandonato come un naufrago sulla riva. Era stabilito che la loro partenza avvenisse di mattina, all'alba. La sera avanti, per la prima volta, mi vidi ammesso alla tavola delle ragazze. Cenai a fianco di Astrid, in mezzo a un nuvolo di donne che mi colmavano di cortesie, specie la moglie del console e le sue due figlie, non so se per un estremo riguardo all'amica o considerazione di me e del mio stato oppure, molto pi semplicemente, per il piacere di essersela cavata a buon prezzo, senza spargimento di sangue. Forse per tutte queste cose insieme. Una separazione sempre un fatto commovente, in cui si mescolano sentimenti vari e opposti, ed probabile che le mie graziose nemiche dopo aver tanto brigato per liberarsi della mia presenza, adesso che si vedevano soddisfatte, provassero un certo rimorso di avermi giudicato cos male e desiderassero magari lasciarmi un buon ricordo. La funebre cena di commiato pareva in realt una cerimonia di fidanzamento. A un certo punto Astrid, orgogliosa e lieta degli onori che mi si rendevano, volle anche laurearmi, ponendomi sul capo, in mancanza di alloro o di quercia, un'effimera ghirlandetta di erbe rampicanti. Ed io fui l'eroe del sentimentale convito: un eroe confuso e mortalmente triste, malgrado i fumi dello spumante che mi salivano alla testa. Tutto mi sarebbe stato concesso quella sera, n pi n meno di quel che si fa coi malati senza speranza e coi condannati a morte. Sparecchiata la mensa e alzatasi da tavola perfino la ghiotta mammina, le altre ragazze, con delicata attenzione, se ne andarono a passeggio per conto proprio. Io e Astrid, lasciati soli, ci avviammo, che gi cominciava a farsi notte, verso il piccolo porto solitario, dove non so come, perdutamente avvinghiati sopra un ponticello di legno senza riparo e largo appena quanto era necessario per reggersi in equilibrio, non finimmo a cadere nell'acqua. Cos, nel pensiero di Astrid e di tutti, la nostra avventura poteva dirsi chiusa, anzi coronata degnamente, secondo una tecnica amorosa che io sperimentavo, a dire il vero, per la prima volta; e con questo reciproco riconoscimento, con la promessa, dal canto mio, di non mostrarmi all'atto della partenza, io e lei, entrambi un po' ebbri, ci eravamo detto addio, addio lungamente. E certo avrei fatto bene a tener fede alla mia promessa, perch, dopo tutto, principalmente per merito della valorosa fanciulla che bevve con me il vino dell'addio fino all'ultimo sorso, il nostro amore non poteva avere un epilogo pi degno. Senonch, la mattina dopo, il terrore che ho cercato di descrivere fu pi forte della parola data e di ogni altro sentimento. Non solo volli assistere alla partenza di Astrid, ma saltai con lei sulla corriera che la conduceva a Como; e a Como saltai sul diretto di Milano. Poco m'importava adesso di quel che potessero pensare di me i due fantomatici inglesi e il personale dell'albergo. Non era pi il caso di preoccupar si delle persone che circondavano Astrid, le quali del resto,
non parvero soverchiamente meravigliate che io la accompagnassi per un certo tratto. Il mio bene mi lasciava e non ero pi in grado di ragionare. Quei due ultimi passi strappati alla sorte furono tutto un delirio. L'ora del distacco suon purtroppo a Milano, quando le solerti viaggiatrici, sostato che ebbero per un paio d'ore nei pressi della stazione, si rimisero di nuovo in cammino verso la loro meta. Soltanto allora trovai finalmente la forza, che avrebbe sradicato una quercia e tuttavia non riusc a far spuntare una lacrima sui miei occhi, di staccarmi dalL'amata, ma per tornare indietro a prendere le valige, non per altro. E non certo solo (come l'avrei potuto?) bens in compagnia di due amici, due dei pi famosi ironisti della nostra letteratura, coi quali vegliai, nella camera abitata da Astrid, come attorno a un cadavere, tutta una notte straordinaria, facendo discorsi da mentecatto, uscendo di tanto in tanto su un terrazzino annesso alla stanza per guardare le stelle che io mi figuravo ella dovesse contemplare ogni sera, da quel medesimo luogo, e cercando invano dovunque, nei pi segreti ripostigli, qualche reliquia del suo passaggio. Non trovai che una spilla, che raccolsi con religione. Tre giorni dopo ero a San Remo, a poco pi d'un chilometro da Ospedaletti, e per tutto il viaggio, in quel gran mare dell'estate, affacciato al finestrino, non avevo fatto che ricalcare con la fantasia le sue orme e dirmi ad ogni momento: questo lo ha visto anche lei, di qui passata. Stranezze da innamorati! Nel tempo stesso che ero in via di raggiungerla pensavo a lei e l'avrei pianta come se fosse morta. In realt io avevo sofferto la sua partenza come si soffre e si sconta in anticipo il trapasso di una persona cara. Con quello strappo dolorosissimo, quell'inopinato esulare da un paese all'altro, qualche cosa era veramente finito. Mai pi avrei potuto risuscitare altrove l'illusione vissuta in quel piccolo albergo. Come non capire che il mio amore, simile a una gran febbre, a una malattia di stagione, si sarebbe dileguato abbastanza presto in circostanze diverse da quelle che l'avevano visto sorgere e in cui s'era svolto? Ma la vita assai pi ricca di sorprese che non noi di saggezza. Correrle dietro, disertare quel luogo cos pieno di lei, di cui avevo bevuto il filtro, per cos dire, era per me la sola maniera di allontanarmi da Astrid, di fuggirla, bench naturalmente, seguendola, io non pensassi che a commettere la mia ultima follia. Un paese m'incant, un altro mi tolse l'incanto. Due settimane dopo che ero in Riviera la mia caldana si quiet. Inutile aggiungere che il coraggio di troncare quella consuetudine amorosa, ormai spaesata e agonizzante, non potevo averlo che io. L'adorabile Astrid avrebbe continuato a farmi soffrire senza fine. La vedo ancora spiare i miei passi, mentre mi allontanavo per sempre, in seguito ad una delle sue pi esasperanti crisi di coscienza, stando un po' nascosta, col fazzoletto agli occhi, fra le persiane socchiuse della sua finestra di Ospedaletti. Questo l'ultimo ricordo che io serbo di lei. Ecco dunque in che modo si perse, sfum in viaggio, co-
me in viaggio era nata, la mia indimenticabile avventura con la bella scandinava. Ma non bisogna credere che a questa conclusione si potesse giungere per solo effetto d'un mutamento d'ambiente. Occorreva pure la mia volont e infine un terzo elemento, quasi immancabile in queste contingenze e facile a immaginarsi. A San Remo la stagione balneare, per quanto limitata alle famiglie della citt e a una piccola colonia di villeggianti, in massima parte piemontesi, era al culmine. Io passavo le mie giornate, ogni volta che Astrid non mi permetteva di andare a Ospedaletti, fra la rotonda e il "Petit Casino", dove si ballava dalla mattina alla sera. I primi giorni lo spettacolo, per me nuovissimo, dei due sessi che con tanta leggerezza si mescolavano al suono di quelle musiche americane, mi era motivo d'infinita malinconia. Vedevo in ogni fanciulla Astrid e mi doleva di tutte. Ma poi mi ci abituai e finii per trovarci il mio interesse anch'io. E fu cos che una ragazzina dagli occhi verdi mi aiut non poco a farmi dimenticare quelli di Astrid, che erano soltanto turchini. Chiodo scaccia chiodo, dice il proverbio. Sebbene certi empirici rimedi non facciano che sprofondarci sempre pi in quell'inferno da cui impossibile salire alla beatitudine, che si trova descritto nell'Etica spinoziana: capitolo "affezioni". /:/IL CIELO SULLE CITTA'. ETRURIA. LA TOMBA DEL GUERRIERO. Tarquinia un paese abbastanza noto, se non altro per la sua posizione geografica e ferroviaria. Chi non l'ha visto, almeno una volta, percorrendo la linea Roma-Pisa? Nel vasto agro che si distende fra Civitavecchia e il Chiarone, sorge inatteso, con le sue molte torri e i suoi campanili, come una San Gemignano in Maremma. E l'unico paese di aspetto propriamente toscano che s'incontri su questa linea e dista da Roma appena un centinaio di chilometri. I paesi turriti e murati sono frequentissimi nell'interno della Toscana, verso Firenze e nel Senese. Ma qui, su queste lande sospette e cos poco abitate, L'apparizione di una cittadina come Tarquinia, situata sopra un colle non troppo alto e a poca distanza dalla stazione, d luogo a una vera sorpresa, una curiosit, una stranezza, che il viaggiatore non dimentica facilmente, specie se gli accada scoprirla venendo da Pisa, dopo aver viaggiato per ore e ore traverso l'ampia regione solitaria, ondulata e selvosa, che i contadini toscani chiamano "france maremme". Da quella parte il terreno si avvalla profondamente per la presenza di un fiume. E l all'improvviso, appare, sullo sfondo indefinito dei monti che si rincorrono verso il Cimino, una citt medioevale, assai pi elevata, impervia e lontana di quel che non sia su quel versante. Ci che si vede il fianco superbo d'un castello che fu gi della contessa Matilde. Poi la visione si addolcisce, si fa sempre pi lineare e distesa, a misura che si prosegue verso il virgiliano Mignone, un fiumiciattolo che fa da confine fra Civitavecchia e Tarquinia, e solo tutte quelle torri di varia altezza spiegano come il nostro paese nativo abbia potuto suggerire a qualcuno l'immagine bislacca d'un paese "sdentato".
E il caso di dire che Tarquinia ha troppo vissuto per avere tutti i denti a posto. L'incuria degli uomini ha gareggiato col tempo nell'oltraggiare questa che fu una delle pi splendide lucumonie etrusche e forse la capitale dell'Etruria, attesoch gli Etruschi non conoscevano unit se non religiosa e Tarquinia fu appunto come chi dicesse la loro Mecca. Una bellissima leggenda vuole che il dio etrusco, rivelatore dei segreti dell'aruspicina, sia nato nel suo territorio. Schizz dalla zolla, a un colpo di vomere dato da un bifolco, ed era un fanciullo canuto: immagine della sapienza originaria e della spiga matura e argentea. Nato vecchio, scomparve rapidamente come l'erba del prato al tempo della fienatura. Il nome di questo dio singolare Tagete. Ed lui che, danzando e cantando, inizi Tarconte, fratello di Tirreno, fondatore della Dodecapoli tirrenica, re di Tarquinia (la quale dunque prende nome da questo mitico personaggio), nei misteri di quella religione che fu prima etrusca, poi romana. Di qui l'ipotesi che Tarquinia sia stata la citt sacra degli Etruschi. E sacro il suolo che nasconde tante incredibili testimonianze della sua remota esistenza. Ma per ben definire questo paese, cos diverso d'aspetti e di vicende, stimiamo necessario, prima di venire al fatto che c'interessa, qualche chiarimento storico e topografico. L'etrusca Tarquinia, L'"urbem Etruriae florentissimam" non quella che si vede oggi. Essa era situata un po' pi indietro, su due o tre colline schiacciate, si direbbe, dal peso che sostennero per qualche millennio. L rimasta l'orma o, se volete, lo spettro di una citt che dovette essere abbastanza grande, a giudicare dall'area che occupava. Illustri archeologi, per esempio il Ducati, la chiamano metropoli, e madre dell'antica Etruria. Ai nostri occhi la "Civita". E siamo talmente usi a quelle rovine che non possiamo vedere la cima sassosa d'un monte senza collocarvi con la fantasia una citt diroccata. Non immaginiamo altre pietre se non quelle che provengono dalla distruzione dei muri e delle case. Il ciottolo con cui giocavamo da ragazzi aveva gi questo sapore e i sassi che tiravamo ai forestieri erano indizio d'una barbarie, diciamo cos, cittadina. Strano paradosso: la Civita non che una localit agricola poco desiderabile, dove il campagnolo gratta con l'aratro basamenti di colonnati e si disseta a pozzi trimillenari che danno ancora un'acqua viva e salmastra. Il grano ch'egli semina come il sale sulle rovine. Distrutta nel quinto o sesto secolo dell'ra volgare, dopo aver sofferto gli oltraggi d'ogni specie di barbari, Tarquinia risorse quasi immediatamente, poich l'immensit del territorio esigeva questa sentinella che non ha mai cessato di montare la guardia sulle sue colline. Ma cambi sede, come abbiamo visto. Camminando nello spazio come nel tempo, varcando in un breve tratto di due o tre chilometri un abisso di epoche, si trov a rifiorire a margine della via Aurelia, in una posizione tale da volgere le impervie spalle al passato. E si chiam Corneto, nome ispido e medioevale per eccellenza, derivato, questa volta, da un albero selvatico, il corniolo, che appunto l'albero ovverossia lo stemma del Municipio. Non ci sono miti, n favole, alle origini della nuova Tarquinia, ma la comune impresa d'un popolo super-
stite che, nell'alto Medioevo, si trasferisce da un colle all'altro per continuare una storia di cui non ha pi nessun ricordo Ridente era allora Corneto, tutta orientata verso il mare, con le sue torri e mura nuove di zecca, le sue chiese campestri, e la sua cinta ulteriore di orti e di vigne, oltre la quale si stendeva la selvaggia maremma, che Dante vide guerreggiata da un ladrone di strada, Rinier da Corneto, di cui per non traccia nelle memorie locali. Verso la Civita, che come dire verso il nudo altipiano e il monte, non aveva neppure uscita, anche perch di l potevano arrivare i viterbesi, vagheggianti le sue pingui pianure. Sta da quel lato tutto ci che Corneto escluse, per molti secoli, dalla sua vita e dai suoi pensieri. Ancora oggi, sulle immaui alture che si ergono dirimpetto alla Civita e difendono questo paese dalla tramontana, tu non vedi che un convento e qualche chiesetta espiatoria. La citt nascosta, adagiata come un panno al sole, dietro una muraglia ciclopica a cui la superstizione popolare fa quasi divieto di affacciarsi, avendo posto l sotto, in una di quelle orride ripe, la casa della "vecchia mora", un essere immaginario, parente del lupo e dell'orco. Solo in tempi abbastanza recenti, allargando le sue mura, Corneto si decise a tornare sui luoghi abbandonati in antico. Ma oltre a compiervi opere poco allettanti, come prova l'esistenza, in cotesti paraggi, d un "poggio degl'impiccati", era inevitabile che finisse per scavarvi nuove fosse. Due citt morte vennero cos a trovarsi di fronte, in una terra che tutta una miniera di sepolcreti. Sovrana di questo regno la Civita. Per una singolare fatalit l'acqua che noi beviamo sempre passata da quelle parti. Sicch nella nostra fantasia le tombe etrusche si confondono coi grottini o tombini delL'acqua potabile. Ivi sono le cave di tufo e d'argilla, i pozzi del camposanto. Rotea il falco immancabile su questa terra cos predata. E la gente che va al cimitero o che passa comunque per la bianca e ossuta stradetta, che la nostra Via Appia, gusta, senz'accorgersene, il sapore di tutte queste cose buone, velenose, familiari, tragiche. Quanto disputata un tempo, dai sostenitori dei Diritti Civici, la triste campagna che non fu mai di altri se non del Comune, che una propriet collettiva, ma in un senso ben diverso da quel che si potrebbe credere. Non c' terra pi maledetta in apparenza: bruciata dal sole, battuta dalla tramontana, piena di sassi e di tumuli, e piuttosto favorevole al mattonaio che all'agricoltore, per la natura cretosa di quei prati dove si capisce. direi, la scoltura in terracotta, che pare sia stata un'invenzione degli antichissimi tarquiniesi. Eppure, per altro verso, non c' terra pi preziosa e nobile di questa che, unendo le due Tarquinie, raggiunge, coi suoi rari ulivi staglianti nelL'azzurro infinito, le estreme altezze e solitudini del nostro paese. Comunalissima terra, che noi possediamo per trasmissione diretta dagli Etruschi e fu sempre dedicata ad usi esclusivamente civili e pubblici. Se i campi si potessero premiare, questi meriterebbero l'onorificenza suprema. Qui sono tutte le nostre glorie e i nostri affetti. E chi voglia vedere il paesaggio cornetano in quanto ha di pi vario, profondo, meditativo, deve guardarlo da questo ritiro elevato. Meraviglioso l'accordo fra ci che sappiamo della Civita e le impressioni che ci destano le sue reliquie e la sua
posizione. La Civita un mistero naturale e paesistico, una grossa macchinazione della fantasia religiosa e politica degli Etruschi, i quali annettevano tanta importanza a questa loro metropoli che non si unirono contro Roma se non quando videro in pericolo Tarquinia, mentre avevano lasciato Veio e Cere senza difesa, forse perch troppo vicine al nemico e grecizzate in gran parte, quindi perdute in anticipo. La tenebrosa depositaria dei misteri dell'aruspicina era custodita come in uno scrigno. Aveva le pendici nell'ombra, fuggiva il mare, a cui si affidava soltanto dalla parte del fiume e della Toscana, cio ad occidente. Di quel sole rosso che cala dietro il monte Argentaro si colorivano i suoi sogni e le sue brame di citt originariamente corsara. E ai nemici che aspettava dal litorale, perch a monte stavano i suoi, protetti, a loro volta, dalla paurosissima Selva Cimina, baluardo dell'etrusca strategia, opponeva le alte rocce che le fanno da antemurale e perfino i morti, collocati lass, in piena luce, come avamposti. Tutto and bene, finch dur la leggenda dell'insormontabile selva. Distrutta questa leggenda, allora veramente fu scoperta e conquistata la misteriosa Etruria. Niente ormai avrebbe potuto salvarla, essendo stati vinti i terrori e le superstizioni che la proteggevano. La regale Tarquinia, spogliata di due castelli dai nomi bellissimi, Cortuosa e Contenebra, divent a poco a poco un municipio della Trib Stellatina e non ebbe pi altro compito che di tessere la tela per le navi di Roma. In tale funzione appare la citt di Tarconte nel glorioso elenco dei contributi etruschi alle guerre puniche. Ed funzione significativa, se si pensa all'originaria parentela di Tarquinia col mare ch'essa domina, con le sue prospicienti alture, per uno spazio immenso e che una volta copriva il suo territorio. Nella scogliera corrosa che la cinge, dove sorgono avanzi di mura ciclopiche, sono rimaste le conchiglie fossili, a ricordare il diluvio da cui questa citt emerse, E rocce e mura hanno lo stesso colore arsiccio e la stessa vecchiaia geologica. Il mare si ritir di alcuni chilometri, dopo aver compiuto l'opera sua; e noi lo vediamo alto all'orizzonte, da Civitavecchia al monte Argentaro. Ma nei giorni di libeccio, quando pi turchino, arruffato, schiumoso, pare avvicinarsi stranamente come per reclamare la preda. Se non che, da gran tempo, Tarquinia cess di rispondere al fraterno richiamo. La morta collina che noi diciamo la Civita il miraggio, la fata morgana di questo paese, gi cos pieno di effetti illusori. Vagando nel suo dominio, la si scopre da tutti i lati, ci si mostra sotto i pi sorprendenti e mutevoli aspetti. Ora remota, addormentata. Ora imminente, di l da un acquedotto seicentesco, par che si ridesti a un tratto e voglia svelarci il suo segreto: pietraia impazzita nella luce marina. Ora un'erta rupe avvolta nel suo cupo mantello di rovi e di borraccina come una citt di Pluto. Non ci si salva da questa presenza, dinanzi alla quale il cimitero che sorge sopra la tomba di Polifemo un'amabile aiola e la necropoli pi antica e maggiore che lo circonda un dolce limbo, un eliso.
Fu dunque in una terra simile, ma in un tempo in cui della necropoli tarquiniese non si aveva che un'idea molto vaga e la solitudine e l'abbandono di quei luoghi, oggi conquistati all'agricoltura e perfino abitati, qua e l, da contadini e cantonieri, dovevano incutere assai pi sgomento che non ai giorni della nostra infanzia, ai quali queste impressioni si riferiscono; fu precisamente nel 1823, sul finire d'una giornata d'inverno, che un gentiluomo cornetano, sorvegliando l'opera di certi cavatori d'argilla, nelle vicinanze del cimitero, not a un tratto alcuni segni di pietre unite a carboni, che andavano, egli dice, perpendicolarmente. Fatto eseguire lo scavo in quella direzione, ebbe un'avventura straordinaria. Scopr una tomba etrusca, una tomba mai visitata n profanata prima d'allora, caso rarissimo. E vide, giacente sopra un letto rilevato nel sasso, un guerriero, che in pochi minuti svan sotto i suoi occhi. Via via che l'aria entrava nella tomba, il corazzato guerriero, quasi fosse impastato dello stesso elemento, si dileguava, non lasciando alla fine su quel giaciglio che una vaghissima traccia della sua millenaria presenza, mirabilmente confermata, incredibile a dirsi, da qualche brandello di tunica gialletta, e le armi che, fiancheggiandolo d'ambo i lati, rendevano la sua sparizione pi impressionante. Questo il prodigio. Colui che ne fu testimone lo aveva spiato dal difuori, traverso una finestrella che s'era aperta nel soffitto della tomba, sollevando una lastra di tufo. Cos aveva sorpreso, esterrefatto, il risveglio di uno spirito nel suo sepolcrale dominio. E non ebbe timore, malgrado la cattva stagione, L'ora tarda, il sito pauroso, di calarsi in quel sepolcro disertato e sonoro. Lo ispezion in ogni angolo e di quel che vide e trov l sotto ci ha lasciato una sua relazione, trascritta nelle "Notizie storiche e archeologiche di Tarquinia", opera dotta e letteraria pregevole di Luigi Dasti, che fu il primo sindaco di questa citt. Leggendo tali pagine si ha l'impressione di veder uscire dalL'ombra il tesoro del conte di Montecristo. Ma si trattava d'un tesoro sepolto bene in fondo, nelle correnti salde della terra; non valutabile in moneta inglese, quantunque i primi ad accorrere sul posto fossero, come sempre, i britannici. Scendendo a recuperarlo il nostro gentiluomo fece, senza saperlo, il viaggio di Ulisse all'Inferno. Egli si trov sbalzato in un altro tempo, in un luogo indefinibile, dove tutto parlava il grande linguaggio funebre degli Etruschi, nelle forme pi commoventi e dirette. Vi si vedevano spoglie bruciate devotamente o distrutte, spezzate, quasi con disperazione o trasandatezza nell'adempimento del rito. Vi si erano celebrati dei sacrifici, consumati dei pasti di avvoltoi. Per terra e alle pareti si alternavano scudi, lampade, lagrimatoi, boccali, vasi d'argilla stupendi e cocci disadorni e rossi in gran copia. Il guerriero appariva, o meglio, era apparso equipaggiato in maniera da non poter porgere l'obolo a Caronte se non sulla punta della spada; avendo vicino al capo un'urna contenente i resti inceneriti del suo carro di guerra. A poca distanza dal letto un simbolo acre e tenero, una immagine lacrimosa e quasi cristiana, vegliava il sonno del guerriero attendato per l'eternit. Consisteva in un diadema d'oro la-
vorato a gigli e posto, ad arte, sopra un mucchietto di terra nera e finissima, in mezzo a una tavola quadrilunga, di pietra lustra e rossina, scorniciata a guscio, alla quale non mancava che lo specchio per essere una "console" perfetta. Ci si sarebbe vista volentieri una pendola su questo mobile da salotto, che reggeva invece una sorta di "memento homo" e, appoggiandosi per tre lati su gambe di tufo sco, per il resto a una sporgenza della roccia, veniva ad assumere una tremenda stabilit funeraria e tombale. Che lugubre senso d'addio in quelle tazze di bucchero nero, schierate davanti alla porta! Sebbene avessero preso internamente una patina quasi vegetale, argentea, che le riconduceva alla natura e impediva ormai di considerarle con un sentimento diverso da quello che pu ispirare un fiore, una pietra, non era possibile non pensare che proprio su queste tazze si erano posate, per l'ultima volta, le mani di coloro che s'allontanarono dalla tomba, in un'epoca remotissima. In quella sepolcrale armeria, in quel forno crematorio spento da migliaia di anni, le ceneri si erano impietrite, le armi ossidate, il leggiadro diadema, di bronzo laminato d'oro, si spezz fra le mani dello scopritore. Le cose stesse erano morte e, pi che morte, incantate. Non avevano pi peso, come se fossero nell'acqua. Il tempo, invisibile ospite, aveva lavorato subdolamente in quella tomba sfuggita, certo per volere d'un dio, alle profanazioni dei vandali e dei saraceni e ad ogni altra manomissione, ma non all'opera della natura e del tempo. Eppure l ogni cosa stava come l'avevano messa o casualmente lasciata i superstiti, i familiari del defunto. Gli oggetti pi disseccati e prossimi a polverizzarsi conservavano la loro posizione originaria, mostrando di aver non subto, attraverso gli evi, la minima scossa. In cos lungo fluttuare di et in et un solo spostamento si era prodotto nell'inviolata dimora, a motivo di alcuni chiodi che, staccatisi da una parete, avevano lasciato cadere a terra gli scudi e i boccali di bronzo. E questa piccola rovina, che faceva l'effetto di una enorme catastrofe, poteva essere accaduta mentre si apriva la tomba oppure mille o duemila anni prima. Il tempo non si calcolava pi, l dentro. L'umanit del luogo sfuggiva ad ogni processo di fossilizzazione e quella tomba, fresca di venticinque secoli di clausura assoluta, suscitava gli stessi sentimenti che se fosse stata arredata e murata il giorno innanzi. C'era in questa scoperta qualche cosa di veramente inatteso e di troppo. Nondimeno l'ottimo pioniere del sottosuolo etrusco, il cercatore, vorrei dire, d'oro nero, non fu neanche sfiorato dal dubbio di poter essere un profanatore, sia pure involontario. Egli scrive anzi che quello fu il pi bel giorno della sua vita N sospett la collera degli dei nella tempesta che lo colse, scendendo la notte, al termine delle sue esplorazioni. Il fatto che una pioggia improvvisa e dirotta lo costrinse, fra lampi e tuoni, a sgombrare la tomba in gran furia. Il tesoro fu riposto, per il momento, in una capanna vicina, dove giacque ammucchiato in un angolo, coi picconi e le vanghe che avevano servito a scoprirlo. E in quest'opera frettolosa e vagamente sacrile-
ga alcuni oggetti andarono in frantumi, altri furono rubati dai lavoranti, col favore dell'oscurit e della pioggia. Cos ebbe fine il memorabile episodio, da cui presero le mosse, per la curiosit destata in tutto il mondo, gli scavi della necropoli tarquiniese e di altre consorelle e circonvicine. Se cggi possiamo vedere a Tarquinia una trentina di tombe affrescate, d'inestimabile valore archeologico, lo dobbiamo in gran parte a un simile evento. Ma la tomba che abbiamo descritta, residenza estrema, ultimo quartiere d'inverno d'un guerriero etrusco, non aveva le pareti dipinte. Quindi l'archeologo la trascur. E ormai i detriti l'avranno colmata, o sar una delle tante buche sospette che s'incontrano per quella terra argillosa e tufacea che i tarquiniesi chiamano, a cagione dei molti tumuli di cui sparsa, "li Monterozzi". GLI ETRUSCHI Una vecchia favola di mia particolare invenzione, mi dice che i Tirreni, progenitori degli Etruschi, vennero dal mare. Chi li vuole autoctoni o calati dalle Alpi non s' forse mai domandato che cosa portano con s i Tirreni venendo in Italia, non pensa ch'essi recarono la luce mediterranea fin nelle pi remote caverne dell'Appennino, ci che basterebbe ad accusarne l'origine. E tuttavia nell'esser rimasti un popolo essenzialmente marinaro, anche dopo aver compiuto una cos profonda conquista terrestre, fu la loro pi vera debolezza nei confronti di Roma e di altri nemici interni, la loro contraddizione originaria e insanabile. Non si pu capire come nasce e muore la nazione etrusca senza riferirsi costantemente alla sua provenienza e fantasia marina. Gli Etruschi appartengono all'Italia. Si sono fatti su questa terra. Le loro divinit sono tutte indigene e locali come le pietre e i metalli che lavorarono. Ma dal contatto degli avventurosi Tirreni coi laboriosi Umbri nacque la civilt etrusca, la quale ha origini sconosciute e lontane; sicch si pu dire che il seme della detta civilt, come quello di certi fiorellini che crescono da noi, in Maremma, attorno alle tombe etrusche, fu portato dal vento a questo paese marino. I Tirreni vennero sul vento e dal mare. La loro apparizione in Grecia, in Egitto, e finalmente in Italia, ha da vedere, nella mia fantasia, con la caduta di Ilio. Il loro viaggio fu quello stesso d'Enea. Sbarcarono sulla riva destra del Tevere, poich la presenza dei Greci nel Mezzogiorno e dei Liguri a Nord non consentiva loro altro approdo. E s'intende facilmente come su quelle aperte sponde inospitali e malsane non potessero vivere che da pirati. Me li immagino benissimo corsari, i padri Tirreni, a cui si attribuisce, fra l'altro, L'invenzione dell'uncino d'arrembaggio, che non disdice alla fantasia etrusca. I Greci, autori di questa quanto di altre informazioni e calunnie sui loro competitori d'oltre Tevere, li chiamarono anche selvaggi e certo in origine dovevano esserlo, come il loro mare. Grazie a questi leggendari predoni fu scongiurato il pericolo che l'Italia diventasse tutta greca. Spazzati, con la furia di una libecciata tirrenica, i Focesi dalla Corsica, L'isola toscanissima venne
uncinata all'Etruria. Onde noi possiamo vantare su quelle acque un diritto che risale, per l'appunto, agli Etruschi. Ma la stessa necessit che impediva ai Tirreni di stabilirsi civilmente sulle rive li port ad inoltrarsi nella terra: nella dolce terra umbra che li invitava come una famigliare Calipso. Eccoli sui colli maremmani, dove la montagna prossima e il mare gi perduto. Tutta quella vasta regione che la remotissima Tuscia, L'Etruria primigenia, si compone in un irresistibile slancio verso il monte. Navigano le greggi sulla pianura ventosa, che s'avvia rapidamente a diventare altipiano, pilota l'aratore, ondeggiano le messi e le groppe schiumose dei cavalli balzani. E chi viene in Maremma da marinaio si tramuter in agricoltore, come accadde ai Genovesi nel breve tempo che ebbero la mia citt nativa in bala. Cos dunque la Maremma, rigata di fiumi, fu pei Tirreni la porta dell'Appennino. In questa regione di passaggio, sctto tutti gli aspetti, furono presi nel corso delle migrazioni interne. Illusi e impigriti, nei loro istinti marini, dal vento della Maremma, che vento di mare e di terra, si famigliarizzarono con la terra stessa e non tardarono a scoprire i limiti montani dell'ampio paese degli Umbri, che scno alle sorgenti del Tevere e dell'Arno Giunti lass, dove le possibilit di avventura terrestre si moltiplicavano all'infinito, capirono di non poter tornare pi indietro. Avevano varcato le loro colonne d'Ercole. Cominci allora quel viaggio senza ritorno che la colonizzazione etrusca in Italia: favola del paesaggio italiano, storia naturale, antefatto necessario della storia di Roma, che pare desunto dai golfi, dai promontori, dai fiumi e dalle rocce del nostro paese. Quasi avvertissero d'aver compiuto una grande infrazione, abbandonando la consuetudine marinara, si direbbe che i Tirreni esitino a chiudersi nelle valli: s'affrettano a scendere dai monti troppo alti e selvosi, corrono alla pianura e fanno la spoletta fra un mare e l'altro. Amano come sempre le alture v entilate e rupestri che, se non vedono il mare, sembrano volerlo scoprire o averne in qualche modo il respiro e la luce. Ma cercano porti, sbocchi, regioni metallifere o pianeggianti. Ed ecco, circa nel tempo stesso che nel Fiesolano, dove giungono alquanto a rilento, portati dal fiumicel che nasce in Falterona, s'affacciano guardinghi, per timore dei Liguri, in Lunigiana, in Val di Magra, sfiorano volentieri il paese dei Piceni, e vanno verso Rimini, verso Bologna e l'alto Adriatico a cui visibilmente miravano. Sulle Alpi Retiche alcuni di loro ci arrivarono soltanto perch sbattuti dalle prime irruzioni galliche. E si deve a questa bufera la singolare esistenza, da quelle parti, di popolazioni artigianesche, parlanti un dialetto aspirato, comprensibile ai contadini della Versilia. Altri, rifugiatisi fra le paludi, fondarono Mantova, che si giov a lungo del malsano elemento per conservare la sua nobilt etrusca. Altri ancora, su antichissime fondamenta umbre, edificarono Ravenna.
Gi la potenza tirrenica si estendeva fino al Volturno; e Roma nasce sopra. un suolo abbondantemente lavorato e scavato dagli Etruschi. Ma di l dal Tevere il pericolo pei Tirreni e pare proprio, a vedere come procede la loro penetraZione in Italia, ch'essi temano la terra nella quale si sono lanciati con folle volo e che li attira sempre pi dentro. Se ci si attaccarono in modo che la storia non conosce un popolo pi fermo, pi radicato, fu soltanto perch in loro l'amore della terra si confondeva con la religione dei morti. Per questo fatto principalmente, per riguardo ai morti, che essi miravano a seppellire intatti, come per una lenta rigenerazione, si affezionarono alla terra che li custodiva; e tutto quel che fecero gli Etruschi non fu, in sostanza, che una grande opera di ricognizione e consacrazione del suolo italiano. Cos possiamo spiegarci il profondo sentimento del paesaggio che li distingue; per cui basta guardare i luoghi dove, con non so quale arcana predilezione, i Tirreni si posarono, per capire l'Etruria. Questa ha il colore del nenfro, tufo bruno, come la Toscana moderna ha il colore della pietra serena. Allorch Dante apostrofa l'ingrato popolo maligno che discese di Fiesole ab antico e tiene ancor del monte e del macigno dipinge, alla sua maniera, il popolo etrusco. E se volete farvi un'idea dell'Etruria (sebbene un po' tarda e romanizzata, perch la primissima Etruria, coi suoi pellegrinaggi annuali al santuario di Bolsena, la giovane e felice Etruria, che beveva il vino d'Orvieto e di Montefiascone, era assai pi soave, pensate alla Toscana del Medioevo, agli affreschi dell'Orcagna, alla geologica fantasia dantesca. Etrusco Leonardo, nella sua negromantica famigliarit con la natura. Etrusca la mente di Machiavelli, inesplorabile caverna. L'amore, anzi il gusto della terra, fu ci che perse gli Etruschi. Questi uomini, questi navigatori approdati, a cui la religione era stata rivelata da una specie di gnomo, balzato dalle profondit del solco; che pare abbiano inventato la scultura in terracotta e lavorarono di preferenza le pietre pi caduche e magari ignobili, purch locali, non vivevano alla superficie, ma quasi dentro la terra. I ricordi pi impressionanti che ci abbiano lasciati gli Etruschi, oltre alle loro necropoli, sono cave, cunicoli, squarci nella roccia rifiuti minerari, ponti seminaturali, cascate. Esploravano il sottosuolo come gente abituata, si direbbe, a scandagliare il fondo marino. Studiavano le viscere degli animali, il senso misterioso dei fulmini e dei portenti, si davano pensiero, pi che non fosse necessario, dei segreti dell'oltretomba, e tutto quel che esorbita, in natura, dalle umane conoscenze li avvinceva in modo che quando Roma li sorprese essi erano gi esuli, gi dimentichi del mondo e prigionieri del loro inferno. Fra le altre cose gli Etruschi, pieni di sottigliezze religiose e curiosissime superstizioni avevano fissati i limiti
della propria durata; e forse per questo riconoscevano il loro dio nazionale in Voltumna, dio delle vendemmie, che ha i colori dell'autunno e del tramonto. Si sentivano destinati a passare. L'eternit di Roma non poteva che sconfiggerli. Roma, potenza formidabilmente terrestre, uscita da un terremoto, che ha il suo epicentro nel Lazio, Roma la terra stessa, la terra italiana la quale si libera dai suoi mitici colonizzatori o, per meglio dire, li inghiotte. Ma nelL'urto con Roma non cadde l'Etruria. Caddero bens i favolosi Tirreni o Raseni, rimasti marinari, nonostante la loro disposizione a interrarsi. Di questi ulissidi della terra noi custodiamo le tombe come gli avanzi d'un glorioso naufragio. In mezzo alle giovani popolazioni autoctone dell'Italia antica, la vecchia Etruria sacerdotale, impolitica, magica, dispotica, fa pensare a Bisanzio. Ma Bisanzio lo spettro di Roma, laddove l'Etruria ne la spirituale matrice. La semplicit romana fiorisce su quest'abisso. VITA DELLE TOMBE ETRUSCHE Se ripenso al mio paese, come l'ho conosciuto e me lo ricordo, non posso meravigliarmi troppo di ci che vedo nelle sue famose tombe dipinte, in quegli affreschi venticinque volte secolari, dove il colore, gettato spesso bravamente sulla nuda pietra calcarea, par rifiorire a contatto del salnitro che lo corrode. Le danzatrici funebri, cos frequenti in questi affreschi, non sono che antichissime ballerine di tarantella e l'immancabile tibicino dal passo lungo e dalle magiche dita, il mistico citaredo, tutto raccolto sul suo strumento, con la fronte appoggiata alla cetra e la mano aperta e lieve sulle corde come un rassegnato prigioniero alle sbarre della finestra, mi sembrano quasi naturali predecessori di quei fanatici musicanti che al tempo della mia infanzia misero sossopra il popolo e il comune con le loro bizze e rivalit bandistiche. La scena che rappresenta, non so pi in quale tomba, un uomo chiuso nel sacco e azzannato da un mastino tenuto al guinzaglio, riproduce iperbolicamente uno dei tanti gicchi ai quali si assisteva nella ricorrenza di Sant'Antonio, protettore delle bestie. La corsa dei somari, in quel giorno raggiungeva il colmo della crudelt e del grottesco etrusco. E soltanto una perfidia sottile e consumata, propria della moralit e fantasia degli Etruschi, poteva inventare l'albero della cuccagna, di cui non mancano tracce in qualcuna delle nostre tombe e precisamente in quella della Caccia e Pesca, che tomba tarquiniese e maremmana per eccellenza. Vi si celebrano, in perfetto accordo col nome che le fu dato, i fasti dell'arte venatoria e pescatoria. Ma interessante notare come in tutte le sue pitture non s'incontri una sola bestia catturata o morta, fuorch in un particolare di cornice, nel quale raffigurato un cacciatore che torna con una lepre uccisa e appesa a un bastone in bilico sulla spalla, mentre il fido bracco lo segue annusando e scodinzolando. I grandi quadri vogliono descrivere, pi che episodi di caccia e di pesca, la gioia, L'esultanza degli uomini e
degli animali per la bella stagione che ritornata. Zefiro torna e 'l bel tempo rimena... I dipinti di queste due stanzette, scavate a una profondit di dodici metri, ricordano, sia detto di passaggio, certi affreschi dell'Orcagna. Solo che nella tomba tarquiniese, in luogo di diavoli, si vedono animali marini, terrestri, palustri in gran copia e in lieta promiscuit, come in una favolosa rappresentazione della creazione del mondo. Veramente nuova, emersa appena dal caos, appare la terra in questo bellissimo poema pittorico. Gli scogli marini sono ancora fioriti di corallo. Il pittore ha dato il massimo spazio al mare, al cielo e alle loro creature. Caso piuttosto raro nella pittura antica, le figure umane sono piccole, inevitabilmente comiche e quasi perdute nel vasto universo che le circonda, sebbene incise e colorite fortemente con l'acre vigore d'un animalista. Qua e l, su uno di quegli scogli coralliferi, un tiratore di fionda invaso da furor venatorio, in atteggiamento caricaturale e danzante, scocca i suoi colpi a vuoto contro nuvoli di uccelli che, imperterriti, seguitano a volare verso di lui come per beccargli il naso. Sono forse "padellari" questi cacciatori etruschi del VI secolo a. C.? O forse la religione etrusca vedeva la caccia poco di buon ccchio e l'artista ha dovuto limitarsi a darne un'immagine puramente decorativa? Lo stesso accade pei pescatori gi sotto, i quali se ne vanno in barchetta sopra un mare di trine, molto simile a quello della "Nascita di Venere" di Botticelli; dove i delfini impazziti, ma per nulla turbati da quelle barche pescherecce, gli si affollano attorno, schizzando fuori dalle artificiose ondicelle a guisa di salmoni che risalgono la corrente. La strabiliante presenza di un'anatra in mezzo ai giocosi delfini (pare si tratti d'un simbolo) accresce l'umorismo dell'allegra vicenda marinaresca; mentre il solo episodio emozionante, fra tante scene gaie e incruente, quello d'un forsennato che da un'altissima rupe si butta in mare per mettere un po' di scompiglio in un gruppo di pescatori che assistono da lontano all'incredibile tuffo. Se non che il forsennato un nuotatore provetto, un campione del salto in acqua, a cui la primavera ha dato alla testa. E nulla potrebbe valere meglio di questo miracoloso episodio a esprimere il furore d'una primavera in Maremma. Questa che ho cercato di riassumere, tralasciando infiniti altri particolari leggiadrissimi, la rappresentazione fedele, bench fantasiosa e burlesca, di una delle pi belle giornate della mia terra La stessa amabile confusione che vi si nota, fra cacciatori e pescatori, tipicamente maremmana; e per conto mio non posso guardare i dipinti della Caccia e Pesca senza che mi si affollino alla memoria una quantit di figure e sensazioni di stagione su cui non star a dilungarmi. A proposito di caccia, nessuno credo si meraviglier di trovare al mio paese una tomba dedicata alla caccia al cinghiale, che noi chiamiamo "cacciarella", con riferimento, suppongo, alle molte piccole e sparse battute necessarie a circuire la bestia. Purtroppo le sue pitture sono quasi del tutto scomparse, ma al tempo in cui furono scoperte si ve-
devano ancora (cito da Luigi Dasti, il gi ricordato storico di Tarquinia) "la testa d'un cavallo spinto sulle tracce della belva, il piede d'un uomo, la testa d'un altro cavallo, un altr'uomo che sembra suonare la cornetta, e poi la figura del cinghiale che fugge e due uomini a lui vicino che lo trattengono". Tutta la meraviglia che posso provare io a questa descrizione consiste dunque nell'apprendere che anche i tarquiniesi di venticinque secoli addietro andavano a cacciarella. E quello strumento che il nostro storico scambia per una cornetta doveva essere probabilmente la famosa "lumaca", cio il conchiglione marino, battezzato da D'Annunzio "buccina tritonia"; giacch appunto con questa fragorosa, oceanica tromba che si snida il cinghiale nelle macchie, oltre a fare, al bisogno, la serenata alle vedove in procinto di rimaritarsi. Con tale svegliarino gli eroi della cacciarella sogliono inoltre annunciare la loro partenza ai dormienti, sul far dell'alba, e il loro trionfale ritorno, di sera, col corpo del cinghiale issato su un carriolo che i prodi cacciatori fiancheggiano, andando a piedi, e i suonatori di buccina precedono, a gote gonfie, come in una caricatura carnevalesca del "Trionfo di Galatea". Usanze oggi un po' impallidite, ma ai miei tempi ancora vive e, ad ogni modo, antichissime quanto il gioco del Saracino e la corsa dei barberi, descritti rispettivamente nella "Tomba del Triclinio" e in quella del Barone. Qui, appena entrati, vi sorprenderanno due mirabili cavallini danzanti e pensanti. Sono cavalli maremmani passati attraverso le convenzioni stilistiche di quell'imperturbabile paradiso che la pittura etrusca dei primi secoli. E vengo alle scene conviviali, tema obbligato d'ogni tomba etrusca. Su quest'argomento ci sarebbe da scrivere un capitolo a parte. Mi limiter a dire che al mio paese tutto buono a giustificare un pranzo, una cena, una merenda. Il rito conviviale suggella ogni lavoro fatto in comune, consacra i frutti della stagione, santifica le ricorrenze, i guadagni, le gioie, qualunque soddisfazione si possa avere dalla vita Perfino un vestito nuovo, perch sia valido, ha da essere "bagnato", cio festeggiato, da chi lo indossa, con un'offerta propiziatoria di qualche bicchiere di vino ai suoi solleciti e complimentosi amici. Ma quel che pi conta e accusa l'eredit etrusca lo spirito con cui si partecipa e ci si prepara a simili eventi. Un banchetto da noi presuppone una vigilia, un digiuno. E qualche cosa di sacro, una cerimonia religiosa, che gli eletti dell'agape celebrano mangiando concordemente, nel pi assoluto silenzio, con la testa al piatto e il collo inarcato come cavalli alla greppia. Cavalli, beninteso, di razza. Sedendo a mensa con questi omerici mangiatori non proverete nessuna di quelle sensazioni sgradevoli o addirittura odiose che vi d cos spesso il prossimo vostro nell'atto manducatorio. Per esempio, sar ben difficile che li sentiate fare, masticando, quello stomachevole strepito di cui ragiona Monsignor Della Casa. Non si puliscono le labbra col pane, per poi trangugiarlo, come usano, purtroppo, anche persone squisitissime. Non si alzano da tavola con lo stecchino in bocca. Tutt'al pi, dato ch'essi pasteggiano in silenzio, rimandando ad altro tempo i discorsi, gli affari, i litigi, potrete avvertire, di tanto in tanto, il poderoso e solidale fragore delle loro sgranocchianti mascelle.
Qualche anno addietro una trentina di amici si trovarono uniti nel far la festa a una vitella. Se la papparono in campagna, lungo la riva del sonante mare. Quindi vollero che della loro prodezza rimanesse un ricordo fotografico. E bisogna vedere che pance! L'"obesus etruscus" non una leggenda. Ma la pancia maremmana, piuttosto rara fra la gente di citt e frequentissima invece nei cosiddetti mercanti di campagna, cresce a cavallo, all'aria aperta. Fedeli al principio "chi disse cammina disse a cavallo", i maremmani si fanno grassi e pingui a forza di cavalcare, passando le loro giornate su quella bardella certamente pi comoda e soffice dei letticcioli ove giacevano, banchettando, gli antichi Tirreni. E a proposito del tanto bistrattato "obesus etruscus", vorrei esprimere un'opinione che non mi sembra del tutto sballata. Credo che gli scultori etruschi esagerassero l'obesit dei loro defunti personaggi per poter dare della morte un'immagine tanto pi efficace e carnale, resa, per cos dire, pi viva, pi edificante, da un forte richiamo agli agi, all'autorit, alla ricchezza, quale pu esser suscitato dalla vista d'un ventre abbondevole. Poi perch, oltre tutto, quelle pance enormi, che escono dalla toga discinta come la spuma dal mare, sono un elemento plastico e monumentale d'indiscutibile effetto, specie nei sarcofaghi di pietra. Si spandono sui coperchi sepolcrali come la pasta del pane sulla spianatora e lasciano gi intravedere, su quei letti funebri, le gaie immagini degli Dei marini e fluviali che orneranno pi tardi le nostre fontane. Ecco, in sostanza, per quali motivi non volgari gli scultori etruschi amarono i tipi corpacciuti. Ecco ci ch'essi vollero adombrare nel raffigurarli con tanto sfacciato realismo, contribuendo innocentemente alla brutta fama di popolo decaduto e molle che gli Etruschi finirono a procacciarsi nei secoli tardi. Sulla quale fama, dovuta in gran parte ai Greci, loro naturali antagonisti, ci sarebbe tuttavia qualche cosa da dire. Ma ci che per il momento m'importava notare, in rapporto agli usi e costumi del mio paese, il carattere locale e realistico, la divina famigliarit della pittura e dell'arte etrusca. LA ROMA DEL RINASCIMENTO Una citt percorsa da un fiume sembra che non se ne possa allontanare troppo se non a patto d'inaridire, quasi che i fiumi, anche in tempi straordinariamente progrediti come i nostri, continuassero ad esercitare la loro misteriosa funzione di apportatori di vita. Roma vecchia, a differenza della nuova, tutta fiumarola. Le sue maggiori vie seguono il corso del Tevere o se ne distaccano leggermente a misura che procedono, andando a tre a tre, a ventaglio. Argini frequentatissimi e allegri la circondavano una volta. I vecchi ponti, a Roma, sono i soli che abbiano ancora un senso, una poesia. "Ve d la bona sera e passo ponte", dice lo stornello. Soprattutto fluviale, per amore di quella luce, fu la Roma del Rinascimento. Le vie principali di quest'epoca si lasciano guidare dal Tevere che scorre dietro le loro case. Sono rettilinee, prospettiche, e si potrebbero dire paesistiche, a
condizione di tener presente che il paesaggio, nella concezione civica romana di ogni tempc, qualche cosa di ben distinto ed escluso dall'abitato. Tanto vero che il Rinascimento, pure amando la natura, gli alberi, il lontano orizzonte, soleva mostrarli in prospettiva, come abbiamo detto, sulla linea dei caseggiati, oppure mediante archi posti in fondo alle strade, a imprigionare il cielo, a segnare un limite fra la citt e la campagna, fra un quartiere e l'altro. Si tratti di archi veri e propri o di cavalcavia o di antiche porte ricostruite o di passaggi aperti nelle vecchie mura, il valore architettonico di queste soluzioni stradali non cambia e la loro presenza ti ammonisce invariabilmente che stai varcando un confine ed entri in un'altra sfera. Fa dunque attenzione, andando per la Lungara, a Porta Settimiana, se non vuoi trovarti impreparato in mezzo ai bulli trasteverini. Il passaggio brusco, il contrasto vivissimo. Trastevere tanto facinoroso e popolaresco quanto la via che ti conduce nobile e sonnolenta. Perfino la luce sembra diversa fra quelle due regioni che si toccano. Roma piena di queste bellissime e sensibilissime differenze fra quartieri finitimi. Anche i Borghi vedono Prati di l da una fila di archi. Ogni volta che si entra o si esce dalla cittadella di San Pietro si ha il senso di oltrepassare una soglia. E per l'arco di via Giulia, uscendo da un sonno di secoli, si sbocca nel Ghetto. Non c' un altro luogo che ti faccia entrare in dimestichezza con la vita romana del Rinascimento come via Giulia. Laggi sono ancora le bellezze che furono di moda nel Cinquecento, le donne che somigliavano a Lucrezia Borgia, a Beatrice Cenci. Tutto ci parla di Giulio II, di Paolo III, di Cosimo de' Medici, e altri simili personaggi. La gente che sta a prendere il fresco sui portoni o alle finestre (ben poca, per la rarit delle case private, quasi tutte di nobile aspetto, sebbene ormai generalmente scadute) ha il colore dei luoghi. E la medesima gente ch'ebbero sotto gli occhi Raffaello, Guido Reni, e par che si rammenti di Benvenuto dell'incendio di Borgo e del Sacco di Roma. A via Giulia il tempo s' incantato. Il suo stesso piano, cos basso che da qualunque parte ci si vada bisogna scendere e si arriva quasi al livello del Tevere, ne fa una via sepolta pi che dimenticata e trascurata dal traffico. Percorrendola verso sera, ci si sente vagabondi, elegiaci e turisti, non meno che sulla Via Appia. Siamo nella Roma del Rinascimento. Calpestiamo il suolo di una citt sprofondata, che non conobbe se non pochi anni di splendore, compresi fra il pontificato di Giulio II e quello di Clemente VII e di Paolo III, cui segue una lunga, immemorabile decadenza. Troppo beata per poter durare, morta giovane; poich i fulmini dei protestanti e le orde dei lanzichenecchi ne interruppero bruscamente lo sviluppo, allo stesso modo, vorrei dire, che una pioggia di lapillo sotterr Pompei. Cos rimasta, quasi nuova, intatta Disertata fin da quando i Papi della Controriforma spostarono il centro dal quartiere di Banchi a quello di Campo Marzio, quasi ad espiazione, e considerata, da allora in poi, come una citt da riconsacrare. Questa Roma sopravvissuta
e stupendamente anacronistica non pi che natura. Vive soltanto della sua assoluta bellezza, nella luce che riceve da uno dei luoghi pi ridenti del paesaggio romano e che, indissolubilmente sposata con le sue architetture, le conferisce una giovent perenne. La storia non consum le sue pietre, bens le intemperie, il lungo abbandono, poterono offenderle. E le sue rovine sono, pi che edilizie, geologiche. L'arco da un capo, dall'altro la Chiesa dei Fiorentini, formano i due magnifici ingressi di via Giulia, che ha, nel suo andamento rettilineo, lo stesso rigore allucinante, il delirio di uno scherzo prospettico della pittura del Cinquecento. Sia che tu la vegga dall'alto del Lungotevere, tagliata come in mezzo a un bosco, fra due montagne, o che lasci cader l'occhio, passando, nei suoi androni, cortili, giardini, sei sempre nel dominio della Dea Prospettiva, in un mondo irreale e magico, dove ogni cosa, allontanandosi, appare nella sua posizione assoluta, fissata per l'eternit. Ecco laggi, in fondo a un magazzino buio, nel rettangolo illuminato d'una terrazza, un uomo seduto e pensoso come in un quadro, in un'altra vita. Non so perch a via Giulia non s'immagina un lupanare, non si pensa che possa accadere un delitto. Una virt incorruttibile diresti che la preservi dal decadere al punto a cui sono giunte altre strade vicine; bench i secoli abbiano fatto del loro meglio per deturparla ed affliggerla; e prima ancora che il Rinascimento avesse finito di costruirla, come attestano i vestigi di quel grandioso edificio del Bramante, rimasto alle fondazioni, era gi abbandonata e morta. Vennero in seguito i tempi della mortificazione i quali, a via Giulia, non fabbricarono pi se non chiesuole barocche, ospizi e, da ultimo, un carcere a cui mette un vicolo detto del Malpasso. Insieme con queste tarde e cupe costruzioni, che spiegano la sua solitudine, qua e l un po' torva, vi si vedono tracce di vandalismi antichi e recenti. Nel secolo scorso i soldati francesi, di presidio allo Stato Pontificio, si divertirono, a quanto sembra, a scalpellare lo stemma del Palazzo Sacchetti, come pure, io suppongo, gli stemmi di Castel Sant'Angelo, egualmente sfregiati e irriconoscibili. Ma nulla poteva sorpassare, in fatto di vandalismo, l'aver lasciato in piena bala della plebe quei palazzi e quelle palazzine dove Papi, Principi, artisti famosi del Rinascimento, ebbero una gaia dimora, e che nondimeno, caduti in condizioni miserevolissime, con la gabbietta del canarino e i pedalini stesi dietro i vetri delle finestre, sorridono, occhieggiano, quasi volessero narrarci i loro galanti segreti. L'aspetto di via Giulia dolce e tragico insieme. Fra quelle due file di palazzi danneggiati e abbaglianti la nostra fantasia si smarrisce come una rondine che non trova pi il nido. Di notte via Giulia pi deserta e silenziosa della luna che la illumina E fu una via papale, fastosa. Aperta o quanto meno ricostruita da quel gran Papa che le die' il nome, da Giulio II, era forse particolarmente dedicata ai cortei, alle cerimonie. Per questa strada fonda, lunga, diritta, passarono solennissime processioni. Che fosse nel Rinascimento una via affettuosa e prediletta dalla Curia par di capirlo anche dal modo come, giunta infine a via Paola
piega dolcemente verso Ponte Sant'Angelo, dando, in quella voltata, L'idea di un braccio che si porge. Ormai non pi che il letto scoperto d'una fiumana. Se passi in tram per il Lungotevere, dietro via Giulia, vedrai, fra una successione di case che si mostrano gloriosamente dalla parte della cucina e del cesso, una specie di tempietto coperto di tegole rustiche e sormontato da due testoni di marmo e da alcune maschere teatrali, pure di marmo, che a prima giunta non si capisce come possano trovarsi in cotesti luoghi, divenuti popolari e trasandatissimi. Sono residui dei tempi felici e folli del Bibbiena.ROMA BAROCCA In una citt destinata a ricevere carattere dal barocco, il Rinascimento appare un'epoca talmente perduta, miracolosa ed assurda, che si spiega, in un certo modo, L'abbandono in cui fu lasciata la Roma di quel periodo e perfino il sinistro colore che ha preso in qualche punto. E una Roma senza chiese, almeno in origine, troppo terrestre, fiorentina, e vorrei dire etrusca, che i secoli successivi non potevano se non trascurare ed occultare, anche perch sarebbe stato difficile competere con quello stile. E oggi, per farsi un concetto del Rinascimento a Roma, bisogna compiere un vero viaggio di esplorazione. Cionondimeno se Roma papale ha un'ossatura edilizia la deve a quei tempi insuperati e brevi, agli architetti del Cinquecento, che costruirono sul sodo, in un terreno pianeggiante, ma pure, qua e l, accidentato, non privo di saporose e opportune disuguaglianze, i primi rettifili del mondo, edifici leggiadri e solidi come fortezze, luoghi fantasiosi e demoniaci, quali i dintorni di via dei Coronari, tutto quel che di pi ammirabile contiene questa citt, in fatto di architettura moderna. Ben altro per bisognava fare di Roma. E venne il Seicento. Il quale seguit a costruire e a distinguere la fisionomia cittadina, sulle orme del secolo precedente, con quello stesso gusto del limite che il Cinquecento gli aveva trasmesso, anzi aggravandolo. Giacch l'architettura barocca perso di vista completamente il paesaggio, non suppone pi che il vuoto intorno, da cui trae un vantaggio immenso, e cerca di ricreare nell'abitato, con ogni sorta di fantasie e di capricci, quell'infinito che ha escluso, alzando muri e facciate. Il disegno topografico e architettonico di Roma, quale risulta dal Seicento in poi, cos vario, complesso, tortuoso, da far pensare che ubbidisca a una specie di casistica, a concetti teologici e morali, oltre che a ragioni pratiche. Roma barocca l'immagine di tutto quanto noi desideriamo, che possiamo sfiorare ogni giorno, ma da cui basta sbagliare vicolo per allontanarsi. Labirinto di vie e di viuzze, che come la vita: ci si pu perdere Pi semplicemente diremo che il Seicento fu ispirato dall'orrore del vuoto e del deserto, che am l'ombra, il fresco, le vie strette, dove il cielo scorre come un fiume tra i cornicioni delle case alte e ininterrotte. Niente vale a dare un'idea del gusto di quel secolo quanto le fontane. Nell'intento di creare, in zone fino ad allora inesplorate, ma non troppo discoste
da San Pietro, una citt viva, popolare e domestica, il Seicento e il Settecento non lasciarono inconquistato il pi piccolo spazio, non trascurarono la minima possibilit di sistemazione. Ad ogni cantone o cantuccio imposero un aspetto proprio e nobile. In questa vecchia Roma i cui nuclei originari sono le chiese, si capisce tuttora che cosa voglia dire un costume cittadino, vivere protetti dalla religione, a riparo dal sole, dal vento e dalle cavallette. E cos che il Seicento e il Settecento tirarono su un'infinit di case le quali, a distanza di secoli, conservano anche oggi, in armonia coi luoghi ove sorsero, non so che aria vagamente campestre e dove i giardinetti pensili rimasero come una nostalgia del fuori porta. Case umili, dolci, borghesi, le case di via Sistina, di via Frattina, di via del Babuino, che sono vere culle e fanno pensare ad esseri che respirano Casette anonime e gentilissime, dall'intonaco arancione o gialliccio, dal tetto sporgente, che s'appoggiano ad una chiesa, vivono all'ombra d'un palazzo o d'un campanile, e stanno, in rapporto agli edifici maggiori. come il gregge intorno a un monte. Formano, per dir cos, L'atmosfera di Roma, in sostituzione di quella naturale che fa un po' difetto. Atmosfera che i nostri architetti fabbricarono con mattoni e calcina, creando in tal modo quel colore estremamente edilizio dei rioni romani che si riverbera perfino sui volti delle donne. Se Roma pu paragonarsi ad un immenso palcoscenico dove il genio dell'architettura d le sue rappresentazioni favolose, il boccascena, le quinte, sono queste case modeste che irretiscono e posseggono, in anguste piazzette simili a preziose conchiglie, le stesse moli romane antiche, per renderle pi schiaccianti e famigliari ad un tempo, s'insinuano dovunque, senza che in nessun caso la loro presenza stoni e sfiguri. Sono anzi esse che dnno il tono. Incuneate fra un palazzo e l'altro, fra questo o quel monumento, servono a circondarli di mistero, e farceli scoprire di sorpresa, a mascherare disarmonie di stile e di epoca, a creare distanze incalcolabili perch illusorie. Basta spesso una viuzza che scompare all'angolo, una piccola casa isolata e galleggiante come nave che si offra dalla parte di prua, rompendo una via, una piazza, a darci il senso dell'infinito. Tale motivo, che si direbbe ispirato dall'isola tiberina, frequentissimo nell'architettura romana degli ultimi secoli e ccstituisce un elemento di sistemazione mirabile. Ce ne sono esempi da per tutto. Ed grazie a queste semplici case che Roma appare, in uno spazio non troppo vasto, una citt cos varia, piena di luoghi sconosciuti e invitanti, dei quali il viandante non scopre se non qualche lato o il punto pi eminente: la guglia d'un campanile di l da una fuga di tetti, lo spicchio d'una cupola in uno scorcio fugace. Il loro gioco architettonico ubbidisce alle leggi della fantasia ed ha pressappoco la stessa funzione che ha il chiaroscuro nella pittura del Seicento. La bellezza di Roma, in realt, non vuol essere svelata oltre il giusto limite. A lei piace apparire e sparire, come se Roma infine vivesse per se stessa. Anche dove si espone pi apertamente, nella gloria dei cieli, gli effetti di cui si giova sono di ordine spirituale e fantastico pi che semplicemente panoramico. La magia sta nel piano su cui questa citt fu edificata. Siamo nella capitale del cattolicismo, nel
cuore della cristianit. Abitiamo in una citt santa. Costruita sopra una superficie mossa come in mezzo alL'acqua, fatta di materie corruttibili, con quel travertino che l'uso spezza, talvolta, come un pane secco e prende, a contatto del piede e del gomito, un color d'osso levigato, con tanti capolavori di stucco, Roma barocca ci rammenta ad ogni passo la nostra fragilit, la nostra miseria, ma, nel tempo stesso, tutto conduce a farci guardare in alto. Ed ecco le grandi arterie di Sisto V, aperte ai pellegrini, che furcno concepite come la via del Calvario. Salgono, scendono, a guisa di arcobaleno, per non lasciarci vedere altro, finch si in cammino, che la sommit d'un obelisco o d'una basilica, mte lontanissime nell'immaginazione, pi che nello spazio. Ecco le piazze romane, dove le persone, giunte in mezzo, scompaiono in profonda vasca, emergono agli orli e le vedi, a distanza, salire la scalinata di San Pietro come se andassero in paradiso. Le ampie crune dei campanili seicenteschi ti dnno proprio la nostalgia del cielo irraggiungibile. Cos` le altissime facciate barocche, le quali, a misura che si allontanano dalla terra, diventano sempre pi bianche, pi immacolate, e lass, in quelle regioni remote, eterne, non arrivano che i piccioni, le rondini e la tramontana. Che dire delle madonne che passeggiano sui tetti? Delle miriadi di croci, di ostensori, e altri emblemi issati in cima agli obelischi e sui fastigi delle chiese, che si scoprono, chiss perch, soltanto all'alba? Sono i miracoli, le apparizioni di Roma. LA LUCE DI ROMA La simbolica citt che ci siamo provati a rappresentare si riconosce nella sua luce, sempre assoluta, sfolgorante, e si potrebbe dire cattolica, in quanto sembra risplendere al disopra delle stagioni. D'autunno, lungi dall'attenuarsi e impallidire, questa luce inesorabile rifulge come nei mesi estivi. Se gli alberi avessero la forza di conservare le loro foglie, se i giorni fossero meno brevi, se il fiato sottile della tramontana non si facesse avvertire troppo, noi perderemmo la nozione del tempo. Tale il carattere immutabile e sempre un po' eccessivo della luce romana. A momenti si finisce per non poterla pi sostenere. Non si ha pi il coraggio di comparire davanti al suo tribunale. E si desidera un po' di grigio, qualche nuvola, un riposante acquazzone. Perch noi abbiamo con la luce romana gli stessi rapporti che con l'assoluto. Ce ne gloriamo, s, ma fino ad un certo punto, oltre il quale siamo tratti, in omaggio al calendario e alle nostre umane possibilit, a cadere nel relativo, a farci partigiani del cattivo tempo. Ma inutile aggiungere che Roma non si cura di noi, neanche da questo lato. Le sue stagioni, apparentemente anacronistiche, sono il riflesso pi sensibile della sua eternit. Eternit di luce che non tollera, come sappiamo, le mezze stagioni, i passaggi graduali dell'anno, e pi volentieri
si concilia con qualche ora, con qualche giornata di bonaccia L'effimero perviene a strappare all'eterno ci che ad intere stagioni negato. E questa la lezione che ci d Roma. Sul finire dell'estate comincia la tacita guerra della tramontana con lo scirocco e a misura che l'uno o L'altro di questi due venti prevalga, conoscerete la gloria e la miseria del clima romano. Ma non ccrcate le stagioni a Roma o, per dir meglio, non illudetevi che siano distribuite regolarmente, secondo le prescrizioni del calendario, che i romani di Gioacchino Belli chiamavano "bugiardello". Di solito arrivano in anticipo o in ritardo, folleggiano quanto pi possono, quasi avessero il compito di far fiorire e sfiorire i monumenti piuttosto che gli alberi, e solo a fine d'anno si pu avere un'idea dell'imperturbabile giustizia di questo clima, capriccioso, ma non tragico, irrequieto, ma educativo. Sempre disposto a riconoscere i suoi torti, a regalarci, quando meno ce l'aspettiamo, una giornata indimenticabile, e a farcela pagar cara, nel caso che noi fossimo cos imprudenti da fidarcene troppo. Rimane tuttavia stabilito che la vera stagione romana fuori del tempo, affidata a quel vento secco e pi costante d'ogni altro,.per sostenere il quale occorrono buoni polmoni. Giacch il clima di Roma non cos molle come si potrebbe credere. Basta pensare che per tre quarti dell'anno la vigorosissima tramontana la naturale alleata del sole di Orazio ed nella sua luce che vivono le "Georgiche". E in questo vento che non dura mai meno di tre giorni, ma pu stabilire amicizie e paci estremamente lunghe e vibranti, che bisogna vedere le chiese di Roma, le grandi chiese barocche, quando il luminoso e ventilato gennaio ce le mostra abitate da uno spirito guerriero come fortezze costruite contro il mutevole tempo. CONSIDERAZIONI SUGLI ALBERI E ALTRE SPECIE DI VEGETAZIONE A ROMA. Le citt antiche furono barriere alzate contro l'ignoto e il caotico. Non digradavano verso la campagna, la escludevano bruscamente, e quel che si dice suburbio stava dentro le mura. La citt aveva un cuore, un centro, dove tutto si raccoglieva. Come l'onda del mare non giunge a lambire la terra, perch fra il mare e la terra c' la spiaggia, ossia una zona deserta e neutra, cos il rumore cittadino si spegneva prima di arrivare alle porte Nei tempi moderni, scomparso il religioso orrore della natura, venute a mancare tutte quelle ragioni che facevano della citt antica un mondo fieramente appartato e difeso, tale concezione civica sopravvive in altre forme. Non pi che una questione di architettura, cio di decoro. Consiste nel fissare limiti e divieti ideali. Ma a Roma, tornata a vita civile nel Rinascimento, assume un aspetto particolarmente deciso. Mi pare evidente che l'architettura romana non tollera intrusioni naturalistiche, allo stesso modo che un coro di Palestrina, a cui quest'architettura comparabile, non ha
bisogno di alcun sostegno orchestrale. Se una citt pu far pensare a una selva, tale sensazione a Roma si pu avere, per il frondeggiare spesso dei caseggiati, delle cupole, dei campanili, per lo scroscio delle fontane, senza tuttavia immaginare un albero in una qualunque piazza romana classica; a meno che non si tratti dell'albero della cuccagna. Due soli elementi, L'acqua e la pietra, bastarono ai nostri architetti per ricostruire tutto l'universo naturale e fantastico. E ditemi se nelle piazze romane c' qualche cosa da nascondere o da aggiungere, se l'architettura di Roma non sufficiente a se stessa, se il bello di questa citt non consiste proprio nella sua rigorosa astrazione dalla natura, che l'arte vari e corresse in mille modi non uscendo per mai la Divina Provvidenza fa nascere sui basamenti degli obelischi e sui cornicioni delle chiese. Quanto al resto, il peggior modo, secondo noi, di far giardinaggio a Roma, quello di mettere la vegetazione in concorrenza con l'architettura. Che i nostri giardini pubblici siano popolati di alberi buoni e modesti, di piante allegre e non cupe. Certi aggruppamenti arborei boecliniani venuti di moda nel 1911, sotto l'influsso della famosa esposizione internazionale di Valle Giulia, il progressivo diffondersi d'una flora che a buon diritto chiameremo archeologica, non possono, in definitiva, se non intristire, affliggere, questa citt luminosa a cui soltanto l'acqua delle` fontane riesce veramente a dar vita. E perci che i Papi la distribuirono a profusione. Pi la storia della Chiesa diventava tempestosa e difficile, pi essi arricchirono Roma di nuovi acquedotti e la riempirono di fontane e di fontanelle, quasi a significare l'inesauribilit della fede. Il Seicento fu un vero diluvio. Purtroppo, con la Terza Roma, si perde il gusto delle fontane o, per meglio dire, s'inizia il periodo delle fontane asciutte. In altri tempi i romani misero il pino, questa pianta cardinalizia, ai margini delle loro ville, sulla linea dell'orizzonte, quale ultimo segno del dominio cittadino sulla campagna, per la stessa ragione onde costruirono i colonnati e le facciate, e cio, ancora una volta, per un motivo architettonico e urbano. Ben altro, s'intende, il carattere delle citt europee. Queste furono fabbricate come in mezzo ai boschi. Non conoscono limiti tra la campagna e l'abitato. La loro architettura, sia essa gotica, neoclassica o razionale, sempre, in qualche modo, legata al paesaggio, suppone un assai ottimistico rapporto con la natura. Metropoli immense, da scoraggiare il viandante, da spingerlo al suicidio lungo il cammino; che alla mancanza d'una vera e propria bellezza suppliscono con la grandiosit delle proporzioni, resa possibile dal fatto di essere costruite, per la maggior parte, in pianura, con quello stile conveniente al paese che le circonda, ai vasti fiumi che le percorrono, e persino, vorremmo aggiungere, a tutta una storia a noi estranea. Ambiziosissima storia delle monarchie del Settecento, sotto il cui dominio queste capitali presero il loro aspetto rigorosamente geometrico, aulico, militare. L'epoca di Napoleone le rese, infine, elegiache e commemorative. Qui si respira la gloria ad ogni passo, ma anche la fame e la carestia.
Dove troveremmo da noi una strada cos visibilmente predestinata alla guerra civile come la Prospettiva Newschi, larga sessanta metri e lunga sette chilometri? Un arco di proporzioni cos enormi come quello dell'"Etoile", da far scomparire, nell'intenzione di chi lo innalz, L'arco di Tito o L'arco di Costantino, un altorilievo tanto esagerato quanto il gruppo della Marsigliese, le cui figure, a furia di agitarsi e venire avanti, si gettano baldanzosamente nel vuoto? Sia che i romani costruissero con pi misura e calma dei francesisia che la terra abbia ceduto sotto il peso delle loro costruzioni, come ha ceduto la storia, il fatto che il nostro Panth con sembra, non dir meno imponente, bens meno alto, meno impettito, di quello che la Francia ha dedicato ai "grands hommes de la Patrie": un sedano andato in cannone, direbbero al mio paese. E sono queste le citt da cui dovremmo ricevere lezioni? Ma giacch siamo in tema di vegetazione urbanistica, vorremmo parlare anche di quella, spinosissima, del ferro battuto. L'epoca che si suol dire umbertina se ne compiacque grandemente. L'arte del ferro soddisfaceva ad un tempo i suoi gusti floreali e il suo gretto spirito proibitivo e borghese. Per cui riemp Roma di cancelli, cancellate, cancelletti Dovunque stimasse di dover custodire un rudero, proteggere un monumento, precludere un passaggio, nascondere una vergogna, stendeva una siepe di ferro. Con questo mezzo mascher e pose, starei per dire, sotto lucchetto tutte le sue incongruenze edilizie, creando una quantit di angoli morti, dove si annidano di preferenza i gatti, i fotografi, i horai. Le cose che stanno di l da quei cancelli sono per noi veramente cancellate e mai abbiamo avuto il coraggio, per esempio, di fermarci troppo davanti alla chiesa di Sant'Agnese in piazza Navona, o a quella di San Giovanni dei Fiorentini, come se le imponenti inferriate che ne ingabbiano gli accessi e tolgono alla cittadinanza il possesso e quasi la vista dei mistici giardini ci proibissero non solo di entrarvi, ma di guardarle. Noi siamo infastiditi dalla petulanza di queste difese che pretenderebbero gareggiare, nel loro decorativismo fastoso e massiccio, con la monumentalit degli edifici tenuti in custodia e non fanno che sottolinearla inopportunamente. Qui come altrove l'aria di mistero, ma ci pare di aver fatto intendere in che cosa consistono i misteri della Roma umbertina. Le irte cancellate sono il simbolo di una capitale assai pi privata che pubblica, portata ad assumere, anche per ragioni di gusto, aspetti crepuscolari ed occulti e che perci amava le vie deserte, i giardini chiusi, le gailerie vietate al transito nelle ore notturne, i ponti a pedaggio. Enorme doveva essere, in questa Roma davvero sparita, la sfiducia del popolo, se si sentiva il bisogno di allontanarlo perfino dai suoi monumenti, con mezzi protettivi ispirati all'estetica del "villino proprio", e del giardino zoologico. Ecco, su per gi, quel che ci dicono le ultime barriere di ferro o di bandone su cui fatalmente cade il piccone demolitore. TERZA ROMA
Gl'italiani venuti a Roma dopo il'70, non solo non cercarono di fondersi con questa popolazione, cosa in quei primi tempi difficile, per tante ragioni, ma neppure si curarono troppo di conoscersi fra di loro. Rimasero appartati, discosti gli uni dagli altri. In una citt estranea, non facilmente conquistabile e di grande richiamo, quando l'aristocrazia nera teneva chiusi a met, in segno di lutto, i portoni dei suoi palazzi e la sprezzante parola "buzzurri" suonava sulle labbra del popolo romano, serbarsi fedeli al proprio dialetto, ai propri costumi, era, fra l'altro, una maniera di difendersi, di eludere, al bisogno, lo scoglio delle divergenze politiche, di semplificare il problema economico e sociale. Rapporti privati, famigliari e di provincia furono le basi su cui sorse la capitale. Ogni regione ebbe in tal modo i suoi luoghi di ritrovo caratteristici, le sue fiaschetterie, bottiglierie, il suo circolo, come ogni collegio aveva il suo deputato. La capitale d'Italia non altro, per parecchi decenni, che l'accozzo dei vari provincialismi trapiantati a Roma. Mi rammento d'un tempo che i sardi residenti nelL'Urbe si davano convegno ogni sera in un angolo del Palazzo Bocconi, oggi "La Rinascente", e l rimanevano per qualche ora a confabulare in piedi. Costume sardo per eccellenza. Quei bravi isolani, probabilmente impiegati, avevano trasportato a Roma addirittura la piazzetta del loro villaggio. Osservazioni simili si potrebbero fare in parte, anche oggi, su molti altri elementi regionali immigrati nella Citt Eterna; i quali conservano intatte le proprie abitudini, esercitano professioni tipiche dei loro paesi d'origine, e si riconoscono perfino dai quartieri dove abitano. Il caff Aragno, dalla mattina alla sera, un piccolo emporio di particolarit regionali. Tutto ci ha da vedere col fatto di esser noi venuti a Roma, troppo timidamente. Entrata da Porta Pia l'Italia impieg sessant'anni per arrivare a San Pietro. Fino ai nostri giorni s'era tenuta prudentemente sulle alture dell'Esquilino, del Viminale, del Quirinale, costruendo, l dove fiorivano le ville dei vecchi patrizi, una citt a parte, orientata verso la Corte, i Ministeri, le Caserme, la Stazione ferroviaria, qualche cosa di eccessivamente burocratico e triste di cui ognuno che conosca Roma pu avere un'idea precisa. L la storia della Terza Roma e della Terza Italia. In quelle vie nuove, che conobbero tanta gloria di bandiere e di sfilate militari nelle ricorrenze patriottiche, furono educati i figli d'una borghesia composta, in massima parte, di funzionari dello Stato e di appaltatori edilizi; quei romani d'una sola generazione che costituiscono oggi la parte pi attiva, pi intraprendente della cittadinanza romana, ma che la Roma vecchia non la conoscono se non in qualit di podisti e amanti del pittoresco. Erano tempi in cui la "questione romana" dava la febbre al buon cittadino e lo faceva insuperbire di tutto quanto vedesse nascere sotto i suoi occhi: edifici pubblici, monumenti, piazze, giardini, fontane. Il dissidio fra la Chiesa e lo Stato s'immiseriva in una sorta di competizione estetica e architettonica. Immagino che nello scendere dal Quirinale a Fontana di Trevi il suddetto buon cittadino dovesse gi sentirsi in territorio ostile e nemico. In quanto al "cuppo-
lone", si contentava di guardarlo dalla terrazza di Monte Cavallo, al tramonto, come lo guarda Garibaldi dal Gianicolo: che un vero supplizio di Tantalo. Con questo spirito, che la massoneria non tard a sfruttare abbondantemente, furono profusi milioni, s'and incontro a fallimenti memorabili, per non riuscire, ci si perdoni l'ardimento, a fare una capitale. La Terza Roma nacque da una grande illusione: che si fosse giunti a identificare l'ordine liberale piemontese con l'Italia. Un tale ottimismo i suoi edifici lo portano scritto sulla fronte. Si volle dare a questa citt un carattere aulico e celebrativo. Si abbond in festoni, in cariatidi, in superfluit ornamentali d'ogni genere, si fece, a quei tempi, uno spreco enorme di stucco, si dorarono gli stemmi e le statue, i monumenti pi solenni furono lavorati al bulino. Fra tanta miseria decorativa e artigianesca svan il ricordo di quella prima, disadorna, severa onest che aveva ispirato i progetti della Destra storica; la quale, prima di tutto, ebbe cura di fabbricare alcune zone popolari e industriali, ma non dur abbastanza per impedire gli sperperi che dovevano succedere inevitabilmente. Con l'avvento della Sinistra comincia un periodo che a Roma, diceva il povero Giovanni Borelli, alludendo alla ressa degli avventurieri e alla voracit dei loro appetiti, non era possibile vivere senza fare un duello ogni settimana. Questo periodo lo conosciamo e non ha bisogno di essere descritto. Lo si vede riflesso come in uno specchio nei villini che ci ha lasciati, nella sua morbida architettura grecizzante, da professori d'ornato, in certi quartieri orribilmente pretensiosi ed eclettici, dove la mancanza di ogni omogeneit di stile, la mescolanza del gotico e del floreale, del barocco e del presbiteriano, sono in relazicne diretta col progressivo disfacimento dell'epoca. Passare oggi per via Po assai istruttivo e triste. E l che la Terza Roma finisce nel pi impressionante disordine architettonico. Gi nella vecchia Roma, intanto, chi rimaneva? Il Papa e il popolaccio che ha fumi anticlericalima si riconcilia volentieri con la religione appena vede la cupola di San Pietro illuminata. Quella la splendida Roma cinquecentesca e seicentesca. Tuttavia nessuno pens mai di occuparla veramente. Anzi fu evacuata da quella parte dell'aristocrazia che, avendo accettato gli eventi storici, stim opportuno e dignitoso scambiare i suoi palazzi aviti coi villini di via Po. Ed ecco, a fianco di una capitale provincialotta e precocemente infrollita, L'Urbe diventare suburbio e bassofondo. La pi bella Citt della terra, la pi sinuosa, dolce, solenne protezione che il genio dei nostri architetti abbia saputo costruire su questo suolo, in quest'aria, dove non c' vicolo, non c' piazzetta, in cui non ci si senta difesi nello spirito e nel corpo e i nostri occhi non abbiano materia di diletto; la Roma del Rinascimento, della Controriforma, del Sei e del Settecento, che comprende tre o quattro corsi fra i pi- eleganti del mondo, vie che sono fiumi di luce, sogni di epoche che non tramontano, lasciata in bala di osti, orzaroli e carbonari, esposta alle invasioni del Ghetto. Quanta ironia, quanto disprezzo, quanta discrezione fuori
luogo verso questa Roma che ha il solo torto di non meravigliarsi pi di nulla; dove potrete vedere i panni messi ad asciugare al balcone della casa che Raffaello possedeva nell'anno 1520. Laggi, dal'70 in poi, gli editti di Monsignor Illustrissimo delle Strade, murati su ogni cantone, rimasero lettera morta. E noi siamo vissuti per trent'anni, senza sapere dove passar la serata, in una strana Roma, piena di aspetti esotici e di chiese protestanti. Noi abbiamo nel sangue un po' di quell'acidezza che Roma umbertina, citt di borghesi trasferiti e scontentici ha trasmessa. E siamo provinciali della pi bell'acqua, pi o meno ripuliti e inurbati; sebbene poi, per il fatto di vivere tra i sette colli, c'illudiamo talvolta di poter vantare non so quale privilegio. Ma tutta la nostra romanit non consiste in altro che nell'essere veterani della Terza Saletta. IL DESTINO DI ROMA Parlare di Roma fatica per me dolce e grave ad un tempo. Dolce pefch non c' un argomento che mi attiri, che mi lusinghi di pi. Grave non soltanto perch Roma Roma, bens anche per il fatto che vivo in questa citt da pi d'un quarto di secolo e a proposito di lei potrei dire con Baudelaire: "J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans". Io ho visto invecchiare i camerieri del caff Aragno, sfiorire le donne che amai o che mi piacquero in giovinezza, andarsene in malora tante illusioni, tante amicizie, e Roma, per converso, trasformarsi, ringiovanire, ingrandire di anno in anno, senza nessuna indulgenza per le nostre personali affezioni e melanconie. Oh no, Roma non una citt comoda, non una citt premurosa! Il destino di Roma di rinnovarsi e in ci consiste, per l'appunto, il segreto della sua perenne vitalit. Citt Eterna cio sempre attuale e militante. Citt che, a somiglianza della proverbiale fabbrica di San Pietro, non sar mai finita perch non ha fine. Non si pu rimanere a Roma, diceva Mommsen, senza una idea. E come dire che non ci si pu rimanere con le mani in mano. E qui i secoli si sono succeduti con calma furia distruttrice e creativa. Ognuno di essi ha sentito il bi sogno di lasciare a Roma la sua impronta, i segni del suo terrestre orgoglio o della sua spirituale grandezza, non senza una ragguardevole dose di irriverenza verso i secoli precedenti. Pi il secolo forte, pi questa irriverenza si dimostra in modo lampante. Tanto che si pu chiamare barbaro il disprezzo, L'odio della Controriforma verso la Roma del Rinascimento e i monumenti dell'epoca repubblicana e imperiale che, al tempo di Sisto V, occupato a costruire strade, acquedotti, si demolivano senza misericordia e furono poi, per tutto il Seicento, costantemente asserviti o sepolti. Ma neppure fu misericordioso, con la Roma del Medioevo, il Rinascimento, epoca esclusiva e sicura del fatto proprio come nessun'altra, che ripudiava il gotico, oltre tutto (se lo rammentino i nostri razionalisti) perch forestiero. E solo nel Settecento, in tempi di stanchezza e di
decadenza, si comincia ad avere, non dir il rispetto, ma il gusto del passato, e nasce la Roma archeologica; dalla quale il primo Ottocento cav quei particolari decorativi che s'accordano fino ad un certo punto con questa citt cosi poco elegiaca. Infatti, mi sapreste dire perch Piazza del Popolo sempre, scusate il bisticcio, cos spopolata? Roma ha vissuto e sofferto d'ogni sorta d'irruzioni, di crisi, di rivoluzioni. ila citt meno provinciale del mondo, la sola universale, per definizione. E non ce n' altra, sulla faccia della terra, cos priva di spirito campanilistico, di estetiche idolatrie, che tratti i suoi monumenti con tanta disinvoltura e confidenza; n che sia, d'altro canto, egualmente capace di rispettarli come creature vive, per quel che significano, o, per dirla in pretto romanesco, secondo i meriti loro. La mancanza d'una tradizione di civilt e di coltura, separata da quelle grandi realt politiche e religiose che a Roma si sono sempre agitate, rende il clima spirituale romano particolarmente aspro. L'arte qui ha sempre dovuto ubbidire a necessit contingenti. All'architettura, se lecito per un istante considerarla scltanto nei suoi aspetti decorativi, non si e chiesto altro che di esprimere la gloria dei tempi o il sentimento della loro caducit. Ed perci che l'architettura romana, a differenza di quella fiorentina e di tante altre nostre citt umanistiche, non ha conosciuto interruzioni, stasi, lacune, ma si sempre sviluppata, ha sempre vissuto nel tempo, conservando, fino all'Ottocento, un primato assoluto, anche in fatto di novit e di ardimenti. Il culto delle tradizioni formali non romano, bizantino. E il famoso tradizionalismo di Roma bisogna intenderlo in senso attivo, dinamico e costruttivo, a costo anche di dover sostenere una simile tesi in cattivissima compagnia. Si consideri che il Seicento non esit a radere al suolo qualche edificio del Bramante; che bene spesso i Papi ricostruirono molte facciate non ad altro scopo che di alzare il proprio stemma, e che, insomma, le vicende edilizie di Roma non potevano essere pi idilliche della sua formidabile storia. Tutto ha contribuito a far Roma quale noi oggi la vediamo. Tutto si pu riscontrare in questo immenso teatro, in questo vasto emporio di gusti e stili diversi. E la miracolosa armonia che si osserva negli aspetti architettonici romani opera dell'aria e della luce, prodigio di sistemazioni postume e lente. CASTELLI Quante volte, andando verso i Castelli, ci siamo esaltati alla vista degli acquedotti e della nobile, ondulata campagna che li circonda! Carretti a vino sull'ampia strada luminosa e scoperta, a cui l'asfalto non toglie, anzi pare aver restituito l'antica dignit consolare. Ed ecco le prime vigne, i primi cancelli papali. La strada romana si perde in un intrico di vie e viottoli ombrosi e pittorescamente animati. Gruppetti di preti, drappelli di collegiali, fanciulle robuste e brune,
a passeggio, bighette di vignaroli. Il vario traffico dei tram, delle automobili e delle motociclette si smista ai crocevia. Chi va di qua, chi di l. E dovunque bei muri seicenteschi, splendide ville, boschi di querce vetuste, cupi sprofondi, ponti aerei, hnestre altissime e sfolgoranti al tramonto che abbaglia. Roma laggi, in un mare di luce purpurea. Siamo nella fervida zona "delli Castelli", sacra a Bacco. Qui una volta la mano correva lesta al coltello. Le passioni politiche erano costantemente in bollore come il mosto nei tini. Le sbornie, come sempre, un po' funebri, le domeniche facilmente luttuose. Clericali e repubblicani si contendevano il dominio di questi paesi ai tempi beati dell'"Asino", quando il cardinale Merry del Val soleva trascorrere gran parte dell'anno a Castel Gandolfo. E specialmente feroci avevan fama di essere i repubblicani di Marino che in nome di Barzilai e di Pilade Mazza perpetuavano le tradizioni baronali della regione. Oggi nessuno si ricorda pi d'un passato cos recente. Percorrendo adesso queste magnifiche terre, meglio che a Valenzani e alle vecchie rivalit fra Albano e Frascati, si pensa a Orazio, a Virgilio, a Poussin, a Salvator Rosa, ai prischi riti boscherecci laziali. Una luce umanistica inonda il divino paesaggio. E vien fatto di riconoscere nella dorata cinta dei colli albani i veri confini dell'Urbe, una bellissima protezione, pei romani d'altri tempi, dalle vicine paludi. Con questi pensieri ci allontaniamo da Genzano, mentre la strada s'inoltra, discendendo, in una campagna meno luminosa e tuttavia sempre nobile, che quella di Velletri ultimo contrafforte, hno a pochi anni addietro, del mondo abitabile. Pi oltre Cisterna, il cui solo nome richiama il deserto. Cisterna, sentinella della palude, la cui popolazione vissuta per secoli accampata, respinta e quasi in via di fuggire, senza speranza di sbocco su quell'immensa pianura che le si apriva dinanzi. gio credo che mi abbiano giovato a intendere la vecchia Roma assai pi di qualsiasi curiosit estetica. Nella capitale di don Prospero Colonna, detto universalmente don Cerino, e poi di quel bizzarro personaggio che fu il sindaco Nathan, io mi aggiravo con la testa piena di Roma antica e di quella medioevale che andavo frattanto scoprendo in Gregorovius. E quelle due smarrite chiesette che sorgono sulle alture del Palatino, in un paesaggio monumentale, dominato dal Colosseo, dalla Basilica di Massenzio e dalL'Arco di Costantino, quantunque non abbiano nulla da vedere col Medioevo e siano, mi pare, del Settecento, furono per me, in un certo periodo, e specialmente in certe ore, pi commoventi delle Catacombe e delle prime basiliche del Cristianesimo. Tutto serviva ad erudirmi e a farmi gustare il sapore di Roma: le leggende non meno che la realt, i nomi delle vie, i ben noti e famigliari nomignoli affibbiati ai luoghi pi illustri, ai monumenti pi sontuosi, a questo o quel frammento di statua collocato sull'angolo di una via e carico di alcuni secoli di storia. A tempo mio si sentiva dire ancora campo Vaccino e monte Cavallo, invece che Foro e Quirinale. Il Panth con era "la Ritonna". Il Senato, palazzo Madama. I Tribunali venivano detti i "Filippini" dal nome dell'edificio in cui avevano sede, un vecchio convento
borrominiano. E tutta la horita e azzeccatissima toponomastica romana squillava sulle labbra del popolo. La Roma della mia giovinezza quella che cominica a sparire nel 1911. Non aveva che cinquecentomila abitanti e soltanto tredici linee tranviarie. Chi abitava in Prati o fuori porta San Giovanni poteva dirsi un pioniere. Quando io venni a Roma, per intenderci, comparivano in questa citt le prime lampade ad arco e le prime automobili pubbliche. Le une si spegnevano spesso, creando, fra tanto sfolgorio, scandalose zone d'ombra e le altre, per i loro continui investimenti, non tardarono a diventare l'argomento del giorno e a dar la stura ad ogni sorta di facezie. Essendo tinte di giallo, furono subito dette "il pericolo giallo". Le questioni municipali assumevano un rilievo enorme nella Roma di quegli anni. Il Campidoglio, per un uomo politico, era il primo gradino da salire. E solo a caso e distrattamente si cominci a sentir parlare, ad un certo punto, di Giovani Turchi e di "comitagi" balcanici. Ma questo avveniva sulla hne del 1911, al tempo della guerra di Libia. Negli anni anteriori uno dei maggiori interessi della capitale era costituito dal teatro Stabile dell'"Argentina" che, d'altra parte, faceva "forni" memorabili, mentre il pubblico accorreva alle pochadei e all'operetta. I pi grandi successi teatrali, nella Roma della mia giovinezza, furono la Geicha e la Turlupineide. Roma umbertina aveva a quei tempi un sapore particolare per chi venisse dalla provincia e non fosse ancora iniziato ai segreti di quella Roma che si scopre lentamente e pu anche essere trascurata, come la trascurano infatti molti immigrati per i quali andare a Piazza Navona gi un'escursione, un'avventura. N da credere che io potessi far eccezione, che avessi il minimo sospetto delle differenze che corrono fra Roma nuova e la vecchia. In principio, a parte la pacifica esistenza del Colosseo, della cupola di San Pietro e di altri monumenti del genere, aggirandomi per via Nazionale, via del Viminale, via XX Settembre, vissi quasi nella persuasione che a Roma non ci fossero se non portieri e camerieri, sentinelle, palazzoni a sei piani, ristoranti sotterranei o "grottini", la fontana dell'Esedra, il Costanzi, il palazzo delle Esposizioni e il giardinetto del Quirinale, frequentato seralmente da una pallida ragazza del mio paese che abitava da quelle parti, vicino alla caserma dei pompieri. Sicch le mie prime ansie d'amore sono legate ad una Roma un po' triste e borghese, che un giovane letterato, ammiratore fervente di Joyce, ha creduto di poter definire "la nostra Dublino". Eppure, hn da allora, mi attiravano certe improvvise rivelazioni di un'altra Roma che, allontanata, sfuggita, risorge dovunque e proprio sullo sfondo di qualche brutta via umbertina ti riserba le migliori sorprese. Via Nazionale hancheggiata e, starei per dire, controllata da via Panisperna. Il mercato di piazza Vittorio si svolge intorno ai ruderi della villa di Mecenate. E la basilica di Santa Maria Maggiore, con la regione annessa dei Quattro Cantoni, occupa tanto spazio e crea tanto mistero che sarebbe difficile distruggerlo, anche se si moltiplicassero per dieci gli orrori
architettonici che l'ultimo Ottocento ha saputo perpetrare sull'Esquilino. cos che a poco a poco, nonostante la mia distrazione e ignoranza, contentandomi di vivere nei luoghi che la Provvidenza mi assegnava, andando per vie obbligate, senza nessuna disposizione ai pellegrinaggi estetici o turistici, finii per scoprire la vecchia Roma e per trarne, com' naturale, un grande motivo di consolazione. Ho visto degli stranieri all'alba, con un po' di vino in corpo, mettersi a piangere a piazza del Popolo. Non sembrer esagerato dicendo che, in un tempo in cui ero spesso costretto a passare la notte alla stelletta, la compagnevole bellezza delL'Urbe mi ha ripagato di tutto, mi ha fatto sembrare dolce la novert e ha ooerato su me in maniera che io non mi Un autore di cui non posso trascurare il giudizio, Riccardo Bacchelli, ebbe ad uscirsene qualche tempo addietro in talune ossenazioni assai gravi, circa gli scrittori di memorie d'infanzia e di giovinezza, denunciando in essi non so quale assenza di maturit, di pienezza creativa, rappresentandoli insomma come scrittori mancati. Ci sarebbe da chiedersi perch il semplice fatto di assumere una materia nillecentestmo,hP nellaltra noccalefilere della forza di uno scrittore. Ma io qui non voglio correre il rischio di fare una polemica letteraria con un polemista temibilissimo. Fra l'altro sono arciconvinto che il mio vecchio e valoroso amico non pensava a me, scrivendo quelle acerbe note, che tutta via mi riguardano e mi hanno dato naturalmente da pensa re. Per fortuna io son venuto su da una scuola cos dura. in mezzo a tali e tanti dissensi, che posso tollerare, senza disperarmi troppo, anche il dubbio e quasi la certezza di essere uno scrittore mancato. Oserei quasi ripetere un luogo estremamente comune: cio, che rispetto ai propri ideali ogni scrittore, ogni artista mancato. Manc Michelangelc il monumento a Giulio II, Leopardi e Baudelaire non riuscirono mai, nonostante i loro sforzi, a scrivere un roman zo e neppure una novella. Qualche contemporaneo di Manzoni si meravigli che un poeta il quale aveva cominciatc, in tono altamente lirico, con gli Inni sacri e le tragedie, si risolvesse nell'apparente dimessit e bonomia dei Promessi sposi. Vi sono delle opere e degli artisti che suppongono un fallimento pratico, politico, sociale e magari anche hnanziario. Il lievito dei Mmoires di Saint-Simon la disgrazia dei pari di Francia e quella dell'autore in particolare, alla corte di Luigi XIV. In quali tristi condizioni sia stato scritto il Principe di Machiavelli tutti lo sanno. A coloro che ban dirono Dante dobbiamo esser grati per averci dato il poeta della Commedia. Cose stucchevoli e anche un tantino bla sfematorie a ridirsi. Ma i grandi esempi valgono a hssare almeno certe idee e a metterci in condizione di giudicare. minimi. Le vie che conducono all'arte sono infinite, n sempre cos dirette come si potrebbe credere. Uno fallisce come critico e diventa poeta, oppure avviene il contratio, che il caso pi comune fra gli scrittori d'oggi. Niente pi sbagliato che esigere o ricercare quel che un artista avrebbe dovuto o voluto fare. Si ricerchi piuttosto quel che ha potuto e che ha fatto. Felici, senza dubbio, quegli artisti che
non conoscono crisi, cadute, sorprese, intoppi sul loro cammino; che non subiscono influenze esterne. Chiusi nella loro nativa perfezione, possono attuare tutto quello che si propongono, a rischio anche di rimanere un po' discosti dai tempi. Altri invece sono il frutto dei tempi e magari delle stagioni. Sentono il sole, i venti, le piogge, gli uragani che li hanno prodott. E non mancano esemplari grandissimi sia dell'una che dell'altra razza. Tutto questo viene a dire che difficile parlare delle cose dall'arte a priori, formulare princpi categorici che non raggiungono poi altro effetto se non quello di limitare la libert della fantasia. Che cosa il tempo molte volte si pretenderebbe insegnarlo a un artista che lo esprime. E per tornare al nostro discorso probabile che qualcuno giudichi non troppo consono alla natura dei tempi che stiamo attraversando indugiarsi in memorie personali, ripiegarsi sulla propria vita, mentre a me pare che niente sia pi umanamente giustificato. Ed esprime una buona e valorosa disposizione a staccarsi dal proprio passato e perhno dall'esistenza. Pu essere per qualcuno una tacita e delicata maniera di partecipare della gravit dei tempi. Meglio ricordare, credete a me, che far finta di nulla. Detto questo, continuiamo i nostri ricordi su Roma. La Roma dei nostri tempi era bella soprattutto perch noi eravamo giovani e certe donne stupende che ci avvenne di conoscere allora o semplicemente di notare quasi ogni giorno, a passeggio per le vie dell'Urbe, occupano un posto particolare nella nostra memoria. A distanza di tanti anni, le rivediamo con piacere, anche se ormai questi incontri sono per noi pi edificanti d'una visita all'Ossario dei Cappuccini. Dopo averci dato qualche gloriosa illusione, queste donne della nostra giovent che hanno avuto, possiamo dirlo con orgoglio, un'incredibile facolt di durare, ci somministrano adesso una profonda lezione morale. Furono dei monumenti di bellezza che noi ammirammo lungamente, persino nei loro restauri. Oggi non sono pi che vecchie signore impenitenti, poveri esseri piegati dall'artrite, antiche peccatrici vaganti, costrette da una circolare di polizia a rifluire nella vita domestica e diventate nonne e bisnonne. Le incontriamo talvolta, verso sera, con la bottiglia del latte in mano, queste pensionate del marciapiede che una volta ci si avvicinavano subdolamente per chiederci una sigaretta. A ripensarci, ho l'impressione che nella Roma di quegli anni ci fosse pi sole, che le estati fossero pi precoci, le primavere pi oneste. In maggio tutti erano gi in paglietta e si camminava all'ombra delle tende come in agosto. Barbieri, sarti, lustrascarpe, lavoravano a tutt'uomo. Le trattorie facevano credito. Si disprezzavano le monete d'oro, perch soggette a smarrirsi, e si ricercava sempre invano qualcuno che ci facesse la grazia di cambiarcele in biglietti da cinque. Che lusso! Che sciccheria! Che scialo di sigari Minghetti tra i frequentatori della Terza Saletta! In quel tempo erano di moda i levrieri russi che s'intonavano con le pellicce e l'andatura dinoccolata delle elegan-
tone del Corso, use a camminare appoggiando la mano inguantata sulla schiena ossuta e pelosa di queste docili bestie. Le donne romane di qualsiasi classe portavano un busto non troppo alto, ma cos rigoroso che faceva del loro ventre una parete a picco e le povere fanciulle di provincia che venivano a Roma a fare la cameriera, non avendo ancora adottato questo strumento di tortura, parevano tutte disonorate I bulli riempivano le strade, se la spasseggiavano in botticella, vestendo come Petrolini nella macchietta di "Gigi er bullo". Le ragazze della piccola borghesia uscivano di sera, al Corso o a Via Nazionale, in cerca di marito, a braccetto con la mamma. La banda Vessella e quella degli Allievi Carabinieri si alternavano sul palchettone di Piazza Colonna, per rallegrare quelle sere lontane che ognuno trascorreva con moltaemma, non essendo ancora invalso l'uso della corsa a;li spettacoli, ai divertimenti, e igno randosi che il passar la serata potesse rappresentare un problema, un assillo. L'ora pi fulgida di Roma era quella del passeggio anti meridiano tra San Carlo al Corso e Palazzo Chigi. Chi potr mai descrivere quell'ora, quel passeggio, le due hle di car rozze che procedevano rispettivamente in senso inverso, al ternate da qualche automobile elettrica, la folla scintillante di divise, fiorita di ombrellini da sole, punteggiata di bombette grigie, alla quale sorrideva la promessa della Corsa alle Capannelle? Chi si dar la pena di rievocare i tempi, le avventure, le imprese del Conte Tacchia? Roma si destava come sempre, di ottimo e temerario umore, per alterarsi con la prima digestione, allorch si iniziavano le discussioni, battibecchi e le vertenze cavalleresche del Caff Aragno. i quale non era un caff, ma un foro, una basilica, un porto di mare. A Camera aperta, fra le "interrogazioni" e le "interpellanze", dalle due alle tre come nel Falstafl, tutto il mondo parlamentare italiano si riversava in quelle sale, dove non era affatto necessario sedersi, neppure per consumare un sifoncino di acqua di soda. Si sfarfallava da un tavolo all'altro. Si entrava, di solito, dal lato del Corso e si usciva su Via delle Convertite, dopo aver fatto una lunga sosta in piedi, nel canale di spurgo. Una sola giornata di questo caff, quale io lo conobbi in quegli anni, potrebbe offrire materia per un romanzo o quanto meno per un film. Tempi dorati, felici, almeno in apparenza. Le posizioni era no solide e redditizie. Non c'era invidia. La Terza Saletta un esempio di come si riconoscessero e sostenessero gli uo mini di quel tempo. Per entrare l dentro senz'avervi qual che conoscenza, ci voleva del coraggio e una gran voglia di farsi avanti. Chi riusciva a farvisi una posizionera gi un eletto. Ma inutile dire che io non mi sentivo tale e facevo parte di un piccolo gruppo di giovani dissidenti. Gio vani arrivati troppo tardi, a lumspenti, a festa hnita. Perch non crederete, spero, che io abbia voluto dipingervi il Paradiso. Questa capitale cos lustra, cos beata, era una citt agli sgoccioli. Nuovissima e gi decrepita, viveva dei humi e dei ricordi che le aveva lasciati l'epoca di Crispi e di D'Annunzio, mentre gi presentiva, sia pur vagamente, la bufera che si stava addensando. Era insomma la Roma umbertina ROMA 1911.
Addio giovinezza. Tale era proprio l'aria che spirava nelL'Urbe e in tutta Italia fra il 1907 e il 1911. Quelli sono anni di sgombero, di sbaraccamento, di trasformazioni profonde in ogni senso. Come se ognuno presentisse la bufera che s'addensava sull'Europa, tutti s'affrettavano, magari per semplice snobismo, o forse soltanto per questo, a mettere il capo a partito. I socialisti non credevano pi nel socialismo, molti di essi parteggiavano per il duello e per le "spese improduttive" (si ricordi ch' di quegli anni la celebre frase di Leonida Bissolati "il partito socialista un ramo secco", cui fa riscontro la non meno celebre battuta di Giolitti in pien Camera "non ho paura dei socialisti, dal momento che hanno messo il ritratto di Carlo Marx in sofhtta"), i letterati si convertivano alla politica, mentre alcuni giovani che venivano dalla politica pi eterodossa bastava che ponessero piede in Terza Saletta per uscirne conservatori ad oltranza o per passare alla letteratura e al teatro, illusi da una momentanea rinascita del gusto teatrale rappresentata dal "Teatro Stabile". Un'altra maniera d'imborghesirsi. I poeti eludevano la poesia in quelle forme, pi o meno encomiabili, che tutti sanno. il tempo de La Signorina Felicita ovvero la Felicit, delle Poesie scritte col lapis di Marino Moretti, delle Provinciali di Fausto Maria Martini. Questi poeti furono detti "crepuscolari" e mai dehnizione fu pi azzeccata, da qualunque lato si voglia considerare, all'insaputa probabilmente del suo stesso inventore. Fra il 1900 e il 1912 muoiono Verdi, Carducci, Pascoli. E proprio negli anni a cui mi riferisco lasciava l'ltalia D'Annunzio, della cui "mirabile" vita fino a quel punto io feci appena in tempo a conoscere la Capponcina deserta, la porta chiusa e scrostata, la soglia erbosa per antico abbandono, della vicina Porziuncola, gi abitata dalla Duse. Non erano liete quelle tracce che non parevano d'uomo, ma di un'epoca. Il fanatico Ottocento moriva, con qualche anno di ritardo, e tutti quelli della mia generazione lo hanno visto agonizzare sui loro passi. Tanto per dire che io venni a Roma, giovanissimo, in una epoca piuttosto vecchiotta, morbida e stanca. Della Roma di D'Annunzio non ebbi la ventura d'imbattermi nemmeno in Sergio Corazzini, morto qualche anno prima della mia venuta. Quanto a D'Annunzio, L'ho visto fuggevolmente una volta sola in tutta la mia vita, sull'ingresso della Biblioteca Vittorio Emanuele, in conversazione con Annibale Tenneroni, suo grande e devoto amico. Ho sempre nella memoria quell'unico incontro col pi celebrato poeta dei nostri tempi. L'autore delle Laudi mi apparve assai diverso dall'idea che me n'ero fatta. Era piccolo, biondo, paffuto, come lo raffiguravana su per gi i caricaturisti del Travaso delle idee. Niente lasciava sospettare in quest'uomo dal sorriso angelico, dai gesti leziosi, vestito con l'attillata eleganza dell'epoca, l'autore di certe pagine sensuali e veementi che avevano impressionato la mia adolescenza. Ma certo il D'Annunzio vero non era quello che si manifestava ad un suo famosissimo succubo. Lo sentii d'istinto. E perci, pur essendo, in quell'epoca, un accanito lettore e ammiratore del poeta, rimasi
piuttoSto freddo e pochissimo interessato da quell'incontro. Quando sarei stato in condizione di conoscerlo un po' meglio lo avevo gi spiritualmente abbandonato ed egii era ormai, pi che un poeta, uno strano depositario di reliquie di guerra, L'autore del discorso di Quarto che , se non sbaglio, una contraffazione della Prire deeannette, ossia delL'ultimo capitolo del Mystre de la eharit de Jeanne d'Ar di Charles Pguy: uno scherzo letterario, con cui l'ltalia entr in guerra. S'inizia cos il 1911, anno fatidico, che mi piacerebbe rievocare e sul quale vorrei scrivere un film. il Cinquantenario della nostra Unit nazionale. Per celebrare questa data si preparano a Roma i pi grandiosi festeggiamenti. L'anno della Esposizione internazionale di Valle Giulia e della Mostra etnografica regionale, l'anno in cui s'inaugura il monumento a Vittorio, il Palazzo di Giustizia, il Ponte Vittorio Emanuele, il Giardino zoologico, l'Augusteo, il nuovo Palazzo della Galleria d'Arte moderna, il congiungimento di Villa Borghese col Pincio, e non so quante altre opere pubbliche. Per l'occasione si sono congiunti anche i Palazzi Capitolini mediante passaggi costruiti con cartapesta. Ed egualmente con cartapesta s' costruito sullo sterrato di Piazza Colonna, dove ora sorge la Galleria, un enorme padiglione con locali di ogni genere: caff, trattorie, un cinematografo. Ma la cosa che pi interessa lo spostamento del Palazzotto Venezia, demolito e riedificato con le stesse pietre una ventina di metri pi indietro, per fare del largo intorno all'Altare della Patria. Quest'opera incredibile stata eseguita da una ditta americana e non manca di suscitare polemiche e meraviglie. Ah, questi americani! Che tecnici! E veramente la prima volta che i "buoni Quiriti" (cos venivano detti i romani di quel tempo, allo stesso modo che i consiglieri comunali eran chiamati "padri coscritti") constatano che un palazzo si pu spostare come un mobile e quello che pi stupisce la meticolosit, la pazienza di una simile opera, L'idea di quei mattoni che, segnati uno per uno, sono stati delicatamente scomposti e ricomposti nello stesso ordine. L dove sorse il Palazzotto Venezia, si vede adesso un'isoletta arborea che risale appunto al 1911 e pu ricordare, in qualche modo, "L'isola dei morti". Non per nulla Boecklin sar uno dei trionfatori della Esposizione ,di Valle Giulia, insieme con Franz Stuch, Anglada, Zuloaga, Mestrovic, col suo famoso padiglione, ch' il progetto d'un .tempio in memoria della battaglia di Kossovo, Klimt, Zorn, L szl, Sergent ed altri pompieroni forestieri e nostrani. Giacch sar bene tener presente che l'esposizione di Valle Giulia fu l'apoteosi e la liquidazione di tutto il pompierismo europeo dell'ultimo Ottocento. Che cosa c' d'italiano nella Mostra di Valle Giulia? Il 1911 il trionfo della cartapesta e del cemento armato. Ma lasciamo andare. Io ero allora troppo giovane e immaturo per poter giudicare l'arte di quel tempo come la giudico adesso. Delle manifestazioni artistiche romane del lgll tutto mi piacque; perfino la statua della Dea Roma di Zanelli, il Canale Veneziano della Mostra etnografica e i maccheroni "a la pommarola" che si mangiavano in un vicoletto napoletano altrettanto bene imitato nella stessa Mostra. E mai vidi Roma cos bella, n
un anno che si annunciasse cos festoso. Ma proprio il giorno dell'inaugurazione del Giardino zoologico, accadde un fatto che non s'aspettava. L'assessore della Pubblica Igiene, a un certo punto, sal sopra una sedia, invitando noi giornalisti (io ero allora un laborioso reporter dell'Avanti!) a constatare di persona come certi giornali stranieri, diffondendo la notizia del colera in Italia, avessero approfittato di alcuni casi ordinari di gastroenterite per mandare a monte i festeggiamenti del nostro Cinquantenario. Sono cose passate, che non varrebbe la pena di rammentare, se non fosse per mettere in rilievo l'inaudita disgrazia dei tempi in cui ci toccato vivere. Le nostre malinconie, diciamo cos, patriottiche e nazionali cominciano col fallimento dei festeggiamenti del 1911, ordinati e predisposti appunto, con tanta fastosit e larghezza, in omaggio ai forestieri che non vennero, perch spaventati dal bacillo virgola. Pensate che in loro onore il sindaco Nathan, non troppo tenero verso la vecchia Roma, aveva progettato perfino la demolizione di Via dei Coronari, un'illustre via cinquecentesca, uno dei primi esempi di rettifilo dei tempi moderni, divenuta, per secolare incuria, la pi sudicia e miserabile strada della capitale. Che cosa avrebbero detto infatti quei milioni di visitatori invitati ad ammirare le glorie di Valle Giulia, se avessero visto, per caso, Via dei Coronari sbandierante, coi lenzuoli fuori delle finestre, la sua invereconda miseria? Col sindaco Nathan, che s'atteggiava ad uomo pratico e ad urbanista spregiudicato, che aveva attuato, infischiandosi delle critiche dei giornali, il congiungimento di Villa Borghese col Pincio e lo slargamento del Tritone, c'era poco da scherzare. Ma i poeti crepuscolari che adoravano quella via pittoresca, la via dell'Alcazar e dei bulletti coi calzoni "a zampa di tavolino", fermi sui cantoni in ogni ora del giorno e della notte, la preservarono, con una nutrita campagna di stampa, da una fine cos obbrobriosa e superflua. Dico superflua, perch tanto i forestieri, nel 1911 non si fecero vedere se non in minima parte. Le celebrazioni del nostro Cinquantenario furono rese nulle e quasi deserte come un'asta pubblica per via d'una campagna giornalistica inspirata, bisogna pur dirlo, da bassi motivi di concorrenza alberghiera. Il Comitato romano dei festeggiamenti nel 1911 chiuse il suo bilancio con un enorme. L'estate pass squallidissima fra i padiglioni di Valle Giulia e un'infinita malinconia regnava, nei primi dell'autunno, sulla spiaggia di Riccione Marina, dove non erano apparsi se non pochi bagnanti, e fra questi, immancabile, il tenore Borgatti, quando mi sorprese la notizia della guerra di Libia, inevitabile coronamento d'un anno cos sfortunato, remoto inizio di tutte le nostre disgrazie. Viaggio nelle Marche. MARCHE ROMANE. Dal tempo dei tempi le Marche hanno con Roma rapporti naturali e famigliarissimi, derivanti da certe vie migratorie e commerciali che non conducono, ma precipitano verso la Citt Eterna. Non so dove ho letto che i Piceni, allo stesso modo che i Latini e gli Etruschi, sarebbero addirittura alle origini della cittadinanza romana. Certo non risulta che Ro-
ma abbia dovuto sostenere grandi guerre per soggiogarli. Piceni e Umbri Camerti noi li troviamo, gi nel terzo secolo a. C., fedeli alleati di Roma contro i Galli invasori del loro territorio, i quali, a loro volta, si lasciano romanizzare o etruschizzare abbastanza presto; mentre, nell'ra moderna dal secolo VIII, quando si assiste ad una prima, spontanea donazione delle Marche alla Chiesa, fino alla caduta del potere temporale, il dominio dei Papi su questa regione appare come il pi incontrastato e legittimo. Insigne il posto che occupano le Marche nella storia della Chiesa; non tanto per aver dato in ogni tempo, come osserva uno scrittore marchigiano, eccellenti prelati alla Curia e ottimi aiutanti al boia, quanto per il fatto significantissimo che i due Papi rimasti pi profondamente scolpiti nella memoria e nella fantasia del popolo romano sono due marchigiani: Sisto V e Pio IX. Il Rinascimento a Roma si compendia, meglio che in qualunque altro nome, in quelli di Bramante e di Raffaello. E se vero il proverbio "Pi marca giri, pi marchigiani trovi", incontestabile altres che fuori delle Marche, nel cuore del Vecchio Stato Pontificio, questa laboriosa e silenziosa genia si dimostra talmente diffusa da formare, in alcuni luoghi, una specie di "humus" insospettato. Al mio etrusco paese, per esempio, non si contano le famiglie che si scoprono marchigiane di l da una o due generazioni. E una inchiesta simile fatta a Roma, darebbe, credo, qualche sorpresa ai superbi Quiriti che hanno coniato sui marchigiani due o tre proverbiacci assolutamente iniqui. Da noi, quando Si dice montagna e aria fina, s'intende Visso: giacch i pecorai che vengono a svernare in Maremma sono di lass o di "lai", come si vuole. Dalle Marche, una volta, prima che si usassero le macchine per segare il grano, giungevano ogni estate al mio paese turbe di mietitori. Da quelle province picene, che l'Impero Romano divise in suburbicarie e annonarie, calarono verso Roma, in tutti i tempi, le vettovaglie, i carretti carichi di buon vinello marchigiano, sopra i quali mio padre, bambino, addetto alla guardia della martinicca, and su e gi per alcuni anni, sonnecchiando in piedi, col viso appoggiato alle botti, tanto che una notte, a uno sbalzo del carro, si ruppe onorevolmente un dente contro un cerchio, oppure dormendo nelle soste, sui montini della breccia e imparando a sue spese che si pu dormire e perfino sudare sotto la neve; sino al giorno in cui, trasportato ancora una volta dall'irresistibile pendio non volle pi rifare la salita e se ne rimase in Maremma. Per la qual cosa io posso considerarmi una testimonianza del fatale residuo che le temporanee migrazioni marchigiane lasciano, di anno in anno, sul suolo romano. E giacch sono in vena di confessioni mi si lasci dire che nella mia qualit di marchigiano spaesato, ma non troppo, ero forse particolarmente disposto a sentire Leopardi. Aggiunger che da ragazzo ho sfogliato il granturco sulle aie dei contadin; piceni trapiantati nella mia terra e che i colori dell'idillio leopardiano mi sono dunque noti da un pezzo. Nei giorni festivi questi umili pionieri della coltura intensiva in Maremma si distinguevano in mezzo a noi, gente cittadinesca finc al midollo, per i loro costumi villerecci. Le donne avevano il fazzoletto in testa e gli uomini, di schietto tipo adriatico, con la faccia completamente rasata e il pelo al naso, portavano gli orecchini. Sentita la messa, che era il solo scopo della loro venuta in paese, se ne tornavano alla
campagna nelle prime ore del pomeriggio, lasciavano senza rimpianto le cittadine infauste mura. Spettacolo abituale e un po' triste, nelle feste della mia infanzia, questo dipartirsi dei contadini dall'abitato, coincidente spesso, per rendere pi vivo il contrasto, con l'apparire della banda in piazza. E una domenica a Recanati avendo osservato una scena simile, mi torn a gola una malinconia ben antica. Con tutto ci, non so come, pervenni ad una et ragguardevole senza conoscere le mie care Marche. Forse mi bastava sentirle nei miei e in me stesso, fino ad esserne sazio. Il lettore immagini, ad ogni modo, con quale animo io mi sia deciso a risalire quella strada che conduce ai due luoghi pi sacri della mia vita: al paese di mio padre e a quello di Leopardi. Egualmente mitici per me, sono vicinissimi l'uno all'altro, si guardano come due paesi che avrei potuto conoscere e possedere a fondo, ma che persi nascendo. Sar bene avvertire subito che molto opportunamente ai motivi pi segreti del mio pellegrinaggio se ne aggiungevano altri di natura professionale, poich non conosco una terra meno propizia per chi voglia andarci a frugare il passato. Sia detto a loro onore, le Marche non sono un paese elegiaco. Il sole di quei campi, allo stesso modo che fa maturare il grano e le biade, sembra voglia cuocere e ridurre in calcina anche le pietre e i mattoni pi vulnerabili. A due passi da Macerata, le galline razzolano, il fieno s'ammucchia odoroso intorno alle informi rovine di una citt romana, Helvia Recina, le quali devono sostenere il confronto coi numerosi e monumentali pagliai sparsi nelle vicinanze. I contadini, in campagna, si sono impossessati di ogni edificio, sia pure antico ed illustre. Si ha qui il senso di una vera invasione agricola, di un assoluto predominio della campagna sulla citt, come se in questo paese fosse accaduta, non so quando, una formidabile rivoluzione rurale. Il Castello della Rancia, famoso per aver dato il suo nome alla sfortunata battaglia di Gioacchino Murat contro gli Austria ci, combattutasi l attorno e detta dai marchigiani, un po' arbitrariamente, ma con molto orgoglio patriottico, la prima Novara del Risorgimento, divenuto, se non sbaglio, una casa colonica. E i contadini della Mensa Vescovile di Sar Claudio sul Chienti non intendono certo profanare la loro chiesetta romanica giovandosi della parte superiore come di una soffitta o di un ripostiglio per gli attrezzi agricoli. Nobili ville, pittoresche locande del tempo delle corriere, sonc egualmente possedute, abitate, circuite da poderi che aspirano a dare un'idea del Paradiso Terrestre. Ogni fabbrica buona da ridurre a casolare, a magazzino. E tutto conser vato a meraviglia, ai fini che ho detto. Credo che la Dire zione dei Monumenti e Scavi abbia poco da fare nelle Mar che, paese eminentemente agricolo e peschereccio. I campi sono cos gonfi di vegetazione che il trifoglio in fiore trabocca, in primavera, sulle scarpate della ferrovia. Si vedonc le stradette campestri, polverose e bianche come i buoi che le percorrono, salire serpeggiando, in tutte le direzioni, le vaste colline lavoratissime, dove il grano gi in via di matu rare, mette dei toni divinamente stinti, in contrasto con le macchie azzurrastre di un'altra qualit di grano meno precoce, che ha, in questo tempo, il colore dell'acqua ramata.
Quale ampiezza di linee in questo paesaggio trasfigurato da una luce che tutta un suono un Sospiro. Ecco le dolci Marla terra bruna e leggiadra su cui spiccano le pianticelle di pomodoro, di aglio e di cipolla, che si coltivano nei frugalissimi orti del litorale. I pescatori lavorano il mare come i contadini la terra. Al carro tinto di rosso e turchino, ai buoi infiocchettati, rispondono al largo (immenso respiro operoso di questa regione) le loro vele colorate. Le Marche sono un paese di collina e vogliono la vista scoperta da tutti i lati. Inoltrandosi verso il monte e allontanandosi dal litorale perdono facilmente il loro carattere. per questo che, in piccolo spazio, troverete una moltitudine di citt e cittadette situate su per gi nella medesima posizione, su lunghe colline piuttosto alte a cui sorride il mare da una parte, con la vista assidua del promontorio d'Ancona, e il lontano, aereo Appennino dall'altra. Che buon profumo di soffritto si respira in queste citt! Che sole paesano! Che pace! Nei calorosi meriggi di primavera le chiese odorano d'incenso. Fra il canto glorioso dei galli e lo strepito delle galline, si ritrova nelle citt delle Marche una polvere d'altri tempi; quella che le tramontane hanno lasciata sui palazzoni pontifici, sulle grandi chiese gotiche rimaste incompiute, ed , per cos dire, la polvere della nostra infanzia. Il mare arriva da per tutto come la sua luce. Se ci si affaccia dall'alto, lo si vede insinuarsi, occhieggiare, fin sotto le pendici dei colli pi apparentemente discosti, si scoprono le sponde marchigiane formatesi, al dire dei geologi, per emersione e quindi sicure dalla malaria, ma non altrettanto, in antico, dalle incursioni piratesche, le quali spiegano il perch di tante torri in luogo di campanili. Torri che, isolate oppure vigilanti sull'abitato, si rispondono da tutti i monti, segnalano a valle i passi obbligati e dnno a questo idillico paese un aspetto difensivo e guerresco. L'agricoltura infatti, come la religione, fu custodita, nelle Marlarit di questa terra che, aperta sull'Adriatico, esposta per secoli alle scorrerie degli infedeli, ha avuto evidentemente una storia abbastanza rude, sebbene abbia l'aria di non ricordarsene; dove tuttavia nulla vi parr pi simbolico e commovente dell'Arco di Traiano nel porto di Ancona. La mancanza di cipressi e di ulivi sulle coste delle colline alberate, ma non boscose, e preferibilmente adorne di querce giovani ed alte, la forma stessa dei colli, non aguzzi, bens opulenti e quasi direi sensuali, rivelano infine una sostanziale differenza fra il paesaggio marchigiano, che io chiamerei rinascimentale, e quello toscano e umbro, che evoca il Medioevo, i Santi, i Comuni. Qui, nelle Marche, L'animo non si eleva, si smarrisce nella luce, naufraga nello spazio. Ridotto alla sua essenza poetica, il paesaggio marchigiano quale noi lo conosciamo in Leopardi: bellissimo, dolce, e nondimeno avaro di ogni facile e umana consolazione. Mancano, per intenderci, o sono assai rade, le sovrapposizioni del costume cittadino e dell'arte, che rendono altrove cos agevole, ma forse meno profondo il rapporto dell'uomo con la natura. E se c' una malinconia nelle Marche proprio quella che
Leopardi ha espressa nel "Canto notturno d'un pastore errante nell'Asia": la malinconia degli anni che passano, delle stagioni che si succedono e tornano senza posa, "del tacito, infinito andar del tempo". La malinconia dell'"Infinito", della "Sera del d di festa". Non andrete nelle Marche con qualche illusione estetica o mistica, come si va, poniamo, a Montecassino, alla Verna, a Subiaco. Ci andrete per visitare la Santa Casa di Loreto, che uno dei pi lieti santuari del mondo, per rendervi conto d'un popolo naturalissimo, il cui cattolicismo attivo, pratico, morale, pu vagamente sfiorare la superstizione, ma non l'ascesi. E in quanto a romitaggi o monasteri celebri, nelle Marche, a dire il vero, io ne conosco uno solo, quello di Recanati: un monastero del Tibet. ANCONA. ovvero DELL'ARCHITETTURA MARCHIGIANA. I caratteri architettonici delle Marche sono festosi, empirici, popolareschi, altri direbbe dialettali, pi che regolari o razionali. Le disuguaglianze del suolo su cui le citt marchigiane furono costruite, favorendo virtuosismi da architettura, direi, militare, sembra che architetti e capomastri si siano divertiti, non a ridurle, ma ad accrescerle, a ingigantirle. Ne resulta un barocchismo strepitoso, il quale, nel caso specifico, pi una questione di misura, di piani, di rapporti, di fantasia costruttiva, che di stile o di epoca. Per l'impeto che le anima, per la grandiosit delle dimensioni, per il loro aspetto trasandato e polveroso, possono dirsi barocche, nelle Marche, perfino le chiese gotico-lombarde di cui non c' penuria. Parr strano che nella terra di Bramante e di Raffaello il Rinascimento abbia lasciato scarse tracce, sebbene considerevolissime. Eppure cos; e non mi sembra necessario, per il momento, ricercarne le cause. Dir piuttosto che la rarit di queste tracce in relazione diretta col loro splendore; giacch le Marche sono il paese della modestia come regola e dell'assoluto in via di ecceZione. In quale altro luogo si respira un'aura di Rinascimento cos puro e nobile come nella piazZa di Loreto? Ivi aleggia e quasi esula il genio di quel tempo primaverile. E se vogliamo ricercare altrove il Rinascimento marchigiano, lo troveremo a Pesaro, non tanto nel Palazzo Ducale, quanto nelle due ville e nella chiesa di Girolamo Genga, che una specie di Annibal Caro dell'architettura. Quanto al Laurana, sembra pi a posto, qui, come costruttore di fortezze, che nella sua qualit di allestitore di Palazzi Ducali. Il suo rinascimento venezianeggiante e morbido rivela il gusto dei signori ch'egli serviva, ma poco ha da vedere coi caratteri dell'architettura marchigiana, incline, come abbiamo detto, al popolaresco. In opere molto pi acclimatate ricorrono frequentissimi i nomi di Baccio Pontelli, Francesco di Giorgio, Giuliano da Maiano: architetti toscani. Generalmente per il Rinascimento marchigiano anonimo e tardo. In certi palazzi di Ancona il Cinquecento appare ormai infinitamente pi tragico e sinistro che a Roma; e non senza meraviglia si vede spuntare, qua e l, qualche vaso di garofani su quei deserti .di mattoni e di marmi rovinati e affumicati dal tempo.
Furono i Papi che diedero un'impronta architettonica alle Marche. Quindi il barocco romano, col suo inevitabile eccesso di chiese, conventi, palazzi annonari e vescovili, porte monumentali. Ma bisogna pensare a un barocco trapiantato in un clima architettonico piuttosto rude, in quelle aspre condizioni di suolo, e praticato non sul travertino, ma sul mattone, Cui fa da intonaco la polvere delle strade: una polvere farinosa che rende il sole bianco e accecante sulle facciate. Le eleganze borrominiane furono per il truculento genio costruttivo marchigiano, una vera quaresima, una triste penitenza. Ce ne rendiamo conto a Recanati. Poi venne il Neoclassicismo che nelle patriottiche Marche, nella terra del Gioco del Pallone, oltre ad attecchire grandemente, si color di spiriti cittadineschi e agonistici. Fu allora che l'architettura marchigiana, afflitta da un clericalismo "fin de sicle", torn a respirare nei teatri, negli sferisteri, nelle tipiche pescherie in mattone rosso ccstruite a forma di tempio greco. L'ultimo Ottocento fabbric ad Ancona un Palazzo delle Ferrovie cos decoroso e ampio che potrebbe stare benissimo in qualche grande capitale europea. Ma ci che meglio ci d il senso di quest'epoca sono i monumenti e le lapidi anticlericali e repubblicane di cui abbonda in maniera sorprendente ogni citt marchigiana. Lavorarono nelle Marche e anzi si sbizzarrirono, a comin.iare dal Vanvitelli, architetti di ogni parte d'Italia. Nondimeno il fondo di quest'architettura paesano, artigianesco, e si pu ben parlare di un'architettura marchigiana, caratterizzata da quella bella negligenza, sprezzatura, da quello stile ardito e libero che Leopardi lodava negli scrittori; o, se si vuole, dalla ricerca della comodit, dalla passione del grande. Vi potr accadere qui di svegliarvi in una camera d'albergo, sotto una volta da Cappella Sistina, e di affacciarvi ad.una loggia che sfonda in paradiso. icos che s'intende la comodit nelle Marche. Piazze larghissime e chiuse, con la statua d'un Papa nel mezzo o da una parte, davanti alla scalea d'una chiesa, case troppo alte su vie che sprofondano a gradinate e non mancano, per lo pi, di corrimani di ferro, da ambo i lati, per aggrapparvisi nel caso che la citt dovesse oscillare o beccheggiare da un momento all'altro. Tali accidentate stradette si chiamano rampe o piagge e sono vie portuali, anche se si trovano in citt poste a quaranta chilometri dal litorale e a trecento metri sul livello del mare. Potrebbero anche paragonarsi alle scalette di una nave. N si direbbe che, abbordandole con tanta agilit e franchezza, questi marchigiani di collina e quasi di montagna portino scarpe di cuoio imbollettate, ma pantofole, come i gondolieri di Venezia. Qualche cosa di marinaresco insomma in ogni angolo delle Marche. In una cittadina situata in mezzo ai monti, da cui si scopre il Gran Sasso, vi sorprender un poco la presenza d'una pescheria. Per tutte queste ragioni le Marche non potrebbero avere una capitale pi rappresentativa di Ancona. Dico in senso architettonico e in ogni altro senso, dato che Ancona esprime a meraviglia la formidabile reazione di questa razza di agricoltori sul mare e, pi che citt marinara, una fortezza, una vecchia fortezza repubblicana e papale. Citt dura, fierissima, costruita non soltanto con vigore, ma con veemen-
za, o, per meglio dire, col dsprezzo della forza stessa. La sua chiarezza luminosit, il suo rilievo risentimento. Tutto concorre a darci di Ancona un'idea severa, bellicosa e donchisciottesca, perfino il suo stemma, che rappresenta ur guerriero galoppante, a visiera calata e con la durlindana in aria, contro un nemico che non si vede; una specie di San Giorgio senza il drago: eroe oscuro e terribile. In tale at teggiamento, la citt che seppe resistere al Barbarossa e nor. fu presa da Clemente VII se non con la frode, sembra galoppare nei secoli, alzando quel suo enorme braccio che il colle Guasco, una vera guasconata della natura, sulla cui vetta impervia gli anconitani costruirono la loro cattedrale, non si sa bene se con mistico intendimento o per un capriccio da marinai usi ad arrampicarsi sulle corde. A sconto di tutti i miei peccati, appena giunto in questa citt, sono salito fino a San Ciriaco pensando che, se Genova superba Ancona riottosa e, per vederla, occorre guadagnarsela, necessario salire. Messo il piede nella Loggia dei Mercanti, m'imbattei subito in una rissa di fanciulli, uno dei quali, gracile e acceso nel viso, brandiva una fune annodata, cor un pezzo di cinghia in cima. Dovunque fu il Governo Pontificio scoprirete dei sottintesi morali e religiosi nell'architettura. Ancona l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso delle Marche. Le sue luride calate sono una bolgia dove gli operai, sbucando da certi archetti nell'ora che la sirena fa sentir il suo lugubre, straziante richiamo, sembra che escano dalla galera per entrare nell'arsenale. L sotto, a quell'ora, si possono anche vedere cara binieri in fazione, sudati, impolverati e col moschetto in ispalla. Ma basta imbroccare una scala che sale a zig-zal, per usCire da quell'inferno e trovarsi a un tratto esiliati nella luce. E vorrei sapere in quale altro porto del mondo dat( imbattersi in un Arco romano. Meno fastoso, ma non meno eroico dei suoi confratelli dell'Urbe, quest'Arco annerito e predato che Traiano eresse nel porto della citt dorica ha il colore di Ancona vecchia. Sorge fra i capannoni, le gru, le ciano la banchina. Alquanto pi indietro, in una massa confusa di edifici e alberature di navi, si delinea il non disprezzabile Arco Clementino. Imminente, sul colle Ascanio, la fortezza del Sangallo e altissima, sul nostro capo, la chiesa di San Ciriaco, col suo basso e buio portaletto puntato come un cannone. La citt, gialloscura, tutta raccolta, accatastata, come in una culla, nel breve spazio che le concedono le sue prepotenti colline, aperta sul mare latteo, senz'ombra di pittoresco. Dai caseggiati che s'addossano su per il ripido colle, verso San Ciriaco, emergono, come due grandi macchine da processione, una cupola, una facciata barocca. Profondo, meditativo, il verde dei colli intorno. La terra dorata. Una luce di beatitudine scende sul mare al tramonto. iallora che dall'alto di San Ciriaco si vede il porto, l sotto, come un giocattolo. Alle dieci di sera le vie d'Ancona, deserte e illuminatissime, sembrano spazzate dalla tramontana. Tale l'effetto che producono, a vederle vuote, queste polverose citt delle Marche. Il lungo, intenso, processionale passeggio finito. Gli anconitani sono gi a letto o sparsi pei cinematografi affollati di sottufficiali e bassa forza di tutte le armi. In quel momento, alla fine d'una giornata ricca d'impressioni,
disposti a gettare un po' d'acqua fredda sul nostro entusiasmo, notiamo tuttavia con piacere i marciapiedi di marmo rosa; e guardando le bianche vie non lastricate che salgono verso i colli, potremmo quasi illuderci di essere a Napoli, a Civitavecchia. Ma Ancona Ancona. Ben disse non so qual Patriarca di Aquileia che, in omaggio alla sua positura, questa citt meritava di essere costruita "tutta de horo mas-*** Andare da Ancona a Recanati come passare da una festa da ballo ad un romitorio. Ancona un trionfo di luce e di buona salute. Per le sue vie non s'incontrano che facce toste, ragazze poppute, dagli occhi bovini, vecchie serene e vegete, popolane ingenue che, richieste di qualche indicazione, corrono con la mano ad accomodarsi i capelli. Recanati, al contrario, uno dei paesi pi solitari che io abbia visti nelle Marche. Salendovi dalla marina si ha l'impressione che la strada s'inoltri un po' troppo verso il mon te, ci si domanda dove andremo a finire. Sono in mano d'un autista di fortuna, non avendo trovato a Porto Recanati altro mezzo di trasporto pi regolare e fidato. Mentre va divorando, con una specie di rabbia, la tortuosa salita, lo strano conducente mi studia, gettandomi di tanto in tanto, per lo specchietto, certe occhiatacce nemiche e furtive che mi danno subito il senso di essere in terra di villici. Fugge il mio sguardo, il buon uomo. Lo disturba evidentemente che io mi sia accorto della sua curiosit e che l'osservi a mia volta. Cos andiamo avanti, per un buor tratto, senza dirci una sola parola. Devo convenire che questo ingresso nella terra di Leopardi non piacevole. Giun. gendo qui da pellegrino e devoto del poeta dei Canti, avrei potuto desiderare un incontro pi felice e soprattutto un servizio di corriera meglio organizzato. Per fortuna, a un cer to punto, sale sulla vettura un soldato che torna a Recanati in licenza. Ora mi sento un po' pi a mio agio. Ed ec co dei contadini che vengon gi per la via polverosa, spingendo un vitello bianco. Ecco a una svolta, la cupola di Loreto: apparizione miracolosa e fugacissima, in un cielo di fiamma. Ci avviciniamo all'abitato. Passando accanto al cimitero, dove si ha quasi l'illusione di sfiorare la tomba di Leopardi e si come percossi dalla sua presenza, poich in quale altro luogo l'autore di Amore e morte potrebbe avere una sepoltura pi degna di lui, pi poetica?, l'amico automobilista si leva il cappello, anzi un berrettaccio che porta sul capo a sghimbescio, ed io faccio altrettanto. Sarebbe una buona occasione per riconciliarci. Ma neanche per sogno. Quest'uomo sembra volermi negare l'estrema confidenza di salutare i morti in sua compagnia. Non dimenticher mai la brutta occhiata che m'ha scagliato in quell'istante, sempre attraverso lo specchietto, come se lo imbarazzasse enormemente il dover manifestare i suoi sentimenti religiosi in presenza d'uno sconosciuto e diffidasse, ad un tempo, dei miei sentimenti; n la smorfia indescrivibile che gli ha contratto il ceffo, scontrandosi col mio sguardo proprio nel momento in cui compivamo lo stesso atto di devozione. La mia solidariet, invece di addolcirlo, non ha fatto che inasprire il suo disappunto, aggiungendovi la delusione e lo scorno di vedersi scoperto in tutto il suo umano fondaccio.
Le invettive leopardiane contro il "natio borgo selvaggio" sarebbero dunque giustificate? Lasciamo andare. Sono marchigiano anch'io e mi rendo conto benissimo del carattere dei marchigiani: della difficolt ch'essi hanno a famigliarizzare con gente che non conoscono, di una certa loro disposizione a rendere difficili e complicati i propri rapporti col mondo, e la loro persona, senza volerlo, oppure volendolo, il che riprovevole, interessante e preziosa. Un altro tipo del genere, che m'ha condotto con la sua balilla sulle vie del maceratese, lasci passare un'intera giornata prima di sciogliersi un poco. Solo verso sera, davanti ad una buona bottiglia di vernaccia rossa, intenerito dalla vista di un gran piatto di "ciavuscolo", gustoso affettato casereccio di queste parti, si decise a far sentire la sua voce Recanati, a diocesi e citt autonoma, caddero a poco a poco tutte le fortune di questo paese che, per le sue defunte glorie e per il suo panorama immenso, pu far pensare a San Miniato al Tedesco. I luoghi pi suggestivi di Recanati sono le porte, sparse qua e l, su diversi livelli: specchi del cielo e del lontano orizzonte. Ce n' una particolarmente adatta per farsi un'idea della sconfinata bellezza di questo paesaggio. Di l si domina tutto il borgo, che s'incurva sull'alta vetta, e si vede il colle turgido, con quei ricchi andamenti di cupola, coltivato fin sotto le mura, posseduto dolcemente dal lavoro e dalla pazienza dell'uomo. Quante ginestre nel paese di Leopardi! E soprattutto intorno a quella casa che si potrebbe credere sia nel centro ed invece all'estremit di Recanati, in uno dei punti pi romiti di questo paese cos deserto. Confina con un monastero e con la campagna, ed ha i monti alle spalle, il mare di faccia. A Leopardi bastava uscire dal giardino e fare due passi lungo un viottolo solitario per evadere sull'ermo colle, il quale, come tutti i luoghi, come tutte le cose a cui si riferisce il poeta dei Canti non altro che una dipendenza del Palazzo Leopardi. Sicch parlare di Recanati a proposito di Leopardi forse dir troppo. In realt, tutto il mondo leopardiano contenuto in uno spazio infinitamente pi ristretto, sebbene spiritualmente incalcolabile. Per ricalcare le orme di uno dei pi grandi poeti che siano mai esistiti non necessario uscire dai limiti d'una casa patrizia dell'Ottocento. Ecco il palazzo, ingrandito e rifatto da uno zio del poeta, canonico e dilettante di architettura, in quello stile squallido che abbiamo adombrato. Soltanto a vedere i due piccoli bracci di scale marmoree e curvilinee che s'arrestano al primo piano si capisce la malinconia di Leopardi bambino. La stanza da letto di Giacomo guardava sull'androne per una finestrella che ora non esiste pi. Ed da quella specie di grata che il giovane innamorato e assetato di gioia vide baluginare il giorno per tanti anni, n ud i primi rumori, e spi una mattina, all'alba, "con l'orecchio avidissimamente teso", la partenza della signora pesarese, protagonista del suo Diario d'amore. ... Qui non cosa ch'io vegga o senta, onde un'immagin dentro non torni, e un dolce rimembrar non sorga...
Passando per un corridoio che mette nel giardino s'intravedono, di l da una porta a vetri, i primi gradini d'una scaletta di scrvizio. Sono di lavagna, cosi accanitamente raspati e logori sull'orlo che si volge l'occhio altrove come se si fosse spinta la propria curiosit un po' troppo oltre. Non si pu fare a meno di pensare, scorgendo quelle impressionantissime tracce, alle scarpette di Giacomo, ai suoi rimbombanti sollazzi, e il contatto con la realt leopardiana si fa, d'improvviso, insostenibile. Pi triste del giardinetto d'una suora maniaca il "paterno giardino", orgoglio del buon Monaldo, che lo divise pomposamente in orto e pomario e non manc di celebrare la sua domestica gloria in una iscrizione latina. Da tutto il palazzo spira quella musoneria, quel non so che di fastoso e tirchio, che si possono immaginare. Ma non facciamo simili osservazioni di buona voglia. Giacch il Palazzo Leopardi non riesce a diventare un museo. Esso tuttora vivo, dolente. E l'affabile vecchietta che ci guida per le sale della biblioteca, persona di servizio della famiglia, chiama Giacomo, con una punta di riguardo per la dignit della casa, "il poeta". Nello studio di Monaldo par di vederlo, il vecchio sanfedista, seduto a quella sua scrivania da fattore di campagna, mentre va facendo i conti che non tornano o s'abbandona volentieri, con paterna inopportunit, in una lettera al figlio, ad alcune acri e tendenziose considerazioni sugli aggravi fiscali del Governo Provvisorio di Bologna. Il destino volle che Monaldo fosse uomo di lettere e appassiondto biblifilo, fino a spendere gran parte del suo patrimonio nei libri, perch da lui nascesse un mostro di erudizione e di sapienza. Fece di Giacomo Leopardi un prigioniero, Un martire dello studio e non gli concesse altro mezzo di liberazione vero fuorch il viottolo breve che mena al colle dell'Infinito" e le finestre della sua biblioteca bassissime, fornicatrici, dove allungando una mano, si ha l'impressione di poter accarezzare i capelli di una ragazza che passa. Oh quelle finestre che paiono fatte apposta per rendere pi inquieta e mossa, con la loro vicinanza alla strada la solitudine del poeta! Di quali affetti, scoperte, avventure usualissime e indimenticabili, furono mediatrici. Sono le finestre da cui Leopardi vide le cose pi prossime tanto lontane quanto, dal lato opposto, le vaghe stelle delL'Orsa. E per intendere tutta la loro poesia, la parte che ebbero nella vita e nell'opera del Nostro, si consideri che l sotto la piazzetta del villaggio, cosi carica di ricordi leopardiani che non si pu guardiare: la chiesa di Montemorello, da un lato, in cui da bambino il grdn pessimista serv messa e pi innanzi negli anni, rispettoso delle convenienze e delle tradizioni domestiche, soleva recarsi puntualmente ogni domenica; la casa di Silvia, la bottega del legnaiuolo, la piccola via per la quale il poeta, alzando il capo dal lavoro, vedeva tornare dai campi la donzelletta, e l'erta stradicciola rasente il palazzo, ove "Siede con le vicine su la scala a filar la vecchierella". Chiunque voglia, su quelli stessi scalini esterni, pu rivedere oggi il quadretto del "Sabato del villaggio"; poich nelle Marche ancora il tempo che Berta filava. In una casupola situata dietro il palazzo, ma ora scom-
parsa, abitava Nerina, che fu come chi dicesse una pigionante e una servetta di casa Leopardi, allo stesso modo che Silvia la figlia del cocchiere e va identificata con quella Teresa Fattorini, del cui commovente destino Leopardi, nelL'intento di scrivere uno dei molti racconti che poi non scrisse prende nota negli Appunti e ricordi, nove anni prima che gli uscisse dalla penna l'immortale canzone. Leggiamo: "Storia di Teresa... e interesse che io ne prendeva come di tutti i morti giovani in quello aspettar la morte per me". E un poco pi oltre: "Come alcuni godono della loro fama ancora viventi, cos ella per la lunghezza del suo male speriment la consolazione dei genitori ecc., circa la sua morte e la dimenticanza di s e l'indifferenza ai suoi mali ecc.". In queste frasi abbreviate e smozzicate, in queste ruminazioni di discorsi ascoltati in famigliasono i primi fermenti della canzone a Silvia. Tutti i motivi che spingono il poeta a interessarsi dell'infelice giovinettaa cominciare da quell'aspettar la morte per s, appaiono cos naturalinella loro leopardiana profondit e gentilezza, che il pi piccolo commento guasterebbe. Ma l'adolescente Leopardi aveva Silvia sempre davanti agli occhi e negli orecchi; bench non esista, negli appunti suddetti, un accenno che ce la mostri presente, essendo stati scritti dopo la morte di lei. E quella figlia del cocchiere che in una paginetta indimenticabile s'affaccia una sera alla finestra per lavate un piattello e, nel tornare, dice a quei dentro: "Stanotte piove da vero. Se vedeste che tempo. Nero come un cappello", non pu essere che la sorella di Silvia, di cui conosciamo l'umilissima e tristanzuola esistenza. Nonostante ci, prima che nella poesia, la "tenerella" vive, come abbiamo visto, negli Appunti? riordinati l dove passa in un tramonto di fuoco, in un nembo di giovinezza, un'altra fanciulla che Leopardi am, di amore assai pi reale e veemente, sia pure per un attimo, e rimase obliata fra le Carte napoletane la vezzosissima Brini, "instabile come un'ape". Del racconto non se ne fece nulla. Nove anni dovevano trascorrere avanti che il mosto si tramutasse in nobile vino e Leopardi potesse cavare dal suo fallito romanzetto una lirica sublime. Tuttavia i fanatici della poesia pura o astratta possono venire a Recanati per controllare l'assoluta concretezza leopardiana. Qui non neppure il caso di parlare di realt, ma di cronaca, non di aderenza alla natura o al vero, ma di esattissima relazione con le pi strette contingenze, con la topografia, coi punti cardinali e coi registri dello stato Civile. Ognuno intende che la poesia di Leopardi non poteva riuscire cos autentica, cosi stagionata, se non a queste famigliarissime condizioni; e che molto spesso a formare un grande uomo occorrono circostanze particolarmente tragiche. La grazia della poesia coincideva in Leopardi con quella che parve a lui dannazione; dannazione di vivere a Recanati. Fino a tanto ch'ebbe la forza di rimanervi, la sua casa fu un osservatorio umano e cosmico di cui non si conosce l'eguale, e ogni volta che vi ritorn, sempre pi persuaso del suo possente errore, in uno stato da far pena o, per usare una sua espressione favorita, misericordia, le pareti di quel palazzo scrosciarono come canne d'organo. l'anno "grande e matematico" in cui scrive, d'un fiato, quasi tutte
le Operette. Sono le brevi, ultime, risolutive stagioni del'28 e del'29 che diedero al mondo, tra l'altro, Le ricordanze. Dopo di che Leopardi, pur destinato ancora a cose grandissime, aspetta veramente la morte e non pi che un pietoso e consapevole trastullo in mano della fortuna, pi insumciente che iniqua. Venire a Recanati come tornare dopo molti anni al proprio paese natale. Non si pu salire questo colle senza sentirsi il cuore stretto da una commozione indicibile. Par proprio di averci vissuto in questo paese. Ogni suo aspetto ci noto come per antica e personale esperienza e se abbiamo qualche sorpresa di quelle che si provano rivedendo i luoghi della nostra infanzia e comparando la loro presente realt con la nostra fantasia di allora. Povere cose che noi colorimmo d'infinite illusioni e che ci appaiono adesso co me le scene d'un teatro a spettacolo finito. Le loro misere o ingrate apparenze risaltano maggiormente alla luce dei nostri ricordi. Eppure qui non soltanto il nostro passato, che risorge da ogni pietra, ma un motivo inesauribile e perenne di meditare sul nostro destino, di ripiegarci su noi stessi. Questi sono i luoghi che noi ricerchiamo e fuggiamo ad un tempo; i luoghi in cui vorremmo tornare a vivere per sempre e dove ci terrorizza l'idea di trascorrere una sola notte. Non dir a Recanati, ma a Montemorello, che la contrada pi propriamente leopardiana di questo paese, si sente il bisogno di fuggire al pi presto, come se noi ci avessimo vissuto e sofferto tutto quel che sappiamo di Leopardi. bile. Ma per capire Urbino forse meglio venirci dal mare e veder comporsi a poco a poco, dalla soleggiata e catastrofica valle del Marecchia, il misterioso Montefeltro. URBINO Dalla parte di Fabriano la terra d'Urbino sembra dominata da due colori: il grigio e il rosso. Cresta secca, e pietrame dvampato come per fuoco interno o quasi fosse investito da un tramonto abbagliante. L ardore si fa pi vivo nelle colori dei monti che paiono tanti bracieri. Come se ci non bastasse simbatte sovente in giovani contadine vestite di rosso col volto sudato e acceso. Ma i luoghi pi belli e pi frequenti sono quelli in cui la campagna, nelle zone arate, lla il colore d una giornata senza sole. La luce marina, scontrandosi con questa terra argillosa e pietrosa, mette ovpure uno splendore arido, illumina le verdi colline poco lavorate e tuttavia dolcissime, con una casetta in cima. Il paesaggio ampio, vario, disteso, mai soffocante. L'aria sente il sasso, l'aria delle cave, specialmente al Furlo. Altissime rocce, macchiate di verde alla base, chiudono da un lato le acque del Candigliano, d'un verdazzurro cos carico e squillante da parere artificiale, simile a quello dei laghi alpini. Imprevedibile incontro sulla via d'Urbino. Ma la parentesi breve. Ecco la galleria che i romani, dice una favoletta locale, scavarono in una notte. Di l ricomincia l'infinita melodia delle colline raffaellesche. I campi coltivati sono rari e, pi che altro, a vite. Paese povero e stupendo. Primordiale senza essere selvaggio. C' in esso quel misto di desertico e colto che, secondo la felice espres-
sione d'uno scrittore d'arte, proprio del cuore d'Italia. Urbino terra originaria, una delle sacre fonti della bellezza italiana. La vicinanza dell'Adriatico e l'altezza della sua posizione fanno di questa citt un luogo incomparabile. Fra Rimini e San Leo, passato San Marino, appare come in un plastico o in una mappa geografica, un paesaggio luminoso e geologico, una vasta e curiosa rovina di montagnette livellate e nane, su cui non traccia di vegetazione. Solo i venti e le acque hanno lasciato sui declivi impronte visibilissime del loro fuggevole e incessante lavorio. Sono i calanchi: monticciattoli dirupati, smontati, tutti su per gi disegnati ad un modo, perch soggetti all'azione, fatalmente omogenea, d'una medesima legge dissolvitrice. Formazioni dell'acque e del vento, si somigliano come le onde del mare e le dune del deserto. Nelle pieghe di queste rovine terrestri l'ombra azzurra e fonda e la luce che arride sul rupestre paese, dominato a distanza dal Titano, fulgida. Un torrente asciutto, dal vasto letto rossastro, percorre la valle franosa, spaziando in larghi giri, di l da un monumentale viadotto, per tutta la pianura di Romagna, fino al mare azzurro e fumoso. questo, io credo, il paesaggio che Piero della Francesca dipinse nel ritratto del Duca di Urbino, ingentilendolo come poteva, mettendo un fiume ricco o addirittura un lago solcato da vele a stendardo al posto dell'arido corso torrentizio. Il Duca non comandava che sopra un reame di luce. Il pittore volle aggiungervi i segni della prosperit, del commercio, e quasi direi un indizio di marina mercantile. Certo ch'egli rappresent la terra d'Urbino guardandola dall'alto, come in un prezioso rilievo geografico, allo stesso modo che ci si mostrano appunto i monticelli ondosi, i picchi in tempesta, della valle del Marecchia. Ecco perch, alle falde del Montefeltro, non Raffaello che ci viene incontro, ma Piero, con quei fondali da stemma, quei paesaggi araldici, ch'egli dipinse nei Trionfi e nei ritratti dei duchi, a scopo celebrativo. Pi su, alquanto pi su, stanno le colline famigliari che Raffaello conobbe e am ad una ad una. Occorre giungere a San Leo ed essere sorpresi dall'aria, dal silenzio del monte, da qualche gallo, qualche usignolo che canta; necessario che alla nuda e frastagliata regione sopraddetta si sostituisca un paese divinamente domestico, pur nella sua solitudine montanina, che il cielo dolcissimo si confonda coi contorni delle colline verdeggianti e tonde, ognuna delle quali ha un peso, una solennit personale, per entrare nel dominio di Raffaello e di Bramante, e capire, mio Dio, come anche il perfettissimo Cinquecento abbia i suoi riscontri in natura. Quello che noi ritroviamo nella campagna d'Urbino il sentimento, la favola, il mito dei due grandi urbinati. Ma in moltissimi luoghi di questa terra cos spaziata e armonicamente disposta ci par di riconoscere insieme le tonalit dell'uno e le proporzioni dell'altro. In certi colli a cupola gi la forma architettonica bramantesca. E se dovessimo dire, per esempio, di che colore sono i dintorni di Urbino non potremmo che evocare, come abbiamo gi fatto, la pittura di Raffaello e l'architettura di Bramante; il quale ultimo dorato come Alberti marmoreo e Palladio bianco.
I dintorni d'Urbino bisogna vederli verso sera dai bastioni del Palazzo Ducale, destinati al passeggio. Ampiezza, dolce luce, armonia delle colline, l sotto, col loro sfondo di monti aerei, con le distanze che fanno sognare. Vigne, orti, pergole, giardini pensili, qualche viale di cipressi sui colli pi prossimi, e i cipressi del cimitero senza fiori, dove i morti, un po' trascurati, dormono sotto l'erba alta, in una solitudine disadorna e quasi pagana, col piccolo chiostro di San Bernardino accanto, e la chiesetta rustica, di gusto bramantesco; tutto ci che circonda Urbino assume, in quell'ora crepuscolare e lucente, un rilievo magico. Urbino: porte sul cielo, vie ammattonate, ripidissime, su cui si cammina dolcemente come sull'erba. Tale saporosa comodit, ricercata in un suolo cos arduo, ci rammenta che siamo, dopo tutto, in un paese di contadini. Queste vie sono ammattonate per rendere agevole il passaggio ai buoi, il cui piede fesso e molle non sopporterebbe, in siffatti slivelli, una pavimentazione pi dura. Hanno inoltre il pregio, naturale o artificiale che sia, di vincere l'eccessiva pendenza inarcandosi smisuratamente come il dorso d'una balena a fior d'acqua. Caratteristiche vie marchigiane! Ce n' una, bellissima, a Loreto, che Sisto V immagin di prolungare, per valli e colline, fino a Recanati, nell'intento di congiungere i due luoghi e costruire, in questa luce d'oro, la Citt Angelica. Edific la Citt Angelica a Roma, come sappiamo. La edific principalmente sull'Esquilino, dove lo portava la sua nativa predilezione pei luoghi elevati e gi, da cardinale, ci aveva messo, per cos dire, la sua ipoteca, possedendovi una vigna. Ma trattandosi di un Papa abbastanza estroso e non privo d'idee proprie in materia urbanistica, sarebbe arbitrario supporre che, aprendo certe strade dell'Urbe, come quella delle Quattro Fontane, da cui nasce via Panisperna, magnifiche "viae crucis", arterie ondulate e penitenziali del sontuoso calvario monticiano, egli avesse in mente queste colme vie da bifolchi tracciate sulle ampie gobbe dei suoi colli natali? Passeggiando una sera per Urbino ci perdevamo in simili fantasticherie. Ancora una volta ci accadeva di scoprire fra le Marche e Roma i pi insospettati rapporti. E pensammo a Loreto, la quale gi un frammento della Roma Sistina, una piccola Gerusalemme celeste che sulla via di Recanati, ad un'apertura di valle, sorge e tramonta in un attimo. Abbiamo toccato il fondo campagnolo di Urbino. Per il resto, quasi inutile ricordare che questa citt, dotata di scuole d'ogni genere, specialmente d'arte, continua, in qualche modo, le sue tradizioni umanistiche. Vedendo, nell'ora dell'uscita, i gruppetti di studenti e di studentesse, persi per la gran piazza assolata del Palazzo Ducale, saremmo tentati d'immaginarci la patria di Raffaello come un monastero pagano. Quale gloriosa solitudine in questa piazza! Si gira intorno al Palazzo Ducale senza capire con precisione dove comincia, dove finisce. Venuto su in varie epo'che, ricostruito infine dal Laurana "junior", quell'architet-
to dalmata, fastoso e ricamato, di cui gi discorremmo, si estende per uno spazio immenso e coinvolge, incorporandoli in una gran massa architettonica, tutti gli edifici che incontra sul proprio cammino. Si confonde con la citt, tutt'uno col colle. Il Palazzo Ducale Urbino. Agli occhi di chi arriva due alte torrette a punta lo fanno somigliare a un castello francese. E tra l'una e l'altra di queste guglie sono logge paradisiache, di tipo romano e barocco, da vederci un papa affacciato a benedire i monti. Una di esse, la pi aerea, la finestra dello studio di Federigo, aperto sull'Appennino. Rimaniamo sbalorditi dalle proporzioni del Palazzo Ducale, ma ci che piace soprattutto la sua luce, la perdutissima luce di Urbino, che pure accusa, nei muri grigi, le nevi e le nebbie d'inverno. E se una cosa ci commuove, in tanta variet, moltitudine, splendore di sale immense, dalle bianche volte a lunule, un po' cincischiate, quel remoto studiolo sulle cui pareti rivestite di finissimo legno un intarsiatore del Quattrocento figur i progressi del secolo e ogni altra immagine e oggetto atti a distrarre la fantasia d'un principe di quei tempi, non sempre dorati. Parrebbe, a giudicare dalla piccolezza e solitudine del suo studio, che il duca Federigo avesse gusti monacali. Ma da quel nido inaccessibile il falco del Montefeltro spaziava con lo sguardo per tutto il Ducato. E abbiamo anche visto come nello scegliersi un ritiro cosi ascetico, da vero signore del Rinascimento e mezzo artista quale era, a giudizio di Michelangelo, egli ebbe cura di premunirsi, in tutti i modi, contro la melanconia e la noia. Di Raffaello ad Urbino non c' che la casa, la quale custodisce un calco del suo nobile teschio, e il "Ritratto d'incognita" nel Palazzo Ducale. Eppure tutto ci parla di lui, non solo il paesaggio, ma la gente: le facce solcate e ben disegnate di questi antichi umbri civilissimi ed alti, i visi delle donne, che sono aguzzi o tondi come i monti qui attorno e come i visi delle ancelle nello "Sposalizio della Vergine". Tutto ci persuade che Raffaello non poteva nascere se non da questa razza montanina e pura, da questa umanit rarefatta, in una delle pi soavi e misteriose regioni d'ltalia. Tale l'aria che si respira ad Urbino. Gran differenza fra questa ed altre illustri citt italiane. Qui, all'infuori di due tavole di Piero e una tela di Raffaello, c' poco da vedere in materia di opere d'arte. La bellezza della citt tutta naturale, anche in rapporto all'architettura, accidentatissima. Perch dunque si viene ad Urbino? Per motivi niente affatto comuni e non facilmente definibili. Una gita ad Urbino un viaggio alle origini. FERRARA E LE SUE DONNE A mezza strada fra Bologna e Venezia, la capitale estense partecipa un po' dell'una, un po' dell'altra citt, pure avendo, come tutti sanno, una sua fisionomia incomparabile. Il cielo a tratti, visto tra gli archi del castello, gi lagunare. Basta trovare la sera una grossa e pelosa farfalla bianca sul velo della zanzariera che protegge il nostro letto d'albergo per rammentarci che siamo a poca distanza da Comacchio.
Nel fossato del Castello, i ragazzi, eludendo la vigilanza delle guardie, pescano con l'amo grossi pesci, tanto per dimostrare che l'atavismo non una leggenda. Parecchie di queste strade, un tempo, furono canali su cui s'affacciavano le case come a Venezia. Oggi conservano il loro aspetto di corsi d'acqua e qualcuno ha voluto sforzare la fantasia fino ad immaginarsi gli edifici di Ferrara come barconi arenati. Certo che questi edifici hanno le fondamenta nell'acqua ed la ragione per cui sono cos bassi, in generale, e si pu passare in ferrovia davanti a Ferrara senza vederla. Tutto ci ricorda la bassura, la palude, a Ferrara. E proprio qui doveva sorgere uno dei centri pi civili e umani del Rinascimento, quasi in eroica opposizione con la natura, particolarmente ostile. Quel Cinquecento idillico, scettico, gaudente, contro cui tanto infuria il nostro De Sanctis, eccolo a Ferrara, coi suoi principi guerrieri e paterni, che si facevano calare nella fossa vestiti da francescani. Uomini chiusi e duri, sui quali gravava la responsabilit d'uno stato da riconquistare ogni giorno contro nemici potentissimi e pi ancora contendere all'invasione delle acque. Sappiamo che, appunto per questo, gli Estensi furono tra i signori pi illuminati del proprio tempo. C'era gi in essi la stoffa di quei principi che fondarono le monarchie moderne, bench peccassero troppo nella carne per poter distinguere fra eredi naturali e legittimi, non tenendo conto di altro, nell'eleggere i loro successori, che dell'esperienza e del merito; e il Consiglio dei Savi ratificava il loro giusto volere. Qui si ebbe nel Rinascimento una prima idea dello Stato, un primo esempio di lealt e carit patria, da parte di chi governava, una dinastia civilissima che dur per alcuni secoli e fece del Ducato di Ferrara una delle pi progredite nazioni d'Europa. Il Rinascimento artistico ferrarese pieno di spiriti precorritori e di ardimenti. L'"addizione erculea", vale a dire la parte nuova della citt, detta altrimenti "terranova", che Ercole I fece costruire secondo i rigorosi concetti architettonici dell'ultimo Quattrocento, costituisce un archetipo di citt regolata e moderna. Alfonso primo, vissuto in mezzo alle guerre, fu il pi grande artigliere e fabbricatore di bombarde della sua epoca. E oggi possiamo appena immagmare, ispirandoci a qualche fantasioso paesaggio del Dossi, che cosa doveva essere Ferrara ai suoi tempi, chiusa nella cornice delle sue diciotto "delizie"; quelle famose ville estensi (luoghi di sollazzo e accademie ad un tempo, in cui ebbe sede il Rinascimento ferrarese) che la mano castigatrice della Controriforma rase al suolo, spogliando Ferrara de]la sua corona e di quasi tutto il suo patrimonio artistico. Allora anche il Po cambi strada, allontanandosi da Ferrara, dove finalmente fu ricondotto, mediante un canale navigabile. Fatta murare da Clemente VIII la porta per cui era uscito piangendo l'ultimo Duca, la citt cadde nel pi desolato abbandono. Vastissima e con una popolazione grandemente diminuita, non c'era pi motivo di costruire. perci che manca a Ferrara quella continuit architettonica che si pu osservare in altre citt italiane e specialmente a Roma. Nel'59 i ferraresi, rendendo al dominio pontificio pan per focaccia, demolirono la fortezza di Clemente VIII. Cos la citt non reca, si pu dire, tracce di altra civilt, fuorch degli Estensi. Ma l'enorme e tragica interruzione storica si avverte nel vuoto sonoro degli edifici, in quelle vie ampie,
lunghe, diritte, dell'"addizione erculea", dove tutto cos matematicamente architettato che le rare persone in cui ci s'imbatte appaiono come pedine fuori posto. Chi si trova a passare per questa citt metafisica sente il bisogno di nascondersi, di camminare lungo i muri, come se le case lo spiassero, e s'affretta a raggiungere il centro. In questo gioco di linee rette, di costruzioni spaziali e prospettiche, si colti dal terrore della geometria. E un mondo troppo perfetto per poter essere abitato. Gli Estensi costruirono Ferrara nuova per i loro ozi umanistici. Doveva essere una citt vietata, destinata alla Corte. E tale, si direbbe, rimasta. Ma dove sono le ville a cui conducevano queste nobili e grandi vie che ora finiscono in caserme, in villini da impiegati, e vanno a perdersi nell'aperta campagna? Come tronchi superstiti di un bosco abbattuto si elevano i palazzi lineari del Cinquecento e ben si capisce come, in tanta solitudine, potessero divenire, nel'48, propizio asilo di cospirazioni carbonaresche. Qui la patria di Savonarola custodisce le sue glorie civili e artistiche. Altrove pare aver raccolto, un po' alla rinfusa, tutto ci che la sua storia ha dimenticato o respinto. In qualche via romita e pi antica, in certi luoghi che non hanno pi tempo, l dove il marmoreo e splendido Cinquecento si confonde con un Medioevo rustico, immemorabile, che dorme al sole, si pensa a Cosm Tura e al Boiardo allo stesso modo che la parte nuova e aulica della citt pu far pensare ad Ariosto. Ecco, in breve spazio e in un silenzio infinito, la casa dei Romei, costruzione romanica in mattone rosso, col suo melanconico ciliegio centenario nel cortile; il palazzo dal gran giardino claustrale, ove Renata di Francia, la calvinista, fu segregata per volere del Papa. E l, dirimpetto, l'immensa rovina dell'edificio che i signori ferraresi fecero alzare per accogliervi un altro illustre infelice e ribaldo: quel Ludovico il Moro al quale i Francesi tolsero il Ducato come ringraziamento di averli chiamati in Italia. C' niente di pi tragico di questo palazzo? Dedicato ad un principe che non venne mai ad abitarlo, sperando sempre di riconquistare il trono perduto, ebbe storia oscura, anonima, sfortunata. Negli anni del dopoguerra fu ricetto dei senza casa che, nei lunghi e nebbiosi inverni, devastarono i monumentali soffitti di legno per riscaldarsi. Quindi una fortezza del bolscevismo, sgombrata dai fascisti con azioni sanguinose. Sui muri bianchi e oltraggiati sono rimasti i simboli e le scritte del tempo. E questi fatti recenti acquistano, a sentirli raccontare, un che di leggendario. Sono a loro volta antichissimi e lacrimevoli come le pietre che ne furono spettatrici. Poco pi su, ecco finalmente la tomba di Lucrezia Borgia, in un convento di sepolte vive che non so cosa penseranno di questa loro singolare protettrice e inquilina. Pregano in coro e sentendo avvicinarsi il nostro passo profano tacciono insospettite, come i grilli. Bisogna perdersi in queste strade per capire il tenero fascino di Ferrara, quel tanto di travagliato, di umano, di romantico, che forma, per cos dire, il sedimento della sua storia. Ferrara un luogo della fantasia amorosa, un mito di
giovent perenne. I siti pi poetici di questa citt sono legati a nomi femminili, ci ricordano la galanteria, il peccato, e portano infine a riflettere che non a caso pot stabilirsi a Ferrara, insieme con quella degli Estensi, una dinastia di poeti d'amore e d'armi. Siamo nella patria di Giulio d'Este, fatto accecare da Ippolito per gelosia d'una Borgia, nel regno di Niccol terzo il quale am tante donne e mise al mondo tanti bastardi da far sorgere il proverbio "di qua e di l dal Po son tutti figli di Niccol". La presenza femminile, nei monumenti ferraresi, assidua. Usciti appena dalla citt vecchia, dove abbiamo visto il palazzo di Renata e la tomba di Lucrezia, ci fermiamo davanti ad una lunga e leggiadra casina cinquecentesca, a un piano. E la celebre casa di Marfisa. L nel Castello (come non pensarci?) fu giustiziata Parisina. Perfino a pochi passi dalla casa di Ariosto, poeta scanzonato e misogino, malgrado l'assunto, ci sorprende una lapide in memoria di Costanza Monti, la bellissima, irrequieta moglie del Perticari e figlia di Vincenzo Monti, venuta a finire i suoi giorni a Ferrara. Eravamo qui per rendere omaggio a Ludovico Ariosto ed eccoci, senza volerlo, sulle orme dell'amorosa malinconia del Tasso. VENEZIA La prima volta che si vede Venezia si ha l'impressione d. trovarsi in una citt del retroterra che abbia sofferto un'inondazione. I pali del telegrafo, che corrono bellamente sulla laguna, le isole che ne emergono qua e l, con gli alberi e i caseggiati, come da una pianura allagata, quella barca comune su cui arranca un vigile urbano in tenuta estiva, lungo il Canal Grande, la quale par proprio una barca di salvataggio, tutto concorre a favorire l'inganno. Per un momento siamo tratti a considerare lo spettacolo che d Venezia come qualche cosa d'immensamente provvisorio e bellissimo. Illusi dalle apparenze ci perdiamo a seguire con gli occhi e con la fantasia, in tutta la sua estensione, il flagello che ha colpito questa citt, seppellendola per met nelle acque, invadendo tutte le sue vie e viuzze, i suoi negozi e le sue cantine. Ma una gondola che spunta ad un tratto, sull'angolo d'un palazzo del Canal Grande, ci ricorda che siamo a Venezia. Quello che ammiriamo non l'effetto d'un cataclisma, bens opera dell'uomo, capolavoro d'un razza ingegnosa e paziente, che costru una citt in mezzo all'acqua, per ragioni difensive, beninteso, ma soprattutto, io credo, per essersi innamorata di quest'idea, per fare una cosa inaudita e mai vista: Venezia. Dove, a dire il vero, non si ha pi il senso di quel che sia la terra, la buon terra fangosa e fruttifera, che infarina gli abiti e ci fa ombra coi suoi alberi, la terra moderatrice di venti con le sue colline, teneramente sospirosa nelle notti di luna, popolata di effluvi, di voci e di canti. Qui non ci sono che pietre e acqua. A questi due elementi si riduce la vita di una Citt che fu cosi potente nel mondo ed tuttora cos bella. Ecco perch ogni minimo indizio di vegetazione sorprende, a Venezia, in maniera singolare. davvero incredibile veder salire la mattina, verso Rialto, certi barconi colmi di erbaggi freschi. Quei disadorni e sgangherati barconi mettono, a pi dei palazzi del Canal Grande, una nota inattesa di umilt e di gaiezza e sono certo pi significativi dei
famosi e agghindatissimi bragozzi chioggiotti che vengono di notte a sbarcare il pesce a Riva degli Schiavoni. Non per nulla i veneziani si compiacciono grandemente delle loro verdure. Nessuno riuscir mai a convincerli, per esempio, che la lattuga romana pu esser preferibile al radicchio di Treviso. Per un mazzo d'insalata darebbero volentieri tutte le loro pi celebrate rarit e specialit piscatorie. I pittori lagunari, un tempo, non dipingevano che cieli e acque. Era una pittura fatta di formule e di schifosa maniera. Poi vennero i pi sottili e moderni, i quali scoprirono la vera poesia della laguna, consistente, per l'appunto, nei gracili alberelli dell'estuario, in quelle sue disperate tracce di verde e di abitato rustico. Questa insomma la poesia delle isole intorno a Venezia, vale a dire dei luoghi veneziani originari, come Torcello, antichissima cattedrale sepolta, coi suoi preziosi mosaici, in mezzo alle canne. Perduta bellezza, a cui sembrano intonarsi, nella citt dei Dogi, le altane brune, le pesanti e caratteristiche imposte di legno, infisse all'esterno, che rappresentano, in contrasto con la merlettata architettura veneziana, una robusta sopravvivenza della casa rurale o palustre. Segreta nostalgia di Venezia per la campagna, armonioso dissidio, intorno al quale non il caso d'insistere, ma che illumina la storia, le tradizioni, i costumi della Serenissima, nonch la profondit e durevolezza delle sue conquiste, anelanti alla terraferma. Le vele veneziane sono color terra e sospirano il porto. Stendardi religiosi e domestici fecero nascere, dovunque arrivarono, altrettante Venezie. Penso che per fondare questa citt c' voluto molto legno e che i primi costruttori di Venezia dovettero essere boscaioli, tramutatisi, pi tardi, in arsenalotti. Di stirpe latina, scendevano dalle ultime frontiere italiche, portando nel loro carattere qualche cosa di cocciuto e di nordico. Nello studio dell'elemento lagunare spiegarono un talento precocemente positivo e scientifico e furono grandi scavatori di vie d'acqua come i Romani di vie terrestri; giacch la laguna, con le sue alte e basse maree, lascerebbe spesso la citt in secca se non ci fossero quei segreti canali che assicurano la continuit del traffico. Sulla via di Chioggia si pu navigare, in talune ore del pomeriggio, fra due rive di sabbia, avendo innanzi agli occhi la laguna abbassata e desolatissima come una sterminata salina. Nei giorni di caligo le campane sparse in mezzo all'acqua, suonando tutte insieme, ininterrottamente, come quelle d'un armento perduto fra i boschi, segnano la rotta al battello del Lido, ai bastimenti, ai bragozzi che navigano a tentoni verso il mare aperto. E nulla pi dolce, piu veramente veneziano, di queste invisibili campane annunziatrici del pericolo e del maltempo. Cos i veneziani, gente ritiratissima, giunsero al mare e da una situazione originariamente appartata e difensiva nacque la loro potenza. Fu allora che Venezia si rivest di marmi, si adorn di statue, di colonne, di palazzi sfolgoranti. Le pi preziose spoglie di Bisanzio concorsero ad abbellirla. Ma ci che
meraviglia maggiormente, in una citt fabbricata nelle condizioni di suolo e d'ambiente che tutti sanno, selvosa e fragile come un canneto, sono certi edifici monumentali, talmente alti e massicci che noi tremiamo guardandoli, come se dovessero franare sotto i nostri occhi. Non la terra che sorregge Venezia, la tenace volont, L'ardimento, l'affettuosa ostinazione di coloro che la costruirono, con una scienza molto simile a quella che si richiede per costruire una nave. E noi la vediamo galleggiare a somiglianza d'un capriccioso fiore marino. Ce la immaginiamo talvolta come il sogno meridiano d'un tritone. Per mille vene capillari la laguna legata al mare e Venezia ha la stessa vita faticosa e instabile della laguna che la pervade in ogni fibra. Le acque lagunari sembrano aver modellato nel corso dei secoli, con le loro pressioni sotterranee, il geologico pavimento di San Marco, solennissima nave mistica o grotta piena di fulgori disciolti in un'atmosfera tenebrosa e marina. Ci sono momenti che Venezia fa acqua da tutte le parti e se la barca dell'Evangelista non affonda, in quelle occasioni, soltanto perch si tratta di una barca apostolica. Alludo ai repentini allagamenti che si producono dal di dentro, attraverso i pori della citt, quasi per un fenomeno di trasudamento. Possibili in tutte le stagioni, sono pi frequenti d'inverno, quando i pompieri stanno sempre all'erta per fronteggiare i disastri che possono avvenire ad ogni istante. Disastri per cos dire, famigliari, a cui i veneziani, abituati ai perigliosi traghetti del Canalazzo, nelle seratacce di piova o di bora, usi a darsi una buona notte abbreviata e spicciativa da un ponte all'altro ("bona, bona"), come sotto l'urgenza del fortunale, si dimostrano preparatissimi. Che curioso spettacolo, allora, veder la gente andare in sandolo per piazza San Marco! Quale allegro senso di pericolo scampato ci d, in certe mattine, sboccando in piazza dalle Mercerie, la presenza del ponte di legno sospeso fra le Procuratie nuove e le vecchie, a inondazione finita! Com' divertente, in sostanza, vivere in una citt cos fluida, cos immersa nell'acqua, che perfino le donne veneziane fanno l'impressione di essere un po' acquose. acquosa e lattea la luna, a Venezia. Mi recai a Venezia, in un'estate, per trascorrervi un paio di giorni. Ci rimasi tre anni. E non sembri uno scherzo se affermo che nella mia decisione di fissarmi per qualche tempo in questa citt influ moltissimo il sapore della sua cucina marinaresca. Senza essere un buongustaio ho sempre avuto una certa inclinazione a giudicare un paese e magari una famiglia dal modo come vi si mangia; la qual cosa fa di me un ospite poco raccomandabile. Poich dunque, da questo lato, Venezia non ha nulla da invidiare a nessuna altra citt italiana e vi si mangia comunemente bene, anche nelle trattorie pi modeste, non c' da meravigliarsi che, grazie ad alcune vaghe e non ricercate sensazioni d'ordine gastronomico, io fossi portato ad abbandonarmi al fascino veneziano, malgrado il cattivo odore dei canali, in certi giorni, e il caldo soffocante che faceva fermentare di notte, nella mia camera, la vernice dei mobili.
I Piombi di Venezia non sono una favola. Inoltre lo scirocco in questa citt, associandosi ai cattivi odori che ho detti, particolarmente deleterio. Ma il clima della laguna, un po' lurido in estate, si fa improvvisamente lieve e puro di autunno, quando Venezia tutta lagunare, cio priva di ogni inquietudine marina, e rivela il suo vero carattere di citt nordica e fiabesca. Oh i lunghi e dolci autunni veneziani! L'estate se ne va bruscamente, senza lasciare strascichi di sorta. Cola a picco nei canali come una vecchia gondola logora. E ci si accorge del suo passaggio dal diradarsi dei forestieri che, in numero sempre pi esiguo, occupano i tavoli dei caff di piazza San Marco, allineati fuori delle Procuratie. In quelle file gloriose, riempite fino a ieri da un pubblico dorato e fittizio, si sono fatti a un tratto dei vuoti melanconicissimi. Ormai le poche persone che vi si attardano verso sera non sono pi neppure foresti smarriti, ma clienti abituali, tipi del luogo, che si confusero, nei mesi estivi, con la grossa ondata turistica, per poi rimanere scoperti sulla gran piazza come gusci di riccio e ossa di seppia sulla spiaggia. Sembra che stiano li a fare i conti della stagione, a raccoglierne i pettegolezzi, oppure a gustarne, secondo gli umori e le abitudini, l'ultimo sorso. Presto verr il tempo che l'agora sontuosa, paradiso dei visitatori estivi e balneari, non sar pi, nelle parti soleggiate, che un "campo" qualsiasi, ad uso delle balie e dei bambini. Intanto l'autunno veneziano s'accompagna a questo vasto senso di esodo e di solitudine inattesa. I crepuscoli scendono rapidi, soverchiamente bruni; sicch si direbbe che la citt prenda il lutto, per la partenza dei forestieri, se non fosse che proprio allora si manifesta la sua vera vita. Ed ecco di sera piazza San Marco, per tre quarti deserta, umidiccia, severamente illuminata come un androne di casa patrizia, mentre, dal lato delle Procuratie vecchie, s'infittiscono ridenti le luci da palcoscenico delle antiche botteghe e ferve il passeggio obbligato lungo il Liston, con quei rumori d'acqua che fanno i piedi, strusciando, e il brusio delle ciacole. Discosto, in ombra, San Marco non ha che un lumino votivo. Il Palazzo Ducale e la Piazzetta rientrano, per cosi dire, nella notte dei tempi. Lasciando i suoi maggiori monumenti in una solitudine preistorica, rischiarati dalla luna, o avvolti in un'oscurit profonda, appena appena punteggiata da luci smarrite e vivissime che sentono la laguna, la folla s'ingorga per le Mercerie che sono tutto un rigagnolo di luce viva, da far pensare alla colonnina di mercurio del termometro; formicola nelle calli, sparisce nei campielli. Ed qui che ormai dovremo cercare Venezia. Di giorno in giorno, di sera in sera, abbiamo la sorpresa di scoprirla, nella sua realt pi segreta, nelle sue inclinazioni e consuetudini secolari, come per effetto della bassa marea ci si accorge dei canali sepolti in laguna. Stranezza e novit d'una simile residenza. Alto, impressionante silenzio della notte lagunare. Scenografia romantica e cupa di Venezia notturna. Mistero delle calli, sinistro aspettO dei campielli fiocamente illuminati, col pozzo coperto in mezzo, come corti d'antiche prigioni, case che si mostrano dal lato meno decoroso, un po' arcigne, ermeticamente
chiuse all'assalto delle zanzare, nomi strani dei ponti: ponte della morte, ponte dell'assassin. Nei primi tempi, rincasando ad ora tarda, accettavo con piacere la compagnia di alcuni amici, come se a un certo punto, per una calle tenebrosa e deserta, potessi fare l'incontro del povero fornaretto. Rassicuratomi poi, abbastanza presto, sull'indole affabilissima e protettiva della popolazione veneziana, capii non esservi nulla di meno pericoloso e pi gradevole che girare soli e magari perdersi, nelle ore notturne, per questo tacito labirinto di calli e di canali, dove ti pu far trasalire soltanto la scia d'un topo d'acqua o il sordo rumore d'un remo che batte sul fianco d'un rio come un piede di legno. Le voci dei gondolieri che s'annunciano alle voltate, per evitare una collisione, sono voci che non ci riguardano. Vengono da un altro mondo. Quei naufraghi laggi, quegli abitatori dell'abisso, non chiedono il nostro soccorso. E sono viandanti famigliarissimi, quantunque la loro presenza ci sorprenda ogni volta. Li sentiamo sbatacchiare e annaspare, di notte, pei canali pi insospettati. Spuntano all'improvviso, dall'arco d'un ponte, come fantasmi e scivolano via silenziosi, godendosi il vero, il nobile aspetto di Venezia che noi, costretti a girare dietro le sue spalle, per queste segrete vie di servizio, non scopriamo che a tratti. Soltanto i canali hanno sempre uno sbocco, laddove le calli sono traditore e possono condurci da un momento alL'altro sull'orlo d'un rio o in un angola morto e sudicio, davanti a un "memento homo" di marmo, collocato sopra un'arida tazza che forse fu in antico una fontanella. Questo "memento homo" pare messo l per farci riflettere che la conformazione di Venezia rigorosamente obbligata e che, a parte i vagabondaggi notturni, muovendo i passi per questa citt fascinosa e tirannica occorre attenersi a un principio tanto semplice quanto inderogabile: seguir la corrente. Chi cerca le vie solitarie, i luoghi non frequentati, non ha ancora capito evidentemente n la topografia, n i sacrosanti costumi della Serenissima. Conoscendo i quali, al contrario, vi sar palese perch i veneziani, anche in piazza, si guardano bene dallo svariare e il loro pi fantasioso passeggio regolato, arginato dal famoso Liston. Motivi d'ogni ordine, a cui non sono estranei, senza dubbio, i secolari contatti con Bisanzio e l'Oriente, spiegano certi aspetti ieratici della vita veneziana, certe consuetudini apparentemente pedisseque. Dovunque troverete una calle in cui l'elemento umano fluisce come l'acqua nei canali, state pur certi ch'essa la via buona, anzi l'unica via che vi si offre. E se chiederete a un veneziano qualche indicazione di carattere topografico avrete la sorpresa di sentirvi rispondere: Vada sempre diritto. Com' possibile andar diritto in una citt cos tortuosa? Eppure l'espressione ha il suo valore, in quanto significa lasciarsi guidare dai passi altrui, saper distinguere le calli popolose e battute, che hanno visibilmente uno sfogo, da quelle deserte e cieche, abbandonate all'onnipotente dominio dei gatti. Cercate di non uscire dal corso comune della popolazione veneziana, unico filo d'Arianna in que-
sto dedalo, un filo inesauribile, e imparerete a circolare per Venezia, evitando il rischio di trovarvi smarriti in una stradetta allettante, ma senza sbocco. Istintivamente vi sentirete portati a camminare in fila e dalla vostra mano, come in processione, che poi la sola maniera di schermirsi, nei giorni di pioggia, dalle punte degli ombrelli. Giacch il deambulare per Venezia non scevro d'inconvenienti. Questa citt necessariamente incassata, ristretta, piena d'angoli, di spigoli, preziosa, cedevole e maligna come il vetro di Murano che, rovente, si lascia plasmare e lavorare a guisa d'argilla e poi, d'un tratto, si raffredda e ferisce. Voltando da una calle in un'altra, per esempio, consigliabile girare un po' al largo, se non si vuol battere la zucca in quella del passante che sopraggiunge in direzione opposta: avventura tremenda e abbastanza frequente. E che dire dei pericoli che s'accompagnano alla pioggia e alla neve, in una citt lastricata prevalentemente di marmo? In quei giorni gli scivoloni sui ponti, le cadute pi o meno gravi non si contano. E tutta la citt ne discorre. Si vive a Venezia come in un piacevole esilio, non solo dalla terra, ma dal tempo. Nel regno delle acque, in compagnia della muffa che appare e scompare dai campielli con la stessa rapidit inesplicabile e finisce, a poco a poco, per diventare la nostra pi cara amica e vicina di casa, fra tante pietre vellutate dall'acqua, affumicate dalla nebbia, calcinate dal sole, lisciate e levigate dal lungo uso degli uomini e nondimeno prive di quell'elemento che pi d'ogni altro ci d il senso della caducit delle cose, voglio dire la polvere, scopriremo la grazia di Venezia, consistente nel fatto che questa citt non possiede se non un vago sospetto delle stagioni terrestri; e come sia possibile, qui, dimenticarsi della morte, bench in nessun altro luogo si faccia un uso maggiore e pi innocentemente ostentato di annunci e di pompe funebri. Di partecipazioni listate a nero si fregiano abitualmente perfino le vetrine delle botteghe; e l'uso vuole che vi rimangano incollate per lungo tempo. Ma queste consuetudini veneziane, oltre a non recare alcun pregiudizio al commercio, non impediscono che si cammini per le calli pensando alla morte come a qualche cosa d'incredibile; giacch l'idea di dover morire si affievolisce, direi, a misura che ci si allontana dalla terra, e Venezia un labirinto di vita fluidissima, da cui sembra impossibile uscire, sla pure per essere portati al cimitero. E che strano cimitero quello dei veneziani, dove i morti riposano sull'acque e non si sa come n quando potranno tornare in polvere. Pietrificati piuttosto, non seguiteranno a vivere la vita elementare di questa citt senza tempo? Manca a Venezia il sentimento, l'orrore della morte. E' perci che si compiace di rivestirne i colori, le maschere, le apparenze, come dimostrano, fra l'altro, i due simboli pi comuni della vita veneziana: la funebre gondola e la macabra "bauta". Lombardia. RITORNO A MILANO CON ALCUNE RIFLESSIONI SUL VIAGGIARE
Sono un pessimo viaggiatore, lo confesso. Mi tanto difficile staccarmi da un luogo quanto assuefarmici. E sono inoltre un viaggiatore impaziente, incapace di acconciarmi ai fastidi, alle noie del viaggio. Ammiro coloro che sanno trasferirsi da un capo all'altro del globo senza nostalgie di sorta, con pochi oggetti di biancheria nella valigia. Per conto mio, simile a un emigrante, a uno zingaro, potrei dire, una volta in viaggio, "omnia mea mecum porto", ma in un senso affatto opposto a quello che si ricava dal celebre motto di non so quale filosofo greco. un bagaglio pesantissimo, tutta la mia esistenza che io mi trascino dietro viaggiando. Di notte, lungo la linea maremmana, guardo il mio vuoto scompartimento in una prigione che i vetri del finestrino rispecchiano da una parte e dall'altra, prolungandola all'infinito. Viaggio in un lentissimo e rumorosissimo bolide, in un enorme proiettile che non arriva, non scoppia mai. Poter dormire! Ma il mio sonno un'operazione troppo macchinosa perch possa compiersi in ferrovia. Non mi rimane che vegliare e riflettere: starei per dire pregare. Eccitato dal fragore del treno, in preda a una lucida e tormentosa insonnia, cavo di tasca il mio taccuino, destinato ad annotazioni assai pi innocenti, e scrivo: "Per tutta la vita la fortuna m' corsa appresso senza riuscire ad acciuffarmi". Oppure: "Ho vissuto come un morto: nella memoria, nella fantasia degli altri". Scrivo ancora: "Disordine, stanchezza, insufficienza, in tutte le occasioni, in ogni cimento della mia vita: perpetuo deficit o, per esprimermi con una parola meno frusta e meglio appropriata, perpetuo ammanco". Ecco in che modo una semplice notte in ferrovia pu trasformarsi per me in una congiuntura molto seria. Temo il viaggio, perch temo di venire, come al gioco, in troppo immediato contatto con me stesso. Ma quel che mi fa orrore soprattutto il viaggiare di notte, ad occhi bendati, per cosi dire, senza potermi concedere l'unico diversivo e piacere che mi si offra in una situazione cos tediosa: la vista della campagna, delle citt colte a volo dall'alto d'un cavalcavia o rasentando col treno in moto le finestre delle case, e perfino, vorrei aggiungere, di quelle povere stazioni vuote, spesso importanti e provviste di decorosa tettoia, che i rapidi sorvolano rallentando, come per render loro l'onore delle armi. Viaggiare sognare, scrive Pascal. Sognare la felicit fuori di noi. E mentre il treno corre non mai abbastanza veloce per il mio desiderio, in quel trapasso, in quella sospensione di vita e di rapporti, fate che io possa starmene al finestrino, in assidua contemplazione di ci che Rimbaud chiama "il fascino dei luoghi fuggenti". Sar ben difficile ch'io rinunci a questa mia vecchia consuetudine, in viaggio. Consuetudine che, d'altra parte, aggiunge allo strapazzo fisico una fatica psicologica assai pi sottile ed estenuante e mi conduce ad abbrutirmi del tutto. Sono, come vedete, un provinciale, un viaggiatore di terza classe, uno che, avendo talvolta affrontato viaggi piut-
tosto lunghi con lo stesso ingenuo trasporto con cui si fa una gita di piacere, sempre giunto a destinazione come un "ecce homo", con la barba cresciuta e impresentabilissimo. Ragione per cui devo riconoscere che il vero viaggiatore quello che si raccoglie nello scompartimento come in casa propria e viaggia con le tendine abbassate. Costui arriva fresco fresco, senz'avere nessun sospetto dei luoghi che attravers. Ha viaggiato come un baule, sissignori. Ma questa la sola maniera di viaggiare. Cos viaggiano tutti, salvo una piccola categoria d'inesperti e amanti del paesaggio, a cui ho la disgrazia d'appartenere. Come Dio vuole, sorpassata la mia buia e interminabile Maremma, il treno giunto a Livorno ed io entro in un ordine di pensieri meno tetro. Sono le due di notte. La grande stazione deserta e tutta illuminata e scintillante come una nave. Stazione degna d'una citt dove ha sede l'Accademia Navale; fatta per ricevere ammiragli. Quella di Pisa, al contrario, vecchiotta, piccina, provinciale, tinta in verde pisello, - nelle parti in muratura, con un decoro tutto toscano, da vecchia citt universitaria. Alla stazione di Carrara comincia ad albeggiare. Vedo ritto su un uscio, nel vasto scenario dei monti lunensi, un autentico tipo di carrarese che ha l'aria d'aver fatto una levataccia. Il suo viso insonnolito e imbronciato sembra esprimere il malumore della regione per la crisi che incombe sulle cave di marmo. Eccomi in Val di Magra. Nella pura luce del mattino un fiume leonardesco, velato da una nebbiolina leggera, lattea, albescente, si snoda per lungo tratto fra sponde montuose e boscose, bagnando paesi nobilmente adorni di cupole e logge. Case coloniche, in cotto antico e scuro, simili ad abbazie, piccoli cimiteri millenari, chiesette, campanili aguzzi, costruzioni vecchissime e leggiadrissime, tutte in mattone rosso, popolano la campagna montagnosa e fluviale. C' qui un'aria da feudo benedettino, un che di raccolto, di preziosamente cattolico e mistico. E le Alpi Apuane sullo sfondo, fumiganti e qua e l chiazzate di neve; un colore allegro, nei paesi che si succedono frequentissimi, di sobborghi di Genova nel cuore dell'Appennino. Stupendo paesaggio, di cui serbavo, fin dall'infanzia, un ricordo singolarmente fedele. A cinque anni, passai di qui come ora, in ferrovia; e quel che pi mi attir furono certi sprofondi luminosi e pietrosi, ossia il letto della Magra che in quella stagione, per non smentire il suo nome, era in secca. Di quel mio primo viaggio non rammentavo che questo tratto, rimasto nella memoria come una rivelazione oscura e incancellabile del paesaggio italiano ideale, tante volte evocata e rinnovatasi altrove. E proprio su questa linea, giudicate voi se non un motivo di ricordo, rischiai di cadere dal treno in corsa, appoggiandomi a uno sportello che qualcuno s'era dimenticato di chiudere. Potrei quasi ritrovare il luogo dove fui salvo per miracolo. Ma il treno vola, ormai, verso la pianura padana. Mi par di
riconoscere l'alto Parmense, e mi viene in mente perfino la faccia di qualche mio amico di Parma, osservando certi monticiattoli bitorzoluti e scabri, lungo i quali precipitano a cascatelle, come l'acqua d'una fontana, ruscelletti di neve sciolta. Addio Val di Magra. Mentre dileguano gli aspetti e il segreto di questa fulgida terra io penso che una volta guardavo il mondo assai distrattamente. Non lo guardavo, lo sorvolavo. Avevo del tempo davanti a me. Ora vorrei veder bene tutto ed essere informato di ogni cosa, come uno che non ha pi tempo da perdere. Passo il Po a giorno fatto. Fiumi, canali, rogge, marcite: la Lombardia tutt'acqua e vegetazione fluviale. Si offre come un paese straordinariamente omogeneo, con la sua luce un po' fosca e l'insistente monotonia delle masse dei pioppi che si succedono in vasto giro, all'infinito, simulando una variet di piani che non esiste e conferendo a questa grandiosa pianura non so che aspetto arruffato e selvaggio. I canali stretti e neri corrono tra file di pioppi altissimi che hanno i rami fino al pedale. Cos le stradette di campagna, con le anatre nei fossi. Qui evidentemente l'agricoltura ha raggiunto il massimo sviluppo. Forse per questo la Lombardia non ha niente d'idillico. Essa non che un immenso campo sperimentale, dove troverete grandi fattorie isolate, in luogo di poderi e di casolari, e, fino a poco tempo addietro, potevate vedere i cavalli attaccati all'aratro come in certi cartelli pubblicitari americani della nostra infanzia. Adesso siamo alle aratrici meccaniche. Eppure, come ho detto, nonostante una cos elaborata civilt agricola, per l'assenza o la rarit di alcuni elementi, quali la vite e gli alberi da frutto, il paesaggio lombardo conserva un carattere eroico e primordiale che lo distingue da ogni altro. Rivedo Milano dopo undici anni d'assenza, in una luce da ciclone, e non riesco pi ad orientarmi, a ritrovare le mie sensazioni d'un tempo. In uno dei miei molti soggiorni milanesi abitavo, d'estate, in una grande camera umida che riceveva luce da un cortiletto pieno di frescura e di muffa. Di tanto in tanto una bella donna florida e precocemente brizzolata, come sono spesso le milanesi, forse a motivo della nebbia e del freddo, compariva per un attimo ad una finestra prospiciente alla mia, ma sempre in faccende, senza neppure accorgersi della mia presenza. E questo solo fatto bastava a tenermi in casa e a farmi lavorare di buona voglia. Fu in quella stanza che, nel giro di poche settimane, io scrissi gran parte dei "Viaggi nel tempo". N il lavoro m'impediva di vivere e di spendermi, secondo il mio solito, nelle conversazioni artistiche e letterarie, che in quegli anni, a Milano, erano fervidissime. I bastioni di Porta Venezia furono il mio quotidiano divertimentO. Il gran viale di Monza, con gli acrobati e il fotografo la domenica, corso Buenos Aires, tumultuoso e popolaresco, il piazzale della vecchia stazione, coi suoi alberi immoti, incantati, nelle sere estive, come se fossero di ferro. Qui, dalla stazione in fuori, tutto rimasto, presso
a poco, tale quale. Ma io no, io sono invecchiato, ahim! Mortificazioni e noia di ritrovarmi solo, in una citt dove trascorsi alcuni periodi fra i pi lieti e laboriosi della mia vita, con tutte le sorprese e le malinconie d'un reduce, d'un "revenant". Seduto fuori d'un caff di corso Buenos Aires, aspettando l'ora di far visita ad un'amiCa d'altri tempi, che vuol rivedermi ad ogni costo, guardo passare la gente e mi perdo in una quantit di osservazioni futilissime per non pensare a cose pi serie. Undici anni. Anche la citt mutata. Come potrebbe non esserlo, attesa la sua straordinaria sensibilit ai fatti economici e sociali? Ragioni profonde, ragioni che esorbitano da queste noterelle personali, fan s che la Milano di oggi non sia pi quella che io lasciai nei tumulti del dopoguerra e nel lustro dell'inflazione, quando le pi umili popolane vestivano di seta nera e per le vie affollatissime, in quelL'epoca di urbanesimo anormale e di caro-alloggi, non si sentiva dir altro che "sgonfia minga, neh", "cupett", "el va el birocc", e simili frasi proverbiali e caratteristiche, non tutte egualmente riferibili, che davano alla vita milanese un tono fin troppo sicuro, energico, risentito. Allora infieriva la cosiddetta letteratura d'armistizio. Il Cova, il Savini, la Galleria, erano i luoghi sacri dello spirito meneghino e del gigionismo. Adesso Milano pi seria, meno sostenuta dal suo imperturbabile campanilismo, dal suo vecchio orgoglio di capitale morale, che pure le ispir la dignitosissima dedica della Galleria al Padre della Patria; e nondimeno, portata qual a rinnovarsi ad ogni primavera, come si rinnovano i suoi giardini e anche i suoi negozi e le attrezzature dei suoi opifici, sempre all'altezza e all'avanguardia dei tempi. Torna a piacermi il suono delle campane milanesi, pigro, strascicato, fra di "carillon" e di lastre di bandone che cadano lievemente l'una sull'altra. I vocalizzi d'una cantante si confondono, spesso, con questo suono dolcissimo e sonnolento, come i rumori dei tram e le trombette delle automobili, ai miei tempi, coi cori del Duomo. Riconosco il vento di Milano, quell'allegro vento lacustre che segue il temporale della notte. Porta odore di boschi di castagno e invoglia a fuggire verso i laghi. Quando soffia i giornali volano in Galleria; le guglie della cattedrale parrebbe che dovessero piegarsi e stormire. Anche Parigi, mi rammento, ha giornate di vento simili, che rallegrano i cittadini e convengono alla citt imbandierata. Ed eccomi, sulla scia dei ricordi, a ruminare certe mie vecchie impressioni sui laghi lombardi: impressioni del tempo che ogni mia stagione milanese finiva invariabilmente a Como, a Lugano, a Porlezza, a Intra, a Cernobbio, a Bellagio. Lass, nei mesi estivi, non spira un alito di vento. Il paesaggio appare quasi incantato per arte magica. Gli specchi d'acqua sono vitrei e qua e l aggrinziti come la pelle d'un serpente in letargo. Nell'ora pi lieve del
giorno, verso il tramonto, gli abitati vi si riflettono, fermissimi e netti, s che paiono stampati su raso. Le nuvole bianche, immote, massicce, sono pi da scolpire che da dipingere e rammentano le nuvole di stucco che fan da sgabello agli angeli sulla facciata di qualche chiesuola barocca. Isole ingioiellate. Patine di ombre bronzee nelle insenature delle montagne. Di veramente arioso e mosso, in questo paesaggio, non ci sono che le strade, le quali corrono come un lungo brivido sul dorso dei monti e si direbbero scavate dalla mano d'un gigante, con un sasso acuminato. fine.
Potrebbero piacerti anche
- Apuleio Della MagiaDocumento255 pagineApuleio Della MagiaSebastiano PalumboNessuna valutazione finora
- Coosemans Et Al., Quaderno Di Esercizi Per LLPSI Pars I - FR (Vol II, Cap XX-XXXIV), AVN, Montella 2003Documento106 pagineCoosemans Et Al., Quaderno Di Esercizi Per LLPSI Pars I - FR (Vol II, Cap XX-XXXIV), AVN, Montella 2003Gabriel Fernandes100% (1)
- Corpo, Tempio, Città. Le Estensioni Del SacroDocumento50 pagineCorpo, Tempio, Città. Le Estensioni Del SacroLuca CampioneNessuna valutazione finora
- Claude Nicolet - Strutture Dell'Italia Romana (Sec. III-I - A.C.) (2014, Jouvence)Documento447 pagineClaude Nicolet - Strutture Dell'Italia Romana (Sec. III-I - A.C.) (2014, Jouvence)Alexandre ArnoldNessuna valutazione finora
- Paesaggi scartati: Risorse e modelli per i territori fragiliDa EverandPaesaggi scartati: Risorse e modelli per i territori fragiliNessuna valutazione finora
- Toscana Underground ITALIANODocumento164 pagineToscana Underground ITALIANOgNessuna valutazione finora
- Il Disco Di FestoDocumento147 pagineIl Disco Di FestoleonardotrizzinNessuna valutazione finora
- Diana Umbronensis. Hellenistic and RepubDocumento18 pagineDiana Umbronensis. Hellenistic and RepubEdoardo VanniNessuna valutazione finora
- Lezione 3 - Riassunto Dei Pronomi e Pronomi IndirettiDocumento6 pagineLezione 3 - Riassunto Dei Pronomi e Pronomi IndirettiAnastasia SalesNessuna valutazione finora
- M. Cardosa, La Frequentazione Protostorica Del Tombolo Di Feniglia, 2002Documento24 pagineM. Cardosa, La Frequentazione Protostorica Del Tombolo Di Feniglia, 2002Massimo CardosaNessuna valutazione finora
- Italia Sicilia FeniciaDocumento50 pagineItalia Sicilia Feniciaa.menaNessuna valutazione finora
- Apolline Project Vol. 1 Studies On Vesuv PDFDocumento383 pagineApolline Project Vol. 1 Studies On Vesuv PDFaudubelaia100% (1)
- Esagramma o Simbolo Dello Spirito SeparatoDocumento4 pagineEsagramma o Simbolo Dello Spirito SeparatoSheenky_webNessuna valutazione finora
- Schieramento Contro Gli AlaniDocumento20 pagineSchieramento Contro Gli AlaniTommaso100% (1)
- La Toscana RuraleDocumento37 pagineLa Toscana RuraleAnonymous yAH8LaVDUCNessuna valutazione finora
- I Teatri Antichi Di NapoliDocumento14 pagineI Teatri Antichi Di NapoliQfwfwNessuna valutazione finora
- Libri SibilliniDocumento235 pagineLibri SibilliniBogomil67100% (1)
- Curi L'apparire Del BelloDocumento53 pagineCuri L'apparire Del BelloguglielmobilancioniNessuna valutazione finora
- Principato EcclesiasticoDocumento463 paginePrincipato EcclesiasticoGian Paolo CastelliNessuna valutazione finora
- Cilento Incursioni SaracenicheDocumento20 pagineCilento Incursioni SaracenichePallino61Nessuna valutazione finora
- Museo Archeologico e D'arte Della MaremmaDocumento163 pagineMuseo Archeologico e D'arte Della MaremmapspacimbNessuna valutazione finora
- Il riuso dei borghi abbandonati. Esperienze di comunitàDa EverandIl riuso dei borghi abbandonati. Esperienze di comunitàNessuna valutazione finora
- Lo Vetro D. Martini F. 2012 Il Paleoliti PDFDocumento64 pagineLo Vetro D. Martini F. 2012 Il Paleoliti PDFGustavo Ariel LoprestiNessuna valutazione finora
- Fce4df DALMIGNONEALLAFIORAItalianEditionDocumento31 pagineFce4df DALMIGNONEALLAFIORAItalianEditionFrancesco AltamuraNessuna valutazione finora
- D'Annunzio Dall'Estetismo Al SuperuomoDocumento3 pagineD'Annunzio Dall'Estetismo Al SuperuomoPietro Lorenzo PavanNessuna valutazione finora
- Clelia de Vecchi Alberto Furlanetto Greci e VenetiDocumento161 pagineClelia de Vecchi Alberto Furlanetto Greci e VenetibaroquetteNessuna valutazione finora
- PDFDocumento228 paginePDFSalvatoredeiPalazziNessuna valutazione finora
- Alle Origini Della Citta Medievale Il MeDocumento36 pagineAlle Origini Della Citta Medievale Il MeBiblioteca Giovanni Paolo II100% (1)
- Stasolla I Luoghi Gli Oggetti Di Culto I Materiali VotiviDocumento8 pagineStasolla I Luoghi Gli Oggetti Di Culto I Materiali VotiviLaszlo MicaelaNessuna valutazione finora
- Saffo Frammenti Tradotti Da Salvatore Quasimodo e Scheda Biografica Di Fedrico CondelloDocumento22 pagineSaffo Frammenti Tradotti Da Salvatore Quasimodo e Scheda Biografica Di Fedrico CondelloSergioLuizMarinhoNessuna valutazione finora
- Appunti RestauroDocumento29 pagineAppunti RestauroChristian Coppola100% (1)
- A.Ballardini Fare Immagini Tra Occidente PDFDocumento24 pagineA.Ballardini Fare Immagini Tra Occidente PDFSerena ScapagniniNessuna valutazione finora
- Ceramica PDFDocumento20 pagineCeramica PDFRodrigo EchegoyemberryNessuna valutazione finora
- Archivio Fotografico Di Giuseppe PaganoDocumento201 pagineArchivio Fotografico Di Giuseppe PaganoMihai IonescuNessuna valutazione finora
- I Disegni Di Architettura Nelle Accademie Di Belle Arti ItalianeDocumento41 pagineI Disegni Di Architettura Nelle Accademie Di Belle Arti Italianevelio2527Nessuna valutazione finora
- Orazio, Satira 1, 8Documento2 pagineOrazio, Satira 1, 8angelorendoNessuna valutazione finora
- Luciano Parinetto, Magia e Ragione. Una Polemica Sulle Streghe in Italia Intorno Al 1750, Firenze, La Nuova Italia,, 1974.Documento375 pagineLuciano Parinetto, Magia e Ragione. Una Polemica Sulle Streghe in Italia Intorno Al 1750, Firenze, La Nuova Italia,, 1974.Alessandro Zabini50% (2)
- Spunti Per Una Rilettura Critica Delle Honorantie Civitatis Papie.Documento55 pagineSpunti Per Una Rilettura Critica Delle Honorantie Civitatis Papie.Guido Gioria100% (1)
- Dal Soldo All'Euro R. PonticelloDocumento35 pagineDal Soldo All'Euro R. Ponticellorob3rtaNessuna valutazione finora
- Lorenzo de MediciDocumento9 pagineLorenzo de MediciFilipa TolićNessuna valutazione finora
- Archeologia, Architettura e Storia Dell'arte Romana: Ordini, Elementi e Tipologie ArchitettonicheDocumento91 pagineArcheologia, Architettura e Storia Dell'arte Romana: Ordini, Elementi e Tipologie ArchitettonicheMiciagiallaNessuna valutazione finora
- Dizionario Geografico Storico StatisticoDocumento1.020 pagineDizionario Geografico Storico StatisticoJair DemuttiNessuna valutazione finora
- I Santuari Oracolari Nel Latium Vetus PDFDocumento102 pagineI Santuari Oracolari Nel Latium Vetus PDFLuca VerzulliNessuna valutazione finora
- SarzanaDocumento9 pagineSarzanatipo00Nessuna valutazione finora
- Robustelli GibellinaDocumento90 pagineRobustelli GibellinaMarialaura MenoniNessuna valutazione finora
- DitiramboDocumento166 pagineDitiramboAnonymous JLgEGYeblNessuna valutazione finora
- Il viaggio in età moderna: Studi di Gaetano PlataniaDa EverandIl viaggio in età moderna: Studi di Gaetano PlataniaNessuna valutazione finora
- Beni Culturali Ambientali Nel Comune Di Torino Volume1-Indice-parte1Documento280 pagineBeni Culturali Ambientali Nel Comune Di Torino Volume1-Indice-parte1kurtainNessuna valutazione finora
- Mario Negri-Erika Notti - Leonardo Magini - Omero Il Cielo e Il Mare - Intro - Chap. 1Documento51 pagineMario Negri-Erika Notti - Leonardo Magini - Omero Il Cielo e Il Mare - Intro - Chap. 1Luciano DuòNessuna valutazione finora
- Architettura Greca. Storia e Monumenti DDocumento17 pagineArchitettura Greca. Storia e Monumenti DScipioAemilianus50% (2)
- Chiese Basiliane Sicilia Orientale PDFDocumento6 pagineChiese Basiliane Sicilia Orientale PDFOrnella GrassoNessuna valutazione finora
- Scarmoncin Franco - L'Abbazia Di Carceri - 1991Documento21 pagineScarmoncin Franco - L'Abbazia Di Carceri - 1991Silvano VenezianNessuna valutazione finora
- Età Di Mezzo e Secoli Bui - BarberoDocumento24 pagineEtà Di Mezzo e Secoli Bui - BarberoGiovannaNessuna valutazione finora
- Bietti Sestieri - Bronzo Finale in ItaliaDocumento53 pagineBietti Sestieri - Bronzo Finale in ItaliaKavu RI100% (1)
- La Misura Della BellezzaDocumento5 pagineLa Misura Della Bellezzavalentina meliNessuna valutazione finora
- I Sette Slavi Del Bosco Di Bambu'Documento1 paginaI Sette Slavi Del Bosco Di Bambu'Eleonora chiruzziNessuna valutazione finora
- Storia Dell'ArchitetturaDocumento37 pagineStoria Dell'Architetturasilvialuc92Nessuna valutazione finora
- CREVATIN y TEDESCHI 2005 - Studi Di Antichità in Onore Di Segio DarisDocumento335 pagineCREVATIN y TEDESCHI 2005 - Studi Di Antichità in Onore Di Segio DarisLóstregos de BrestNessuna valutazione finora
- AgamennoneDocumento24 pagineAgamennonemy-secret-lifeNessuna valutazione finora
- DialogoDocumento7 pagineDialogoGian LuigiNessuna valutazione finora
- Testamenti Vittorio Amedeo Alfieri (Asti, 16 Gennaio 1749 - Firenze, 8 Ottobre 1803Documento4 pagineTestamenti Vittorio Amedeo Alfieri (Asti, 16 Gennaio 1749 - Firenze, 8 Ottobre 1803Gian LuigiNessuna valutazione finora
- 2013 Reg AirDocumento45 pagine2013 Reg AirGian LuigiNessuna valutazione finora
- Un Grido e PaesaggiDocumento8 pagineUn Grido e PaesaggiGian LuigiNessuna valutazione finora
- Memorie Inutili - Carlo Gozzi (Venezia, 13 Dicembre 1720 - Venezia, 4 Aprile 1806)Documento228 pagineMemorie Inutili - Carlo Gozzi (Venezia, 13 Dicembre 1720 - Venezia, 4 Aprile 1806)Gian LuigiNessuna valutazione finora
- PoesieDocumento2 paginePoesieGian LuigiNessuna valutazione finora
- Il Taccuino Del VecchioDocumento7 pagineIl Taccuino Del VecchioGian LuigiNessuna valutazione finora
- Sentimento Del TempoDocumento26 pagineSentimento Del TempoGian LuigiNessuna valutazione finora
- MeropeDocumento25 pagineMeropegiangi57Nessuna valutazione finora
- FORUM2 PPP Settembre 2013Documento16 pagineFORUM2 PPP Settembre 2013Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Codice Appalti BozzaDocumento8 pagineCodice Appalti BozzaGian LuigiNessuna valutazione finora
- L'Amore Delle Tre Melarance - Carlo Gozzi (Venezia, 13 Dicembre 1720 - Venezia, 4 Aprile 1806)Documento15 pagineL'Amore Delle Tre Melarance - Carlo Gozzi (Venezia, 13 Dicembre 1720 - Venezia, 4 Aprile 1806)Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Appalti Pubblici Cosa Cambia Dopo Il Decreto Del FareDocumento4 pagineAppalti Pubblici Cosa Cambia Dopo Il Decreto Del FareGian LuigiNessuna valutazione finora
- Dell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Documento213 pagineDell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Poesie - Fede e Bellezza Dell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Documento58 paginePoesie - Fede e Bellezza Dell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Poesie Giambattista Vico (Napoli, 23 Giugno 1668 - Napoli, 23 Gennaio 1744)Documento40 paginePoesie Giambattista Vico (Napoli, 23 Giugno 1668 - Napoli, 23 Gennaio 1744)Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Versi Facili Per Gente Difficile - Poesie - Fede e Bellezza Dell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Documento4 pagineVersi Facili Per Gente Difficile - Poesie - Fede e Bellezza Dell'Italia - Niccolò Tommaseo, Detto Anche Nicolò (Sebenico, 9 Ottobre 1802 - Firenze, 1º Maggio 1874Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Prolusione 1769Documento11 pagineProlusione 1769Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Orlando Furioso 24-46 Ludovico Ariosto (Reggio Nell'emilia, 8 Settembre 1474 - Ferrara, 6 Luglio 1533)Documento341 pagineOrlando Furioso 24-46 Ludovico Ariosto (Reggio Nell'emilia, 8 Settembre 1474 - Ferrara, 6 Luglio 1533)Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Suppositi (In Prosa)Documento32 pagineSuppositi (In Prosa)Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Orlando Furioso 1-23 Ludovico Ariosto (Reggio Nell'emilia, 8 Settembre 1474 - Ferrara, 6 Luglio 1533)Documento317 pagineOrlando Furioso 1-23 Ludovico Ariosto (Reggio Nell'emilia, 8 Settembre 1474 - Ferrara, 6 Luglio 1533)Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Timo LeoneDocumento23 pagineTimo Leonegiangi57Nessuna valutazione finora
- L'Imperfetta (Cont. Di Virginio Ariosto A I Studenti)Documento25 pagineL'Imperfetta (Cont. Di Virginio Ariosto A I Studenti)Gian LuigiNessuna valutazione finora
- SatireDocumento32 pagineSatireGian LuigiNessuna valutazione finora
- Arie - Pietro MetastasioDocumento30 pagineArie - Pietro MetastasioGian LuigiNessuna valutazione finora
- Suppositi (In Versi)Documento57 pagineSuppositi (In Versi)my-secret-lifeNessuna valutazione finora
- Poli NiceDocumento25 paginePoli Nicegiangi57Nessuna valutazione finora
- Testamenti Vittorio Amedeo Alfieri (Asti, 16 Gennaio 1749 - Firenze, 8 Ottobre 1803Documento4 pagineTestamenti Vittorio Amedeo Alfieri (Asti, 16 Gennaio 1749 - Firenze, 8 Ottobre 1803Gian LuigiNessuna valutazione finora
- Le Nozze Di Figaro Lorenzo Da PonteDocumento32 pagineLe Nozze Di Figaro Lorenzo Da PonteGian LuigiNessuna valutazione finora
- Prova Comune Italiano 1 MediaDocumento6 pagineProva Comune Italiano 1 MediaValentina FotiNessuna valutazione finora
- Giulio - Sambon - e La Sua CollezioneDocumento53 pagineGiulio - Sambon - e La Sua CollezioneSimone RussoNessuna valutazione finora
- Takeaction Scheda Recupero 79439 U0Documento11 pagineTakeaction Scheda Recupero 79439 U0palmaNessuna valutazione finora
- VERBI PERFETTIVI e IMPERFETTIVI in ItalianoDocumento11 pagineVERBI PERFETTIVI e IMPERFETTIVI in ItalianoRiccardo SpinicciNessuna valutazione finora
- Alfabeto Fonetico Con CittàDocumento6 pagineAlfabeto Fonetico Con Cittàmatteonereo@yahoo.comNessuna valutazione finora
- Darija D.2.testDocumento4 pagineDarija D.2.testTanjaTatjanaNenezicNessuna valutazione finora
- Le Ragazze Di Tampa Extract Michelangelo CaldaraDocumento32 pagineLe Ragazze Di Tampa Extract Michelangelo CaldaraessenetoNessuna valutazione finora
- Avventura D&D 3.5Documento147 pagineAvventura D&D 3.5Gianfranco SamueleNessuna valutazione finora
- Archeologia Del Discorso Etnografico - DispensaDocumento74 pagineArcheologia Del Discorso Etnografico - DispensaAnna Lisa RossiNessuna valutazione finora
- Ungaretti ErmetismoDocumento14 pagineUngaretti Ermetismoenrico del sorboNessuna valutazione finora