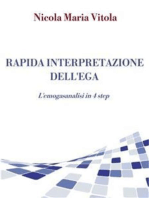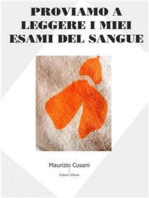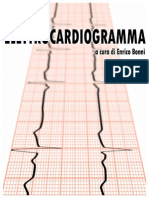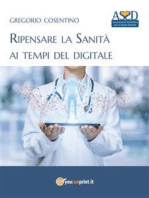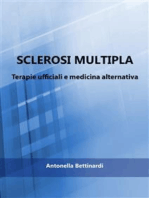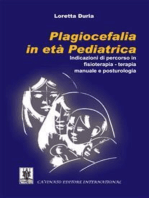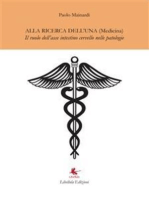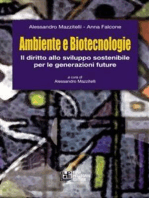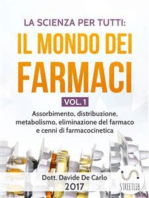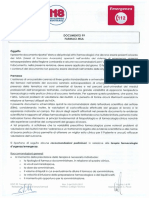Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
ECG Facile (ITA)
Caricato da
dilie1992Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
ECG Facile (ITA)
Caricato da
dilie1992Copyright:
Formati disponibili
ECG
FACILE
Traduzione della 5 edizione inglese di: The ECG made easy
John R. Hampton
Professore di cardiologia Universit di Nottingham, Nottingham, UK
Versione italiana a cura di
hystamina@hackmed.org Edizioni HACKMED.ORG
Ppppppppeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrlllrrrrruuuuulul uuggugggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
INTRODUZIONE
ECG facile stato pubblicato per la prima volta nel 1973: da allora sono state vendute pi di 250 000 copie in tutto il mondo. Il libro stato tradotto in tedesco, in francese, in spagnolo, in italiano, in portoghese, in indonesiano ed in giapponese. Non abbiamo voluto scrivere un manuale completo di elettrofisiologia n un manuale di interpretazione elettrocardiografica, ma una introduzione all'ECG destinata agli studenti in medicina, agli infermieri specializzati ed al personale paramedico. In oltre, l'ECG facile, costituir un'occasione di ripasso per tutti coloro i quali hanno dimenticato quanto appreso da studenti. L'ECG non dovrebbe essere un argomento preoccupante: come la maggior parte delle persone pu guidare la macchina senza avere conoscenze avanzate in meccanica, cos la maggior parte delle persone pu interpretare un ECG senza addentrarsi troppo nelle sue complessit. Questo libro incoraggia il lettore ad accettare l'idea che l'ECG veramente facile da capire, e che il suo utilizzo parte naturale dell'esame obiettivo. L'ECG facile, dovrebbe aiutare gli studenti a prepararsi agli esami: ma per acquisire competenze cliniche e fiducia in se stessi, niente pu rimpiazzare la lettura di un gran numero di tracciati ECG. Il titolo "ECG facile" ci stato suggerito 25 anni fa da Tony Mitchell, Professore di medicina all'universit di Nottingham, a Nottingham in Inghilterra. Cogliamo questa occasione per esprime la nostra sincera gratitudine a lui ed alle molte altre persone che ci hanno permesso di migliorare l'opera lungo il corso degli anni, in particolar modo ai molti studenti che, con le loro critiche costruttive ed i loro utili commenti, ci hanno convinto pi di prima che l'ECG veramente facile da capire.
John Hampton NOTTINGHAM, 1997
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
INDICE
CAP. 1 Che cosa l'ECG? CAP. 2 La conduzione ed i suoi problemi. CAP. 3 Il ritmo cardiaco. CAP. 4 Anomalie dell'onda P, QRS e T.
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
CAPITOLO 1
CHE COSA E' L'ECG?
L'ECG un elettrocardiogramma. Sappiate che: Principi Quando avrete terminato di leggere questo libro, voi sarete in grado di affermare che: 1. L'ECG facile da capire. 2. La maggior parte delle anomalie dell'ECG hanno una spiegazione razionale. COSA POSSIAMO ASPETTARCI DALL'ECG? La diagnosi clinica si basa essezialmente sulla storia clinica del malato ed in misura minore sull'esame obiettivo. L'ECG pu per apportare delle utili informazioni per una corretta diagnosi ed, in alcuni casi, gioca una ruolo di primo piano nella scelta del trattamento terapeutico. E' bene, dunque, considerare l'ECG come uno strumento utile nella diagnosi e non semplicemente finalizzato a se stesso. L'ECG essenziale per la diagnosi e quindi per il trattamento dei problemi del ritmo cardiaco, ci orienta nell'eziologia dei dolori toracici e nell'utilizzazione del trattamento trombolitico dell'infarto del miocardio. Inoltre contribuisce a diagnosticare la causa di problemi respiratori. L'interpretazione dell'ECG basata sulla identificazione della morfologia dei tracciati: tenendo conto di qualche regola semplice, applicando dei principi base, l'ECG pu essere analizzato facilmente. Queste regole saranno presentate in questo capitolo. ELETTRICITA' CARDIACA La contrazione di ogni muscolo si accompagna a modificazioni elettriche chiamate "depolarizzazioni" che possono essere registrate da elettrodi fissati alla superficie del corpo. Poich, in questo modo, saranno messe in evidenza tutte le depolarizzazioni muscolari, le modificazioni legate alla contrazione del muscolo cardiaco saranno visibili solo se il soggetto sar completamente disteso e rilassato, per evitare la contrazione dei muscoli scheletrici. Nonostante il cuore abbia 4 cavit, dal punto di vista elettrico possiamo condiderarne soltanto 2: una costituita dai 2 atri e l'altra dai 2 ventricoli.
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
Schema del circuito elettrico del cuore La depolarizzazione inizia in una regione di tessuto specializzato dell'atrio destro detta NODO SENO ATRIALE (SA) o NODO SINUSALE (Keith e Flack). L'onda di depolarizzazione si propaga, poi, alle circostanti fibre muscolari atriali. E' necessario un certo intervallo di tempo perch l'onda di depolarizzazione raggiunga una seconda zona specializzata nell'atrio destro: il NODO ATRIO VENTRICOLARE (AV). Quindi l'onda di depolarizzazione si propaga lungo un tessuto di conduzione specializzato: inizialmente una via unica, il fascio di HIS, che poi si divide a livello del setto interventricolare in una branca destra ed in una branca sinistra. Nella massa ventricolare, la conduzione dell'onda pu avvenire velocemente grazie ad una altro tipo di tessuto specializzato nella conduzione, le fibre di Purkinje. Il ritmo cardiaco Il termine "ritmo sinusale" definisce quel ritmo cardiaco che inizia nel NODO SA, la parte del cuore che regola fisiologicamente la sequenza di attivazione elettrica cardiaca. Come vedremo in seguito, alcune volte, l'attivazione elettrica del cuore pu iniziare in zone diverse dal nodo SENO ATRIALE. MORFOLOFIA DELL'ECG La massa muscolare degli atri relativamente piccola e le modificazioni elettriche che accompagnano la loro contrazione sono deboli. Le contrazioni degli atri provocano sull'ECG un onda chiamata P; poich la massa ventricolare maggiore, quando i ventricoli si contraggono, si produce una deflessione di ampiezza maggiore sull'ECG: il complesso QRS. L'onda T dell'ECG generata dal ritorno della massa ventricolare allo stato elettrico di riposo (ripolarizzazione). L'ECG normale ha questa morfologia caratteristica:
Le lettere P, Q, R, S e T sono state scelte in modo casuale. Le deflessioni P, Q, R, S e T sono tutte chiamate onde; l'insieme formato dalla onda Q, R e S un complesso; e l'intervallo (o spazio) tra l'onda S e l'onda T e denominato "tratto ST".
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
Definizioni Le differenti parti del complesso QRS utilizzano lettere che sono state scelte a caso. Se la prima deflessione rivolta verso il basso, viene chiamata onda Q.
Una deflessione verso l'alto una onda R (indipendentemente che sia preceduta o meno da una onda Q.
Una deflessione verso il basso preceduta da una onda R un'onda S (indipendentemente che sia preceduta o meno da una onda Q).
Tempi e velocit L'ECG viene tracciato su carta millimetrata che avanza a velocit costante e standard: questo il principio fondamentale degli elettrocardiografi. Ogni grande quadrato corrisponde a 0,2 secondi, in modo tale che ci siano 5 grandi quadrati al secondo e 300 al minuto. Un fenomeno come il complesso QRS che si ripete una volta nella distanza di grande quadrato ha una frequenza di 300 bpm. Si pu calcolare rapidamente la frequenza cardiaca tenendo conto che: se l'intervallo R-R di 1 gran quadrato, la frequenza di 300 bpm 2 gran quadrati, la frequenza di 150 bpm 3 gran quadrati, la frequenza di 100 bpm 4 gran quadrati, la frequenza di 75 bpm 5 gran quadrati, la frequenza di 60 bpm 6 gran quadrati, la frequenza di 50 bpm
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
Come la lunghezza tra le onde R, misurata in quadrati, permette di calcolare la frequenza cardiaca, cos la distanza tra le differenti parti del complesso P-QRS-T correlata al tempo di conduzione tra le differenti parti del cuore. L'intervallo PR (calcolato dall'inizio dell'onda P all'inizio del complesso QRS) corrisponde al tempo impiegato dall'onda di depolarizzazione per propagarsi dal nodo SA, al muscolo atriale, quindi al nodo AV, ed al fascio di HIS. La maggior parte dell'intervallo occupato dal tempo impiegato per giungere al nodo AV. L'intervallo PR normale di 0,12-0,2 sec (3-5 quadratini). Se l'intervallo PR molto corto, vuol dire che la depolarizzazione atriale cominciata vicino al nodo AV o che esistono delle anomalie nella conduzione tra gli atri ed i ventricoli.
La durata del complesso QRS indica il tempo che necessario affinch l'onda si propaghi nei ventricoli: questa normalmente 0,12 sec (3 quadratini) o poco meno: ogni anomalia nella conduzione rallenta i tempi e allarga il complesso QRS.
Registrazione di un ECG I segnali elettrici sono raccolti sulla superficie del corpo da cinque elettrodi, 4 fissati ad ogni arto (responsabili delle immagini in DI, DII, VL, VF, DIII,VR) ed uno fissato con 6 ventose sulla faccia anteriore del torace nelle diverse posizioni: V1, V2, V3, V4, V5, V6. L'elettrocardiografo confronta i fenomeni elettrici registrati nelle diverse posizioni e li trascrive sul tracciato. Ogni derivazione guarda l'attivit cardiaca da un punto di vista differente e produce, quindi, un'immagine elettrocardiografica diversa. Non necessario ricordarsi quali elettrodi corrispondono a determinate derivazioni, ma necessario controllare che gli elettrodi siano posizionati correttamente. Come vedremo, l'ECG costituito da immagini caratteristiche ed il tracciato, nel suo insieme, non pu essere correttamente interpretato se gli elettrodi non sono posizionati nei punti giusti.
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
ECG a 12 derivazioni L'interpretazione dell'ECG facile tenendo ben presenti gli angoli dai quali le diverse derivazioni guardano il cuore. Si pu supporre che le sei derivazioni standard, registrate dagli elettrodi fissati agli arti, guardino il cuore su un piano sagittale, di profilo (VL, DI, DII guardano il lato sinistro del cuore; VR guarda l'atri destro; DIII, VF guardano la parete inferiore del cuore).
Cosi le derivazioni DI, DII, VL guardano la faccia laterale sinistra del cuore, DIII e VF la faccia inferiore del cuore e VR l'atrio destro. (Da tutto ci ne consegue che, per esempio, la localizzazione di un onda Q, espressione di un infarto, in DIII e VR suggerisce una necrosi sulla faccia inferiore del cuore; in DI, DII e VL suggerisce invece una necrosi sulla faccia laterale sinistra.) La derivazione V (precordiale) e fissata sulla parete toracica per mezzo di 6 ventose, ed registrata in 6 posizioni diverse situate tutte sopra il 4 o 5 spazio intercostale
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
Le sei derivazioni guardano il cuore su un piano orizzontale (vedi disegno sotto), dalla parete anteriore fino al lato sinistro.
Cos V1 e V2 esplorano il ventricolo destro, V3 e V4 il setto interventricolare, V5 e V6 guardano rispettivamente la parete anteriore e laterale del ventricolo sinistro: ne consegue che un'onda Q in V1 e V2 espressione di un infarto ventricolare destro, un onda Q in V5 e V6 invece espressione di un infarto del ventricolo sinistro.) Come per le derivazioni degli arti, ogni derivazione precordiale mostra un'immagine differente caratteristica.
Realizzare un ECG Quando si realizza un ECG: 1. Per evitare tremori muscolari il soggetto deve essere sdraiato e rilassato. 2. Bisogna connettere gli elettrodi agli arti e assicurarsi che sia stati posizionati correttamente. 3. L'elettrocardiografo deve essere "calibrato" (di solito avviene automaticamente all'accensione del elettrocardiografo). 4. Per registrare le sei derivazioni standard: tre o quattro complessi sono sufficienti.
8
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
5. Le sei derivazioni V, precordiali, devono essere registrate accuratamente.
MORFOLOGIA DEL COMPLESSO QRS Ora dobbiamo considerare perch l'ECG ha un aspetto diverso per ogni derivazione. Il complesso QRS nelle derivazioni degli arti L'elettrocardiografo costruito in modo tale che per ogni onda di depolarizzazione che si avvicina all'elettrodo, si genera sul tracciato un onda rivolta verso l'alto, e per ogni onda di depolarizzazione che si allontana dall'elettrodo, si genera sul tracciato una onda rivolta verso il basso. L'onda di depolarizzazione si propaga dal cuore seguendo, nello stesso tempo, diverse direzioni, ma la deflessione del complesso QRS indica la direzione media verso la quale l'onda si propaga nei ventricoli. Se il QRS per la maggior parte rivolto verso l'alto (cio l'onda R pi ampia dell'onda S), l'onda di depolarizzazione si avviciner alla derivazione che registra questa onda. Se il QRS per la maggior parte rivolto verso il basso (cio l'onda S pi ampia dell'onda R), l'onda di depolarizzazione si allontaner dalla derivazione che registra questa onda. Quando l'onda di depolarizzazione si sposta ad angolo retto rispetto alla direzione della derivazione, le onde R ed S sono di uguale ampiezza.
Le onde Q hanno un significato particolare (generalmente infarto transmurale) che verr trattato in un altro capitolo. L'asse elettrico cardiaco VR e DII guardano il cuore da direzioni perfettamente opposte. Vista di fronte, l'onda di depolarizzazione si propaga da ore 11 a ore 5: le deflessioni sul tracciato saranno per la maggior parte negative (dirette verso il basso) in VR (infatti per questa derivazione l'onda di depolarizzazione di allontana) e per la maggior parte positive (dirette verso l'alto) per DII (infatti per questa derivazione l'onda di depolarizzazione si avvicina).
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
Si chiama asse elettrico cardiaco la direzione media di propagazione dell'onda di depolarizzazione nei ventricoli. E' utile verificare la direzione di questo asse. Si pu dedurre la direzione dell'asse elettrico a partire dai complessi QRS nelle derivazioni DI, DII e DIII. L'asse normale (ore 11 -> ore 5) traduce un'onda di depolarizzazione che si propaga verso le derivazioni DI, DII e DIII e che quindi caratterizzata da un'onda che nel tracciato ECG sar per la maggior parte diretta verso l'alto (positiva) in DI, DII e DIII. La deflessione sar pi ampia in DII che in DI o DIII. ASSE ELETTRICO NORMALE
Se il ventricolo destro si ipertrofizza, l'asse elettrico ruota verso destra. La deflessione in DI diventa negativa e la deflessione in DIII diventa pi positiva. Questa condizione si chiama "deviazione assiale destra" ed indice di condizioni polmonari che determinano una sovraccarico cardiaco (cuore polmonare) o malformazioni cardiache congenite. DEVIAZIONE ASSIALE DESTRA
10
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
Quando il ventricolo sinistro si ipertrofizza, l'asse pu spostarsi verso sinistra: il QRS diventa in gran parte negativo in DIII, le deviazioni assiali sinistre diventano significativa quando si accompagnano ad una deflessione negativa in DII. DEVIAZIONE ASSIALE SINISTRA
Nel caso di una deviazione assiale sinistra, il difetto generalmente legato ad un problema di conduzione piuttosto che ad un aumento di massa ventricolare sinistra (capitolo 2). Le deviazioni assiali destre e sinistre sono raramente significative da sole, ma la loro presenza deve spingervi alla ricerca di altri segni di ipertrofia destra e sinistra (capitolo 4).
Il QRS nelle derivazioni V precordiali La forma del complesso QRS nelle derivazioni precordiali determinata da 2 fattori: 1. Il setto interventricolare depolarizzato per primo e l'onda di depolarizzazione si propaga, nel setto, da sinistra verso destra. 2. In un cuore normale, c' pi muscolo nella parete del ventricolo sinistro e di conseguenza,la depolarizzazione del ventricolo sinistro ha pi influenza nell'ECG rispetto a quella del ventricolo destro. Le derivazioni V1 e V2 guardano l'attivit elettrica del ventricolo destro. Le derivazioni V3 e V4 quella del setto interventricolare e V5 e V6 quella del ventricolo sinistro. Il complesso QRS pu essere diviso in 2 fasi: la prima traduce la depolarizzazione del setto interventricolare, la seconda la depolarizzazione della massa ventricolare (non settale). PRIMA FASE DEL COMPLESSO QRS In una derivazione ventricolare destra la deflessione sar prima verso l'alto (onda R, perch l'onda di depolarizzazione del
11
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
setto va da sinistra verso destra). Al contrario, in una derivazione ventricolare sinistra, la deflessione sar prima verso il basso (NB: l'onda Q settale ha caratteristiche diverse rispetto a l'onda Q dell'infarto transmurale: la profondit dell'onda Q settale inferiore a 2mm e la sua larghezza inferiore a 1mm). SECONDA FASE DEL COMPLESSO QRS La depolarizzazione della massa muscolare ventricolare (non settale), in una derivazione ventricolare destra, produce una deflessione verso il basso (onda S) mentre in una derivazione ventricolare sinistra, produce una deflessione verso l'alto (onda R). La depolarizzazione ventricolare sinistra di ampiezza maggiore data la notevole massa muscolare, e quindi maschera totalmente la depolarizzazione del ventricolo di destra. . Quando tutto il miocardio depolarizzato, l'ECG registra una linea isoelettrica. Di conseguenza, nelle derivazioni precordiali il complesso QRS mostra una progressione regolare da V1 (dove maggiormente verso il basso) a V6 dove principalmente verso l'alto. Il punto di transizione dove le 2 onde si eguagliano in ampiezza indica la posizione del setto interventricolare.
12
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 1 http://www.hackmed.org
Se il ventricolo destro ipertrofizzato, ed occupa pi spazio del normale, il punto di transizione si sposta verso V4-V5. Questa condizione caratteristica delle pneumopatie croniche. . COME DESCRIVERE UN ECG Adesso siete in grado di presentare un ECG. La presentazione consiste in una descrizione seguita da una interpretazione. La descrizione segue sempre lo stesso ordine: 1. 2. 3. 4. 5. Ritmo. Asse elettrico cardiaco. Intervalli di conduzione. Descrizione dei complessi QRS. Descrizione del tratto ST e delle onde T.
NOZIONI DA RICORDARE 1. L'ECG si ottiene dalle modificazioni elettriche che accompagnano l'attivazione degli atri e poi dei ventricoli 2. L'attivazione degli atri produce l'onda P 3. L'attivazione dei ventricoli produce il complesso QRS 4. Quando l'onda di depolarizzazione si propaga verso una derivazione, la deflessione, registrata in quella derivazione, sar verso l'alto, in caso contrario verso il basso. 5. Il setto interventricolare si depolarizza da sinistra verso destra. 6. In un cuore normale il ventricolo sinistro esercita pi influenza sull'ECG del ventricolo destro.
13
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
CAPITOLO 2
LA CONDUZIONE ED I SUOI PROBLEMI
Abbiamo visto precedentemente che l'attivazione elettrica comincia normalmente nel nodo seno atriale e genera un'onda di depolarizzazione che si propaga dal muscolo atriale verso il nodo atrio ventricolare, per raggiungere poi, attraverso il fascio di His ed i suoi rami, i ventricoli. La conduzione di questo fronte d'onda pu essere ritardata o bloccata in qualsiasi punto. Principi 1. L'ECG facile da capire 2. I problemi della conduzione sono semplici da analizzare, a condizione che si tenga ben presente il circuito elettrico del cuore.
Bisogna ricordarsi che la depolarizzazione inizia sempre nel nodo seno atriale. L'analisi del ritmo cardiaco sar effetuata sulla derivazione che permette di studiarlo al meglio: molto spesso, ma non sempre, si tratta di DII o V1. PROBLEMI DI CONDUZIONE NEL NODO AV E NEL FASCIO DI HIS Il tempo di percorrenza dell'onda di depolarizzazione dal nodo seno atriale fino ai fasci muscolari ventricolari messo in evidenza nel tratto PR e non mai superiore (in condizioni normali) a 0,2 s (dai 3 ai 5 quadratini). Un'interferenza nel processo di conduzione provoca il fenomeno elettrocardiografico chiamato blocco cardiaco.
Blocco atri ventricolare di primo grado Se ogni onda di depolarizzazione nata nel nodo seno atriale condotta verso il ventricolo, in ritardo rispetto al suo tempo fisiologico di percorrenza, l'intervallo PR risulta allungato e questo costituisce un blocco atrio ventricolare di primo grado.
14
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
BLOCCO CARDIACO DI PRIMO GRADO
Nota: Un'onda P per complesso QRS Intervallo PR= 0,36 s
Un blocco di primo grado non significativo in se per se, ma pu essere espressione di un danno coronarico, di una cardite reumatica, di una intossicazione digitalica o di uno squilibrio elettrolitico. Blocco cardiaco di secondo grado Alcune volte, l'eccitazione non attraversa affatto il nodo atrio ventricolare o il fascio di His, Quando questo si verifica, la depolarizzazione intermittente: si parla, dunque, di blocco atrio ventricolare di secondo grado. Ci sono 3 varianti di questo tipo di blocco:
a)
La maggior parte dei battiti sono condotti con un intervallo PR costante, ma ogni tanto c' una depolarizzazione atriale senza successiva depolarizzazione ventricolare. Questo il blocco di MOBITZ tipo II.
BLOCCO DI SECONDO GRADO
Note: L'intervallo PR dei battiti trasmessi costante. Un'onda P non seguita da un complesso QRS: si tratta di un blocco di secondo grado
b) Ci
pu essere un ciclo ripetitivo, caratterizzato dall'allungamento progressivo dell'intervallo PR, seguito dall'assenza della depolarizzazione ventricolare, seguita da una nuova onda di depolarizzazione trasmessa con un intervallo PR corto. Questo il fenomeno di Wenckebach.
15
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
BLOCCO DI SECONDO GRADO (Tipo Weckenbach)
Note: Allungamento progressivo dell'intervallo PR. Un battito non trasmesso. Il successivo battito trasmesso ha un intervallo pi corto.
c)
Ci pu essere una alternanza di battiti atriali trasmessi e non trasmessi,con il risultato che le onde P sono pi dei complessi QRS. Questo tipo di blocco definisce una conduzione 2/1 o 3/1.
BLOCCO DI SECONDO GRADO (Tipo 2/1)
Note: Due onde P per complesso QRS. Intervallo PR normale e costante quando i battiti sono trasmessi.
A questo proposito bisogna ricordarsi che un'onda P pu manifestarsi anche solo come una onda T deformata.
Note: Onda P su di un onda T, indentificabile solamente per la sua regolarit
Le cause del blocco di secondo grado sono le stesse di quelle del blocco di primo grado. Il blocco cardiaco di Mobitz tipo II ed il blocco 2/1 possono evolvere in un blocco cardiaco completo o di terzo grado.
Si dice che si verifica un blocco cardiaco completo (blocco di terzo grado) quando la depolarizzazione atriale normale, ma nessun battito trasmesso ai ventricoli. Quando
16
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
questo si verifica, i ventricoli sono eccitati per un "meccanismo di fuga" lento (capitolo 3), con un centro di depolarizzazione situato nel muscolo ventricolare. BLOCCO DI TERZO GRADO (Completo)
Note: Frequenza delle onde P: 90 bpm Frequenza dei complessi QRS: 36 bpm Assenza di relazioni tra l'onda P e il complesso QRS Complessi QRS di forma anormale a causa di una propagazione irregolare generata nel muscolo ventricolare
Un blocco completo pu costituire un fenomeno acuto che si manifesta in individui colpiti da infarto del miocardio oppure pu essere uno stato cronico generalmente causato da una fibrosi intorno al fascio di His. Un blocco completo pu inoltre essere la conseguenza dell'interessamento contemporaneo dei 2 rami del fascio di His. PROBLEMI DI CONDUZIONE DELLA BRANCA DESTRA E SINISTRA DEL FASCIO DI HIS: BLOCCHI DI BRANCA Se l'onda di depolarizzazione raggiunge normalmente il setto interventricolare, l'intervallo tra l'inizio dell'onda P e la prima deflessione del complesso QRS (intervallo PR) sar normale. Se c' una conduzione anormale lungo la branca destra o sinistra (blocco di branca) ci sar un ritardo della depolarizzazione di una parte del muscolo ventricolare. Il tempo supplementare necessario per la depolarizzazione di tutto il muscolo cardiaco provoca un allargamento del complesso QRS. Nel cuore normale, il tempo impiegato dall'onda di depolarizzazione per diffondersi dal setto fino alle parti pi lontane del ventricolo non supera i 0,12 s (3 quadratini). Se la durata della depolarizzazione superiore, la conduzione ventricolare ha dovuto seguire una via anomala, e di conseguenza, pi lenta. Se un complesso QRS largo pu indicare un blocco di branca, quando la depolarizzazione iniziata nel nodo seno atriale, diversa la situazione di un allargamento del complesso QRS nel caso in cui l'onda non sia iniziata dal nodo seno atriale (capitolo 3). Il blocco della conduzione a livello delle 2 branche ha lo stesso effetto di un blocco cardiaco completo (terzo grado) Un blocco di branca destra (BBD) indica spesso l'esistenza di problemi nel cuore di destra, anche se immagini di BBD con una durata normale del complesso QRS sono molto spesso frequenti in soggetti in buona salute. Un blocco di branca sinistra (BBS) invece indica sempre una malattia cardiaca del cuore sinistro. E' importante riconoscere la presenza di questi blocchi di branca, perch un BBS esclude ogni interpretazione ulteriore dell'ECG mentre un BBD no.
17
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
Blocco di branca destra In caso di BBD, non c' conduzione lungo la branca destra e la parete interventricolare si depolarizza a partire dal lato sinistro. Questo comporta una onda R in derivazione ventricolare destra (V1) e una piccola onda Q in una derivazione ventricolare sinistra (V6).
L'onda si propaga, poi, al ventricolo sinistro, producendo una onda S in V1 e una onda R in V6.
18
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
necessario pi tempo del normale affinch l'onda raggiunga il ventricolo destro a causa del blocco della via normale della conduzione e, di conseguenza il ventricolo destro si depolarizza dopo il sinistro. Nel tracciato vedremo comparire, dunque, una seconda onda R (R1) in V1 e una onda S larga e profonda in V6.
L'immagine RSR1, ma con un complesso QRS di larghezza normale (inferiore a 120 ms), chiamata anche blocco di branca destra incompleto: spesso questa viene considerata come una variante normale.
Blocco di branca sinistra Se impedita la conduzione lungo la branca sinistra, il setto viene depolarizzato da destra a sinistra (l'opposto di quanto avviene in condizioni normali), provocando una piccola onda Q in V1 e una onda R in V6.
19
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
Il ventricolo destro si depolarizza prima del sinistro e per questo, malgrado la massa muscolare pi piccola, c' una onda R in V1 ed una onda S in V6.
Una depolarizzazione ritardata del ventricolo sinistro provoca una onda S in V1 e una onda R in V6.
20
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
Nozioni da ricordare Si osserva meglio un BBD in V1, dove c' una immagine RSR1.
Note: Ritmo sinusale Intervallo PR normale Immagine RSR1 in V1 Onda S profonda.
Il BBS appare pi netto in V6 dove si osserva un complesso largo, che assomiglia alla lettera M. L'immagine classica, con un aspetto a W in V1, non sempre visibilie.
Note: Ritmo sinusale Intervallo PR normale Allargamento del complesso QRS Aspetto ad M del complesso QRS osservato pi nettamente in V4-V6
21
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
PROBLEMI DI CONDUZIONE ALLE ESTREMITA' DELLA BRANCA SINISTRA A questo punto, bisogna considerare un p pi in dettaglio l'anatomia delle branche del fascio di His. La branca destra non ha rami importanti, invece la branca sinistra ne ha 2: il ramo anteriore ed il ramo posteriore. Di conseguenza, l'onda di depolarizzazione si propaga nei ventricoli seguendo 3 vie:
L'asse elettrico del cuore dipende dalla direzione media dell'onda di depolarizzazione dei ventricoli (capitolo 1). Poich il ventricolo sinistro contiene pi massa muscolare del ventricolo destro, esso esercita pi influenza sull'asse elettrico. ASSE NORMALE
Se la conduzione del ramo anteriore della branca sinistra difettosa, il ventricolo sinistro deve essere depolarizzato dal ramo posteriore, l'asse elettrico ruota quindi verso l'alto. DEVIAZIONE ASSIALE SINISTRA
22
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 2 http://www.hackmed.org
Una deviazione assiale sinistra risulta, di conseguenza, da un blocco del ramo anteriore della branca sinistra detto anche emiblocco anteriore sinistro. Il ramo posteriore della branca sinistra interessato di rado, ma se questo dovesse avvenire, avremmo una deviazione assiale destra. Quando la branca assiale destra del fascio di His bloccata, l'asse elettrico abitualmente normale perch il ventricolo sinistro (che influenza l'asse) si depolarizza normalmente.
Tuttavia, se la branca destra e il ramo anteriore sinistro sono bloccati, l'ECG mostra un blocco di branca destro ed una deviazione assiale sinistra. DEVIAZIONE ASSIALE SINISTRA
Questa anomalia viene detta blocco bifascicolare . Se la branca destra ed i 2 rami della branca sinistra sono bloccati, si verifica un blocco cardiaco completo: come se il fascio di His fosse incapace di condurre l'eccitazione.
NOZIONI DA RICORDARE 1. La depolarizzazione inizia normalmente dal nodo SA, si propaga ai ventricoli attraverso il nodo AV, il fascio di His, con la branca destra e sinistra con i suoi rami anteriore e posteriore. 2. Una anomalia della conduzione pu verificarsi in qualsiasi punto. 3. Un BBD si traduce con un immagine RSR1 in V1 mentre un BBS si traduce con un'immagine a "M" in V6. 4. Un blocco del ramo anteriore della branca sinistra del fascio di His provoca una deviazione assiale sinistra.
23
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
CAPITOLO 3
IL RITMO CARDIACO
Fino ad ora, abbiamo considerato soltanto la propagazione dell'onda di depolarizzazione generata dalla normale attivazione del NODO SA. Quando la depolarizzazione comincia nel NODO SA si dice che si tratta di un ritmo sinusale. Tuttavia la depolarizzazione pu cominciare altrove: il ritmo cos generato viene definito in base al punto in cui la sequenza di depolarizzazione inizia (es. ritmo ventricolare se inizia dal ventricolo). Ricordare: Le anomalie del ritmo sono facili da osservare: i due elementi da considerare sono l'onda P e la larghezza del complesso QRS. Principi Quando si prova ad analizzare un ritmo cardiaco, bisogna ricordare che: a) la contrazione atriale accompagnata da un'onda P. b) La contrazione ventricolare accompagna da un complesso QRS. c) LA contrazione atriale precede normalmente la contrazione ventricolare, ed ogni contrazione atriale seguita da una contrazione ventricolare. LA RITMICITA' INTRINSECA DEL CUORE La maggior parte delle zone del cuore possono depolarizzarsi spontaneamente e ritmicamente. La frequenza di contrazione dei ventricoli controllata dalla zona del cuore che ha la pi elevata frequenza di depolarizzazione. Il nodo SA possiede normalmente la pi elevata frequenza di depolarizzazione e, di conseguenza, la frequenza cardiaca sar uguale alla frequenza di depolarizzazione del nodo SA. La frequenza di depolarizzazione del nodo SA controllata dal nervo pneumogastrico (X nervo cranico) e da riflessi nervosi che nascono a livello dei polmoni: questo il motivo per cui, in soggetti giovani, normali, si possono osservare modificazioni della frequenza cardiaca correlate agli atti respiratori: questa l'aritmia sinusale.
24
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
ARTMIA SINUSALE
Note: Un'onda P per complesso QRS. Intervallo PR costante. Modificazione progressiva del''intervallo R-R da un battito all'altro.
Un ritmo sinusale lento (bradicardia sinusale) accompagna l'allenamento sportivo, gli svenimenti, le ipotermie, mixedema e lo si osserva, spesso, dopo una crisi cardiaca. Un ritmo sinusale rapido (tachicardia sinusale) compare con lo sforzo fisico, la paura, il dolore, le emorragie e la tireotossicosi. Non c' una frequenza particolare che caratterizza la tachicardia o la bradicardia. Questi sono solo dei termini descrittivi. I ritmi cardiaci anormali possono prendere origine in tre punti: a livello atriale, nella regione circostante il nodo AV (detti ritmi nodali o pi esattamente giunzionali) e nel muscolo ventricolare. Nello schema sottostante le stelle indicano i punti, a livello del muscolo atriale e ventricolare, da cui pi frequentemente pu nascere l'onda di depolarizzazione. I ritmi anormali possono comunque nascere in qualsiasi punto del muscolo ventricolare o atriale.
I ritmi sinusali, atriali e giunzionali sono dei ritmi sopraventricolari.
Nei ritmi sopraventricolari, l'onda di depolarizzazione si propaga verso i ventricoli seguendo un percorso normale, attraverso il fascio di HIS e le sue branche. La morfologia del complesso QRS , di conseguenza, inalterata, indipendentemente dal fatto che la
25
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
depolarizzazione abbia avuto inizio nel NODO SA, nel muscolo atriale o nella regione di giunzione.
Nei ritmi ventricolari, l'onda di depolarizzazione si propaga nei i ventricoli per una via anomala e, di conseguenza, pi lenta. Il complesso QRS risulta quindi allargato e alterato nella morfologia. Anche la ripolarizzazione modificata, deformando l'onda T.
Nozioni da ricordare 1. I ritmi sopraventricolari hanno dei complessi QRS normali. 2. I ritmi ventricolari hanno dei complessi QRS allargati. 3. La sola eccezione a questa regola si ha quando al ritmo sopraventricolare si associa una blocco di branca destra o sinistra (da soli responsabili di anomalie del complesso QRS, vedi capitolo 2) VARIETA' DEI RITMI ANORMALI I ritmi che nascono nel muscolo atriale, nella zona di giunzione o nel muscolo ventricolare possono essere lenti e duraturi (le bradicardie) oppure possono apparire sotto forma di battiti prematuri isolati (extrasistole) o ancora possono essere duraturi ma rapidi. Quando l'attivazione degli atri e dei ventricoli completamente disorganizzata, si dice che c' una fibrillazione. Ritmo di fuga: le bradicardie La capacit del cuore di poter iniziare la sequenza di attivazione in diverse parti del muscolo cardiaco, di notevole importanza perch consente di avere un certo numero di meccanismi di sicurezza che gli permettono di continuare a battere anche quando il nodo SA incapace di depolarizzarsi o quando l'onda di depolarizzazione bloccata. Questi meccanismi protettori sono normalmente inattivi perch le zone secondarie hanno una
26
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
frequenza di depolarizzazione pi bassa di quella del nodo SA. Il cuore guidato dalla zonea qualsiasi essa sia, che si depolarizza pi rapidamente. In condizioni normali, questa zona il nodo SA che ha una frequenza di circa 70 bpm. Se il nodo SA difettoso, la guida presa da un centro situato pi al disotto, nel muscolo atriale, o nella regione circondante il nodo AV (la zona giunzionale), che hanno una frequenza di scarica di 50 bpm. Se queste zone sono anch'esse difettose, o se la conduzione nel fascio di HIS bloccata (come nel blocco AV di terzo grado, capitolo 2), un il ventricolo prender il comando con una frequenza ventricolare di circa 30 bpm. Questi ritmi lenti di protezione si chiamano ritmi di fuga, perch si verificano quando i centri secondari di depolarizzazione "fuggono" dalla normale inibizione eservitata dal nodo SA che ha una frequenza maggiore di depolarizzazione. I ritmi di fuga si generano, quindi, in risposta a problemi situati a monte della via di conduzione. E' importante non tentare di fermare questi ritmi: il cuore potrebbe infatti cessare del tutto di contrarsi. Ritmo di fuga atriale Se il nodo SA diminuisce la sua frequenza ed un centro secondario atriale prende il comando del ritmo, ci troviamo di fronte ad una fuga atriale. FUGA ATRIALE
Note: Dopo un battito sinusale, il nodo SA non si depolarizza. Dopo un ritardo si osserva un'onda P anormale perch l'attivazione dell'atrio iniziata in una parte pi lontana dal nodo SA.
27
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
Fuga giunzionale Se la zona circostante il nodo AV prende il comando, si dice che il ritmo nodale. FUGA NODALE
Note: Frequenza sinusale a 100 bpm; ritmo di scappamento giunzionale a 70 bpm. Assenza di onde P nei battiti giunzionali, complesso QRS normale
Fuga vetricolare Una fuga ventricolare si ha, spesso, quando la conduzione tra gli atri ed i ventricoli si interrompe. Il blocco completo costituisce il ritmo di fuga ventricolare pi classico. BLOCCO CARDIACO COMPLETO
Note: Onde O regolari. Onde P alla frequenza di 145 bpm. QRS regolari, ma alterati a causa di una conduzione anormale a livello ventricolare. QRS di scappamento a 15 bpm. Assenza di relazione tra onda P complessi QRS.
Il ritmo cardiaco pu essere comandato da un centro ventricolare che si depolarizza con una frequenza di scarica pi elevata di quella che si osserva nel blocco completo. Questo un ritmo idioventricolare accelerato.
28
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
RITMO IDIOVENTRICOLARE ACCELERATO
Note: Dopo tre battiti sinusali, il nodo SA non si depolarizza. Un centro di scappamento situato nel ventricolo prende il comando. Complessi QRS allargati e onde T anormali.
Sebbene l'ECG assomigli a quello di una tachicardia ventricolare, il ritmo ventricolare accelerato benigno e non si deve trattare. Si diagnosticher una tachicardia ventricolare se la frequenza superiore a 120 bpm.
EXTRASISTOLE Qualsiasi parte del cuore pu depolarizzarsi anticipatamente e il battito cardiaco risultante viene detto extrasistole. Si pu anche utilizzare il termine ectopico per indicare che la depolarizzazione nasce in una zona anormale. L'ECG di una extrasistole che nasce a livello atriale, nella regione giunzionale o nodale o ancora nel muscolo ventricolare lo stesso di quello di un battito di fuga corrispondente, con la sola differenza che l'extrasistole si produce precocemente mentre il battito di fuga si produce in ritardo (quest'ultimo infatti un meccanismo di protezione). Le extrasistoli atriali hanno un onda P anormale mentre invece l'extrasistole giunzionale non ha alcuna onda P. I complessi QRS delle extrasistoli atriali o giunzionali sono naturalmente identici a quelli di un ritmo sinusale (la conduzione a livello ventricolare infatti inalterata). EXTRASISTOLE ATRIALI E GIUNZIONALI
Note:Il tracciato mostra un ritmo sinusale con delle extrasistole giunzionali ed atriali. I battiti sinusali, giunzionali ed atriali hanno dei complessi QRS identici: la conduzione oltre il fascio di HIS normale. Un'extrasistole giunzionale non ha onde P. Un'extrasistole atriale ha onde P di forma anormale.
29
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
Al contrario, le extrasistoli ventricolari hanno dei complessi QRS anormali che sono tipicamente allungati. Le extrasistoli ventricolari sono generalmente di scarsa importanza, tuttavia quando queste si generano troppo precocemente, sovrapponendosi ad una onda T precedente (espressione di una ripolarizzazione ventricolare), possono scatenare una fibrillazione ventricolare ed essere potenzialmente pericolose. Gli effetti delle extrasistole sopraventricolari e ventricolari sull'onda P successiva sono illustrate nei 2 esempi successivi: - una extrasistole sopraventricolare sposta il ciclo dell'onda P successiva (pausa compensatoria. EXTRASISTOLE SOPRAVENTRICOLARE
Note: 3 battiti sinusali sono seguita da un'extrasistole giunzionale. Non ci sono onde P al momento previsto. Dopo la pausa compensatrice, l'onda P successiva in ritardo.
una extrasistole ventricolare, al contrario, non ha effetti sul nodo SA e di conseguenza la successiva onda P appare al momento previsto.
EXTRA SISTOLE VENTRICOLARE
Note: 3 battiti sinusali sono seguiti da un'extrasistole ventricolare. Non si osservano onde P dopo questo battito, ma l'onda P successiva arriva al momento previsto.
LE TACHICARDIE: I RITMI RAPIDI Dai centri situati nell'atrio, nella regione giunzionale e nei ventricoli, possono essere inviate delle scariche ripetute che provocano una tachicardia duratura. Si possono adottare i criteri precedentemente descritti per determinare l'origine dell'aritmia e per cercare di identificare l'onda P.
30
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
a) Tachicardie sopraventricolari 1. Tachicardia atriale (centro anomalo situato nell'atrio) Nella tachicardia atriale, l'atrio si contrae con una frequenza superiore a 160 bpm. TACHICARDIA ATRIALE
Note: si possono osservare le onde P sovrapposte sulle onde T del battito precedente. I complessi QRS e le onde T hanno la stessa forma dei battiti sinusali.
Il nodo AV non pu condurre delle frequenze atriali superiori a 200 bpm, quindi se la frequenza atriale supera questo livello, si pu produrre un blocco atrio-ventricolare: non tutte le onde P sono quindi seguite da una complesso QRS. La differenza tra questo tipo di blocco atrio-ventricolare e il blocco cardiaco di secondo grado che nel caso di blocco atrio-ventricolare associato ad una tachicardia, il nodo AV funziona correttamente e impedisce l'attivazione rapida dei ventricoli (alla quale conseguirebbe un inefficiente svuotamente ventricolare). Nel caso di un blocco AV di primo, secondo e terzo grado, il nodo AV non funziona correttamente. Se la frequenza atriale superiore a 250 bpm, non tutte le onde P vengono trasmesse ai ventricoli: si ha dunque un flutter atriale. FLUTTER ATRIALE (4/1)
Note: Ci sono 4 onde P per complesso QRS, e l'attivazione ventricolare perfettamente regolare a75 bpm.
31
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
Il massaggio del seno carotideo pu avere effetti terapeutici sulle tachicardie ventricolari e vale sempre la pena di provarlo. La compressione del seno carotideo scatena un riflesso che provoca la stimolazione vagale dei nodi SA e AV, determinando una diminuzione della frequenza di scarica del nodo SA ed un aumento del tempo di conduzione nel nodo AV. Questo meccanismo importante nella diagnosi e nel trattamento dei problemi di ritmo. La compressione del seno carotideo rallenta o blocca infatti la frequenza ventricolare in alcune aritmie sopraventricolari, ma non ha effetto sulle aritmie ventricolari (a genesi ventricolare, perch in questo caso il nodo SA e AV non sono implicati nella sua genesi).
COMPRESSIONE SENO CAROTIDEO (csc)
Note: in questo caso, la compressione del seno carotideo ha aumentato il blocco tra gli atri ed i ventricoli ed ha reso pi evidente il flutter atriale.
2. Tachicardia giunzionale (nodale) Se la zona che circonda il nodo AV si depolarizza con una frequenza elevata, le onde P possono apparire molto vicine al complesso QRS, o possono anche non esserci del tutto. Il complesso QRS ha una forma normale perch, come per le altre aritmie sopraventricolari, i ventricoli sono attivati dal fascio di HIS, in maniere normale.
TACHICARDIA GIUNZIONALE
Note: nel tracciato non ci sono onde P ed i complessi QRS sono perfettamente regolari.
b) Tachicardie ventricolari Se un centro situato nel muscolo ventricolare si depolarizza con una frequenza elevata (una sorta di extrasistoli ventricolari ripetute), si dice che si tratta di una tachicardia
32
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
ventricolare. L'eccitazione si propaga per una via anormale nel muscolo ventricolare ed il complesso QRS allargato e anomalo. Un po' quello che succede nel blocco di branca, ma in questo ultimo caso possibile identificare con facilit la presenza di onde P ed una frequenza cardiaca non tachicardica.
TACHICARDIA VENTRICOLARE
Note: I complessi QRS si allargano e le onde T sono difficili da identificare. L'ultimo battito mostra il ritorno ad un un ritmo regolare.
FIBRILLAZIONE Tutte le aritmie descritte implicano la contrazione sincrona delle fibre muscolari degli atri e dei ventricoli, anche se a velocit anormali. Quando le fibre muscolari individuali si contraggono indipendentemente, si dice che queste fibrillano. La fibrillazione pu prodursi nel muscolo atriale cos come nel muscolo ventricolare. Quando le fibre muscolari dell'atrio di contraggono indipendentemente, non ci sono onde P sull'ECG, ma solamente un linea irregolare. Il nodo AV bombardato continuamente da onde di depolarizzazione d'intensit variabile e la depolarizzazione si propaga a degli intervalli irregolari lungo il fascio di HiS. Il nodo AV conduce secondo la modalit "tutto o niente", in modo tale che le onde che passano nel nodo AV siano di intensit costante. Tuttavia queste onde sono irregolari per frequenza ed i ventricoli si contraggono in modo irregolare. Poich la conduzione verso i ventricoli e nei ventricoli si effettua seguendo un percorso normale, ogni complesso QRS di forma normale.
33
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
FIBRILLAZIONE ATRIALE
Note: Assenza di onde P, linea isoelettrica irregolare. Complessi QRS irregolari. QRS di forma normale. V1 ha un aspetto che assomiglia a quello di un flutter atriale, fenomeno frequente nella fibrillazione atriale.
Quando le fibre muscolari dei ventricoli si contraggono indipendentemente, i complessi QRS non sono riconoscibili e l'ECG completamente disorganizzato. FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
Fibrillazione ventricolare Siccome il malato avr perso sicuramente conoscenza al momento in cui voi realizzerete l'ECG, la diagnosi sar facile.
34
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 3 http://www.hackmed.org
NOZIONI DA RICORDARE 1. La maggior parte delle zone del cuore sono capaci di depolarizzarsi spontaneamente. 2. I ritmi anormali possono nascere nel muscolo atriale, nella regione circostante il nodo AV e nel muscolo ventricolare. 3. I ritmi di fuga sono lenti e servono da protezione. 4. La depolarizzazione precoce di una qualsiasi regione provoca una extrasistole. 5. Una depolarizzazione di frequenza elevata provoca una tachicardia. 6. Tutti i ritmi sopraventricolari hanno dei complessi QRS normali a condizione che non ci sia un blocco di branca (capitolo 2). 7. I ritmi ventricolari producono dei complessi QRS allargati e anormali ed onde T anormali.
35
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
CAPITOLO 4
ANOMALIE DELL'ONDA P, QRS E T
Quando si interpreta un ECG, si analizza prima di tutto il ritmo e la frequenza. Poi bisogna porsi le seguenti domande, sempre nello stesso ordine: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ci sono delle anomalie dell'onda P? Quale l'asse elettrico del cuore? La durata del complesso QRS normale? Ci sono delle altre anomalie del complesso QRS?Ci sono delle onde Q? Il tratto ST sopraslivellato o sottoslivellato? L'onda T normale?
Principi 1. L'ECG facile da capire. 2. L'onda P pu essere: normale, inabitualmente alto, inabitualmente larga. 3. Il complesso QRS pu presentare tre tipi di anomalie: o troppo largo o troppo ampio o pu associarsi ad un'onda P. 4. Il tratto ST pu solo essere: normale, sopraslivellato o sottoslivellato. 5. L'onda T pu essere o diretta verso l'alto in modo normale o diretta verso il basso in modo anormale. ANOMALIE DELL'ONDA P Se si escludono le anomalie della forma legate ad un problema ritmico (come nel ritmo atriale o giunzionale per esempio), ci sono solo 2 anomalie importanti: 1. Tutto ci che responsabile di una ipertrofia dell'atrio destro (stenosi tricuspidale o ipertensione polmonare) rende l'onda P appuntita. IPERTROFIA ATRIALE DESTRA
2. Una ipertrofia atriale sinistra (generalmente causata da una stenosi mitralica) produce un'onda P larga e bifida.
36
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
ANOMALIE DEL COMPLESSO QRS Il complesso QRS possiede 4 caratteristiche: 1. 2. 3. 4. La sua durata non eccede i 0,12 s (3 quadratini) In una derivazione ventricolare destra (V1), l'onda S pi profonda dell'onda R. In una derivazione ventricolare sinistra (V2), l'ampiezza dell'onda R inferiore a 25mm Le derivazioni ventricolari possono mostare delle onde Q legate alla depolarizzazione settale, ma hanno caratteristiche ben precise che le differenziano dalle onde Q dell'infarto transmusale. Le onde Q settali sono inferiori ad 1mm di larghezza ed a 2 mm di profondit.
1. Anomalie della larghezza del complesso QRS I complessi QRS sono anormalmente larghi in caso di blocco di branca (capitolo 2) o quando la depolarizzazione nasce a livello ventricolare stesso (capitolo 3). In tutti casi, la maggior lunghezza indica che l'onda di depolarizzazione si propaga attraverso il ventricolo per una via anormale e, di conseguenza, pi lenta. 2. Aumento dell'ampiezza del complesso QRS Un aumento della massa muscolare del ventricolo produce un aumento dell'attivit elettrica e quindi dell'ampiezza del complesso QRS. Ipertrofia ventricolare destra L'ipertrofia ventricolare destra meglio visibile nelle derivazione ventricolari destre (V1, V2): il ventricolo sinistro perde il suo effetto dominante sul complesso QRS ed il complesso si inverte cio l'onda R diventa pi ampia dell'onda S. L'onda S sar profonda in V6.
37
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
L'ipertrofia ventricolare destra si accompagna generalmente ad una deviazione assiale destra dell'asse elettrico cardiaco, ad una onda P appuntita (ipertrofia atriale destra) e, nei casi pi severi, una inversione dell'onde T in V1 e V2. IPERTOFIA VENTRICOLARE DESTRA
Note: Ritmo sinusale. Onda P appuntita in V1. Deviazione destra dell'asse elettrico Onda R alta in V1 e onda S profonda in V6. Inversioni dell'onda T in V1 e V6.
In caso si embolia polmonare, l'ECG pu mostrare dei segni di ipertrofia ventricolare destra associata a : 1. Un'onda R alta in V1 2. Onda Q in DIII 3. Inversione dell'onda S in DIII
38
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
Ipertrofia ventricolare sinistra L'ipertrofia ventricolare sinistra determina un onda R alta (superiore a 25mm in V5 o V6) ed un'onda S profonda in V1 e V2. Inoltre la somma di R in V6 e di S in V2 solitamente superiore a 35 mm. Ma comunque difficile diagnosticare una ipertrofia ventricolare sinistra di modesta entit solo sulla base dell'ECG. IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA
Note: Ritmo sinusale. Asse elettrico normale (le onde R e S sono uguali in DII e l'asse elettrico e dunque al limite del normale. L'altezza dell'onda R in V5 di 35 mm. Onde S profonde in V1 e V2. Inversione delle onde T in DI, VL, V4-V6.
3. Origine delle onde Q Le piccole onde Q (settali) nelle derivazioni del ventricolo sinistro risultano dalla depolarizzazione del setto interventricolare da sinistra verso destra (capitolo 1). Tuttavia le onde Q di pi di 0,04 (un quadratino) e di pi di 2 mm di profondit hanno un significato del tutto differente. I ventricoli si depolarizzano dall'interno verso l'esterno. Di conseguenza , un elettrodo posto all'interno della cavit ventricolare registrer un onda Q, perch tutte le onde di depolarizzazione si allontanano dall'ettrodo, essendo dirette dall'interno verso l'esterno. Se un infarto del miocardio provoca la morte completa del muscolo (cio dalla superficie interna a quella esterna), si genera una sorta di finestra elettrica, ed un elettrodo che guarda il cuore attraverso questa finestra, registra un potenziale intracavitario, come se l'elettrodo fosse posto all'interno del ventricolo.
39
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
Le onde Q, che superano il quadratino di lunghezza e i 2 mm di profondit, indicano quindi un infarto del miocardio, e le derivazioni nelle quali compare l'onda Q danno delle informazioni sulla parte del cuore che danneggiata. Cos un infarto della parete anteriore del ventricolo sinistro produce un onda Q nelle derivazioni che guardano il cuore di faccia (V5 e V6). INFARTO ANTERIORE
Note: Ritmo sinusale. Asse elettrico normale. Onda Q in V1, V2, V3 Inversione dell'onde T in V4 e V5.
Se l'infarto interessa contemporaneamente la parete anteriore e laterale del cuore, un onda Q sar presente in V3 ed in V4 e nelle derivazioni che guardano la faccia laterale: DI, V2 e V5-V6.
40
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
INFARTO ANTERO LATERALE
Note: Ritmo sinusale. Asse elettrico normale (ricorda che l'asse calcolato sulle onde R e S e non sull'onda Q). Onde Q nelle derivazioni DI, DII, VL, V3-V5. Elevazione del segmento ST in V2-V6.
L'infarto della faccia inferiore del cuore produce un onda Q nelle derivazioni che guardano quella porzione di cuore: DIII e VF. INFARTO INFERIORE
41
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
Note: Ritmo sinusale. Onde Q in DIII e VF. Sopraslivellamento di ST in DIII e VF. Sottoslivellamento (ischemia) in VL e V6.
ANOMALIE DEL SEGMENTO ST IL segmento ST situato tra il complesso QRS e l'onda T.
Il segmento ST deve essere isoelettrico, cio deve essere allo stesso livello della linea situata tra l'onda T e l'onda P successiva. Ma il segmento ST pu essere sopraslivellato
O sottoslivellato
L'elevazione del segmento ST indica una lesione miocardica acuta, genelamente un infarto recente od una pericardite. Ancora una volta, le derivazioni nelle quali questa immagine appare, indicano la regione del cuore danneggiata: le lesioni anteriori sono evidenti nelle derivazioni V e le lesioni inferiori sono evidenti in DIII ed in VF. La pericardite generalmente diffusa e quindi il sopraslivellamento sar visibile in differenti derivazioni. La depressione (sottoslivellamento) del segmento ST, associato ad una onda P positiva, solitamente espressione di un'ischemia, non di un infarto. Questa depressione del segmento ST pu essere visibile anche solo nella prova sottosforzo spesso associata ad angina pectoris.
42
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
MODIFICAZIONI ISCHEMICHE SOTTO SFORZO
Note: Nel tracciato superiore a riposo, il tratto ST isoelettrici. Nel tracciato inferiore il tratto ST sottoslivellato.
Il segmento ST sottoslivellato e inclinato verso il basso sono generalmente legati al trattamento con digossina (vedere pi avanti). ANOMALIE DELL'ONDA T L'anomalia pi frequente l'inversione dell'onda T. Questa pu essere espressione di: 1. 2. 3. 4. 5. Stato normale Ischemia Ipertrofia ventricolare Blocco di branca Trattamento con digossina
Le derivazioni adiacenti a quelle che mostrano un'inversione dell'onda T, hanno, alcune volte, una onda T bifasica. 1. NORMALITA' L'onda pu essere normalmente invertita in VR ed in V1 (anche in V2 ed in V3). 2. ISCHEMIA Dopo un'infarto del miocardio, la prima anomalia che si osserva sull'ECG, una elevazione del segmento ST. In seguito compaiono le onde Q e le onde T si invertono. Il segmento ST ritorna alla linea isoelettrica dopo circa 24-48h. L'inversione dell'onda T spesso permanente.
43
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
INFARTO INFERIORE
Note: Il primo tracciato nei limiti della norma. 6 ore dopo l'inizio dei dolori, il tratto ST sopraslivellato in DII, DIII e VF e sottoslivellato in VL. Un'onda Q visibile ,m,m,,in DIII. 24 ore dopo, si nota una piccola onda Q in DIII. Il tratto ST ritornato sulla linea isoelettrica, ora visibile un'onda ,m,m,,T invertita in DIII e VF.
Se un infarto non occupa tutto lo spessore della parete, non si ha la "finestra elettrica". Non si avranno pertanto le onde Q (generate dalla finestra elettrica), ma soltanto una inversione dell'onda T. Questa situazione si definisce infarto sotto-endocardico.
44
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
INFARTO SOTTO ENDOCARDICO
3. IPERTROFIA VENTRICOLARE
Note: Ritmo sinusale. Asse elettrico normale. Complessi QRS normali. Inversioin delle onde T in DI, DII, VL, V2-V6.
L'ipertrofia ventricolare sinistra produce un'inversione delle onde T nelle derivazioni che guardano il ventricolo sinistro (V5, V6, DII e VL). L'ipertrofia ventricolare destra, provoca una inversione dell'onda T nelle derivazioni che guardano il ventricolo destro.
45
hystamina@hackmed.org John Hampton - CAPITOLO 4 http://www.hackmed.org
4. BLOCCO DI BRANCA Il percorso anomalo seguito dall'onda di depolarizzazione nel blocco di branca associato ad una onda di depolarizzazione anomala. Di conseguenza si possono avere delle onde T invertite che accompagnano dei complessi QRS di larghezza superiore a 0,16 s. 5. TRATTAMENTO CON DIGOSSINA La somminstrazione di digossina provoca un'inversione dell'onda T, tipicamente accompagnata da una depressione obliqua del segmento ST. EFFETTO DELLA DIGOSSINA
ALTRE ANOMALIE DEL SEGMENTO ST E DELL'ONDA T 6. ANOMALIE ELETTROLITICHE Le anomalie della concentrazione di Potassio, di calcio e di magnesio influenzano l'ECG. L'onda T e l'intervallo QT sono i pi colpiti. Un tasso ridotto di potassio provoca un appiattimento dell'onda T e l'apparizione di un'onda U (dopo la T). L'aumento del potassio si manifesta con onde T appuntite, larghe con scomparsa del segmento ST. Gli effetti del magnesio sono simili. Una bassa concentrazione di calcio allunga il tratto QT, un alta concentrazione aumenta il tratto QT. Ricordo infine che: L'ECG facile da capire. La maggior parte delle anomalie hanno una spiegazione razionale.
Ottobre 2002, Perugia Ciao ragazze/i, spero che questa mia fatica sia servita a rendervi la lettura dell'ECG, davvero piu' facile. Fatemelo sapere, inviatemi i vostri commenti a hystamina@hackmed.org - HYS -
46
Potrebbero piacerti anche
- Rapida interpretazione dell'EGA - II EdizioneDa EverandRapida interpretazione dell'EGA - II EdizioneNessuna valutazione finora
- Interpretazione dell'ECG: Una Guida Pratica ed Intuitiva per Imparare a Leggere l'ECG e a Diagnosticare e Trattare le AritmieDa EverandInterpretazione dell'ECG: Una Guida Pratica ed Intuitiva per Imparare a Leggere l'ECG e a Diagnosticare e Trattare le AritmieNessuna valutazione finora
- Corso Base Di Elettrocardiografia I Parte DiapositiveDocumento136 pagineCorso Base Di Elettrocardiografia I Parte Diapositiveguitar1985Nessuna valutazione finora
- Lezione Ecg 2013Documento67 pagineLezione Ecg 2013Medicine Conspectus100% (2)
- Elettrocardiogramma Tesina Bioingegneria ElettronicaDocumento31 pagineElettrocardiogramma Tesina Bioingegneria ElettronicasmNessuna valutazione finora
- Guida all'ECG-KrupenDocumento39 pagineGuida all'ECG-KrupenEmanuele CrupiNessuna valutazione finora
- ECGDocumento12 pagineECGPietro Di BariNessuna valutazione finora
- ECG Facile1Documento14 pagineECG Facile1Michele Scilla FresielloNessuna valutazione finora
- ECGDocumento28 pagineECGFederica MilanNessuna valutazione finora
- Ecg Facile Hampton Capitol o 2Documento0 pagineEcg Facile Hampton Capitol o 2angiolikkiaNessuna valutazione finora
- Ecg e PMDocumento6 pagineEcg e PMtodino32Nessuna valutazione finora
- Piccolo Manuale Pratico Di Approccio All'ECG Per La Sopravvivenza Dello Studente Di Medicina Del III AnnoDocumento9 paginePiccolo Manuale Pratico Di Approccio All'ECG Per La Sopravvivenza Dello Studente Di Medicina Del III AnnoFelice SperandeoNessuna valutazione finora
- Medicina di Laboratorio: Una Guida Pratica alla Scoperta dei Valori di Laboratorio e la loro Rilevanza nella Diagnosi delle MalattieDa EverandMedicina di Laboratorio: Una Guida Pratica alla Scoperta dei Valori di Laboratorio e la loro Rilevanza nella Diagnosi delle MalattieNessuna valutazione finora
- Elettrocardiogramma v3Documento15 pagineElettrocardiogramma v3Marcello VecchioNessuna valutazione finora
- Rianimazione e Terapia IntensivaDocumento34 pagineRianimazione e Terapia IntensivaPopa D. Silviu100% (1)
- Verità e bugie della medicina: Tutto quello che non viene detto su osteoporosi, colesterolo, cancro, sclerosi multipla, Alzheimer, morbo di Crohn, allergie, vaccinazioni, autismo, malattie autoimmuni, ecc.Da EverandVerità e bugie della medicina: Tutto quello che non viene detto su osteoporosi, colesterolo, cancro, sclerosi multipla, Alzheimer, morbo di Crohn, allergie, vaccinazioni, autismo, malattie autoimmuni, ecc.Nessuna valutazione finora
- A tavola con l'osteopata: Come e perché l'alimentazione può migliorare il tuo stato di salute per sempreDa EverandA tavola con l'osteopata: Come e perché l'alimentazione può migliorare il tuo stato di salute per sempreNessuna valutazione finora
- EmogasDocumento56 pagineEmogaspattada3333100% (1)
- Medicina riabilitativa: Scienza dell'assistenzaDa EverandMedicina riabilitativa: Scienza dell'assistenzaNessuna valutazione finora
- ElettrocardiogrammaDocumento25 pagineElettrocardiogrammaapi-3704348100% (7)
- File Unico ECGDocumento12 pagineFile Unico ECGAbraham AGNessuna valutazione finora
- Appunti Di Emmergenze (Medicina d'Urgenza-Chirurgia D'urgenza)Documento264 pagineAppunti Di Emmergenze (Medicina d'Urgenza-Chirurgia D'urgenza)chatzigeorgiou931Nessuna valutazione finora
- CARDIOLOGIADocumento39 pagineCARDIOLOGIAFedericoPppzPippoNessuna valutazione finora
- Compendio di riabilitazione ortopedica VOL 1: Il legamento crociato anterioreDa EverandCompendio di riabilitazione ortopedica VOL 1: Il legamento crociato anterioreNessuna valutazione finora
- Ebook-AnnalisaPazienza-ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN TERAPIA INTENSIVA - AssoCareNews PDFDocumento33 pagineEbook-AnnalisaPazienza-ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN TERAPIA INTENSIVA - AssoCareNews PDFlorenzo70v100% (1)
- Sentire l'Osteopatia: Indagine sensoriale ed energeticaDa EverandSentire l'Osteopatia: Indagine sensoriale ed energeticaNessuna valutazione finora
- Calcolo Dello Shunt, Consumo Di Ossigenocontrollo Nervoso e Chimico Della RespirazioneDocumento23 pagineCalcolo Dello Shunt, Consumo Di Ossigenocontrollo Nervoso e Chimico Della Respirazioneapi-3704348100% (5)
- Medicina Generale Ordine AlfabDocumento201 pagineMedicina Generale Ordine Alfabcarlofac100% (2)
- Pressione, Gittata Cardiaca, Circolo PolmonareDocumento19 paginePressione, Gittata Cardiaca, Circolo Polmonareapi-3704348100% (5)
- Manuale Di Malattie CardiovascolariDocumento189 pagineManuale Di Malattie CardiovascolariVale Peanuts100% (1)
- Semeiologia Del Torace CattolicaDocumento73 pagineSemeiologia Del Torace Cattolicamanuvit.mc1611100% (1)
- Appunti Di Cardiologia (+cardiochirurgia+chirurgia Vascolare) Pneumologia-Nefrologia (+urologia)Documento780 pagineAppunti Di Cardiologia (+cardiochirurgia+chirurgia Vascolare) Pneumologia-Nefrologia (+urologia)Αντώνιος ΧατζηγεωργίουNessuna valutazione finora
- ESAME AVVOCATO 2017. Tecniche di redazione Atti e Pareri alla luce dei criteri di correzione dei Commissari – 2a EdizioneDa EverandESAME AVVOCATO 2017. Tecniche di redazione Atti e Pareri alla luce dei criteri di correzione dei Commissari – 2a EdizioneNessuna valutazione finora
- Sclerosi multipla - Terapie ufficiali e medicina alternativaDa EverandSclerosi multipla - Terapie ufficiali e medicina alternativaNessuna valutazione finora
- Farmaci AntiipertensiviDocumento4 pagineFarmaci AntiipertensiviMassimiliano CasadeiNessuna valutazione finora
- Cardiologia SportDocumento301 pagineCardiologia SportMonica Bambi PerrottaNessuna valutazione finora
- Drenaggi VariDocumento22 pagineDrenaggi VariSergio100% (2)
- Ritmi Di ArrestoDocumento62 pagineRitmi Di ArrestoFedericaNessuna valutazione finora
- EdemaDocumento5 pagineEdemaMissyNessuna valutazione finora
- Malattie Del Cure e Dei Vasi 887Documento118 pagineMalattie Del Cure e Dei Vasi 887Or MillerNessuna valutazione finora
- Ambiente e Biotecnologie. l diritto allo sviluppo sostenibile per le generazioni futureDa EverandAmbiente e Biotecnologie. l diritto allo sviluppo sostenibile per le generazioni futureNessuna valutazione finora
- Fisiologia - Fisica Dell'EcgDocumento23 pagineFisiologia - Fisica Dell'EcgBenjaminMeghnagi0% (1)
- La Scienza Per Tutti: Il Mondo Dei Farmaci Vol. 1Da EverandLa Scienza Per Tutti: Il Mondo Dei Farmaci Vol. 1Nessuna valutazione finora
- Manuale Di Malattie CardiovascolariDocumento121 pagineManuale Di Malattie Cardiovascolarimgibbin85Nessuna valutazione finora
- Scale Per Chitarra ElettircaDocumento49 pagineScale Per Chitarra ElettircaCostanzo Di TullioNessuna valutazione finora
- 99 Farmaci MSA Rev3 Del 25-01-2017Documento99 pagine99 Farmaci MSA Rev3 Del 25-01-2017dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1527349653Documento17 pagineBLOB1527349653dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB499209549Documento4 pagineBLOB499209549dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB598835313Documento2 pagineBLOB598835313dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1444122630Documento16 pagineBLOB1444122630dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB656102858Documento10 pagineBLOB656102858dilie1992Nessuna valutazione finora
- Rapporto ISS COVID-19 N. 4 - 2021dDocumento25 pagineRapporto ISS COVID-19 N. 4 - 2021ddilie1992Nessuna valutazione finora
- Capitolato Maristella NuovoDocumento8 pagineCapitolato Maristella Nuovodilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1037669485Documento3 pagineBLOB1037669485dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB64934978Documento4 pagineBLOB64934978dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1888360309Documento2 pagineBLOB1888360309dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1646924879Documento23 pagineBLOB1646924879dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1405172731Documento1 paginaBLOB1405172731dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1353300632Documento2 pagineBLOB1353300632dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1495879767Documento26 pagineBLOB1495879767dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1963011591Documento2 pagineBLOB1963011591dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1254652001Documento4 pagineBLOB1254652001dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB2007846602Documento3 pagineBLOB2007846602dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB1837965368Documento1 paginaBLOB1837965368dilie1992Nessuna valutazione finora
- Blob 12220605Documento2 pagineBlob 12220605dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB2058195728Documento2 pagineBLOB2058195728dilie1992Nessuna valutazione finora
- Blob 1710558351Documento1 paginaBlob 1710558351dilie1992Nessuna valutazione finora
- Blob 12220605Documento2 pagineBlob 12220605dilie1992Nessuna valutazione finora
- Verbale Del Colloquio Per Servizio Privato Di Supporto Ai FamiliariDocumento1 paginaVerbale Del Colloquio Per Servizio Privato Di Supporto Ai Familiaridilie1992Nessuna valutazione finora
- Blob 482364664Documento2 pagineBlob 482364664dilie1992Nessuna valutazione finora
- BLOB735088358Documento3 pagineBLOB735088358dilie1992Nessuna valutazione finora
- Blob 482364664Documento2 pagineBlob 482364664dilie1992Nessuna valutazione finora
- Blob 482364664Documento2 pagineBlob 482364664dilie1992Nessuna valutazione finora
- Blob 482364664Documento2 pagineBlob 482364664dilie1992Nessuna valutazione finora