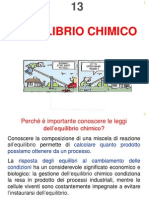Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Velocità Di Reazione
Caricato da
Lello PacellaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Velocità Di Reazione
Caricato da
Lello PacellaCopyright:
Formati disponibili
Velocit di reazione
La velocit di reazione definita matematicamente come la concentrazione di prodotto o di reagente in un intervallo di tempo, ossia v = [P]/ t = -[R]/ t . La diversa velocit con cui avviene una reazione pu avere anche effetti opposti: lacciaio esposto allaria e allacqua dopo un po di tempo si ossida, provocando ruggine; lacciaio fatto ossidare velocemente (avviene nel caso dellacciaio inox a causa del nickel) comporta una reazione veloce che provoca la formazione di uno strato intimamente connesso al substrato che costituisce una barriera inossidabile. Teoria degli urti e dello stato di transizione Una reazione chimica il risultato di un urto. Il principale fattore che condiziona il numero di urti che possono avvenire in un intervallo di tempo la temperatura. Maggiore la temperatura, maggiore il movimento delle molecole, maggiore il numero di urti, maggiore la possibilit che avvenga la reazione. Lurto per condizione necessaria ma non sufficiente. Prima di tutto lurto deve avvenire con unenergia tale da rompere le molecole dei reagenti, ma la rottura delle molecole non garantisce la formazione dei prodotti. Pu capitare infatti che a seguito dellurto si formino i legami iniziali e quindi non c alcuna formazione di prodotti. In questo caso, lurto efficace ma non utile. Se lurto tale da rompere i legami tra i reagenti e tale urto avviene in punti specifici della molecola e con un orientamento corretto, si formano i prodotti: lurto in questo caso efficace ed utile. C una diretta correlazione tra temperatura ed energia. Cos, se esiste una temperatura necessaria perch avvenga la rottura di alcuni legami, esister anche unenergia minima che consente di rompere questi legami: lenergia di attivazione. Quando viene raggiunta lenergia di attivazione si giunge in uno stato di transizione che comporta la formazione di un complesso attivato (lunione dei reagenti in ambito inorganico) che ha contenuto superiore ai prodotti. A causa del suo contenuto energetico, tale molecola altamente instabile e si trasforma subito nei prodotti della reazione. Matematicamente, definita come la differenza tra lenergia del complesso attivato e quella dei reagenti. Altra grandezza che entra in gioco nelle reazioni chimiche la variazione di entalpia1, definita come la differenza tra lenergia dei prodotti e quella dei reagenti. Se la reazione comporta lacquisizione di energia dallambiente esterno (reazione endotermica), i prodotti hanno energia superiore rispetto ai reagenti e la variazione di entalpia positiva; al contrario, avremmo una reazione esotermica con variazione di entalpia negativa. E chiaro quindi che la temperatura un fattore determinante nelle reazioni chimiche. Ci sono diversi fattori che condizionano la velocit con cui avviene una reazione chimica. - Concentrazione dei reagenti, che deve essere stechiometrica. - Superficie di contatto. Affinch avvenga una reazione necessario che i reagenti siano in contatto. Maggiore la superficie di contatto, maggiore leffetto adsorbimento 2, maggiore la velocit di reazione. Cosicch se i reagenti sono delle sfere solide la reazione molto probabilmente non avverr, al contrario se, ad esempio, il carbonio presente sotto forma di polvere esposta allaria pu facilmente avvenire la seguente reazione: C + O2 = CO2 + calore. Da ci deriva la pericolosit, nelle miniere di
carbone, delle polveri di carbone, che possono portare ad un esplosione allo scoccare di una scintilla. - Pressione e volume. Se la pressione alta le molecole dei reagenti sono come schiacciate tra loro; se il volume ridotto le molecole sono compresse: in entrambi i casi, le molecole urtano pi facilmente e la velocit di reazione maggiore. Es. amm - Catalizzatori. Sono sostanze che favoriscono le reazioni, indebolendo i legami nelle molecole dei reagenti. Il catalizzatore inorganico pi usato il platino in forma polverizzata o sotto forma di lamine. I catalizzatori biologici sono gli enzimi, proteine a struttura terziaria. Non sempre detto che velocit di reazione aumenti in modo proporzionale allenergia cinetica. Se la reazione endotermica, maggiore lenergia fornita, maggiore la velocit di reazione altrimenti nel caso di una reazione esotermica, laumento di energia provoca un effetto rallentamento (perch viene favorita la reazione inversa, come prevede il principio di Le Chatelier). Equilibrio chimico. Consideriamo la reazione reversibile H2 + I2 = 2HI , in questa reazione, man mano che si forma il prodotto lo stesso si converte nei reagenti, fino a quando non si raggiunge una situazione in cui la velocit della reazione diretta uguaglia quella inversa e la concentrazione di prodotti e reagenti resta constante (non detto che sia 50 e 50 dei due componenti). Questa situazione definita equilibrio mobile o dinamico perch c qualcosa che resta costante (la concentrazione di reagenti e prodotti) in presenza di cambiamenti (reagenti che diventano prodotti e prodotti che diventano reagenti). In una situazione di equilibrio chimico, possibile trovare una relazione matematica che mette in relazione (a parit di temperatura e pressione) le concentrazioni di reagenti e prodotti con un valore che la costante di equilibrio. Tale relazione prevede che in un sistema chimico in equilibrio a specifici valori di temperatura e pressione, il rapporto tra le concentrazioni molari dei prodotti e dei reagenti, elevate ciascuna al proprio coefficiente stechiometrico costante. Nel caso della reazione precedente avremo: [HI]2/ ([H2]+[I2]) = ke. Principio di Le Chatelier. Lequilibrio chimico pu essere turbato da una serie di fattori, concentrazione, volume, pressione e temperatura. Per ciascuno di questi casi, il principio di Le Chatelier permette di stabilire che in un sistema in equilibrio, perturbato da unazione esterna reagisce in modo da ridurne o annullarne leffetto, ristabilendo lequilibrio. Cos, aggiungendo un reagente a un sistema in equilibrio, si ha la trasformazione del reagente introdotto in prodotto, viceversa se si aggiunge un prodotto al sistema. Laumento di pressione o la diminuzione di volume di un sistema gassoso allequilibrio fa avvenire la reazione in modo tale che siano presenti il numero minore di molecole (cos la pressione resta la stessa ma la concentrazione cambia). Laumento di temperatura favorisce, in un sistema che in equilibrio, la reazione che implica assorbimento di calore, in modo tale da far restare
inalterata la temperatura del sistema. Se la reazione diretta endotermica, laumento di temperatura favorisce la reazione diretta. Gli effetti prodotti dalla variazione di concentrazione, temperatura e pressione sono usati ad esempio per produrre ammoniaca attraverso distillazione frazionata. Negli impianti di distillazione frazionata viene creato un sistema chimico in equilibrio e gradualmente vengono immessi i reagenti in modo che sia favorita la trasformazione dei reagenti in prodotti; inoltre si cerca di mantenere le temperature relativamente basse, ma sempre al di sopra dellenergia di attivazione, perch la reazione di produzione dellammoniaca esotermica e lalta temperatura favorisce la reazione inversa, con conseguente basso rendimento; oltre a ci, si cerca di mantenere unalta pressione o di diminuire il volume: ci favorisce la reazione che tende a far diminuire il volume cio quella diretta (nella reazione diretta N2 + 3H2 = 2NH2, si ha la riduzione da 4 volumi a 2).1
Lentalpia solitamente indicata con H, una funzione di stato che esprime la quantit di energia che un sistema termodinamico pu scambiare con l'ambiente. L'entalpia definita dalla somma dell'energia interna e del prodotto tra volume e pressione di un sistema.
2 Con il termine assorbimento si intende il processo di penetrazione di un gas in un solido o in un liquido o di un liquido in un solido quando la sostanza assorbita permea uniformemente tutta la massa del corpo assorbente. Viceversa il termine adsorbimento viene utilizzato per indicare il processo attraverso il quale un gas viene fissato sulla superficie di un solido o pi raramente di un liquido. Esistono due tipi di adsorbimento. Si parla di adsorbimento chimico o chemiadsorbimento quando gli atomi (o gli ioni) del gas adsorbito vengono fissati alla superficie attraverso veri e propri legami chimici (calore di adsorbimento dell'ordine di 20-100 kcal/mole). Si parla invece di adsorbimento fisico quando le molecole del gas vengono trattenute sulla superficie mediante forze pi deboli dei legami chimici che vengono tecnicamente chiamate forze di van der Waals (calore di adsorbimento inferiore o uguale a 5 kcal/mole).
Potrebbero piacerti anche
- FichteDocumento3 pagineFichteLello Pacella100% (1)
- PurgatorioDocumento2 paginePurgatorioLello PacellaNessuna valutazione finora
- SchellingDocumento2 pagineSchellingLello PacellaNessuna valutazione finora
- Riassunto PhiloDocumento7 pagineRiassunto PhiloLello PacellaNessuna valutazione finora
- QuantisticaDocumento3 pagineQuantisticaLello PacellaNessuna valutazione finora
- Radicali OmegaDocumento2 pagineRadicali OmegaLello PacellaNessuna valutazione finora
- Red OxDocumento2 pagineRed OxLello PacellaNessuna valutazione finora
- Teorie Acido-BaseDocumento1 paginaTeorie Acido-BaseLello PacellaNessuna valutazione finora
- Lib Stamp ADocumento3 pagineLib Stamp ALello PacellaNessuna valutazione finora
- NordsudDocumento1 paginaNordsudLello PacellaNessuna valutazione finora
- Nu Me RossDocumento1 paginaNu Me RossLello PacellaNessuna valutazione finora
- Periodic ADocumento2 paginePeriodic ALello PacellaNessuna valutazione finora
- Leg A MiDocumento2 pagineLeg A MiLello PacellaNessuna valutazione finora
- Leggi PonderaliDocumento1 paginaLeggi PonderaliLello PacellaNessuna valutazione finora
- He GelDocumento3 pagineHe GelLello PacellaNessuna valutazione finora
- Fonti AlchimiaDocumento5 pagineFonti AlchimiaLello PacellaNessuna valutazione finora
- IdrocarburiDocumento2 pagineIdrocarburiLello PacellaNessuna valutazione finora
- KantDocumento3 pagineKantLello PacellaNessuna valutazione finora
- Il Decadimento RadioattivoDocumento3 pagineIl Decadimento RadioattivoLello PacellaNessuna valutazione finora
- Geo Astro 1Documento3 pagineGeo Astro 1Lello PacellaNessuna valutazione finora
- Chi MicaDocumento1 paginaChi MicaLello PacellaNessuna valutazione finora
- CosaalchimiaDocumento8 pagineCosaalchimiaLello PacellaNessuna valutazione finora
- CompostiDocumento3 pagineCompostiLello PacellaNessuna valutazione finora
- Astro 4Documento17 pagineAstro 4Lello PacellaNessuna valutazione finora
- AstroDocumento3 pagineAstroLello PacellaNessuna valutazione finora
- Casta DefinitivoDocumento23 pagineCasta DefinitivoLello PacellaNessuna valutazione finora
- Astro 1Documento2 pagineAstro 1Lello PacellaNessuna valutazione finora
- AllotropiaDocumento2 pagineAllotropiaLello PacellaNessuna valutazione finora
- AlchimiaiDocumento2 pagineAlchimiaiLello PacellaNessuna valutazione finora
- Equilibio QuimicoDocumento40 pagineEquilibio QuimicoFranck Pereira0% (1)
- Esercizi Di ChimicaDocumento31 pagineEsercizi Di ChimicaAlessandro Ingrosso100% (2)
- Formulario Chimica GeneraleDocumento2 pagineFormulario Chimica GeneraleFrancesco Provenzano100% (1)
- 5-Termodinamica Ed Equilibrio PDFDocumento12 pagine5-Termodinamica Ed Equilibrio PDFValerio Jackson MelucciNessuna valutazione finora
- Riassunto Di ChimicaDocumento67 pagineRiassunto Di ChimicaMarioNessuna valutazione finora
- Pertu Victoria - Relazione Sull'equilibrio ChimicoDocumento5 paginePertu Victoria - Relazione Sull'equilibrio ChimicoVictoriaNessuna valutazione finora
- Slides Chimica I Equilibrio ChimicoDocumento69 pagineSlides Chimica I Equilibrio ChimicoErin SimonNessuna valutazione finora
- Chimica TuttoDocumento61 pagineChimica Tuttob_stasi33% (3)
- Orale Chimica 1Documento22 pagineOrale Chimica 1NoemiNessuna valutazione finora
- Equilibri ChimiciDocumento9 pagineEquilibri ChimiciPietro MontagnaNessuna valutazione finora
- Capitolo 16Documento27 pagineCapitolo 16Francesco PozielloNessuna valutazione finora
- Lez 20 - Equilibrio ChimicoDocumento45 pagineLez 20 - Equilibrio ChimiconaomiNessuna valutazione finora
- Relazione Lab 05-05Documento4 pagineRelazione Lab 05-05alexNessuna valutazione finora
- Cap 4 CHIMICA Elettroliti 1 2019 2020Documento39 pagineCap 4 CHIMICA Elettroliti 1 2019 2020rodrigue yanNessuna valutazione finora